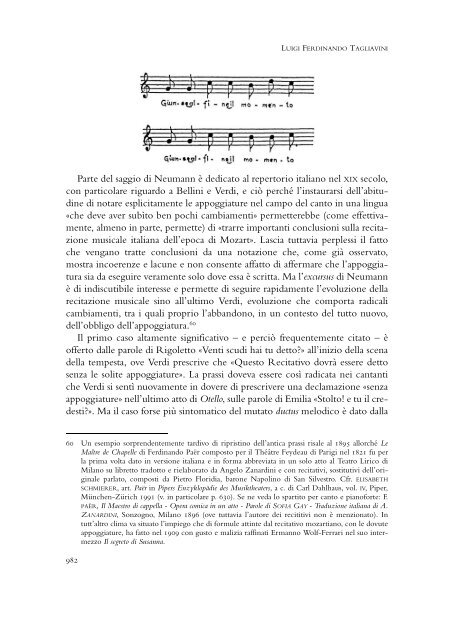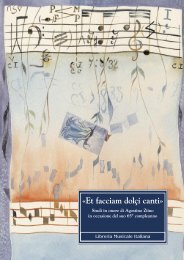Articolo Tagliavini appoggiature
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
LUIGI FERDINANDO TAGLIAVINI<br />
Parte del saggio di Neumann è dedicato al repertorio italiano nel XIX secolo,<br />
con particolare riguardo a Bellini e Verdi, e ciò perché l’instaurarsi dell’abitudine<br />
di notare esplicitamente le <strong>appoggiature</strong> nel campo del canto in una lingua<br />
«che deve aver subìto ben pochi cambiamenti» permetterebbe (come effettivamente,<br />
almeno in parte, permette) di «trarre importanti conclusioni sulla recitazione<br />
musicale italiana dell’epoca di Mozart». Lascia tuttavia perplessi il fatto<br />
che vengano tratte conclusioni da una notazione che, come già osservato,<br />
mostra incoerenze e lacune e non consente affatto di affermare che l’appoggiatura<br />
sia da eseguire veramente solo dove essa è scritta. Ma l’excursus di Neumann<br />
è di indiscutibile interesse e permette di seguire rapidamente l’evoluzione della<br />
recitazione musicale sino all’ultimo Verdi, evoluzione che comporta radicali<br />
cambiamenti, tra i quali proprio l’abbandono, in un contesto del tutto nuovo,<br />
dell’obbligo dell’appoggiatura. 60<br />
Il primo caso altamente significativo – e perciò frequentemente citato – è<br />
offerto dalle parole di Rigoletto «Venti scudi hai tu detto?» all’inizio della scena<br />
della tempesta, ove Verdi prescrive che «Questo Recitativo dovrà essere detto<br />
senza le solite <strong>appoggiature</strong>». La prassi doveva essere così radicata nei cantanti<br />
che Verdi si sentì nuovamente in dovere di prescrivere una declamazione «senza<br />
<strong>appoggiature</strong>» nell’ultimo atto di Otello, sulle parole di Emilia «Stolto! e tu il credesti?».<br />
Ma il caso forse più sintomatico del mutato ductus melodico è dato dalla<br />
60 Un esempio sorprendentemente tardivo di ripristino dell’antica prassi risale al 1895 allorché Le<br />
Maître de Chapelle di Ferdinando Paër composto per il Théâtre Feydeau di Parigi nel 1821 fu per<br />
la prima volta dato in versione italiana e in forma abbreviata in un solo atto al Teatro Lirico di<br />
Milano su libretto tradotto e rielaborato da Angelo Zanardini e con recitativi, sostitutivi dell’originale<br />
parlato, composti da Pietro Floridia, barone Napolino di San Silvestro. Cfr. ELISABETH<br />
SCHMIERER, art. Paër in Pipers Enzyklopädie des Musiktheaters, a c. di Carl Dahlhaus, vol. IV, Piper,<br />
München-Zürich 1991 (v. in particolare p. 630). Se ne veda lo spartito per canto e pianoforte: F.<br />
PAËR, Il Maestro di cappella - Opera comica in un atto - Parole di SOFIA GAY - Traduzione italiana di A.<br />
ZANARDINI, Sonzogno, Milano 1896 (ove tuttavia l’autore dei recititivi non è menzionato). In<br />
tutt’altro clima va situato l’impiego che di formule attinte dal recitativo mozartiano, con le dovute<br />
<strong>appoggiature</strong>, ha fatto nel 1909 con gusto e malizia raffinati Ermanno Wolf-Ferrari nel suo intermezzo<br />
Il segreto di Susanna.<br />
982