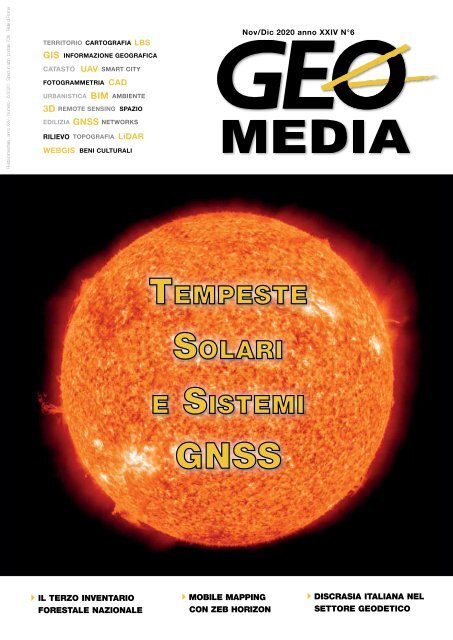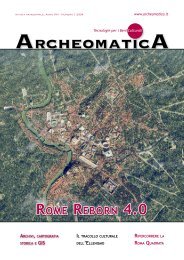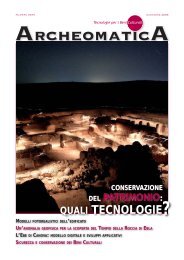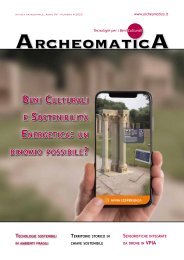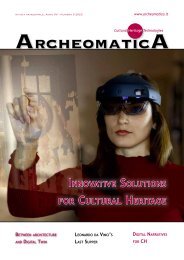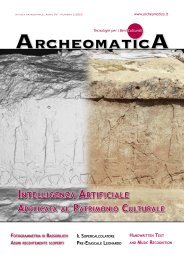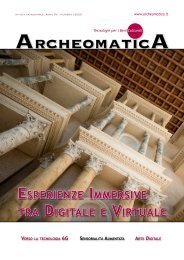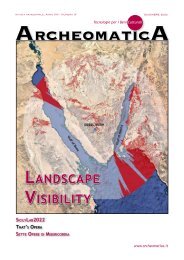GEOmedia_6_2020
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Rivista bimestrale - anno XXIV - Numero - 6/<strong>2020</strong> - Sped. in abb. postale 70% - Filiale di Roma<br />
TERRITORIO CARTOGRAFIA<br />
GIS<br />
CATASTO<br />
3D<br />
INFORMAZIONE GEOGRAFICA<br />
FOTOGRAMMETRIA<br />
URBANISTICA<br />
EDILIZIA<br />
GNSS<br />
BIM<br />
RILIEVO TOPOGRAFIA<br />
CAD<br />
REMOTE SENSING SPAZIO<br />
WEBGIS<br />
UAV<br />
SMART CITY<br />
AMBIENTE<br />
NETWORKS<br />
LiDAR<br />
BENI CULTURALI<br />
LBS<br />
Nov/Dic <strong>2020</strong> anno XXIV N°6<br />
TempesTe<br />
solari<br />
e sisTemi<br />
GNss<br />
IL TERZO INVENTARIO<br />
FORESTALE NAZIONALE<br />
MOBILE MAPPING<br />
CON ZEB HORIZON<br />
DISCRASIA ITALIANA NEL<br />
SETTORE GEODETICO
<strong>2020</strong> addio<br />
È stato un anno difficile, duro, sofferto: sia dal punto di vista umano che economico. Un anno<br />
che ha lasciato il segno in ognuno di noi. Fortunatamente, e grazie all’impegno di tutti, ci<br />
avviamo - quasi - ad intravvedere un possibile termine di questo periodo che ha letteralmente<br />
sconvolto il pianeta: oltre due milioni di morti secondo l’OMS dall’inizio della Pandemia. E con<br />
l’arrivo imminente della primavera, si respira un’aria nuova, fresca di speranza, almeno qui in<br />
Italia. Ed è proprio con questo anelito dentro di noi che abbiamo cominciato l’anno 2021: un<br />
ciclo che sembra prevedere enormi cambiamenti dal punto di vista economico con il digitale e<br />
la tecnologia (con tutti i loro annessi e connessi), sempre preponderanti nella nostra vita e che<br />
sono il perno centrale della quarta rivoluzione industriale, ormai penetrante più che imminente.<br />
La tecnologia sta ponendo le basi di quel progresso che non conosciamo ancora per tutti i suoi<br />
effetti e che sembra non volersi più arrestare, ma la cui storia è ancora da scrivere: un progresso<br />
che inevitabilmente impatta anche il mondo della Geomatica e che, anzi, si fonda anche su<br />
alcuni aspetti della Geomatica: basti pensare al posizionamento, alla cattura della realtà in 3D,<br />
ai GNSS e all’intelligenza artificiale. Una rivoluzione industriale che sta accelerando ancora,<br />
se possibile, il ritmo attuale dell’innovazione sul mercato, con nuovi trend ai quali è difficile<br />
stare dietro, soprattutto per i non giovanissimi. Una rivoluzione che, in un futuro peraltro non<br />
molto prossimo, tenderà sempre di più ad eliminare i confini tra sfera fisica, digitale e biologica,<br />
rendendo anche più complesso il codice etico e deontologico. Bisogna essere pronti, preparati,<br />
dotati di autocontrollo e di verifica dell’informazione, sapere stare al passo con i tempi e al passo<br />
di questa incessante dinamica che procede ininterrottamente, non senza una grammatica in<br />
evoluzione: pena diventare un oggetto di antiquariato depositato su un vecchio scaffale di un<br />
mercatino dell’usato di seconda categoria, prima di essere buttato in una discarica o acquistato<br />
da un nostalgico dei tempi andati, di orwelliana memoria. Vedremo cosa ci riserva il futuro nei<br />
termini della conservazione della specie e della crescita sostenibile.<br />
Torniamo a noi, al qui e ora, a <strong>GEOmedia</strong>. Apriamo l’ultimo numero del <strong>2020</strong> con un focus<br />
dedicato all’inventario forestale nazionale (INFC 2015), un'indagine che mira a quantificare<br />
e descrivere le risorse nazionali e i servizi ecosistemici sotto il profilo del loro contributo nel<br />
mitigare i cambiamenti climatici. Il lavoro è stato realizzato in collaborazione dall’Arma dei<br />
Carabinieri e dal CREA e si è concluso a fine <strong>2020</strong>. Ed è Simone Orlandini a parlarci invece<br />
del Rilievo di un pezzo piezometrico alla profondità di circa 30 metri, un lavoro complesso con<br />
un’alta difficoltà di acquisizione, in particolare per via delle superfici estremamente omogenee,<br />
fattore che ne ha reso quanto mai ardua l’acquisizione 3D, anche con un un sistema di mobile<br />
mapping portatile, noto per la sua versatilità.<br />
Attilio Selvini ritorna in questo numero sul tema della soppressione della Commissione geodetica<br />
italiana negli anni 70, dichiarata ente non utile con la legge del 20 Marzo 1975 n. 70 e soppressa<br />
due anni più tardi. Un articolo intenso, vivacemente mosso dal rammarico verso un’altra<br />
occasione perduta di un’azione organica volta a preservare, anche ecologicamente, il territorio<br />
da parte di una fonte istituzionale, referente a livello planetario. Ed è ancora Tiziana Primavera,<br />
con la sua rubrica sulle tecnologie di realtà aumentata e realtà virtuale, a riferire e delineare quali<br />
siano i nuovi trend mirati al mondo del lavoro: avatars e digital twin.<br />
Giorgio Franco Pocobelli, nella rubrica "L’aerofototeca nazionale racconta", ci parla della “lettura<br />
delle fotografie aeree in archeologia: tracce e false tracce”, un altro approfondimento o ‘case study’<br />
sulla falsariga del tema dell’osservazione della Terra, che chiude il numero con la rubrica di Marco<br />
Lisi dedicata allo stesso argomento, dove l’autore ci illustra come il comportamento del sole, o<br />
“space weather”, possa influenzare in vari modi l’andamento dei sistemi GNSS, tra i quali GPS e<br />
Galileo.<br />
Buona lettura,<br />
Valerio Carlucci
FOCUS<br />
iN quesTo<br />
Numero...<br />
foCus<br />
reporT<br />
Terra e spazio<br />
LE RUBRICHE<br />
18 MERCATO<br />
il Terzo iNveNTario<br />
foresTale NazioNale<br />
iTaliaNo iNfC 2015:<br />
proCedure, sTrumeNTi<br />
e appliCazioNi<br />
DI P. GASPARINI, A. FLORIS,<br />
M. RIZZO, A. PATRONE, L.<br />
CREDENTINO, G. PAPITTO,<br />
D. DI MARTINO<br />
6<br />
24 Immagine ESA<br />
34 AUGMENTED REALITY<br />
42 AEROFOTOTECA<br />
46 AGENDA<br />
26<br />
sisTema mobile<br />
mappiNG Geoslam<br />
zeb HorizoN per il<br />
rilievo di uN pozzo<br />
DI SIMONE ORLANDINI<br />
Il Sole fotografato a 304 angstrom<br />
dall'Atmospheric Imaging Assembly<br />
(AIA 304) del Solar Dynamics<br />
Observatory (SDO) della NASA.<br />
Questa è un'immagine in falsi colori<br />
del Sole osservata nella regione<br />
ultravioletta estrema dello spettro<br />
((Credits NASA)<br />
geomediaonline.it<br />
4 <strong>GEOmedia</strong> n°6-<strong>2020</strong><br />
<strong>GEOmedia</strong>, bimestrale, è la prima rivista italiana di geomatica.<br />
Da più di 20 anni pubblica argomenti collegati alle tecnologie dei<br />
processi di acquisizione, analisi e interpretazione dei dati,<br />
in particolare strumentali, relativi alla superficie terrestre.<br />
In questo settore <strong>GEOmedia</strong> affronta temi culturali e tecnologici<br />
per l’operatività degli addetti ai settori dei sistemi informativi<br />
geografici e del catasto, della fotogrammetria e cartografia,<br />
della geodesia e topografia, del telerilevamento aereo e<br />
spaziale, con un approccio tecnico-scientifico e divulgativo.
INSERZIONISTI<br />
3Dtarget 22<br />
30<br />
la disCrasia<br />
iTaliaNa Nel seTTore<br />
GeodeTiCo<br />
DI ATTILIO SELVINI<br />
Codevintec 23<br />
Epsilon 19<br />
ESRI 29<br />
Geomax 37<br />
GIS3W 17<br />
Gter 45<br />
Planetek Italia 48<br />
Sokkia 21<br />
Stonex 47<br />
<br />
Teorema 46<br />
il NosTro amiCo<br />
(?) sole<br />
DI MARCO LISI<br />
38<br />
PENISOLA DI BANKS<br />
(06 DICEMBRE <strong>2020</strong>)<br />
La missione Copernicus<br />
Sentinel-2 ci porta al di<br />
sopra della penisola di<br />
Banks, nell’Isola del Sud<br />
della Nuova Zelanda.<br />
La penisola di Banks, visibile<br />
nell’immagine in basso<br />
a destra, è formata da due<br />
vulcani estinti sovrapposti:<br />
il vulcano Lyttelton ed il<br />
vulcano Akaroa. La penisola<br />
ha avuto origine da numerose<br />
eruzioni vulcaniche<br />
avvenute circa otto milioni<br />
di anni or sono. Il nome<br />
della penisola si deve a sir.<br />
Joseph Banks, un biologo<br />
britannico che navigò con<br />
il capitano Cook.<br />
Fratture lungo le pareti del<br />
cratere hanno portato alla<br />
formazione di due rade<br />
lunghe e sottili: Lyttelton<br />
a nord ed Akaroa a sud.<br />
La penisola possiede anche<br />
molte altre piccole baie ed<br />
insenature, fatto che le conferisce<br />
un inusuale aspetto<br />
a forma di ruota dentata.<br />
Christchurch, la città più<br />
grande dell’Isola del Sud,<br />
è visibile immediatamente<br />
a nord della penisola di<br />
Banks. (Fonte: ESA)<br />
una pubblicazione<br />
Science & Technology Communication<br />
<strong>GEOmedia</strong>, la prima rivista italiana di geomatica.<br />
ISSN 1128-8132<br />
Reg. Trib. di Roma N° 243/2003 del 14.05.03<br />
Direttore<br />
RENZO CARLUCCI, direttore@rivistageomedia.it<br />
Comitato editoriale<br />
Vyron Antoniou, Fabrizio Bernardini, Mario Caporale,<br />
Roberto Capua, Luigi Colombo, Mattia Crespi, Luigi Di<br />
Prinzio, Michele Dussi, Michele Fasolo, Marco Lisi, Flavio<br />
Lupia, Luigi Mundula, Beniamino Murgante, Aldo Riggio,<br />
Mauro Salvemini, Attilio Selvini, Donato Tufillaro<br />
Direttore Responsabile<br />
FULVIO BERNARDINI, fbernardini@rivistageomedia.it<br />
Redazione<br />
VALERIO CARLUCCI, GIANLUCA PITITTO,<br />
redazione@rivistageomedia.it<br />
Diffusione e Amministrazione<br />
TATIANA IASILLO, diffusione@rivistageomedia.it<br />
Progetto grafico e impaginazione<br />
DANIELE CARLUCCI, dcarlucci@rivistageomedia.it<br />
Editore<br />
MediaGEO soc. coop.<br />
Via Palestro, 95 00185 Roma<br />
Tel. 06.64871209 - Fax. 06.62209510<br />
info@rivistageomedia.it<br />
Stampa: System Graphics Srl<br />
Via di Torre Santa Anastasia 61 00134 Roma<br />
Condizioni di abbonamento<br />
La quota annuale di abbonamento alla rivista Science è di € & 45,00. Technology Communication<br />
Il prezzo di ciascun fascicolo compreso nell’abbonamento è di € 9,00. Il prezzo di<br />
ciascun fascicolo arretrato è di € 12,00. I prezzi indicati si intendono Iva inclusa.<br />
L’editore, al fine di garantire la continuità del servizio, in mancanza di esplicita<br />
revoca, da comunicarsi in forma scritta entro il trimestre seguente alla scadenza<br />
dell’abbonamento, si riserva di inviare il periodico anche per il periodo successivo.<br />
La disdetta non è comunque valida se l’abbonato non è in regola con i pagamenti.<br />
Il rifiuto o la restituzione dei fascicoli della Rivista non costituiscono disdetta<br />
dell’abbonamento a nessun effetto. I fascicoli non pervenuti possono essere<br />
richiesti dall’abbonato non oltre 20 giorni dopo la ricezione del numero successivo.<br />
Gli articoli firmati impegnano solo la responsabilità dell’autore. È vietata la<br />
riproduzione anche parziale del contenuto di questo numero della Rivista in<br />
qualsiasi forma e con qualsiasi procedimento elettronico o meccanico, ivi inclusi i<br />
sistemi di archiviazione e prelievo dati, senza il consenso scritto dell’editore.<br />
Rivista fondata da Domenico Santarsiero.<br />
Numero chiuso in redazione il 28 febbraio 2021.
REPORT FOCUS<br />
Il terzo inventario forestale<br />
nazionale italiano INFC2015:<br />
procedure, strumenti e applicazioni<br />
di P. Gasparini, A. Floris, M. Rizzo, A. Patrone, L. Credentino, G. Papitto, D. Di Martino<br />
Fig. 1 - Alcune schermate di esempio dell’applicativo GeoInfo.<br />
L’inventario forestale<br />
nazionale è un’indagine<br />
che mira a quantificare<br />
e descrivere le risorse<br />
forestali del Paese e i<br />
servizi ecosistemici da<br />
esse forniti, e in particolare<br />
il loro contributo per la<br />
mitigazione dei cambiamenti<br />
climatici. La campagna di<br />
rilievi del terzo inventario<br />
forestale italiano (Inventario<br />
Nazionale delle Foreste e dei<br />
serbatoi forestali di Carbonio<br />
- INFC2015), realizzato<br />
dall’Arma dei Carabinieri<br />
e dal CREA, si è conclusa<br />
nei primi mesi del <strong>2020</strong>. Per<br />
la sua realizzazione sono<br />
stati sviluppati e messi a<br />
punto specifici processi<br />
di acquisizione dei dati,<br />
piattaforme e servizi WebGIS<br />
e un applicativo Android<br />
dedicato.<br />
L’<br />
L’indagine inventariale<br />
consiste nell’esecuzione<br />
di osservazioni e misure<br />
relative alle caratteristiche delle<br />
formazioni forestali, in corrispondenza<br />
di punti distribuiti<br />
sul territorio nazionale secondo<br />
un disegno che comprende tre<br />
fasi di campionamento. Per la<br />
prima fase sono impiegati oltre<br />
301.000 punti, localizzati<br />
secondo un reticolo a maglie<br />
quadrangolari di 1 km 2, che<br />
vengono classificati per il loro<br />
uso e copertura mediante fotointerpretazione<br />
di ortofoto digitali<br />
a colori e infrarosso-falso<br />
colore (Gasparini et al, 2014).<br />
La visualizzazione delle ortofoto<br />
avviene per mezzo del WebGis<br />
GeoInfo realizzato da AlmavivA<br />
SpA con la collaborazione di<br />
Telespazio (Figura 1). La classificazione<br />
dell’uso e della copertura<br />
del suolo segue regole<br />
di fotointerpretazione coerenti<br />
con le definizioni internazionali<br />
6 <strong>GEOmedia</strong> n°6-<strong>2020</strong>
FOCUS<br />
UNECE-FAO, che si basano<br />
sulle seguenti caratteristiche:<br />
la copertura delle chiome, che<br />
deve essere superiore a 10%,<br />
la dimensione dei poligoni<br />
boscati, che devono avere una<br />
superficie superiore al 0.5 ha<br />
e larghezza maggiore di 20 m,<br />
l’altezza potenziale dei soggetti<br />
arborei, almeno 5 m per le<br />
foreste, e infine l’uso prevalente<br />
forestale. Vengono così<br />
individuati i punti ricadenti<br />
in aree di interesse per l’inventario<br />
forestale, ossia i boschi e<br />
le altre terre boscate - boschi<br />
radi, boscaglie, arbusteti, che<br />
saranno oggetto dei rilievi nelle<br />
successive fasi di campionamento.<br />
Le fasi seconda e terza<br />
dell’inventario riguardano<br />
due sottoinsiemi dei punti di<br />
campionamento, costituiti rispettivamente<br />
da oltre 30,000<br />
e oltre 8,000 punti, e hanno lo<br />
scopo di raccogliere i dati necessari<br />
per stimare la superficie<br />
forestale e le sue ripartizioni<br />
e per quantificarne la consistenza<br />
in termini di numero<br />
di soggetti, volume legnoso e<br />
biomassa, suddivisi per specie<br />
e per dimensione. Durante la<br />
terza fase, inoltre, si raccolgono<br />
dati sul legno morto o necromassa<br />
(numero di elementi,<br />
tipo, dimensione, grado di<br />
decomposizione) e sugli strati<br />
inferiori di vegetazione (rinnovazione<br />
e arbusti). La stima<br />
della biomassa presente, viva e<br />
morta, consente di quantificare<br />
il carbonio accumulato nei<br />
tessuti vegetali e nel suolo, al<br />
fine di misurare l’azione di mitigazione<br />
dei cambiamenti climatici<br />
dovuta all’assorbimento<br />
e immobilizzazione del carbonio<br />
atmosferico da parte delle<br />
formazioni forestali. Con l’inventario<br />
viene inoltre misurato<br />
l’accrescimento delle foreste<br />
attraverso il prelievo di campioni<br />
incrementali (carote)<br />
dagli alberi presenti nell’area<br />
di saggio, su cui si misura lo<br />
spessore degli ultimi anelli. Da<br />
queste misure si deriva quindi<br />
l’incremento annuo di volume<br />
e di biomassa; il primo, confrontato<br />
con il prelievo annuo<br />
di legna e legname, consente<br />
di valutare la sostenibilità della<br />
gestione forestale; il secondo<br />
consente di stimare l’assorbimento<br />
annuo di anidride<br />
carbonica, il principale gas ad<br />
effetto serra, dall’atmosfera. Le<br />
osservazioni e misure realizzate<br />
in seconda e terza fase vengono<br />
eseguite in aree di saggio<br />
di dimensione variabile, con<br />
centro nel punto inventariale.<br />
I caratteri qualitativi (tipo di<br />
vegetazione, stadio di sviluppo,<br />
modalità di gestione, ecc.)<br />
vengono osservati su un intorno<br />
di forma circolare con raggio<br />
25 m; le misure (diametro<br />
e altezza degli alberi, incremento<br />
diametrico, diametro<br />
e lunghezza delle porzioni di<br />
legno morto, numero di soggetti<br />
della rinnovazione, ecc.)<br />
riguardano i soggetti ricadenti<br />
in aree circolari con raggio 13<br />
m, 4 m e 2 m (Gasparini et al,<br />
2016).<br />
Il terzo inventario forestale<br />
nazionale è realizzato dal<br />
Comando Carabinieri per<br />
la Tutela della Biodiversità<br />
e dei Parchi - Comando<br />
Unità Forestali, Ambientali<br />
e Agroalimentari Carabinieri<br />
(CUFAA) in collaborazione<br />
con le Regioni e Province autonome,<br />
con il supporto scientifico<br />
e tecnico del Centro di<br />
Ricerca Foreste e Legno del<br />
CREA, la cui sede di Trento<br />
ha contribuito alla realizzazione<br />
dei due precedenti inventari<br />
forestali nazionali IFNI85<br />
e INFC2005 (MAF-ISAFA,<br />
1988; Gasparini P., Tabacchi<br />
G. a cura di, 2011) insieme al<br />
Corpo Forestale dello Stato.<br />
I rilievi in campo relativi alle<br />
fasi seconda e terza dell’inven-<br />
tario, eseguiti contestualmente<br />
anziché in due momenti distinti<br />
come per l’INFC2005, sono<br />
stati avviati nell’autunno 2017<br />
e si sono conclusi nei primi<br />
mesi del <strong>2020</strong>.<br />
Localizzazione e posizionamento<br />
al suolo dei punti<br />
inventariali mediante GNSS<br />
La maggior parte dei punti<br />
inventariali da rilevare, circa il<br />
90%, è costituita da punti rilevati<br />
in campo nel precedente<br />
inventario forestale nazionale<br />
INFC2005, materializzati con<br />
picchetti di tipo permanente<br />
o semi-permanente a seconda<br />
che si trattasse di punti di fase<br />
3 oppure di fase 2 e corredati<br />
di monografie descrittive e<br />
fotografiche. Per tali punti si<br />
dispone sia delle coordinate<br />
“teoriche” derivanti dal piano<br />
di campionamento, sia delle<br />
coordinate “di campo” rilevate<br />
con GPS in INFC2005. Per<br />
tali coordinate l’incertezza di<br />
posizionamento è di 3-4 m<br />
(Colle et al., 2007). Per questa<br />
tipologia di punti l’obiettivo è<br />
il ritrovamento del picchetto<br />
che individua il punto stesso e<br />
il centro delle aree di saggio. I<br />
picchetti sono completamente<br />
interrati e le aree di saggio in<br />
bosco sono in condizione di<br />
completo anonimato visivo per<br />
i non addetti ai lavori che non<br />
Fig. 2 - Picchetto permanente di un punto di<br />
campionamento INFC.<br />
<strong>GEOmedia</strong> n°6-<strong>2020</strong> 7
FOCUS<br />
testuali, cartografia tecnica,<br />
ortofoto, altre fotografie) informatizzata<br />
nella precedente<br />
campagna inventariale è a<br />
disposizione dei rilevatori per<br />
pianificare il percorso di avvicinamento,<br />
in auto e a piedi,<br />
al punto da rilevare. Terrasync<br />
fornisce all’operatore la distanza<br />
e l’azimut verso il punto da raggiungere,<br />
costantemente aggiornati<br />
ad ogni nuova posizione<br />
acquisita. In ambienti forestali<br />
questo tipo di navigazione fornisce<br />
dati instabili e incerti con<br />
l’avvicinarsi al punto obiettivo,<br />
mostrandosi poco o per nulla<br />
idonea al reperimento di precisione<br />
di un picchetto interrato<br />
e non visibile. Per tale motivo<br />
essa viene sostituita, quando l’operatore<br />
si trova a 10-15 m dalla<br />
posizione presunta del punto<br />
obiettivo, da una navigazione<br />
da posizione media (NPM)<br />
(INFC, 2004). Essa consiste in<br />
un posizionamento stazionario,<br />
con media di 50 posizioni<br />
istantanee, in un punto con<br />
buone condizioni di ricezione<br />
del segnale scelto discrezionalmente<br />
dall’operatore (punto<br />
F o punto di fine navigazione<br />
istantanea), e nel successivo<br />
calcolo delle coordinate polari<br />
(distanza e azimut) da materializzarsi<br />
sul terreno per raggiungere<br />
il punto obiettivo della<br />
navigazione (punto C o punto<br />
di campionamento). In questo<br />
modo l’area d’incertezza entro<br />
la quale ricercare il picchetto interrato,<br />
con l’ausilio di un metal<br />
detector, viene ridotta notevolmente.<br />
Le misure di azimut e<br />
distanza vengono eseguite con<br />
clino-bussola Suunto Tandem<br />
e distanziometro-ipsometro a<br />
ultrasuoni Haglof Vertex, strumenti<br />
particolarmente adatti<br />
all’utilizzo in aree boscate e<br />
che vengono utilizzati anche<br />
in diverse altre fasi del rilievo<br />
inventariale, quali ad esempio la<br />
determinazione dei limiti dell’adispongano<br />
della documentazione<br />
monografica, allo scopo<br />
di evitare disturbi e preservare<br />
la rappresentatività dei punti di<br />
campionamento (Figura 2). Il<br />
restante 10% circa di punti da<br />
rilevare proviene dal campione<br />
INFC2015 di fase 1; si tratta<br />
quindi di punti non localizzati<br />
in campo in precedenza, e per<br />
i quali si dispone delle sole<br />
coordinate teoriche. Per essi<br />
l’obiettivo è il raggiungimento<br />
in campo di tali coordinate<br />
teoriche e un posizionamento<br />
ex-novo ad elevata accuratezza<br />
che, unito alla marcatura con<br />
picchetto interrato e alla monografia<br />
del punto, ne consenta il<br />
ritrovamento in future campagne<br />
inventariali. In tutte le fasi<br />
di navigazione verso punti prestabiliti<br />
e nei nuovi posizionamenti<br />
il sistema di riferimento<br />
adottato è UTM (zone 32 o 33)<br />
su datum WGS84. Le quote<br />
sono riferite al livello del mare<br />
(geoide ITALGEO2005).<br />
In INFC2005 l’equipaggiamento<br />
strumentale delle squadre<br />
di rilevamento era tecnologicamente<br />
avanzato, sia nelle<br />
componenti destinate a navigazione<br />
e posizionamento, sia in<br />
quelle dedicate ai rilievi forestali<br />
veri e propri e alla trasmissione<br />
telematica dei dati rilevati<br />
(Muscaritoli et al, 2004). Gli<br />
anni trascorsi tra il secondo<br />
e il terzo inventario forestale<br />
nazionale hanno reso comunque<br />
necessaria una profonda<br />
rivisitazione della dotazione<br />
strumentale, sia per naturale obsolescenza<br />
delle apparecchiature<br />
utilizzate negli anni 2004-2006,<br />
sia per fruire dei significativi<br />
miglioramenti tecnologici intervenuti<br />
in questo lasso di tempo.<br />
In questo processo si è però<br />
voluto adottare un principio di<br />
“efficientamento” delle risorse<br />
già disponibili, impiegando al<br />
meglio una serie di strumenti<br />
già in possesso del personale<br />
CUFAA, e di contenimento dei<br />
costi necessari all’acquisizione<br />
di nuova strumentazione. Il<br />
risultato è una configurazione<br />
strumentale i cui fulcri sono un<br />
ricevitore GNSS Trimble R1<br />
pilotato via bluetooth da un datalogger<br />
Trimble Juno SB, e un<br />
tablet Samsung Galaxy A6, che<br />
a sua volta dialoga con il Juno<br />
SB per il trasferimento dei dati<br />
di navigazione (Figura 3). Una<br />
volta terminate le fasi di avvicinamento<br />
al punto, ritrovamento<br />
del picchetto e aggiornamento<br />
della sua posizione, tutti i successivi<br />
rilievi inventariali vengono<br />
effettuati tramite l’applicazione<br />
INFC_APP residente nel<br />
Galaxy A6. La scelta di utilizzare<br />
un ricevitore GNSS Trimble<br />
R1 è stata presa dopo averne<br />
verificato le prestazioni, in termini<br />
di accuratezza, affidabilità<br />
e operatività, tramite una serie<br />
di prove effettuate nell’area test<br />
di Feudozzo istituita con il progetto<br />
Targetstars (Pompei et al.,<br />
2009); il ricevitore, utilizzando<br />
più costellazioni GNSS (GPS,<br />
GLONASS, Beidou, EGNOS-<br />
Galileo) ha ottime capacità di<br />
ricezione anche in ambienti<br />
orograficamente svantaggiati<br />
e a elevata copertura arborea,<br />
con prestazioni in termini di<br />
accuratezza adeguate alle esigenze<br />
di progetto. La gestione dei<br />
rilievi con il software Trimble<br />
Terrasync consente il salvataggio<br />
di tutte le misure grezze<br />
che conducono al calcolo delle<br />
coordinate, con possibilità di<br />
correzione differenziale in post<br />
processing e successivi controlli<br />
di qualità sui posizionamenti.<br />
La prima fase di avvicinamento<br />
al punto di campionamento,<br />
comune a tutte le tipologie di<br />
punto, è detta navigazione da<br />
posizione istantanea (NPI), e<br />
viene svolta avvalendosi delle<br />
funzionalità standard del software<br />
Terrasync. La documentazione<br />
monografica (descrizioni<br />
8 <strong>GEOmedia</strong> n°6-<strong>2020</strong>
FOCUS<br />
rea di saggio e la misura delle<br />
altezze degli alberi.<br />
Nei rilievi svolti per<br />
l’INFC2015 i tempi di attesa<br />
per ottenere idonee ricezioni<br />
del segnale radio GNSS sono<br />
stati molto contenuti (da pochi<br />
secondi a qualche minuto nei<br />
casi più problematici), come<br />
pure sono state pochissime le<br />
occorrenze di mancato ritrovamento<br />
del picchetto interrato<br />
non dovute a effettivo cambiamento<br />
nell’uso del suolo. La<br />
Tabella 1 riporta i dati relativi<br />
al ritrovamento dei picchetti,<br />
provvisori o permanenti, collocati<br />
nei punti F e C in occasione<br />
dei rilievi INFC2005. Si<br />
osserva che i picchetti originari<br />
di F e C sono stati ritrovati in<br />
una percentuale elevata di punti<br />
inventariali (rispettivamente nel<br />
86.6% e 87.1% dei casi a livello<br />
nazionale), con differenze regionali<br />
che vanno da percentuali<br />
di ritrovamento molto elevate,<br />
superiori al 90%, per Valle<br />
d’Aosta, Alto Adige, Liguria,<br />
Lazio, Abruzzo e Sardegna, a<br />
percentuali di poco inferiori a<br />
80% per Piemonte, Calabria e<br />
Sicilia. Il mancato ritrovamento<br />
sia del picchetto di F sia di<br />
quello di C si è verificato in una<br />
percentuale di casi pari a 7.0%<br />
su scala nazionale. Le regioni<br />
con minore incidenza di questi<br />
casi (meno di 4.0%) sono Valle<br />
d’Aosta, Alto Adige, Trentino,<br />
Liguria, Lazio e Abruzzo. I fattori<br />
che possono avere influito<br />
sui diversi risultati regionali<br />
sono molteplici: le condizioni<br />
della vegetazione e orografiche<br />
delle diverse aree, il tempo trascorso<br />
tra le due campagne di<br />
rilevamento e il tipo di marcatura<br />
(provvisoria o permanente<br />
a seconda che si tratti di punti<br />
di fase 2 o 3), la quota di punti<br />
di fase 2 e 3 assegnata alle diverse<br />
regioni e, non da ultimo,<br />
il funzionamento del metal<br />
detector, che si è rivelato non<br />
omogeneo per tutte le squadre e<br />
le regioni.<br />
Un applicativo Android<br />
per l’acquisizione dei dati<br />
in campo<br />
L’applicazione INFC_APP è<br />
stata sviluppata da AlmavivA<br />
SpA sulla base delle indicazioni<br />
e con la collaborazione del<br />
personale del Centro Foreste e<br />
Legno del CREA. Per garantire<br />
la riservatezza dei dati durante<br />
la campagna di rilievo, INFC_<br />
APP è stata installata esclusivamente<br />
sui tablet a disposizione<br />
delle squadre di rilevatori e<br />
del personale del CREA, il cui<br />
codice IMEI era stato inserito<br />
in una lista di dispositivi autorizzati.<br />
Le principali fasi che hanno<br />
portato allo sviluppo di INFC_<br />
APP si possono riassumere nei<br />
punti di seguito descritti.<br />
i) Descrizione delle esigenze<br />
informatiche: durante la<br />
prima fase di progettazione di<br />
INFC_APP sono stati redatti<br />
diversi documenti contenenti<br />
le informazioni necessarie alla<br />
progettazione dell’applicativo,<br />
in particolare: l’elenco degli<br />
attributi da rilevare; i tracciati<br />
record del database con il formato<br />
dei relativi campi; le codifiche<br />
per gli attributi qualitativi;<br />
i range di valori ammessi per gli<br />
attributi quantitativi; le regole<br />
per la compilazione e per i controlli<br />
incrociati tra campi.<br />
ii) Analisi e valutazione delle<br />
tecnologie disponibili: per lo<br />
sviluppo del software applicativo<br />
è stato scelto di utilizzare<br />
il sistema operativo Android<br />
6.0, l’ultima versione disponibile<br />
durante l’implementazione<br />
dell’app, seguendo lo standard<br />
Material Design per le interfacce,<br />
che introduce nuovi componenti<br />
grafici e animazioni<br />
garantendo una navigazione<br />
più semplice e fluida tra i vari<br />
layout.<br />
iii) Progettazione architetturale<br />
e realizzazione dell’applicazione:<br />
uno dei requisiti<br />
fondamentali richiesti è stato<br />
Fig. 3 - Strumentazione informatica per la raccolta e l’archiviazione dei dati di campo.<br />
<strong>GEOmedia</strong> n°6-<strong>2020</strong> 9
FOCUS<br />
Regione<br />
Numero<br />
punti<br />
totali<br />
Numero punti con<br />
picchetto (accessibili,<br />
forestali, di fase 2 o 3<br />
per INFC2005)<br />
Ritrovamento<br />
del picchetto<br />
di C<br />
Ritrovamento<br />
del picchetto<br />
di F<br />
Mancato<br />
ritrovamento<br />
dei picchetti di<br />
F e C<br />
Piemonte 782 624 83.0% 79.5% 9.0%<br />
Valle d’Aosta 124 113 94.7% 100.0% 0.0%<br />
Lombardia 484 391 85.2% 82.4% 8.7%<br />
Alto Adige 316 294 95.2% 96.6% 1.7%<br />
Trentino 325 307 89.9% 90.2% 3.9%<br />
Veneto 373 324 92.0% 89.8% 5.6%<br />
Friuli-Venezia<br />
Giulia<br />
314 277 89.5% 86.6% 8.3%<br />
Liguria 340 297 92.9% 96.6% 1.0%<br />
Emilia-Romagna 537 426 81.5% 83.6% 10.6%<br />
Toscana 768 642 80.7% 85.2% 10.7%<br />
Umbria 369 309 92.2% 81.2% 6.1%<br />
Marche 292 256 91.0% 89.1% 4.7%<br />
Lazio 475 360 95.8% 93.9% 1.7%<br />
Abruzzo 382 322 94.7% 94.1% 3.1%<br />
Molise 171 144 84.0% 86.8% 8.3%<br />
Campania 363 287 86.8% 81.2% 7.7%<br />
Puglia 230 179 87.7% 81.6% 5.0%<br />
Basilicata 304 244 85.2% 84.4% 11.5%<br />
Calabria 440 310 76.5% 70.0% 15.5%<br />
Sicilia 403 271 73.4% 86.7% 9.6%<br />
Sardegna 666 544 90.3% 91.4% 4.6%<br />
ITALIA 8458 6921 87.1% 86.6% 7.0%<br />
Tab. 1 – Statistiche relative al ritrovamento dei picchetti, riferite ai punti di fase 2 e fase 3 INFC2005 (con picchetti sia provvisori, sia permanenti).<br />
quello di creare un’applicazione<br />
il più possibile user-friendly,<br />
ma nello stesso tempo completa<br />
di tutte le funzionalità necessarie<br />
a questo tipo di indagine.<br />
L’interfaccia utente dell’applicativo<br />
è stata quindi realizzata<br />
attraverso un sistema di sezioni<br />
e maschere che guidano il rilevatore<br />
nello svolgimento logico<br />
e cronologico delle diverse fasi<br />
di rilievo e inserimento dei dati,<br />
dalla procedura di navigazione<br />
e posizionamento del punto<br />
di campionamento fino alla<br />
raccolta dei dati sugli attributi<br />
qualitativi e quantitativi. È possibile<br />
spostarsi liberamente tra<br />
le varie sezioni dell’applicativo,<br />
con il vincolo che per salvare i<br />
dati inseriti in una specifica sezione<br />
è necessaria una esplicita<br />
conferma. Dalla home screen<br />
è possibile inoltre consultare la<br />
documentazione di supporto<br />
(manualistica, istruzioni per l’uso<br />
degli strumenti, ecc.) senza<br />
uscire dall’applicativo (Figura<br />
4).<br />
Le maschere sono di due diversi<br />
tipi: il primo è rappresentato<br />
da moduli di input dei dati, il<br />
secondo è il risultato di query<br />
di riepilogo dei dati già inseriti,<br />
visualizzabili sia all’interno di<br />
ogni singola sezione sia nella<br />
home screen, facilitando così<br />
il controllo delle operazioni di<br />
raccolta dei dati da parte del<br />
rilevatore.<br />
Al fine di ottimizzare e semplificare<br />
le operazioni di inserimento<br />
degli attributi qualitativi<br />
sono state create maschere con<br />
campi aventi valori selezionabili<br />
da menu a tendina con una<br />
lista delle sole modalità possibili.<br />
In base al tipo di attributo<br />
da rilevare, inoltre, sono state<br />
create anche combinazioni di<br />
maschere e sotto-maschere per<br />
l’inserimento di dati a dettaglio<br />
progressivamente superiore<br />
(Figura 5a e 5b). Per garantire<br />
un controllo automatico dei<br />
dati in termini di plausibilità,<br />
coerenza e completezza già nella<br />
fase di raccolta, l’applicativo è<br />
stato sviluppato integrando precise<br />
regole per la compilazione<br />
e per i controlli incrociati tra<br />
campi, che consentono di impedire<br />
eventuali dimenticanze<br />
o l’inserimento di valori fuori<br />
scala (Figura 6).<br />
iv) Test del prototipo: ciascuna<br />
10 <strong>GEOmedia</strong> n°6-<strong>2020</strong>
FOCUS<br />
delle versioni dell’applicativo<br />
prodotte durante la fase di realizzazione<br />
è stata testata dal personale<br />
INFC del CREA, sia in<br />
ufficio sia in campo, attraverso<br />
l’esecuzione di stress test finalizzati<br />
a verificarne la stabilità e il<br />
buon funzionamento ed evidenziarne<br />
eventuali anomalie.<br />
Servizi web per<br />
l’organizzazione logistica e<br />
il monitoraggio dei rilievi<br />
Lo scambio di informazioni<br />
tra dispositivo tablet e server<br />
centrale avviene tramite web<br />
service SOAP (Simple Object<br />
Access Protocol) appositamente<br />
sviluppato per l’INFC2015.<br />
La scelta del protocollo SOAP<br />
è stata dettata dalla necessità<br />
di trasferire oltre a dati alfanumerici<br />
anche dati binari, nello<br />
specifico il file ssf, contenente<br />
attributi relativi alla navigazione<br />
eseguita dalle squadre per raggiungere<br />
il punto da rilevare.<br />
Si tratta di servizi sincroni richiesta<br />
- risposta, in particolare<br />
il client (il tablet in dotazione<br />
alle squadre) invia una richiesta<br />
e resta in attesa di una risposta<br />
del server. Sono stati implementati<br />
quattro servizi web per la<br />
ricerca, il download, l’upload e<br />
l’aggiornamento dello stato dei<br />
punti, fondamentale per la distinzione<br />
tra i punti da rilevare,<br />
in lavorazione oppure conclusi<br />
(Figura 7). Il web service per la<br />
ricerca riceve in input il codice<br />
IMEI del tablet ed invia al dispositivo<br />
in risposta la lista dei<br />
punti assegnati alle squadre,<br />
tramite opportuna funzione<br />
web. A questo punto le squadre<br />
possono scaricare sul proprio tablet<br />
tutti gli attributi precaricati<br />
del punto da rilevare, come le<br />
coordinate e alcuni dati del precedente<br />
inventario per i punti<br />
già visitati durante la campagna<br />
INFC2005. Se la procedura<br />
si conclude correttamente il<br />
tablet invoca automaticamente<br />
il servizio che modifica lo<br />
stato del punto, portandolo da<br />
“assegnato” a “in lavorazione”,<br />
escludendolo in questo modo<br />
dalla lista dei punti da scaricare<br />
sui dispositivi. La scelta di separare<br />
le operazioni di download<br />
e di aggiornamento assicura che<br />
la base dati centrale sia allineata<br />
anche in caso di un malfunzionamento<br />
durante la fase di<br />
caricamento dati sul dispositivo<br />
Android. A conclusione del<br />
rilievo, le squadre invocando<br />
il servizio per l’upload dei dati<br />
inviano tutti i dati raccolti al<br />
database centrale, mettendoli<br />
a disposizione del personale<br />
INFC del CREA. Ai fini del<br />
monitoraggio dell’inventario,<br />
in un’area riservata accessibile<br />
con un’opportuna autenticazione,<br />
sono state implementate<br />
funzioni con le API di Google,<br />
per la visualizzazione su mappa<br />
e su pie chart dei siti del rilievo<br />
e relativo stato, consentendo in<br />
questo modo agli attori coinvolti,<br />
in base ai rispettivi ruoli, di<br />
avere rapidamente un’istantanea<br />
sull’andamento dell’inventario.<br />
Archiviazione e flusso dei dati<br />
Il passaggio da due fasi di campagna<br />
ad un’unica fase, in cui<br />
vengono rilevati contemporaneamente<br />
dati geografici e informazioni<br />
sia di tipo qualitativo<br />
che quantitativo, ha reso necessaria<br />
la progettazione di un database<br />
articolato, per le relazioni<br />
tra tabelle e la natura eteroge-<br />
4 - Schema dell’architettura della INFC_APP, con lista delle funzioni disponibili, macro-sezioni e<br />
rispettive sottosezioni.<br />
<strong>GEOmedia</strong> n°6-<strong>2020</strong> 11
FOCUS<br />
nea dei dati. La realizzazione<br />
della struttura del database è<br />
stata effettuata congiuntamente<br />
da CREA e AlmavivA SpA, che<br />
ne cura anche l’aggiornamento<br />
e la manutenzione.<br />
Per l’archiviazione dei dati è<br />
stato allestito un server fisico,<br />
opportunamente dimensionato<br />
e dotato dei requisiti di sicurezza.<br />
L’accesso al server centrale<br />
avviene tramite autenticazione e<br />
protocolli di protezione variabili<br />
in relazione alla qualifica e al<br />
ruolo dell’utente. Nella fattispecie<br />
sono stati individuati quattro<br />
profili associati a corrispondenti<br />
specifici ruoli preordinati.<br />
Il monitoraggio e l’andamento<br />
dei flussi lavorativi a livello<br />
nazionale è demandato al ruolo<br />
del Coordinatore Centrale,<br />
che è appannaggio dei funzionari<br />
del Comando per la<br />
Tutela della Biodiversità e dei<br />
Parchi - Ufficio Studi e Progetti<br />
del CUFAA dell’Arma dei<br />
Carabinieri. Il Coordinatore<br />
Centrale può consultare l’andamento<br />
delle lavorazioni a livello<br />
nazionale e a livello regionale e<br />
provinciale (punti aperti, punti<br />
assegnati, punti in lavorazione,<br />
punti chiusi); inoltre, su<br />
richiesta del CREA e in particolari<br />
condizioni, può agire per<br />
assegnare il punto ad un’altra<br />
squadra o in casi eccezionali<br />
riaprire un punto precedentemente<br />
chiuso. Al Coordinatore<br />
Centrale è anche demandata<br />
l’attività, condivisa con il<br />
Coordinatore Regionale, di<br />
gestione, all’interno della piattaforma<br />
web, dei componenti<br />
delle squadre e della registrazione<br />
in associazione del numero<br />
di codice IMEI del tablet in<br />
dotazione ad ogni singola squadra,<br />
conditio sine qua non per<br />
procedere al corretto utilizzo<br />
dell’applicazione di campo.<br />
Il Coordinatore Regionale è<br />
rappresentato dal referente<br />
regionale INFC del CUFAA e<br />
Fig 5 - Alcune viste di esempio delle sezioni Navigazione, Dati Qualitativi (a) e Dati Quantitativi (b).<br />
delle Regioni a statuto speciale<br />
e delle Province autonome, uno<br />
per ogni Regione e per ciascuna<br />
delle Province autonome, che<br />
coordina il lavoro delle squadre<br />
della propria regione. Egli può<br />
agire nell’ambito delle specifiche<br />
competenze territoriali:<br />
oltre alla consultazione dell’andamento<br />
lavorativo, assegna<br />
i punti alle singole squadre e<br />
può, nei casi che lo richiedano,<br />
riassegnare il punto ad altra<br />
squadra.<br />
Un altro importante profilo è<br />
quello del Capo Squadra che,<br />
Fig. 6 - Alcune viste di esempio di controlli di plausibilità, coerenza, completezza.<br />
12 <strong>GEOmedia</strong> n°6-<strong>2020</strong>
FOCUS<br />
attraverso le funzionalità messe<br />
a disposizione nella piattaforma<br />
web, pianifica le operazioni per<br />
l’avvio dei sopralluoghi in campo.<br />
All’utente Capo Squadra,<br />
così come per i precedenti ruoli,<br />
viene messo a disposizione<br />
anche l’applicativo GeoInfo<br />
per avere la disponibilità delle<br />
ortofoto e degli oggetti grafici<br />
di riferimento dimensionale<br />
sovrapposti in trasparenza su<br />
ogni punto, utilizzati nella fase<br />
precedente per le attività di fotointerpretazione<br />
(Gasparini et<br />
al, 2014). Per INFC2015 sono<br />
stati attivati 54 profili di Capo<br />
Squadra, corrispondenti ad altrettante<br />
squadre composte da<br />
2-4 rilevatori ciascuna.<br />
L’utente Coordinatore CREA,<br />
oltre al monitoraggio dell’andamento<br />
nazionale e alle funzionalità<br />
di riapertura dei punti,<br />
procede con le funzionalità di<br />
estrazione dei dati dei punti lavorati<br />
e dei file ssf.<br />
Ogni ruolo ha a disposizione,<br />
nella piattaforma web, le funzioni<br />
di consultazione della documentazione<br />
tecnica e dei manuali<br />
e linee guida da utilizzare<br />
come pronto riferimento.<br />
Il database Oracle 10g relazionale<br />
del server centrale è composto<br />
da un totale di 27 tabelle<br />
(circa 280 campi), collegate tra<br />
loro tramite una chiave primaria<br />
(identificativo del punto). Lato<br />
client (tablet) il database è stato<br />
implementato tramite la libreria<br />
Sqlite. I campi riguardano<br />
sia le informazioni precaricate,<br />
derivanti dai rilievi INFC2005,<br />
sia i nuovi dati della campagna<br />
INFC2015.<br />
La trasmissione delle informazioni<br />
da e verso il server centrale<br />
avviene attraverso funzionalità<br />
specifiche, implementate<br />
nell’applicativo di campo, da<br />
eseguire mediante la connessione<br />
internet direttamente dal<br />
tablet (con scheda 4G) per il<br />
progressivo popolamento della<br />
banca dati inventariale. La pro-<br />
Fig. 7 - Schermata di esempio della funzionalità web per l’assegnazione dei punti di campionamento alle squadre di rilevatori.<br />
<strong>GEOmedia</strong> n°6-<strong>2020</strong> 13
FOCUS<br />
Fig. 9 – Attività<br />
svolte durante gli<br />
start-up eseguiti in<br />
tutte le regioni.<br />
Fig. 8 – Lezione in aula<br />
ed esercitazioni in bosco<br />
durante i corsi di addestramento<br />
ai rilievi.<br />
cedura software di trasferimento<br />
via internet prevede un primo<br />
download sul tablet dei dati di<br />
partenza, necessari per l’avvio<br />
dei rilievi, e successivi upload<br />
al server centrale, come backup<br />
parziali o per il trasferimento<br />
finale dei dati, a conclusione<br />
dei rilievi. Per alcuni campi (es.<br />
lettura carote incrementali), è<br />
prevista la possibilità di completamento<br />
dell’inserimento dati<br />
in ufficio, successivamente ai<br />
rilievi in campo.<br />
Formazione dei rilevatori,<br />
start-up e assistenza in remoto<br />
Le squadre di rilevatori hanno<br />
ricevuto opportuna formazione<br />
per mezzo di corsi residenziali,<br />
con lezioni teoriche ed esercitazioni<br />
pratiche in bosco (Figura<br />
8). Oltre alla manualistica tradizionale,<br />
in formato cartaceo ed<br />
elettronico, i rilevatori hanno<br />
potuto accedere ad una piattaforma<br />
di e-learning via Web,<br />
per approfondire contenuti e<br />
procedure appresi durante la<br />
formazione. All’avvio dei rilievi<br />
è stato effettuato dallo staff<br />
tecnico-scientifico del CREA<br />
Foreste e Legno di Trento uno<br />
start-up in ciascuna regione,<br />
consistente in un rilievo completo<br />
di uno o più punti di<br />
campionamento, congiuntamente<br />
con le squadre di rilevatori<br />
e alla presenza del referente<br />
regionale (Figura 9). È stata<br />
inoltre attivata una struttura di<br />
assistenza a distanza per i rilevatori,<br />
operante tutti i giorni lavorativi<br />
a mezzo telefono o email<br />
e supportata da un software di<br />
ticketing su local server, per la<br />
gestione e l’archiviazione degli<br />
interventi di assistenza, molto<br />
utile per l’armonizzazione delle<br />
indicazioni fornite e per la documentazione<br />
dell’attività svolta<br />
(Figura 10).<br />
Conclusioni<br />
La campagna inventariale<br />
appena conclusa rappresenta<br />
un caso di studio importante,<br />
poiché coinvolge un numero<br />
molto elevato di rilevatori, oltre<br />
150, distribuiti su tutto il<br />
territorio nazionale e operanti<br />
in condizioni ambientali molto<br />
diverse e spesso critiche. Essa<br />
rappresenta, a livello nazionale,<br />
la fonte di dati più importante<br />
sulle foreste, che coprono oltre<br />
un terzo del territorio del Paese.<br />
Durante i rilievi è necessario<br />
assicurare un continuo scambio<br />
di dati tra soggetti con ruoli<br />
differenziati, dislocati in sedi<br />
ed enti diversi: i rilevatori, i<br />
referenti regionali e il personale<br />
dell’Ufficio Studi e Progetti<br />
del Comando per la Tutela<br />
della Biodiversità e dei Parchi<br />
dell’Arma dei Carabinieri; i rile-<br />
14 <strong>GEOmedia</strong> n°6-<strong>2020</strong>
FOCUS<br />
vatori e i referenti delle Regioni<br />
e Province autonome; i ricercatori<br />
e tecnici del Centro Foreste<br />
e Legno del CREA di Trento;<br />
gli sviluppatori e i tecnici di<br />
AlmavivA SpA.<br />
La dotazione tecnologica individuata<br />
e i software sviluppati<br />
hanno consentito di integrare<br />
efficacemente dati di carattere<br />
geografico e dati alfanumerici<br />
e numerici relativi ai caratteri<br />
qualitativi e quantitativi delle<br />
foreste. A conclusione della<br />
campagna di rilevamento al<br />
suolo, si può affermare che la<br />
soluzione adottata per l’acquisizione<br />
dei dati, rappresentata<br />
da un applicativo Android<br />
installato su un tablet con caratteristiche<br />
non specifiche per<br />
rilievi in bosco, si è dimostrata<br />
pienamente idonea allo scopo.<br />
Sono stati molto rari, infatti,<br />
i casi di rottura del tablet o di<br />
malfunzionamento dell’applicativo,<br />
nonostante la varietà di<br />
situazioni in cui hanno operato<br />
le squadre (condizioni climatiche<br />
avverse, basse temperature,<br />
ecc.). Inoltre, il tablet consente<br />
di archiviare molti altri dati utili<br />
per i rilievi quali porzioni di ortofoto<br />
e mappe, le monografie<br />
per il ritrovamento dei punti<br />
compilate nei rilievi precedenti,<br />
le foto scattate durante i rilievi<br />
precedenti e quelli in corso, e di<br />
visualizzarli a una scala opportuna<br />
per un’agevole lettura in<br />
campo.<br />
La scelta di una configurazione<br />
tecnologica articolata in più<br />
strumenti separati, apparentemente<br />
meno razionale rispetto<br />
all’uso di un solo strumento<br />
dotato di tutte le funzionalità<br />
necessarie, ha consentito da<br />
un lato di utilizzare hardware<br />
(datalogger Juno) e software<br />
(Terrasync) già in possesso del<br />
CUFAA, e potrà consentire in<br />
futuro una scalabilità tecnologica<br />
selettiva, aggiornando e sostituendo<br />
solo alcune componenti<br />
mirate in funzione dei progetti<br />
cui esse saranno destinate, con<br />
evidente risparmio di risorse<br />
e di tempi di apprendimento<br />
nell’uso delle stesse.<br />
L’apprendimento dell’uso<br />
dell’applicativo INFC_APP è<br />
stato molto facile e rapido, e<br />
non sono pervenute segnalazioni<br />
di difficoltà nell’utilizzo o<br />
malfunzionamenti, se non per<br />
casi sporadici. L’acquisizione dei<br />
dati per mezzo dell’applicativo<br />
è rapida e di facile intuizione,<br />
mentre i controlli implementati<br />
e la sequenza di compilazione<br />
impostata favoriscono una<br />
corretta esecuzione dei rilievi<br />
e impediscono l’introduzione<br />
di errori accidentali. Il corretto<br />
funzionamento dei controlli è<br />
stato verificato periodicamente<br />
attraverso interrogazioni del<br />
<strong>GEOmedia</strong> n°6-<strong>2020</strong> 15
FOCUS<br />
Fig. 10 – Schermate di esempio dell’applicativo su local - web server per l’assistenza da remoto ai rilevatori.<br />
database, miranti a evidenziare<br />
l’eventuale mancanza di dati, la<br />
presenza di dati non richiesti o<br />
incongruenze tra dati di campi<br />
diversi. L’attività di controllo<br />
non ha evidenziato particolari<br />
problemi di completezza e coerenza<br />
e il flusso dei dati si è<br />
svolto sempre in modo regolare<br />
e affidabile.<br />
Ringraziamenti<br />
Oltre agli autori del presente<br />
testo, molte persone con professionalità,<br />
compiti e ruoli<br />
diversi hanno contribuito alla<br />
progettazione e realizzazione<br />
dei rilievi in campo del terzo<br />
inventario forestale nazionale<br />
INFC2015. Hanno partecipato,<br />
per il CREA Foreste<br />
e Legno, Lucio Di Cosmo e<br />
Monica Notarangelo per la<br />
definizione del protocollo di<br />
rilievo e i test sull’applicativo<br />
INFC_APP, Roberto Eccher<br />
e Stefano Morelli per la realizzazione<br />
della piattaforma<br />
di e-learning e del software di<br />
ticketing su local server, Marco<br />
Fontanari e Sandro Zanotelli<br />
all’help desk per l’assistenza da<br />
remoto dei rilevatori. Per l’Ufficio<br />
Studi e Progetti del CUFAA<br />
hanno partecipato al coordinamento<br />
delle attività INFC2015<br />
Emanuele Paolella3, Alfonso<br />
Scimia3, Claudia Cindolo3 e<br />
Cristiana Cocciufa3. Inoltre<br />
tutti gli Ufficiali responsabili<br />
regionali e militari rilevatori, il<br />
personale dei Servizi forestali<br />
delle Regioni a Statuto Speciale<br />
e Province Autonome, a cui si<br />
deve la preziosa opera di completamento<br />
delle attività di<br />
rilievo in bosco dell’INFC2015.<br />
Per la società AlmavivA SpA<br />
hanno dato il loro contributo<br />
anche Annamaria Musolino e<br />
Giuseppe Cossu. Per Telespazio,<br />
sulla parte del portale GeoInfo,<br />
hanno contribuito Alessandro<br />
Cuccagna, Filippo Daffinà e<br />
Andrea Martinelli.<br />
16 <strong>GEOmedia</strong> n°6-<strong>2020</strong>
FOCUS<br />
BIBLIOGRAFIA<br />
Colle G., Floris A., Scrinzi G., Tabacchi G., Cavini L., 2009. The Italian National Forest Inventory: geographical and positioning aspects in relation to the different phases of the<br />
project. In: Proceedings, 8th annual forest inventory and analysis symposium; 2006 October 16-19; Monterey, CA, USA: 1-8<br />
Gasparini P., Tabacchi G. (a cura di) 2011 - L’Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio INFC 2005. Secondo inventario forestale nazionale italiano.<br />
Metodi e risultati. Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Corpo Forestale dello Stato; Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura, Unità di ricerca<br />
per il Monitoraggio e la Pianificazione Forestale. Edagricole, Milano, pp.653.<br />
Gasparini P., Rizzo M., De Natale F., 2014. Manuale di fotointerpretazione per la classificazione delle unità di campionamento di prima fase. Inventario Nazionale delle Foreste e dei<br />
serbatoi forestali di Carbonio, INFC2015 - Terzo inventario forestale nazionale. Consiglio per la Ricerca e la sperimentazione in Agricoltura, Unità di Ricerca per il Monitoraggio e la<br />
Pianificazione Forestale (CRA-MPF); Corpo Forestale dello Stato, Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali. 64 pp. https://www.inventarioforestale.org/it/node/72<br />
Gasparini P., Di Cosmo L., Floris A., Notarangelo G., Rizzo M., 2016. Guida per i rilievi in campo. INFC2015 – Terzo inventario forestale nazionale. Consiglio per la ricerca in<br />
agricoltura e l’analisi dell’economia agraria, Unità di Ricerca per il Monitoraggio e la Pianificazione Forestale (CREA-MPF); Corpo Forestale dello Stato, Ministero per le Politiche<br />
Agricole, Alimentari e Forestali. 341 pp. https://www.inventarioforestale.org/it/node/72<br />
INFC, 2004 – Manuale di campagna per i rilievi di seconda fase con istruzioni per l’uso dell’applicativo INFOR2. Autori: Floris A., Gasparini P., Scrinzi G., Tabacchi G., Tosi V..<br />
Inventario Nazionale delle Foreste e dei Serbatoi Forestali di Carbonio. MiPAF – Direzione Generale per le Risorse Forestali Montane e Idriche, Corpo Forestale dello Stato. Istituto<br />
Sperimentale per l’Assestamento Forestale e per l’Alpicoltura - ISAFA, Trento. 182 pp. https://www.inventarioforestale.org/it/node/72<br />
MAF-ISAFA, 1988 – Inventario forestale nazionale – IFN1985. Sintesi metodologica e risultati. Ministero dell’Agricoltura e delle Foreste, Corpo Forestale dello Stato. Istituto Sperimentale<br />
per l’Assestamento Forestale e per l’Alpicoltura, Trento. 461 pp.<br />
Muscaritoli C., Froncillo F., Piccoli D., Scrinzi G., Floris A., Tartarini G. L., Battistini F., 2004 – L'integrazione GPS/DGPS e database sincronizzati nell’Inventario Forestale Nazionale<br />
Italiano mediante l’applicativo INFOR2 ed i Servizi Territoriali del Sistema Informativo della Montagna. CARTOgraphica, Aprile 2004: 13-16<br />
Pompei E., Clementel F., Colle G., Floris A., Galvagni D., Librandi I., Marzullo L., Piccoli D., Scrinzi G., 2009 - Sistema di valutazione e certificazione delle performance di precisione<br />
delle tecnologie di rilievo satellitare in dotazione al Corpo Forestale dello Stato in presenza di copertura forestale. Atti 13a Conferenza Nazionale ASITA – Bari, 1-4 dicembre<br />
2009: 1627-1632<br />
PAROLE CHIAVE<br />
monitoraggio forestale; GNSS; rilievi forestali; Android; dataset ambientali; cambiamenti climatici.<br />
ABSTRACT<br />
The Italian National Forest Inventory aims to quantify and describe the forest resources of the Country, as well as the ecosystem services which they provide and particularly their<br />
contribution to climate change mitigation.<br />
The field survey of the third inventory (Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio - INFC2015) was carried out by the Arma dei Carabinieri with the<br />
scientific supervision of the research Centre for Forestry and Wood of CREA, and it was completed during the first months of the year <strong>2020</strong>. To conduct the field surveys, specific<br />
procedures for the data collection were developed, as well as the necessary services on a WebGIS platform and a dedicated mobile app.<br />
The paper describes in detail the whole architecture of the system and the operational solutions adopted to manage different aspects of the project, including the training of the<br />
personnel and the remote assistance of the field crews.<br />
AUTORE<br />
Patrizia Gasparini (patrizia.gasparini@crea.gov.it)<br />
Antonio Floris (antonio.floris@crea.gov.it)<br />
Maria Rizzo (maria.rizzo@crea.gov.it)<br />
Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria – Centro di Ricerca Foreste e Legno, p.zza Nicolini 6, 38123 Trento<br />
Amato Patrone (a.patrone@almaviva.it)<br />
Laura Credentino (l.credentino@almaviva.it)<br />
AlmavivA SpA, Divisione IT – Agriculture and Environment Practice - Roma<br />
Giancarlo Papitto (giancarlo.papitto@carabinieri.it)<br />
Domenico Di Martino (d.dimartino@forestale.carabinieri.it)<br />
Comando Carabinieri per la Tutela della Biodiversità e dei Parchi - Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari Carabinieri (CUFAA)<br />
<strong>GEOmedia</strong> n°6-<strong>2020</strong> 17
MERCATO<br />
180 immagini SAR Sentinel 1A e 1B rispettivamente<br />
delle orbite discendenti 22 e 124<br />
ed ascendente 44; l'arco temporale considerato<br />
per la ricerca risulta essere compreso tra<br />
il gennaio <strong>2020</strong> e il 16 gennaio 2021.<br />
Risultati<br />
Dall’analisi effettuata non si rilevano mediamente<br />
spostamenti significativi (superiori a 2<br />
– 3 mm/anno), secondo l'angolo di osservazione<br />
del satellite, nell’area interessata dall’evento.<br />
Fatto salvo alcune anomalie piuttoste<br />
circoscritte, ma con un effetto deformativo<br />
lieve presso la struttura Ospedale del Mare.<br />
CROLLO DEL PARCHEGGIO DELL’OSPEDALE<br />
DEL MARE A NAPOLI: RICERCA DI UNA IPO-<br />
TESI PLAUSIBILE ATTRAVERSO LA TECNICA<br />
A-DINSAR<br />
Una piattaforma innovativa, pensata per gestire le flotte<br />
L'Interferometria Differenziale SAR (DInSAR) si configura<br />
come una solida tecnica non invasiva per il monitoraggio<br />
di spostamenti di corpi continui (Scatteratori Permanenti<br />
– PS). Resta fermo che disponiamo anche di altri strumenti<br />
per monitorare le deformazioni superficiali quali: i sistemi di<br />
posizionamento satellitari GPS/GNSS, la fotogrammetria e i<br />
sensori laser scanner per il rilevamento di modelli tridimensionali.<br />
In poche parole, ad oggi, volendo, abbiamo molti<br />
strumenti a disposizione per effettuare un monitoraggio delle<br />
deformazioni superficiali.<br />
Gli avvenimenti ante-evento<br />
In effetti l’aver incaricato alcuni esperti in geotecnica di effettuare<br />
dei sopralluoghi nell’area interessata dal crollo dell’8<br />
gennaio per la presenza di avvallamenti, certo rappresenta un<br />
primo passo importante. Un numero considerevole di terremoti<br />
piccoli o moderati, Magnitudo di Durata (Md) intorno<br />
ad 1.5, hanno caratterizzato l’area sia la settimana che i mesi<br />
precedenti l’evento; fermo restando l’incessante attività di<br />
bradisismo negativo e positivo a cui l’area è da sempre esposta.<br />
Analisi degli scenari attesi<br />
Impiegando la tecnica A-DInSAR per tipologie di analisi di<br />
questa natura, ossia aree di circa 150 mq, si rende necessario<br />
effettuare preventivamente una analisi multisensore e multitemporale<br />
degli scenari attesi (AMtSA). Tale analisi qualitativa,<br />
che discende direttamente dalla fotointerpretazione, permette<br />
di verificare l’effettiva presenza di quali e quanti corpi<br />
continui (PS) hanno stazionato in modalità permanente o<br />
semi-permanente nell’area d’indagine.<br />
Metodologia di analisi<br />
Per l’analisi interferometrica sono state acquisite presso l’Agenzia<br />
Spaziale Europea (ESA) – Progetto Copernicus, circa<br />
Considerazioni<br />
Le considerazioni sono di due ordini: la prima<br />
di carattere generale dell’area, la seconda<br />
quasi puntuale, del luogo di innesco del cedimento.<br />
Il quadro generale manifesta che, nell’arco temporale<br />
considerato, l’andamento può essere stimato come non<br />
particolarmente ricco di anomalie. Fatto salvo, come sopra<br />
descritto, in alcune aree e date, per esempio il 24 agosto scorso.<br />
Considerando che nell’area collassata non sono presenti<br />
in forma permanente corpi continui, come è anche emerso<br />
dall’analisi multisensoriale e multi-temporale degli scenari<br />
attesi, non è stato possibile ricostruire con i dati in nostro<br />
possesso la cronologia temporale di spostamento lungo la<br />
LOS degli stessi. Si attendono le risposte a richieste da inviare<br />
all’ASI e ad altre agenzie.<br />
Conclusioni<br />
Il presente lavoro ha focalizzato l'attenzione su un tema di<br />
norma sottostimato in Italia, comequello del monitoraggio<br />
delledeformazioni superficiali. Molte attività istituzionali vanno<br />
verso la direzione del monitoraggio delle deformazioni<br />
superficiali sia a scala Nazionale che attraverso Progetti finanziati<br />
dalla Comunità Europea. Nel merito si ricorda il Piano<br />
Straordinario di Telerilevamento che mira a potenziare gli<br />
strumenti di conoscenza e a rafforzare le capacità di osservazione<br />
e controllo del territorio mediante l’utilizzo di tecniche di<br />
Telerilevamento all’avanguardia, contribuendo al contempo ad<br />
accrescere le competenze tecnologiche e a diffonderne l’utilizzo<br />
nella Pubblica Amministrazione - legge n. 179/2002 (art. 27).<br />
Sicuramente l’impiego di dati di maggior dettaglio e ripetitività,<br />
come quelli prodotti dalla Costellazione Cosmo-<br />
SkyMed, TerraSAR-X e RADARSAT, permetterebbero di<br />
poter ancor meglio investigare l’area del collasso. Anche in<br />
forza a quel principio, ormai non più oggetto di editti preelettorali<br />
che va sotto il nome di “riuso dei dati satellitari”.<br />
La richiesta di potersi dotare, come Associazione di<br />
Volontariato Ambientale, anche dei dati suindicati, ci auguriamo<br />
non rimanga lettera morta. Comunque vada, vi terremo<br />
informati sugli sviluppi.<br />
Massimo Morigi<br />
18 <strong>GEOmedia</strong> n°6-<strong>2020</strong>
MERCATO<br />
DJI PHANTOM 4 E MAVIC 2 PRO RTK/<br />
PPK – SOLUZIONE COMPLETA PER<br />
FOTOGRAMMETRIA SENZA TARGET<br />
Il rilievo fotogrammetrico senza target consente di ottenere<br />
precisioni centimetriche anche in posti irraggiungibili o poco<br />
sicuri. Chi si occupa di fotogrammetria sa bene che, fino a<br />
quando il rilievo è di piccole proporzioni e la zona oggetto del<br />
rilievo è facilmente accessibile, il posizionamento, il rilievo e il<br />
recupero dei target è fattibile. Ma quando si parla di effettuare<br />
rilievi di grosse dimensioni o anche di modeste entità ma<br />
difficilmente accessibili (si pensi a frane, versanti montuosi<br />
o altro) ecco che una soluzione RTK/PPK a bordo drone si<br />
rivela essere la scelta vincente perché, in questi casi, i nostri<br />
cari punti di appoggio diventerebbero limiti invalicabili più<br />
che alleati preziosi.<br />
Ma la tecnologia RTK/PPK da sola può bastare?<br />
Gran parte dello scetticismo dovuto a questa tecnologia risiede<br />
nel fatto che, chi non la conosce, non riesce ad ottenere i<br />
risultati sperati. Questo perché, essere in possesso di uno strumento<br />
eccellente e non riuscire ad utilizzarlo equivale a non<br />
possederlo!<br />
A questa conclusione sono giunti anche i ragazzi di www.<br />
strumentitopografici.it che, invece di fornire esclusivamente<br />
l’Upgrade per DJI Mavic 2 Pro o DJI Phantom 4 Pro, hanno<br />
pensato ad una soluzione all inclusive dal prezzo davvero incredibile<br />
per i lettori di <strong>GEOmedia</strong>. La soluzione comprende,<br />
oltre al ricevitore GNSS per drone, anche un software e un<br />
corso di formazione capace di rendere l’utente immediatamente<br />
operativo.<br />
Scopriamo di seguito tutti i dettagli:<br />
• Upgrade del tuo Phantom 4 Pro o del tuo DJI Mavic 2 Pro:<br />
senza apportare modifiche invasive, sarà montato a bordo<br />
del tuo drone un ricevitore GNSS L1/L2 collegato direttamente<br />
alla telecamera e comprensivo di una scheda SD<br />
per la memorizzazione dei dati.<br />
• Software Toposetter in regalo per 1 anno: un software di facile<br />
utilizzo per il post processing dei dati GNSS, il geotagging<br />
delle immagini e la sostituzione delle coordinate di navigazione<br />
nei tag EXIF delle immagini con coordinate esatte<br />
ottenute dopo la post-elaborazione dei dati GNSS.<br />
• Corso di formazione sull’utilizzo della soluzione: un video<br />
corso da vedere e rivedere a proprio piacimento, comprensivo<br />
di tutte le informazioni relative alla soluzione<br />
acquistata. I passi da compiere prima e dopo un rilievo,<br />
le impostazioni da settare, le modalità di elaborazione dei<br />
dati e tanti utili e pratici consigli per un rilievo eccellente<br />
e accurato.<br />
Soluzione PPK all in one<br />
C’è vita nel nostro mondo.<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
www.epsilon-italia.it<br />
www.inspire-helpdesk.eu<br />
<strong>GEOmedia</strong> n°6-<strong>2020</strong> 19
MERCATO<br />
TEOREMA MILANO<br />
PRESENTA IL LASER<br />
SCANNER LEICA BLK360<br />
Le nuove tecnologie rappresentano uno<br />
dei motori del progresso dell'industria,<br />
ma accesso e disponibilità limitati possono<br />
spesso costituire degli ostacoli<br />
all'espressione di tutte le potenzialità<br />
offerte da tali tecnologie ed al vero cambiamento.<br />
Per questo motivo, democratizzare<br />
le tecnologie esclusive ed i risultati<br />
che esse consentono di ottenere,<br />
è diventato un modo per le aziende di<br />
assumere un ruolo di guida e di avere<br />
un impatto significativo, trasformando<br />
la maniera di operare di interi settori.<br />
Lanciata nel 2015, l'azienda britannica<br />
di dati spaziali Pupil è stata una di<br />
quelle aziende con una visione concreta<br />
ed ambiziosa del potenziale dei dati<br />
geospaziali in grado di rivoluzionare<br />
le valutazioni in campo immobiliare.<br />
Leica Geosystems nel novembre 2016<br />
ha presentato lo strumento di acquisizione<br />
della realtà più piccolo e più facile<br />
da utilizzare al mondo, Leica BLK360,<br />
che rappresentava la soluzione perfetta,<br />
consentendo di acquisire dati relativi ad<br />
immagini sferiche in HDR a 360° e nuvole<br />
di punti in pochi minuti. Questo<br />
imaging laser scanner compatto in 3D<br />
ha permesso nuove applicazioni in ambito<br />
di architettura, progettazione, edilizia<br />
ed ingegneria, e riveste un ruolo<br />
fondamentale nei prodotti forniti oggi.<br />
Ciò che è più importante, la tesi iniziale<br />
secondo cui acquisizioni precise e ad<br />
alto contenuto di dati degli spazi interni<br />
avrebbero consentito di creare un nuovo<br />
gold standard nel settore immobiliare<br />
è ora divenuta realtà grazie all'uso di<br />
BLK360.<br />
La visione<br />
Pupil e Leica Geosystems condividono<br />
la mission di democratizzare l'accesso<br />
a dati precisi, come dimostrano i prodotti<br />
che offrono ai clienti. Sistemi di<br />
ricostruzione 3D e di comprensione<br />
della scena consentono di partire da<br />
spazi reali e convertirli in registrazioni<br />
digitali iperprecise. Ciò garantisce misurazioni<br />
corrette a supporto di valutazioni<br />
precise e contribuisce ad evitare<br />
negoziazioni immobiliari fuorvianti.<br />
L'azienda britannica ha introdotto sul<br />
mercato il suo primo brand che si ripropone<br />
di creare un nuovo standard per<br />
il settore dell'immobiliare residenziale,<br />
offrendo agli agenti risorse precise e sicure<br />
che includono la fotografia professionale,<br />
immagini a 360°, planimetrie,<br />
contenuto immersivo di realtà virtuale,<br />
relazioni di misurazione di superfici e<br />
rapporti relativi alle condizioni.<br />
La missione<br />
Sebbene i mercati della proprietà immobiliare<br />
residenziale e commerciale<br />
comportino diversi processi e prodotti,<br />
si fa affidamento ai dati raccolti utilizzando<br />
l'imaging laser scanner BLK360.<br />
Mettendo questa tecnologia nelle mani<br />
di un team qualificato di periti digitali,<br />
vengono acquisiti oltre 3 miliardi di<br />
punti di misurazione alla settimana, che<br />
corrispondono a milioni di metri quadri<br />
nel mondo reale. L'esercito di "periti<br />
digitali" visita e scansiona proprietà<br />
e location in tutta Londra quotidianamente.<br />
Le grandi quantità di dati che<br />
ne risultano alimentano un'architettura<br />
di tipo cloud di proprietà aziendale, per<br />
essere poi elaborati da un team che offre<br />
l'accesso a risorse destinate all'utente<br />
finale entro 24 ore. Cosa che include<br />
immagini a 360° ed un'esperienza immersiva<br />
in realtà virtuale con visualizzazioni<br />
simili al reale accessibili da computer<br />
fisso, da smartphone o mediante<br />
la app per dispositivi mobili, da qualunque<br />
parte del mondo. Con il tocco di<br />
un solo pulsante, BLK360 acquisisce<br />
immagini sferiche in HDR a 360° ed<br />
esegue una scansione laser di 360.000<br />
punti al secondo, con una precisione<br />
pari a +-4mm a 10 metri ed una portata<br />
complessiva di 0,6 - 60 metri. In pochi<br />
minuti, l'immagine sferica e la scansione<br />
laser sono complete e pronte per la<br />
visualizzazione nell'app prima di essere<br />
caricate nel cloud. L'uso intuitivo e la<br />
produzione di dati estremamente precisi<br />
hanno una portata rivoluzionaria, tutto<br />
all'interno di un bene immobiliare, con<br />
un livello di precisione che garantisce fiducia<br />
nelle nostre risorse digitali. Il software<br />
lavora in perfetta sintonia con lo<br />
scanner laser 3D Leica Geosystems. La<br />
produzione di acquisizioni e dati è integrata<br />
con BLK360 e consente di offrire<br />
dati migliori ed immagini più rapide di<br />
quanto siamo mai riusciti a fare in passato.<br />
Considerando la scala industriale<br />
del servizio e la naturale mobilità della<br />
giornata-tipo del perito digitale, la leggerezza<br />
di BLK360 ha davvero ridefinito<br />
la velocità e la qualità delle acquisizioni.<br />
Il futuro<br />
La scansione laser e la tecnologia di<br />
BLK360 non solo ridefinirà il futuro<br />
dell'ambiente costruito e la maniera<br />
in cui si svolgeranno le valutazioni e<br />
le negoziazioni relative alle proprietà<br />
immobiliari, ma offrirà anche dati che<br />
alimenteranno moltissime altre applicazioni<br />
negli spazi interni e non solo.<br />
Dispositivi come quelli creati da Leica<br />
Geosystems stanno contribuendo a realizzare<br />
concretamente tutto questo<br />
nel settore immobiliare, cambiando e<br />
guidando anche altri settori nella direzione<br />
giusta, verso dati maggiormente<br />
accurati. I dispositivi di scansione laser<br />
Leica, precisi e facili da usare, stanno<br />
consentendo di offrire misurazioni più<br />
affidabili e precise. In futuro, l'utilizzo<br />
di questi dati di alta qualità e dell'intelligenza<br />
artificiale consentirà anche<br />
di offrire una serie di nuovi prodotti ed<br />
esperienze. Ora più che mai, stabilire un<br />
rapporto di fiducia con i consumatori è<br />
una priorità per aziende che vogliono<br />
essere all'avanguardia in un mercato ed<br />
in uno scenario tecnologico in rapida<br />
mutazione.<br />
Teorema<br />
Via Romilli 20/8 20139 MILANO<br />
Tel. 02/5398739<br />
www.geomatica.it<br />
20 <strong>GEOmedia</strong> n°6-<strong>2020</strong>
MERCATO<br />
Non<br />
perdiamoci<br />
di vista.<br />
DA PLANETEK LE<br />
IMMAGINI SATELLITARI<br />
ALLA RISOLUZIONE DI 15<br />
CM PIXEL<br />
Le immagini a 30 cm di risoluzione<br />
hanno rappresentato per molto tempo<br />
il meglio che il mercato potesse<br />
offrire. Planetek Italia annuncia la<br />
disponibilità sul mercato di dati satellitari<br />
alla risoluzione senza precedenti<br />
di 15 cm pixel. Da oggi analisti,<br />
foto-interpreti e persino macchine,<br />
possono acquistare e utilizzare le<br />
immagini satellitari 15 cm HD per<br />
estrarre gli attributi e le informazioni<br />
territoriali più importanti e significative<br />
con una precisione e accuratezza<br />
mai ottenute prima. Una rinnovata<br />
visione della Terra che permette di<br />
potenziare tutte le applicazioni territoriali<br />
di svariati ambiti applicativi<br />
come la difesa, l’intelligence, l’ambiente,<br />
l'ingegneria, l’energia, l’urbanistica,<br />
la navigazione e molto altro.<br />
Complemento dei dati aerei<br />
Molti utenti stanno già utilizzando<br />
i prodotti satellitari 15 cm HD per<br />
progetti in regioni remote e difficili<br />
da raggiungere con i tradizionali voli<br />
aerei. Questo prodotto rappresenta,<br />
infatti, un ottimo supporto a tutte<br />
le attività di mappatura aerea contribuendo<br />
a coprire zone impervie<br />
con dati satellitari acquisiti in tempi<br />
rapidi e senza particolari limitazioni<br />
territoriali.<br />
Cos’è la HD Technology?<br />
La risoluzione di 15 cm pixel è resa<br />
possibile grazie alla nuova tecnologia<br />
di High Definition. I dati satellitari<br />
15cm High Definition sono<br />
prodotti attraverso il ricampionamento<br />
di dati satellitari alla risoluzione<br />
di 30 cm della costellazione<br />
Maxar technologies: WorldView-3 e<br />
WorldView-4.<br />
Con la tecnologia di High<br />
Definition il livello di dettaglio e la<br />
qualità visiva dell’immagine satellitare<br />
migliora sensibilmente, favorendo<br />
una eccellente interpretazione degli<br />
elementi geografici e una definizione<br />
dei contorni senza precedenti.<br />
L’algoritmo di ricampionamento<br />
HD è una tecnologia che aumenta<br />
in modo intelligente il numero di<br />
pixel attraverso un modello matematico<br />
complesso, fornendo un nuovo<br />
livello di dettaglio che supera di gran<br />
lunga quello di qualsiasi altra immagine<br />
satellitare commerciale presente<br />
sul mercato.<br />
La soluzione HD Technology non<br />
ha limiti di risoluzione nel suo utilizzo<br />
e può essere, ad esempio, applicata<br />
anche ad immagini native di<br />
40-50 cm di risoluzione, fornendo<br />
come risultato immagini satellitari<br />
alla risoluzione di 30 cm HD e incrementando<br />
in maniera considerevole<br />
la disponibilità di immagini<br />
ad altissima risoluzione nell’archivio<br />
storico.<br />
Per qualsiasi necessità o approfondimento,<br />
non esitare a contattare<br />
Planetek Italia.<br />
www.planetek-italia.it<br />
Fusion<br />
Misurazioni ottiche e GNSS<br />
Misurate con precisione anche<br />
quando la linea di collimazione è<br />
<br />
tecnologia Fusion è possibile gestire<br />
qualsiasi imprevisto e incertezza.<br />
Ora, anche i progetti più impegnativi<br />
diventano più facili e veloci.<br />
Componenti Tecnologia Fusion<br />
• Stazione totale Serie iX<br />
• Ricevitore GNSS GCX3<br />
• Computer da campo SHC5000<br />
• <br />
<strong>GEOmedia</strong> n°6-<strong>2020</strong> 21<br />
SOKKIA.COM
MERCATO<br />
DAL POLITECNICO<br />
DI MILANO UN NUO-<br />
VO SISTEMA DI<br />
MONITORAGGIO A<br />
SOLUZIONI SATELLI-<br />
TARI INTEGRATE<br />
GIMS (Geodetic Integrated<br />
Monitoring System), nuovo<br />
sistema di monitoraggio a<br />
tecnologie integrate dei movimenti<br />
della crosta terrestre<br />
(processi di deformazione come cedimenti, smottamenti, inondazioni,<br />
affondamenti), è stato proposto dalla società GReD,<br />
spin off del Politecnico di Milano. La GReD progetta e realizza<br />
soluzioni innovative e altamente personalizzate basate sulla<br />
geodesia e tecniche geomatiche. Il progetto internazionale è<br />
finanziato per 2.000.000 di euro al 70% da UE nell’ambito del<br />
programma quadro per la ricerca e l’innovazione Horizon <strong>2020</strong><br />
e per il 30% dai soggetti partner di GReD.<br />
Il Professore Emerito Fernando Sansò, presidente della GReD,<br />
ha dichiarato che: "Siamo sicuri che il nuovo sistema di monitoraggio<br />
possa giocare un ruolo di primo piano all’interno dell’attività<br />
di controllo delle infrastrutture, per garantire livelli di sicurezza<br />
adeguati a salvaguardia della popolazione. D’altra parte<br />
GIMS si posiziona come sistema innovativo, dal momento che<br />
integra tecnologie solitamente concepite a compartimenti stagni.<br />
È stato proprio l’uso combinato di sistemi satellitari diversi<br />
la carta vincente del progetto, testato sul territorio sloveno con<br />
risultati promettenti. Siamo convinti che GIMS costituirà un<br />
volano per lo sviluppo dell’interno campo di attività di GReD,<br />
abilitandoci a divenire interlocutori nell’ambito di operazioni<br />
rilevanti su scala nazionale”.<br />
Il progetto GIMS, infatti, si avvale simultaneamente di due<br />
tecnologie satellitari, ovvero GNSS (Global Navigation Satellite<br />
System) e SAR, solitamente utilizzate separatamente. Invece, l’idea<br />
di ricorrere ad entrambe in forma combinata è risultata performante,<br />
in quanto le due soluzioni sono state valorizzate nella<br />
reciproca complementarietà. GNSS e SAR sono due sistemi di<br />
antenne che recepiscono i segnali di sistemi satellitari differenti,<br />
rispettivamente Galileo e Copernico, le cui potenzialità non<br />
sono state finora mai sfruttate in forma integrata usando sensori<br />
a basso costo.<br />
L'iniziativa ha infatti permesso di contenere le soglie dei costi<br />
perché, facendo leva sulla sinergia generata da GNSS e SAR, si è<br />
potuto evitare di ricorrere alle componenti hardware di fascia di<br />
prezzo eccessivamente elevato. Naturalmente senza compromettere<br />
i risultati attesi in fase di progetto, ovvero la capacità di fornire<br />
con tempestività informazioni sul movimento del suolo con<br />
un’elevata risoluzione spaziale e temporale. L’inquadramento<br />
nella fascia cost effective, parallelamente, permette a GIMS di<br />
potere essere anche collettore di dati ambientali per reti intelligenti<br />
(smart landscape/smart city).<br />
Il sistema funziona anche in chiave predittiva, in quanto è in<br />
grado di lanciare warning in vista di possibili movimenti della<br />
crosta terrestre. Un segnale d'allarme che può essere inserito<br />
all’interno di un sistema di gestione proattivo della manutenzione<br />
infrastrutturale, con l’obiettivo di pianificare interventi anche<br />
nel breve periodo.<br />
Finora il progetto GIMS è stato testato in territorio sloveno, precisamente<br />
nelle aree di Vipava e Potoska per rilevare i movimenti<br />
in corso che interessano le due frane e le loro risposte a driver<br />
esterni. Nel quadro di queste operazioni, sono state installate 15<br />
stazioni GNSS.<br />
www.gims-project.eu/<br />
www.comonext.it/en/progetti/gims/<br />
LASER SCANNER, SENSORI PER DRONI, IMU,<br />
LIDAR, MOBILE MAPPING, FOTO 360°<br />
WWW.3DTARGET.IT INFO@3DTARGET.IT CENTRALINO +39 0200614452<br />
22 <strong>GEOmedia</strong> n°6-<strong>2020</strong>
MERCATO<br />
LE NUOVE APP DELLA RIEGL PER IL CON-<br />
TROLLO DA REMOTO DELLE OPERAZIONI IN<br />
MINIERA<br />
Le operazioni da remoto ad oggi sono diventate sempre più frequenti<br />
e comuni, anche nel settore minerario. L’azienda austriaca RIEGL ha<br />
presentato tre nuove app nel settore minerario per la serie VZ-i dei loro<br />
Laser Scanner terrestri con lo scopo di affrontare le impegnative sfide<br />
del Remote Operation. Le nuove app, semplici ed intuitive, supporteranno<br />
gli utenti nel lavoro quotidiano e soprattutto nelle situazioni critiche.<br />
Le tre app riguardano aspetti fondamentali nel lavoro di estrazione minerario:<br />
• App Slope Angle: per il calcolo di pendenze critiche in fase di lavoro<br />
in miniera;<br />
• Design Compare App: per ottimizzare e semplificare il processo di<br />
estrazione;<br />
• RIEGL Monitoring App: monitorare in tempo reale l’estrazione di<br />
materiali prevenendo un possibile cedimento del pendio<br />
RIEGL App Slope Angle<br />
Utilizzando questa app gli angoli di inclinazione delle pareti rocciose<br />
vengono calcolati automaticamente dai dati di scansione. Gli angoli di<br />
pendenza critici possono essere evidenziati e inviati all'utente. Le informazioni<br />
in tempo reale consentono agli operatori di mantenere gli angoli<br />
di inclinazione degli accumuli delle aree di discarica entro i limiti definiti.<br />
Gli addetti ai lavori connessi alla rete mineraria possono attingere<br />
a queste informazioni su web utilizzando un qualsiasi dispositivo: non è<br />
necessaria, infatti, alcuna installazione software o elaborazione dei dati.<br />
Tutto viene elaborato automaticamente all'interno dell'app.<br />
RIEGL Design Compare App<br />
Grazie a questa nuova app, che<br />
calcola gli strati in base a un<br />
determinato modello di progettazione,<br />
il funzionamento<br />
di attrezzature pesanti come le<br />
macchine da scavo può essere<br />
ottimizzato per semplificare il<br />
processo di estrazione.<br />
RIEGL Monitoring App<br />
Consente di rilevare la concentrazione di materiale di scarico in determinate<br />
aree molto prima che siano visibili all'occhio umano.<br />
L'interpretazione dei movimenti calcolata attraverso le singole scansioni<br />
di riferimento consente la previsione di un possibile cedimento del<br />
pendio, permettendo di evacuare in tempo le persone e di rimuovere<br />
i macchinari dalle aree a rischio. Inoltre, la RIEGL ha ulteriormente<br />
ottimizzato i software RiSCAN PRO e RiMINING. Il nuovo LIS<br />
GeoTec Plugin consente l'analisi geotecnica dei dati di scansione fornendo<br />
strumenti statistici all'interno di un'interfaccia grafica di facile<br />
utilizzo. Oltre al calcolo della direzione e dell'angolo di caduta delle pareti<br />
rocciose, consente l'analisi delle discontinuità creando diagrammi<br />
polari e colorando i dati di scansione da cluster di orientamento simile.<br />
Ciò offre agli specialisti una migliore comprensione della stabilità, delle<br />
articolazioni e dei difetti delle pareti rocciose analizzate.<br />
Per provare di persone queste 3 nuove applicazioni:<br />
Scrivere a info@microgeo.it inviando una mail con oggetto “RIEGL<br />
APPLICAZIONI IN AMBITO MINERARIO”.<br />
1986:<br />
Codevintec porta in Italia il primo GPS civile.<br />
Era un Trimble.<br />
Ancora insieme.<br />
CODEVINTEC<br />
Tecnologie per le Scienze della Terra e del Mare<br />
GPS, GNSS, ricevitori, sensori e sistemi per applicazioni marine.<br />
<strong>GEOmedia</strong> n°6-<strong>2020</strong> 23
MERCATO<br />
24 <strong>GEOmedia</strong> n°6-<strong>2020</strong>
MERCATO<br />
Giappone in fiore (07 febbraio 2021)<br />
La missione Copernicus Sentinel-2 ci porta su vortici di fioriture<br />
di alghe nell’Oceano Pacifico, appena al largo delle coste del Giappone. Per<br />
fioriture di alghe si intende il rapido moltiplicarsi di fitoplankton – microscopiche<br />
piante marine che vanno alla deriva sulla superficie del mare o in prossimità di essa. Una<br />
intensa crescita delle alghe – denominata ‘fioritura’ - può diventare visibile ad occhio nudo e può<br />
tingere le acque dell'oceano, consentendo la rilevazione di questi organismi dallo spazio. Sebbene le<br />
fioriture di alghe costituiscano un fenomeno naturale ed essenziale della vita in mare, è noto che le attività<br />
umane hanno portato ad un incremento del numero annuale di questo fenomeno. Dannose fioriture di alghe<br />
possono essere stimolate da fattori ambientali, quali la luce, la temperature delle acque più alta o ancora l'eccesso<br />
di presenza di nutrienti. Nell’immagine mostrata qui, catturata in data 14 giugno 2019, si possono osservare alte<br />
concentrazioni di alghe a circa 130 km al largo dell’isola di Hokkaido, la seconda isola più grande del Giappone.<br />
Questa specifica fioritura misurava oltre 500 km di lunghezza e 200 km di larghezza , con l’area ripresa che mostra<br />
solo una piccola porzione del fenomeno, circa 100 km da nord a sud e circa 110 da est ad ovest. Durante la stagione<br />
primaverile delle fioriture sostanze nutrienti come nitrati e fosfati sono molto più abbondanti sulla superficie delle acque.<br />
Senza l’ausilio di misure dirette ‘in situ’ è molto difficile distinguere le tipologie di alghe che in tal caso ricoprono l’oceano.<br />
Le alghe normalmente sono poi trasportate da venti e correnti in prossimità della costa del Giappone. E’ proprio in questa<br />
parte dell’Oceano Pacifico, nei pressi di Hokkaido, dove la corrente più fredda di Oyashio proveniente da nord si incontra<br />
con la più calda corrente di Kuroshio, che invece fluisce da sud. Quando collidono due correnti che presentano differenti<br />
temperature e densità spesso si creano dei vortici e mulinelli di acqua, che vanno alla deriva lungo il confine delle due<br />
masse d’acqua. Il fitoplankton che cresce sulla superficie dell'acqua si concentra lungo i bordi di questi vortici e segue i<br />
movimenti dell’acqua. Il fitoplankton gioca un ruolo importante nella catena del cibo, ma ha anche un impatto sul ciclo<br />
del carbonio globale, grazie all’assorbimento del diossido di carbonio su una scale equivalente a quella delle piante<br />
terrestri. La parte principale della sua produzione è utilizzata per descrivere la sintesi di materiale organico da diossido<br />
di carbonio ed acqua attraverso la fotosintesi. Anche piccole variazioni nella produzione primaria possono<br />
incidere sulle concentrazioni di diossido di carbonio, come pure influenzare la biodiversità e la pesca. Mentre<br />
le superfici oceaniche si riscaldano in risposta all’aumento dei gas serra atmosferici, la produzione di fitoplankton<br />
deve essere monitorata, sia in modo coerente che sistematico. I dati satellitari possono essere<br />
impiegati non solo per seguire la crescita e l’espansione di fioriture di alghe pericolose - allo scopo<br />
di allertare e mitigare l’impatto dannoso sul turismo e sulla industria ittica – ma si sono anche<br />
dimostrati recentemente fondamentali per fornire una visione globale del fitoplankton e<br />
del suo ruolo all’interno e come risposta al fenomeno del cambiamento climatico.<br />
Crediti: European Space Agency.<br />
Traduzione: Gianluca Pititto.<br />
<strong>GEOmedia</strong> n°6-<strong>2020</strong> 25
REPORT<br />
SISTEMA MOBILE MAPPING<br />
GEOSLAM ZEB HORIZON PER IL<br />
RILIEVO 3D DI UN POZZO<br />
di Simone Orlandini<br />
MicroGeo ha avuto<br />
l’occasione di sperimentare<br />
lo strumento ZEB Horizon<br />
per acquisire in 3D un pozzo<br />
piezometrico.<br />
Lo scenario non è quello<br />
dei più semplici da rilevare.<br />
Questa tipologia di pozzi,<br />
infatti, si estende in<br />
profondità per diverse decine<br />
di metri e con i tradizionali<br />
Fig. 1 - Supporto per sospensione utilizzato per calare il Sistema Mobile Mapping ZEB Horizon<br />
all'interno del pozzo<br />
sistemi di scansione è<br />
praticamente impossibile<br />
ottenere un’acquisizione 3D<br />
completa del soggetto.<br />
Con il Sistema Mobile<br />
Mapping ZEB Horizon<br />
è stato possibile acquisire<br />
il pozzo. Il soggetto si presenta<br />
come pozzo piezometrico<br />
profondo 30 m con diametro di<br />
3,6 m, con un alta difficoltà di<br />
acquisizione: le superfici estremamente<br />
regolari del pozzo<br />
hanno reso l’attività di rilievo<br />
con tecnica SLAM molto complessa,<br />
l’algoritmo che genera<br />
il modello a nuvola di punti<br />
3D deve essere estremamente<br />
potente per poter riuscire a generare<br />
un dato corretto anche<br />
in una condizione di estrema<br />
omogeneità superficiale.<br />
Per effettuare il rilievo è stato<br />
impiegato: il sistema Mobile<br />
Mapping ZEB Horizon, dell’azienda<br />
GeoSLAM, leader nelle<br />
soluzioni tecnologiche 3D<br />
in movimento. Si è scelto di<br />
impiegare questo strumento<br />
soprattutto per la sua versatilità<br />
(può essere montato su auto,<br />
drone, fatto calare in cavità<br />
profonde ecc…) e per la facilità<br />
di utilizzo: leggero e compatto,<br />
veloce in fase di rilievo e semplice<br />
nel processare il dato; un<br />
supporto per sospensione per<br />
ZEB Horizon; una Stazione<br />
Totale e un set di sfere di riferimento<br />
per le scansioni laser.<br />
Il rilievo<br />
Il rilievo si è sviluppato in tre<br />
fasi principali.<br />
Prima fase<br />
Dopo aver controllato lo scenario<br />
si è deciso di posizionare le<br />
sfere in modo che rispondessero<br />
a due requisiti: che tutte fossero<br />
facilmente rilevabili da una sola<br />
posizione della stazione totale<br />
e tutte facilmente individuabili<br />
all’interno della nuvola.<br />
Si è proceduto, quindi, con la<br />
26 <strong>GEOmedia</strong> n°6-<strong>2020</strong>
REPORT<br />
Fig. 2 - Settaggio dei parametri per il processing per<br />
la restituzione del dato grezzo a nuvola di punti 3D.<br />
Fig. 3 - Individuazione delle sfere all'interno di GeoSLAM Draw per georeferenziare la nuvola di punti.<br />
battitura del centro delle sfere<br />
(sono stati battuti per ogni<br />
sfera tre punti tramite i quali<br />
si è potuto ricavare il centro)<br />
da parte della Stazione Totale<br />
per la georeferenziazione del<br />
modello 3D.<br />
Fig. 4 - Estrazione di viste bidimensionali all'interno della piattaforma GeoSLAM Draw.<br />
Seconda Fase<br />
La seconda parte ha riguardato<br />
il rilievo del pozzo con lo<br />
strumento ZEB Horizon.<br />
Le sfere sono state scansionate<br />
nella sessione di rilievo dinamico<br />
intorno all’apertura del<br />
pozzo, ponendo particolare<br />
attenzione al fatto che potessero<br />
essere acquisite con elevata<br />
risoluzione.<br />
Poi, senza interrompere la<br />
sessione di scansione il sistema<br />
Zeb Horizon è stato calato<br />
tramite supporto per sospensione<br />
all’interno del pozzo,<br />
dove è avvenuta l’acquisizione<br />
a 360° della cavità (Fig. 2; v<br />
video). Per una profondità di<br />
rilievo fino a 30 m.<br />
Terza fase<br />
La terza ed ultima fase ha portato<br />
alla restituzione del dato<br />
grezzo a nuvola di punti 3D<br />
del pozzo all’interno del software<br />
GeoSLAM Hub.<br />
Prima di lanciare il processing<br />
sono stati modificati due parametri<br />
rispetto alla configurazione<br />
standard: la voce Voxel<br />
Density e la Windows Size. In<br />
spazi chiusi e omogenei superficialmente<br />
come nel nostro<br />
caso è consigliabile diminuire<br />
il primo parametro in modo da<br />
aumentare le dimensioni del<br />
voxel (volumetric picture element)<br />
e avere un maggiore dettaglio<br />
volumetrico. Il secondo<br />
parametro – che si riferisce alla<br />
quantità di dati utilizzati per<br />
l’allineamento all’interno di una<br />
sessione di rilievo 3D – invece<br />
va aumentato negli spazi chiusi<br />
(Fig 2.).<br />
Terminata l’elaborazione il risultato<br />
finale è stato aperto all’interno<br />
di GeoSLAM Draw dove<br />
la nuvola è stata georeferenziata<br />
tramite le coordinate del centro<br />
delle sfere ricavate dal rilievo<br />
<strong>GEOmedia</strong> n°6-<strong>2020</strong> 27
REPORT<br />
Fig. 5 - Individuazione delle sfere all'interno di GeoSLAM Draw per georeferenziare la nuvola di punti.<br />
topografico della Stazione<br />
Totale (Fig. 3) e dove<br />
sono state estratte le viste<br />
bidimensionali tramite gli<br />
strumenti di editing che<br />
fornisce il software (Fig.<br />
4).<br />
Risultato finale: rilievo riuscito.<br />
La nuvola di punti<br />
finale (Fig. 5) presenta un<br />
valore RMS tra la nuova<br />
posizione delle sfere<br />
rispetto alle coordinate<br />
prese dalla stazione totale<br />
molto basso (1 cm; Fig.<br />
6).<br />
Per la realizzazione del rilievo<br />
del pozzo, della zona<br />
circostante e l’elaborazione<br />
dei dati ci sono volute<br />
circa 2 ore, tra posizionamento<br />
delle sfere, battitura<br />
con la Stazione Totale,<br />
rilievo dinamico con ZEB<br />
Horizon (ca. 10 min.).<br />
Fig. 6 - Estrazione di viste bidimensionali all'interno della piattaforma GeoSLAM Draw.<br />
PAROLE CHIAVE<br />
Rilievo; 3D; mobile mapping systems; GEOslam; zebhorizon<br />
ABSTRACT<br />
MicroGeo had the opportunity to experiment with the ZEB Horizon instrument to acquire a piezometric well in 3D.<br />
The scenario is not the easiest to detect. This type of wells, in fact, extends in depth for several tens of meters and with traditional<br />
scanning systems it is practically impossible to obtain a complete 3D acquisition of the subject.<br />
With the ZEB Horizon Mobile Mapping System it was possible to acquire the well. The subject presents itself as a 30 m deep piezometric<br />
well with a diameter of 3.6 m, with a high difficulty of acquisition: the extremely regular surfaces of the well have made the<br />
survey activity with the SLAM technique very complex, the algorithm that generates the 3D point cloud model must be extremely<br />
powerful in order to be able to generate a correct data even in a condition of extreme surface homogeneity.<br />
AUTORE<br />
Simone Orlandini<br />
info@microgeo.it<br />
28 <strong>GEOmedia</strong> n°6-<strong>2020</strong>
REPORT<br />
10 – 14 maggio<br />
DIGITAL WEEK<br />
Scopri le ultime novità<br />
della tecnologia Esri<br />
alla Digital Week<br />
www.esriitalia.it<br />
<strong>GEOmedia</strong> n°6-<strong>2020</strong> 29
REPORT<br />
LA DISCRASIA ITALIANA<br />
NEL SETTORE GEODETICO<br />
di Attilio Selvini<br />
Non ci si stupisca per il titolo di questo articolo: se il<br />
sostantivo discrasia (di derivazione greca) è normalmente<br />
usato in ambito medico, mi permetto di impiegarlo qui,<br />
confortato da quanto dice il Vocabolario Treccani:<br />
“In usi fig., con riferimento soprattutto a organismi<br />
economici e politici, a uffici o servizi pubblici, disfunzione,<br />
mancanza di coordinamento, e sim.”. Sottolineo i termini<br />
“disfunzione” e “mancanza di coordinamento”, che sono<br />
fondamentali per ciò che scriverò.<br />
Fig. 1 - Interfaccia utente IdroGEO - Sezione Pericolosità e indicatori di rischio.<br />
Un breve inciso, prima<br />
di affrontare l’argomento<br />
del quale mi<br />
occupo da tempo. Abito in<br />
una delle più lunghe e trafficate<br />
vie di Milano, peraltro<br />
molto ben servita sia dai mezzi<br />
di trasporto che da negozi<br />
e uffici pubblici. Sono seduto<br />
sotto l’apposita pensilina, in<br />
attesa dell’autobus e davanti a<br />
me sul marciapiede affollato<br />
passano veloci più o meno<br />
giovani ciclisti, che lo hanno<br />
scambiato per una pista<br />
ciclabile (peraltro in questo<br />
tratto mancante). Nonostante<br />
che a lato della pensilina<br />
faccia bella mostra di sé un<br />
contenitore di carte e rifiuti<br />
con annesso portacenere,<br />
vedo per terra molte decine<br />
di mozziconi insieme ad altri<br />
rifiuti. Penso desolato che<br />
cinquanta chilometri a nord,<br />
a Lugano od a Chiasso, un<br />
simile spettacolo non sarebbe<br />
possibile: e non per il timore<br />
delle pesanti ammende che<br />
un solerte vigile non mancherebbe<br />
di contestare, bensì per<br />
il comportamento dei cittadini<br />
e per il loro diverso senso<br />
civico. Pazienza! Peraltro questa<br />
Milano è vivibile e pulita,<br />
per cui mi sento fortunato se<br />
penso a Roma Caput mundi<br />
ed alla sua drammatica situazione.<br />
Mi sono occupato per l’ultimo<br />
mezzo secolo della<br />
mia lunga vita, di questioni<br />
relative alle discipline del rilevamento<br />
e della rappresen-<br />
30 <strong>GEOmedia</strong> n°6-<strong>2020</strong>
REPORT<br />
tazione, sia per ciò che riguarda<br />
le vecchie e nuove tecniche<br />
operative che per quanto si riferisce<br />
al loro insegnamento in<br />
Italia e nel mondo. E’ inutile<br />
che ne riporti qui la bibliografia.<br />
La vita politica del nostro<br />
Paese, a partire dalla fine del<br />
secolo ventesimo e da “tangentopoli”,<br />
è stata tormentata e<br />
molto diversa da quella media<br />
della Comunità Europea; negli<br />
ultimi vent’anni si è rivelato<br />
ciò che più ci divide dagli altri<br />
stati componenti, che è assai<br />
meno di ciò che ci unisce.<br />
Nell’ambito di quello che ho<br />
chiamato nel titolo “geodetico”<br />
per ragioni di semplificazione,<br />
sono in realtà comprese tutte<br />
le discipline del rilevamento<br />
e della rappresentazione, insomma<br />
quelle che da tempo<br />
si dicono ormai “geomatica”:<br />
proprio in tale ambito dirò<br />
di quanto ci separa dal resto<br />
dell’Europa.<br />
Le Commissioni Geodetiche<br />
A partire dall’Ottocento, in<br />
Europa si svilupparono a livello<br />
nazionale le operazioni<br />
topografiche e quindi cartografiche<br />
(catasto, carte per la<br />
difesa). Tutti gli Stati vi parteciparono,<br />
creando organi scientifici<br />
che ne dettassero le linee<br />
fondamentali. Nacquero così<br />
le “commissioni geodetiche”.<br />
Queste esistono ed operano<br />
tuttora nella UE, con l’eccezione<br />
dell’Italia.<br />
La Commissione geodetica<br />
italiana è stata un ente pubblico<br />
italiano che costituiva<br />
la controparte italiana della<br />
Associazione internazionale<br />
di geodesia. Ne furono presidenti,<br />
in ordine, i seguenti<br />
studiosi:<br />
Annibale Ferrero (generale e<br />
ministro della difesa): 1884<br />
- 1902;<br />
Giovanni Celoria (illustre<br />
astronomo): 1902 - 1920;<br />
Nicola Vacchelli (generale<br />
e direttore IGM): 1920 -<br />
1932;<br />
Emanuele Soler (professore<br />
ordinario e senatore): 1932<br />
- 1940;<br />
Gino Cassinis (professore<br />
ordinario e presidente Soc.<br />
Int. Fotogrammetria): 1940<br />
- 1964;<br />
Antonio Marussi (professore<br />
ordinario di fama internazionale):<br />
1967 - 1977 (data di<br />
soppressione della commissione).<br />
Nel 1975 la commissione fu<br />
dichiara ente non utile in base<br />
alla legge 20 marzo 1975 n.<br />
70 e quindi soppressa con il<br />
DPR del 4 luglio 1977. Evito<br />
il commento, lasciandolo ai<br />
lettori: ma indico qui avanti le<br />
Commissioni geodetiche dei<br />
maggiori stati dell’Unione, per<br />
quei parlamentari che dichiararono<br />
la nostra ente non utile.<br />
Elenco delle Commissioni<br />
Geodetiche in Europa:<br />
Spagna: Comision Espanola<br />
de Geodesia y Geofisica<br />
Francia: Commission sur les<br />
Infrastructures géodésiques<br />
Olanda: Nederlands<br />
Centrum voor Geodesie en<br />
Geo-informatica (NCG)<br />
Svizzera: der<br />
Schweizerischen<br />
Geodätischen Kommission<br />
Germania: Deutsche<br />
Geod tische Kommission<br />
Austria: Österreichische<br />
Geodätische Kommission<br />
Polonia: Z Komisji<br />
Geodezji i Infrastruktury<br />
Come risultato della soppressione<br />
della nostra<br />
Commissione Geodetica,<br />
è nato il caos completo fra<br />
gli organi cartografici dello<br />
Stato: Questi sono l’Istituto<br />
Geografico Militare, il<br />
Dipartimento del Territorio<br />
(ex direzione generale del catasto),<br />
l’Istituto Idrografico<br />
della Marina, il Centro<br />
Informazioni Geotopografiche<br />
Aeronautica, e il Servizio<br />
Geologico Italiano. A loro<br />
vanno aggiunti gli uffici cartografici<br />
regionali, che del caos<br />
sopraggiunto hanno finito per<br />
avere la responsabilità. Nessun<br />
coordinamento fra una regione<br />
e l’altra, scale, aspetti grafici,<br />
struttura, segni convenzionali<br />
“a capocchia”. L’esempio della<br />
Repubblica Federale Tedesca è<br />
la “Grundkarte” al cinquemila,<br />
identica dal Mar del Nord<br />
alle Alpi Bavaresi, eseguita<br />
secondo i dettami della locale<br />
Commissione Geodetica.<br />
All’inizio del nuovo millennio,<br />
un gruppo di volenterosi<br />
raccolse firme (poco meno di<br />
un migliaio) per una petizione<br />
al Parlamento con la precisa<br />
richiesta di ricostituire la<br />
Commissione Geodetica della<br />
Repubblica Italiana: ma la cosa<br />
finì nel nulla.<br />
La questione dei geometri<br />
Su questo argomento ho scritto<br />
e pubblicato molto, su riviste<br />
e su libri. Riassumo in breve.<br />
Il geometra italiano, oggi<br />
sostituito dal “perito delle<br />
costruzioni, del territorio e<br />
dell’ambiente” (ma rimangono<br />
gli albi professionali insieme<br />
al Consiglio Nazionale dei<br />
Geometri) è un diplomato da<br />
scuola secondaria. In Europa<br />
l’equivalente, dai nomi diversi<br />
(Geomètre Expert in Francia,<br />
Vermessungsingenieur nei Paesi<br />
di lingua tedesca, Chartered<br />
Surveyor nel Regno Unito) è<br />
invece di formazione universitaria.<br />
In Francia, Germania,<br />
Inghilterra e Spagna questi tecnici<br />
operano nel settore topocartografico<br />
e sono per ognuno<br />
di quei Paesi alcune migliaia.<br />
In Italia i geometri lavorano<br />
<strong>GEOmedia</strong> n°6-<strong>2020</strong> 31
REPORT<br />
prevalentemente nel settore<br />
dell’edilizia e sono all’incirca<br />
centodiecimila (!) regolarmente<br />
iscritti negli albi professionali,<br />
secondo una indagine de<br />
“L’Espresso”. Come non vedere<br />
la differenza fra Italia e Unione<br />
Europea?<br />
I geometri topografi si sono da<br />
tempo costituiti in associazione.<br />
Sono in totale qualche migliaio,<br />
in linea con i colleghi europei<br />
dei Paesi sopra ricordati,<br />
ma testimoni della differenza<br />
fra “geometri” e “topografi”.<br />
Chi scrive ne conosce alcuni,<br />
sicuramente allo stesso livello<br />
dei colleghi d’Oltralpe. Ma<br />
allora, a che servono i centomila<br />
e più, che fanno tutt’altro,<br />
compreso gli amministratori<br />
condominiali, se non ad alimentare<br />
una ricca Cassa di<br />
Previdenza?<br />
Il CNG si è dato da fare per<br />
l’apertura di corsi universitari<br />
triennali per “geometri laureati”,<br />
e ne ho scritto su diverse<br />
riviste. Ma a che pro’, dato che<br />
già e non da oggi ci sono laureati<br />
triennali in ingegneria civile<br />
e architettura?<br />
Gli ingegneri topografi<br />
Anche qui ne ho già scritto.<br />
All’inizio degli anni Novanta,<br />
su mia richiesta l’allora illuminato<br />
Rettore del Politecnico<br />
di Milano Adriano De Maio,<br />
mi ricevette insieme ai colleghi<br />
Fernando Sansò e Carlo<br />
Monti, per esaminare la proposta<br />
di aprire nel nostro<br />
Ateneo un corso simile a quelli<br />
esistenti presso altre Università<br />
europee ed in particolare nel<br />
Politecnico di Zurigo, col quale<br />
l’Ateneo milanese aveva da<br />
tempo collaborazione. Un corso<br />
cioè per veri ingegneri geodeti<br />
o topografi che dir si volesse.<br />
La cosa non ebbe seguito,<br />
anche perché Adriano De Maio<br />
lasciò il posto ad altri.<br />
Poi, quasi d’improvviso, le facoltà<br />
di ingegneria scopersero<br />
l’indirizzo di laurea proprio in<br />
“ambiente e territorio”, indirizzo<br />
che nulla o quasi ha in<br />
comune con l’andamento generale<br />
europeo di tipo geomatico.<br />
Se ci riferiamo al Politecnico di<br />
Milano, questa laurea magistrale<br />
si propone di operare per:<br />
Difesa del Suolo e<br />
Prevenzione dai Rischi<br />
Naturali<br />
Pianificazione e Gestione<br />
delle Risorse Naturali<br />
Tecnologie di Risanamento<br />
Ambientale<br />
Monitoraggio e Diagnostica<br />
Ambientale<br />
Environmental Engineering<br />
for Sustainability..<br />
(la serie austera di “maiuscole”<br />
non è mia, è del testo ufficiale).<br />
E per ottenere tali ambiziosi<br />
traguardi, le discipline del<br />
gruppo “ICAR 06”, ovvero<br />
quelle di tipo geomatico, sono<br />
esattamente ben QUATTRO<br />
(!), in ordine: Tecniche di<br />
posizionamento e controllo<br />
(quindi una modestissima<br />
parte della topografia, del resto<br />
assente), Fotogrammetria<br />
e Fotointerpretazione,<br />
Telerilevamento, Sistemi<br />
Informativi Territoriali. Sic et<br />
simpliciter. Dove stiano geodesia,<br />
topografia, cartografia, sistemi<br />
catastali, posizionamento<br />
satellitare e altro ancora, nessuno<br />
lo sa. Vorrei qui riportare il<br />
piano di studi del Politecnico<br />
di Zurigo, nel quale peraltro<br />
hanno lavorato e lavorano a diversi<br />
livelli molti italiani di varia<br />
estrazione, ma ci rinuncio.<br />
In definitiva l’Italia, unico<br />
Paese europeo (ma vorrei dire<br />
dell’intero mondo) non possiede<br />
non solo una Commissione<br />
Geodetica o comunque un unico<br />
organo scientifico ufficiale,<br />
cogente e dirimente che si<br />
occupi del rilevamento e della<br />
rappresentazione, ma nemmeno<br />
una figura professionale<br />
corrispondente a quelle presenti<br />
nella FIG, la Federazione<br />
Internazionale dei Geometri,<br />
ormai e da molto tempo solo<br />
di formazione universitaria.<br />
Che dire?<br />
PAROLE CHIAVE<br />
Commissione geodetica; geomatica;<br />
topografia; discrasia<br />
ABSTRACT<br />
Beginning in the nineteenth<br />
century, topographic and then cartographic<br />
operations (land registry,<br />
defense maps) developed nationally<br />
in Europe. All the States participated<br />
in it, creating scientific bodies<br />
that dictated the fundamental<br />
lines. Thus were born the "geodetic<br />
commissions". These exist and still<br />
operate in the EU, with the exception<br />
of Italy.<br />
The Italian Geodetic Commission<br />
was an Italian public body that was<br />
the Italian counterpart of the International<br />
Association of Geodesy.<br />
In 1975 the commission was<br />
declared a non-useful body according<br />
to the law of 20 March 1975<br />
n. 70 and then suppressed with the<br />
Presidential Decree of 4 July 1977.<br />
I avoid the comment, leaving it to<br />
the readers.<br />
AUTORE<br />
Attilio Selvini<br />
attilio.selvini@polimi.it<br />
attilio.selvini.polimi@gmail.com<br />
già presidente della Società<br />
Italiana di Fotogrammetria e<br />
Topografia<br />
32 <strong>GEOmedia</strong> n°6-<strong>2020</strong>
2021<br />
ROMA 5-7 OTTOBRE<br />
Tecnologie per il Territorio, il Patrimonio Culturale e le Smart City<br />
www.technologyforall.it<br />
Science & Technology Communication<br />
#TECHFORALL
AUGMENTED REALITY<br />
WITH XR TECHNOLOGIES, NEXT TREND<br />
IN THE WORLD OF WORK: WILL BE<br />
AVATARS AND DIGITAL TWINS<br />
Testying the automatic<br />
creation of my avatar<br />
in VR collaborative<br />
space.<br />
XR <strong>2020</strong>:<br />
News & Events<br />
a cura di<br />
Tiziana Primavera<br />
Innovative Tech<br />
Evangelist - AR/VR<br />
senior expert<br />
The social context redefined by<br />
the pandemic that has characterized<br />
our last months, has certainly<br />
allowed the development<br />
of new ways of remote social<br />
interaction, mainly for professional,<br />
work purposes.<br />
But this has been re-defined<br />
not only in business contexts,<br />
but also in those oriented towards<br />
training and leisure.<br />
Technology with its interactive<br />
potential has certainly allowed<br />
many structures to survive and<br />
many people to communicate.<br />
However, most people have<br />
adopted elementary platforms<br />
based essentially on video streams<br />
shared by multiple users,<br />
as they are cheap, and certainly<br />
intuitive to use and above all<br />
decidedly widespread globally.<br />
But these new practices are only<br />
the first steps in a development<br />
path in the field of distance<br />
communications, which will<br />
increasingly feature XR technologies.<br />
Recent advances in augmented<br />
and virtual reality will allow a<br />
progressive revolution in modus<br />
operandi in work contexts. We<br />
can already see the concrete<br />
possibility of using real avatars<br />
and digital twins prepared and<br />
configured to allow more complete<br />
and humanized perceptual<br />
experiences for remote work<br />
and it is highly likely the adoption<br />
of a hybrid model of work<br />
in business contexts.<br />
The next generation of wireless,<br />
5G and 6G technologies will<br />
certainly substantially facilitate<br />
the massive spread of these<br />
technologies, therefore destined<br />
to define immersive spaces for<br />
work and collaboration at a<br />
distance, very similar to those<br />
proposed to date in some science<br />
fiction films.<br />
With these assumptions there<br />
will be a substantial revolution<br />
inherent in the modes of digital<br />
interaction, therefore limited<br />
no longer only to the view and<br />
mouse paradigm keyboard screen.<br />
Several companies of interplanetary<br />
relevance are facing industry<br />
research to develop and<br />
market transformative wireless<br />
technologies.<br />
On the other hand, new pandemics<br />
can certainly be ruled<br />
out in the near future and in<br />
the light of what has happened,<br />
for reasons of a pre-event nature<br />
and for economic reasons, it seems<br />
absolutely advantageous for<br />
companies to reconfigure operations,<br />
to structure themselves<br />
by sectoralising the tasks of<br />
their resources and adopting<br />
hybrid models in which only<br />
part of the workforce will be<br />
required on site.<br />
Spatial visual interaction<br />
technologies will improve how<br />
you can interact between colleagues<br />
and collaborators virtually,<br />
amplifying the humanization of<br />
the interactive experience.<br />
The fact that the need is felt<br />
and that it is a magmatic sector<br />
of increasing interest is demonstrated<br />
by the fact that already<br />
today many users are very much<br />
wondering about the possibility<br />
of optimizing the experience<br />
that has become classic on the<br />
zoom platform.<br />
With the use of XR technologies,<br />
in fact this sensory<br />
34 <strong>GEOmedia</strong> n°6-<strong>2020</strong>
AUGMENTED REALITY<br />
overshoot is already possible,<br />
using its own digital twin and<br />
being able to define scenarios<br />
and objects that can be shared<br />
spaces. Participatory design, based<br />
on interactively inspectable<br />
objects, lived remotely will be<br />
the new paradigm of the near<br />
future.<br />
At the state of the art, this kind<br />
of shared spatial experiences are<br />
already possible, it remains to<br />
bewondered how socially acceptable<br />
they are and how effective<br />
user experiences are from a qualitative<br />
point of view.<br />
The available wearable devices<br />
have certainly become affordable,<br />
but they are still too invasive<br />
and heavy to guarantee smooth<br />
and captivating experiences.<br />
As far as fully immersive experiences<br />
are concerned, the best<br />
performing headsets are able to<br />
process one gigabit/sec, while in<br />
order to solve the above critical<br />
issues, much more advanced<br />
performance, of the order of<br />
hundreds of megabits/sec,<br />
would be required.<br />
With this in mind, it is possible<br />
to define this a period of experimentation,<br />
metabolization<br />
and learning that offers a real<br />
revolution in social customs and<br />
collaborative models over the<br />
next ten years.<br />
The consequences of the pandemic<br />
crisis are a driver of diffusion<br />
and familiarization with digital<br />
tools and it is highly likely<br />
that this development trend<br />
can continue and develop more<br />
intensively over the next decade.<br />
Accenture, a multinational<br />
professional services company, is<br />
using virtual reality exercises for<br />
new recruitment techniques.<br />
Some data related specifically<br />
to virtual reality According to<br />
ARtillery Intelligence:<br />
• The capital invested by companies<br />
will grow considerably<br />
from $829 million in 2018 to<br />
$4.26 billion in 2023, exceeding<br />
$24.5 billion in revenue<br />
by 2024.<br />
• The use will be verticalized<br />
for training, meetings or to<br />
optimize customer services<br />
during the pandemic.<br />
• Facebook recently released an<br />
Oculus for Business platform<br />
specifically for commercial<br />
use.<br />
• Legal experts have spoken out<br />
about the danger of potential<br />
possible crimes in the digital<br />
world and possible data privacy<br />
breaches.<br />
Apple and Google as well as<br />
multiple other companies are<br />
particularly attentive to the<br />
phenomenon and active in development<br />
and research.<br />
The American giants are facing<br />
each other, and it is not yet clear<br />
who will succeed in establishing<br />
themselves at the mainstream<br />
level. Both have multiple possibilities<br />
for action, Apple began<br />
its research several years ago by<br />
acquiring Metaio's sophisticated<br />
AR technology and in May<br />
bought the Californian start-up<br />
NextVR, whose core business<br />
focuses on live broadcasting<br />
of sporting events or concerts,<br />
made in virtual reality.<br />
It is expected that between the<br />
different areas, health care will<br />
be the area most affected by<br />
immersive technologies in the<br />
<strong>GEOmedia</strong> n°6-<strong>2020</strong> 35
AUGMENTED REALITY<br />
coming year: medical staff will<br />
be able to view medical statistics<br />
superimposed directly on the<br />
patient’s body in MR or AR,<br />
training and protocols can be<br />
conveyed in VR, interventions<br />
can be remotely participated<br />
by more distinguished professionals<br />
etc.<br />
Also because of the large spread<br />
envisaged, it will be absolutely<br />
necessary to define in advance<br />
an ad hoc body of legislation,<br />
considering that all possible<br />
crimes in physical reality are<br />
in fact feasible even in virtual<br />
contests. Land social norms<br />
are perceived quite quickly in<br />
the virtual space and, in an<br />
immersive context observing<br />
other people, one really perceives<br />
the feeling of interacting<br />
with natural people, and it is<br />
therefore relevant to prepare in<br />
the development of application,<br />
interpersonal spaces of respect,<br />
reflecting the behavioral codes<br />
proper to reality.<br />
Particular attention should be<br />
paid to the protection of privacy,<br />
an extremely sensitive issue<br />
considering that there are legitimate<br />
reasons why companies<br />
must record the eye movement<br />
or heart rate of their users,<br />
perhaps in order to protect the<br />
same from VR motion sickness,<br />
but such data could also be aimed<br />
at outlining physiological<br />
responses and evaluating behavioral<br />
forecasting models, such<br />
as the propensity to violence or<br />
the degree of empathy.<br />
Data acquired for legitimate<br />
technical reasons by the companies<br />
dispensing the applications,<br />
but objectively of inestimable<br />
value in the world of e-commerce<br />
and not only, therefore sensitive<br />
to the risk of misuse.<br />
It is therefore important to define<br />
a new line of development,<br />
capable of politically contemplating<br />
the different aspects that<br />
distinguish the massive penetration<br />
of disruptive technologies<br />
from a social point of view.<br />
It is therefore important not<br />
to be caught unprepared, to<br />
train legal staff in depth on the<br />
subject and to adopt in good<br />
time criteria for regulating virtual<br />
spaces.<br />
(Imagines of three different wearable<br />
mixed- reality holographic<br />
computing).<br />
PAROLE CHIAVE<br />
Mixed reality; augmented reality;<br />
virtual reality; avatar; digital<br />
twins; xr technologies<br />
ABSTRACT<br />
The article critically investigates the<br />
possibilities offered by new interactive<br />
visual technologies for remote professional<br />
collaboration, highlighting the<br />
legal aspects yet to be defined.<br />
AUTORE<br />
tiziana.primavera@unier.it<br />
36 <strong>GEOmedia</strong> n°6-<strong>2020</strong>
GeoMax Zenith40<br />
Direttamente al punto<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
geomax-positioning.it
TERRA E SPAZIO<br />
Il nostro amico (?) Sole<br />
di Marco Lisi<br />
Il comportamento del Sole, o “Space Weather”, può influenzare<br />
il comportamento dei sistemi GNSS, come GPS o Galileo, in vari<br />
modi.<br />
“Il sole, con tutti quei pianeti che gli girano attorno e da lui<br />
dipendono, può ancora far maturare una manciata di grappoli<br />
d’uva come se non avesse nient’altro da fare nell’universo.”<br />
Galileo Galilei<br />
Il Sole è la stella intorno alla<br />
quale ruota il nostro microcosmo<br />
planetario, simile ad altri<br />
miliardi di stelle nell’universo,<br />
ma per noi unica, perché fonte<br />
primaria ed insostituibile di energia,<br />
in ultima analisi di vita.<br />
Il ruolo fondamentale del Sole è<br />
tanto importante, quanto spesso<br />
considerato come scontato,<br />
nonostante l’attenzione ad esso<br />
dedicata negli ultimi anni come<br />
fonte rinnovabile di energia pulita,<br />
attraverso l’utilizzo di pannelli<br />
termici e solari.<br />
È solo quando il Sole fa i capricci,<br />
comportandosi in modo anomalo<br />
(secondo i nostri standard),<br />
che ci si accorge di lui e si deve, a<br />
volte, correre ai ripari.<br />
L’attenzione scientifica e tecnica<br />
al comportamento del Sole è<br />
come vedremo vecchia di alcuni<br />
secoli, ma solo con l’avvento<br />
dell’elettricità prima e delle trasmissioni<br />
radio poi che essa ha<br />
assunto un’importanza primaria,<br />
a volte strategica. Negli ultimi<br />
anni, lo studio del Sole e degli<br />
effetti da esso indotti su vari<br />
aspetti tecnologici e biologici<br />
della nostra vita e della nostra<br />
salute è stato denominato “Space<br />
Weather”.<br />
Il primo evento storico di proporzioni<br />
catastrofiche, che ha dimostrato<br />
l’estrema fragilità della<br />
nostra tecnologia “elettrica” (non<br />
si parlava ancora di elettronica,<br />
telecomunicazioni “wireless” o<br />
computer) risale al cosiddetto<br />
“Carrington Event”, una potentissima<br />
tempesta geomagnetica<br />
verificatasi il primo settembre<br />
1859, come conseguenza di una<br />
“eruzione” solare (“Coronal Mass<br />
Ejection”, CME) di enorme potenza.<br />
Questa tempesta solare, oltre<br />
a provocare spettacolari aurore<br />
a tutte le latitudini, degradò (a<br />
volte distrusse) il sistema di telecomunicazioni<br />
allora diffuso,<br />
basato sulla telegrafia via fili.<br />
È importante notare che un<br />
evento simile a quello del 1859<br />
provocherebbe ai nostri giorni<br />
una calamità planetaria con conseguenze<br />
catastrofiche su tutti gli<br />
aspetti della nostra società: danni<br />
alle apparecchiature elettroniche,<br />
distruzione delle reti di telecomunicazione,<br />
danni e blackout<br />
nelle reti di distribuzione dell’energia<br />
elettrica. In altri termini,<br />
niente smartphone, reti cellulari<br />
e Wi-Fi; niente Internet e Web;<br />
niente computer, frigoriferi, condizionatori,<br />
radio, televisione.<br />
E non si pensi che un altro disastro<br />
di portata simile sia così<br />
improbabile: nel 2012 si fu ad un<br />
passo da esso, quando un’eruzione<br />
solare di simile potenza mancò<br />
di poco la nostra Terra.<br />
La domanda che sempre più<br />
spesso ci si pone è: che succederebbe<br />
se un evento simile a<br />
quello di Carrington si ripetesse<br />
oggi? E indipendentemente da<br />
prospettive catastrofiche, qual<br />
è l’incidenza degli eventi solari,<br />
anche di piccola e media entità,<br />
su comunicazioni radio, sistemi<br />
di navigazione globali (GNSS) e<br />
sistemi di controllo del traffico<br />
aereo?<br />
Fig. 1 - Le macchie solari osservate e disegnate<br />
da Galileo Galilei.<br />
Fig. 2 - Immagine presa dalla sonda SOHO<br />
dell’ESA.<br />
38 <strong>GEOmedia</strong> n°6-<strong>2020</strong>
TERRA E SPAZIO<br />
Galileo e l’osservazione<br />
scientifica del Sole<br />
Il primo, o perlomeno uno fra i<br />
primi, a scoprire che il Sole, nella<br />
sua fiera potenza, non era esente<br />
da comportamenti anomali<br />
fu, nessuna sorpresa, il nostro<br />
Galileo Galilei. Nell’estate del<br />
1611, in Toscana, Galileo usò il<br />
suo piccolo e rudimentale telescopio<br />
per proiettare l’immagine<br />
del Sole su uno schermo bianco<br />
(deve aver qualche volta provato<br />
ad osservare direttamente con gli<br />
occhi, perché in tarda età diventò<br />
purtroppo quasi cieco). Ciò che<br />
vide e riportò nei suoi appunti<br />
e libri (figura 1) era alquanto<br />
sorprendente: lungi dall’essere un<br />
astro perfetto, esente da impurità<br />
ed imperfezioni, la nostra stella<br />
presentava invece delle piccole<br />
imperfezioni, delle “macchie”: da<br />
qui il termine “macchie solari”<br />
(“Sun Spots”). In realtà, l'osservazione<br />
delle macchie solari, almeno<br />
di quelle più grandi, è possibile<br />
anche ad occhi nudo, seppur<br />
in condizioni particolari (nebbia,<br />
cielo nuvoloso, alba e tramonto).<br />
Gli astronomi cinesi già 2000<br />
anni fa avevano registrato tali<br />
eventi. Solo dopo Galileo e per<br />
mezzo del telescopio, tuttavia, è<br />
cominciata l'osservazione sistematica<br />
della superficie solare.<br />
Oggigiorno abbiamo ben altri<br />
e più potenti telescopi, ma soprattutto<br />
satelliti sonda dedicati<br />
all’osservazione del Sole, come<br />
il satellite SOHO dell’Agenzia<br />
Spaziale Europea. I risultati, tuttavia,<br />
non sono molto dissimili<br />
(figura 2).<br />
Cosa sappiamo del Sole?<br />
Il Sole emette radiazione elettromagnetica<br />
e materia come conseguenza<br />
dei processi di fusione<br />
nucleare che avvengono al suo<br />
interno.<br />
Le radiazioni elettromagnetiche<br />
coprono tutto lo spettro, partendo<br />
dalle onde radio a frequenza<br />
più bassa, passando per le mi-<br />
Fig. 3 - Lo spettro elettromagnetico.<br />
croonde, l’infrarosso, lo spettro<br />
visibile, l’ultravioletto ed arrivare<br />
ai raggi X ed ai raggi gamma (figura<br />
3).<br />
Maggiore la frequenza della<br />
radiazione, maggiore la temperatura<br />
dell’oggetto che emette la<br />
radiazione stessa.<br />
Oltre alle radiazioni elettromagnetiche,<br />
il Sole emette anche<br />
materia, incluse particelle cariche<br />
come elettroni e protoni, che costituisce<br />
il cosiddetto “vento solare”<br />
(“Solar Wind”). In un giorno<br />
di “quiete”, questo vero e proprio<br />
vento di particelle viaggia verso<br />
la Terra con una velocità di 400<br />
chilometri al secondo.<br />
Mentre le radiazioni elettromagnetiche<br />
ionizzano strati diffe-<br />
Fig. 4 - Vento solare e magnetosfera terrestre.<br />
renti dell’atmosfera terrestre, la<br />
cosiddetta ionosfera, creando vari<br />
fenomeni di propagazione (ed influenzando,<br />
come vedremo, i segnali<br />
dei satelliti GNSS), le particelle<br />
cariche vengono intrappolate<br />
dal campo magnetico terrestre,<br />
creando le fasce di particelle della<br />
magnetosfera (figura 4).<br />
Ma, come anticipato, il nostro<br />
astro non è sempre in quiete.<br />
Innanzi tutto presenta periodicamente<br />
sulla sua superficie<br />
delle macchie scure (perché più<br />
“fredde”, si fa per dire, rispetto<br />
al resto della superficie solare), le<br />
già citate macchie solari, o macchie<br />
fotosferiche. Il numero e le<br />
dimensioni delle macchie solari<br />
segue un ciclo mediamente pari<br />
<strong>GEOmedia</strong> n°6-<strong>2020</strong> 39
TERRA E SPAZIO<br />
Fig. 5 - Evolversi dei cicli solari, da Galileo ad oggi.<br />
Fig. 6 - Predizioni sul prossimo ciclo solare, il 25°<br />
(2021 – 2022 circa).<br />
ad undici anni, detto ciclo solare,<br />
che è anche la principale causa<br />
delle periodiche variazioni di<br />
tutti i fenomeni solari che influiscono<br />
sul tempo meteorologico<br />
spaziale (“space weather”) (figure<br />
5, 6).<br />
Ad un maggiore numero di<br />
macchie solari è quasi sempre associata<br />
una maggiore probabilità<br />
di eventi macroscopici, quali i<br />
brillamenti solari (“Solar Flares”)<br />
e le espulsioni di massa coronale<br />
(“Coronal Mass Ejection”,<br />
CME).<br />
I brillamenti solari avvengono<br />
in prossimità di macchie solari<br />
Fig. 7 - Lo “Space Weather” ed i suoi effetti.<br />
e consistono in un<br />
potentissimo “flash” di<br />
energia elettromagnetica<br />
su tutto lo spettro,<br />
fino ai raggi X. Questa<br />
emissione di energia<br />
elettromagnetica può<br />
avere influenza sulla<br />
propagazione delle<br />
onde radio e quindi<br />
sulle radiocomunicazioni<br />
e, in generale, su<br />
tutti i sistemi terrestri<br />
che operano a radiofrequenza.<br />
Le espulsioni di massa<br />
coronale sono espulsioni<br />
di materiale dalla<br />
corona solare, nello<br />
stato di plasma, composto<br />
essenzialmente<br />
da elettroni e protoni,<br />
ma anche di nuclei<br />
di elementi più pesanti, quali<br />
elio, ossigeno e ferro. Insieme a<br />
spettacolari aurore polari (“luci<br />
del Nord” o aurore boreali e<br />
“luci del Sud” o aurore australi),<br />
questi eventi oltre a disturbare le<br />
trasmissioni radio, creare interruzioni<br />
di energia e danneggiare<br />
le linee di trasmissione elettriche,<br />
possono, a causa delle particelle<br />
ionizzate dotate di massa e di alta<br />
energia cinetica, danneggiare,<br />
in modo temporaneo o definitivo,<br />
i componenti elettronici<br />
dei satelliti (microprocessori,<br />
memorie, pannelli solari) ed essere<br />
letali per esseri<br />
umani in viaggio o<br />
in permanenza nella<br />
spazio (per esempio,<br />
gli astronauti della<br />
Stazione Spaziale<br />
Internazionale, ma<br />
anche, cosa poco<br />
conosciuta, viaggiatori<br />
e membri<br />
dell’equipaggio dei<br />
voli transatlantici di<br />
linea ad alta quota).<br />
È importante sottolineare<br />
che tutti<br />
gli eventi legati al<br />
Sole sono di portata gigantesca e<br />
coinvolgono energie elevatissime.<br />
Senza ritornare sull’Evento di<br />
Carrington del 1859, in tempi<br />
molto più recenti, nel marzo<br />
1989, una tempesta geomagnetica,<br />
innescata da una emissione di<br />
massa coronale particolarmente<br />
potente, provocò nove ore di<br />
black-out dell’energia elettrica<br />
nel Quebec canadese, oltre ad<br />
aurore a basse latitudini, interruzioni<br />
nelle trasmissioni radiofoniche<br />
e problemi con vari satelliti<br />
in orbita.<br />
Eventi di minore entità, che tuttavia<br />
provocano anomalie e disagi<br />
in vari contesti (figura 7), sono<br />
molto più frequenti e devono essere<br />
presi in seria considerazione.<br />
Il Sole, lo Space Weather ed i<br />
sistemi GNSS<br />
Il comportamento del Sole, o<br />
“Space Weather”, può influenzare<br />
il comportamento dei sistemi<br />
GNSS, come GPS o Galileo, in<br />
vari modi.<br />
Ricordiamo che il principio alla<br />
base di questi sistemi è la misura<br />
del tempo impiegato da un<br />
segnale radio, opportunamente<br />
modulato, per viaggiare da un satellite<br />
al ricevitore dell’utente.<br />
D’altra parte i segnali radio<br />
provenienti dai satelliti devono<br />
passare attraverso la ionosfera<br />
terrestre. Il plasma di particelle<br />
cariche della ionosfera “piega”<br />
(rifrange) il percorso dei segnali<br />
radio GNSS, un po’ come una<br />
lente agisce sul passaggio di un<br />
raggio di luce.<br />
In situazioni di comportamento<br />
solare “quieto”, i ricevitori<br />
GNSS, anche quelli più semplici<br />
ed economici, compensano gli<br />
effetti della ionosfera attraverso<br />
l’uso di modelli matematici alquanto<br />
fedeli. Tali modelli falliscono<br />
quando il comportamento<br />
solare è anomalo e ne conseguono<br />
sostanziali modifiche della<br />
ionosfera. Si hanno quindi come<br />
risultato degli errori di propaga-<br />
40 <strong>GEOmedia</strong> n°6-<strong>2020</strong>
TERRA E SPAZIO<br />
Fig. 8 - Effetti della ionosfera sui sistemi GNSS.<br />
zione molto alti, che si riflettono<br />
in più alti errori sulla stima della<br />
posizione e del tempo, ovvero,<br />
in alcuni casi, all’impossibilità di<br />
fatto di utilizzare alcuni dei satelliti<br />
(figura 8).<br />
Tale è l’importanza dei sistemi<br />
GNSS nelle attività industriali ed<br />
economiche della nostra società<br />
(in particolare quelle “safety critical”<br />
come i trasporti aerei), che si<br />
pone la necessità di studiare continuamente<br />
i fenomeni solari per<br />
adattare in tempo reale i nostri<br />
modelli della ionosfera e fornire<br />
segnalazioni di allarme agli utenti<br />
nel caso di eventi gravi.<br />
Per questo motivo la Commissione<br />
Europea ha promosso e<br />
recentemente lanciato il progetto<br />
“Galileo Ionosphere Prediction<br />
Service (IPS)” (figura 9), il quale<br />
ha lo scopo di monitorare,<br />
attraverso una rete di sensori, la<br />
composizione della ionosfera e<br />
la sua evoluzione in presenza di<br />
eventi solari. Le informazioni e<br />
gli eventuali “allarmi” vengono<br />
distribuiti continuamente agli<br />
utenti attraverso un portale<br />
pubblico (l’iscrizione è gratuita)<br />
(https://ionospheric-prediction.<br />
jrc.ec.europa.eu/). Il servizio IPS<br />
è attualmente gestito dal “Joint<br />
Research Center” (JRC) della<br />
Commissione Europea, in Ispra,<br />
sul lago Maggiore, in provincia<br />
di Varese.<br />
Le informazioni distribuite da<br />
IPS riguardano non solo il territorio<br />
europeo ma tutta la superficie<br />
terrestre e sono fornite in tre<br />
orizzonti temporali: tempo reale,<br />
30 minuti e 24 ore di anticipo.<br />
IPS genera più di 160 prodotti<br />
in quattro differenti<br />
aree:<br />
1. Fisica del Sole:<br />
a. Detezione<br />
automatica delle regioni<br />
solari attive e<br />
valutazione della probabilità<br />
di brillamenti<br />
(“flares”);<br />
b. Predizione ed allarmi<br />
su brillamenti ed emissioni<br />
di massa coronale (“CME’s”);<br />
c. Misure su particelle solari<br />
ad alta energia (“Solar Energetic<br />
Particles”, SEP) e su raggi cosmici<br />
di origine galattica.<br />
2. Ionosfera: misura e predizioni<br />
della composizione della<br />
ionosfera in termini del suo contenuto<br />
di elettroni liberi (“Total<br />
Electron Content”, TEC);<br />
3. Prestazioni dei sistemi<br />
GNSS: stima e predizione sugli<br />
errori indotti dalla situazione<br />
ionosferica sulle misure di posizione<br />
a livello ricevitore utente<br />
(figura 10);<br />
4. Prestazioni delle applicazioni<br />
basate su GNSS:<br />
a. Stime e predizioni delle<br />
prestazioni di posizionamento<br />
e tempo con riferimento ad un<br />
numero di stazioni selezionate;<br />
b. Stime e predizioni delle<br />
prestazioni a livello globale.<br />
Iniziative come quelle dell’IPS<br />
contribuiranno sicuramente non<br />
solo a meglio conoscere il nostro<br />
Sole ed i suoi comportamenti,<br />
ma, e soprattutto, a saperne<br />
gestire le implicazioni sull’organizzazione<br />
della nostra società,<br />
anche negli aspetti più minuti<br />
della nostra vita quotidiana.<br />
Una nota conclusiva: numerosi<br />
scienziati, alcuni di essi italiani,<br />
sostengono la tesi di una relazione<br />
di causalità tra fenomeni<br />
solari e fenomeni geofisici, quali<br />
terremoti ed eruzioni vulcaniche.<br />
In particolare, si sarebbe notata<br />
una forte correlazione statistica<br />
fra minimi del ciclo solare e stato<br />
di attività dei vulcani. In questi<br />
mesi siamo al minimo del ciclo<br />
solare passato ed all’inizio del<br />
nuovo (il venticinquesimo) e<br />
l’Etna ha ripreso ad eruttare…<br />
Fig. 9 - Il portale del servizio di predizione ionosferica della<br />
Commissione Europea.<br />
Fig. 10 - Probabilità a livello globale che un ricevitore<br />
GNSS perda l’ “aggancio” al segnale<br />
PAROLE CHIAVE<br />
GNSS; Space Weather; GPS; Galileo;<br />
macchie solari; Galileo Galilei; ionosfera; brillamenti;<br />
eruzioni solari; propagazione ionosferica<br />
ABSTRACT<br />
The behaviour of our star, the Sun, also known<br />
as "Space Weather" may affect our technological<br />
society and our daily lives in various ways.<br />
Major events, already occurred in the past and<br />
not so unlikely, would have catastrophic effects<br />
on our civilization, heavily based on electricity,<br />
wireless communications and electronics.<br />
But even less disastrous (but much more<br />
frequent) solar anomalies might affect some of<br />
our critical infrastructures, such as the GNSS<br />
systems (GPS and Galileo), in terms of performance<br />
and availability. For this reason, increasing<br />
attention is being spent, also in Europe, on<br />
the study of the Sun and on the prediction of<br />
its anomalies.<br />
AUTORE<br />
Dott. ing. Marco Lisi<br />
ingmarcolisi@gmail.com<br />
Independent Consultant<br />
Aerospace & Defense<br />
<strong>GEOmedia</strong> n°6-<strong>2020</strong> 41
AEROFOTOTECA<br />
L’AEROFOTOTECA<br />
NAZIONALE<br />
RACCONTA....<br />
la lettura delle fotografie aeree<br />
in archeologia: tracce e false<br />
tracce<br />
di Giorgio Franco Pocobelli<br />
È noto che le fotografie aeree<br />
costituiscono uno strumento di<br />
lavoro utile per specialisti che<br />
provengono da settori scientifici<br />
differenti – urbanisti, paesaggisti,<br />
geografi, geologi, agronomi<br />
– e si rivelano in particolar<br />
modo indispensabili per gli<br />
archeologi che si occupano degli<br />
studi di topografia antica riguardanti<br />
il territorio e le città antiche.<br />
E questo è tanto più vero<br />
se prendiamo in considerazione<br />
le fotografie aeree scattate nei<br />
decenni intorno alla metà del<br />
‘900, immagini talvolta definite<br />
“storiche”, che costituiscono l’unica<br />
testimonianza di una realtà<br />
paesaggistica oggi profondamente<br />
mutata per l’espansione dei<br />
centri abitati ed il diverso assetto<br />
agrario realizzato, in Italia a partire<br />
dalla riforma fondiaria del<br />
secondo dopoguerra.<br />
Basilare diventa dunque la<br />
consultazione di tali immagini<br />
che escludendo le società private,<br />
non facilmente accessibili,<br />
può essere effettuata presso gli<br />
archivi di Firenze dell’Istituto<br />
Geografico Militare (IGM),<br />
dove si conservano i voli ad<br />
alta quota effettuati per la realizzazione<br />
della cartografia<br />
ufficiale dello stato italiano, e<br />
dell’Aerofototeca Nazionale a<br />
Roma, presso la sede dell’Istituto<br />
Centrale del Catalogo e della<br />
Documentazione (AFN-ICCD).<br />
In linea di massima, dal punto<br />
di vista archeologico, i rilievi<br />
dell’IGM si dimostrano utili<br />
soprattutto per gli studi mirati<br />
alla ricostruzione della viabilità<br />
antica o al riconoscimento<br />
delle grandi infrastrutture (acquedotti,<br />
centuriazioni, ecc.),<br />
considerando l’ampiezza del<br />
territorio rappresentato su ogni<br />
singolo fotogramma (si pensi<br />
che le immagini del c.d. “volo<br />
Base” del 1954/55 sono in scala<br />
1:33.000), mentre il patrimonio<br />
fotografico dell’AFN risulta particolarmente<br />
adatto per gli studi<br />
sugli insediamenti antichi e sulle<br />
necropoli. Esso infatti è composto<br />
da numerose collezioni, acquistate<br />
o donate nel tempo, tra<br />
le quali risulta di notevole valore<br />
il fondo MAPRW, nella sua parte<br />
c.d. RAF (Royal Air Force), le<br />
cui immagini, scattate dalle forze<br />
alleate tra il 1943 ed il 1945<br />
per motivi bellici con il fine di<br />
identificare gli obiettivi da colpire<br />
nelle incursioni aeree (strade,<br />
ferrovie, ponti, industrie,<br />
strutture portuali e aeroportuali,<br />
ecc.), sono più ravvicinate e documentano<br />
un paesaggio ormai<br />
scomparso che, caratterizzato da<br />
grandi tenute con un reticolo<br />
viario poco sviluppato per il<br />
rado popolamento, ancora permetteva<br />
di leggere chiaramente<br />
le caratteristiche riconducibili<br />
alle diverse sistemazioni di epoche<br />
precedenti, come in un palinsesto<br />
topografico.<br />
La stessa storia dell’Aerofototeca<br />
Nazionale ha un particolare<br />
legame con le ricerche<br />
d’ambito archeologico: Dinu<br />
Adamesteanu, il primo direttore,<br />
è considerato dagli specialisti<br />
uno dei padri nobili dell’aerotopografia<br />
archeologica, essendo<br />
egli stesso un archeologo; archeologa<br />
era anche Giovanna Alvisi,<br />
che gli succedette nella direzione<br />
dell’ufficio, come anche l’attuale<br />
responsabile, Elizabeth J.<br />
Shepherd (per la storia dell’Aerofototeca<br />
si veda la pagina<br />
ufficiale dell’istituto http://<br />
www.iccd.beniculturali.it/it/<br />
Aerofototeca-Nazionale/storia).<br />
Fig. 1 - Dettaglio di una fotografia aerea della città etrusca di Vulci scattata della RAF nel 1944 (a sinistra). A destra: le tracce archeologiche cartografate<br />
su Modello Digitale del Terreno (DTM) (Da Guaitoli 2003).<br />
42 <strong>GEOmedia</strong> n°6-<strong>2020</strong>
AEROFOTOTECA<br />
Fig. 2 - Schema delle tracce archeologiche: da vegetazione (A); da umidità (B); da microrilievo (C); da alterazione della composizione del terreno (D)<br />
(Da Guaitoli 2003)..<br />
Le tracce archeologiche<br />
L’utilità delle fotografie aeree è<br />
rappresentata dalla possibilità<br />
di riconoscere le strutture archeologiche<br />
sepolte attraverso la<br />
manifestazione sui fotogrammi<br />
di “tracce”, che possono essere<br />
individuate con una visione<br />
dall’alto, tanto da permettere di<br />
definire con precisione lo sviluppo<br />
geometrico di edifici e sepolture<br />
o l’andamento dei tracciati<br />
stradali. Tali tracce, per i motivi<br />
che ne determinano la comparsa,<br />
possono essere raggruppate<br />
in due grandi classi: tracce dirette,<br />
ovvero quando gli elementi<br />
sepolti influiscono attivamente<br />
sulla formazione dell’anomalia<br />
fotografica, e tracce indirette,<br />
nel caso in cui le evidenze archeologiche<br />
sono individuate per<br />
fattori non imputabili al bene<br />
stesso.<br />
Al primo gruppo sono ascrivibili<br />
le tracce da vegetazione, da<br />
umidità, da microrilievo e da<br />
alterazione del terreno, mentre<br />
al secondo appartengono quelle<br />
difinite da sopravvivenza e da<br />
anomalia.<br />
Le tracce da vegetazione (cropmarks<br />
in inglese) si manifestano<br />
quando i resti sepolti interferiscono<br />
direttamente con l’apparato<br />
radicale delle piante, con<br />
conseguente alterazione cromatica<br />
della vegetazione facilmente<br />
distinguibile sia nelle immagini<br />
pancromatiche che a colori. Nel<br />
caso di un muro, per esempio,<br />
o una strada o qualsiasi altro<br />
elemento costruito, il minore<br />
spessore di terreno fertile in<br />
corrispondenza della struttura<br />
interrata influenza negativamente<br />
la crescita e la colorazione del<br />
manto vegetale, che risulterà<br />
meno verdeggiante e rigoglioso<br />
rispetto all’area circostante,<br />
determinando sulla fotografia<br />
aerea una traccia di tonalità più<br />
chiara. Al contrario, in corrispondenza<br />
di fossati, canali e<br />
tombe interrate, in altri termini<br />
dove è stata effettuata un’azione<br />
di scavo nel terreno, il maggior<br />
spessore di humus consente una<br />
crescita più veloce e rigogliosa<br />
della vegetazione che apparirà<br />
sulle foto aeree come una traccia<br />
con tonalità più scura.<br />
La differenza di spessore del terreno<br />
vegetale in corrispondenza<br />
delle strutture archeologiche,<br />
rispetto all’area circostante, è<br />
anche alla base della comparsa<br />
delle tracce da umidità (soilmarks).<br />
In questo caso, però,<br />
queste si manifestano su superfici<br />
prive di vegetazione e sono<br />
determinate dalla diversificata<br />
capacità di drenaggio ed assorbimento<br />
d’acqua del terreno. Le<br />
alterazioni del substrato dovute<br />
alla presenza di strutture interrate<br />
o cavità, che come per le tracce<br />
di vegetazione si traducono in<br />
un differente spessore del terreno<br />
fertile, comporteranno una<br />
variazione di tonalità dovuta<br />
alla quantità di umidità presente<br />
nel terreno: in corrispondenza<br />
di elementi costruiti, il terreno<br />
subirà un processo di essiccazione<br />
più veloce, con conseguente<br />
formazione di una traccia chiara,<br />
mentre tonalità più scure<br />
per una maggiore presenza di<br />
umidità indicano la presenza di<br />
tombe o tagliate.<br />
Le tracce da microrilievo<br />
(shadow-sites), come indica la<br />
<strong>GEOmedia</strong> n°6-<strong>2020</strong> 43
AEROFOTOTECA<br />
definizione stessa, sono determinate<br />
dal differente andamento<br />
altimetrico della superficie per<br />
la presenza di strutture sotto<br />
il manto vegetale; visibili con<br />
l’aiuto di uno stereoscopio, esse<br />
si manifestano per l’ombra proiettata<br />
quando la ripresa è fatta<br />
con luce radente.<br />
Anche i resti di muratura riportati<br />
in superficie dalle arature,<br />
provocando una alterazione<br />
della composizione del terreno<br />
(soil-sites), determinano una<br />
differenza cromatica che risulta<br />
facilmente riconoscibile dalle<br />
foto aeree.<br />
In tutti questi esempi è direttamente<br />
la struttura interrata che<br />
determina la comparsa di una<br />
delle tracce descritte. Diverso<br />
è invece il caso di una strada<br />
rettilinea che, senza motivo<br />
apparente, compie una leggera<br />
deviazione per riprendere successivamente<br />
lo stesso percorso,<br />
come anche la presenza di<br />
un’area incolta all’interno di un<br />
campo intensamente coltivato<br />
ed arato regolarmente, o con<br />
una zona con vegetazione arbustiva.<br />
Tali esempi servono per<br />
spiegare le c.d. tracce da anomalia.<br />
In altri termini, l’attenzione<br />
del fotointerprete viene attratta<br />
da quegli elementi che appaiono<br />
“estranei” (dunque “anomali”)<br />
rispetto una logica coerente, che<br />
“stonano” con il contesto circostante,<br />
e che potrebbero dunque<br />
celare resti sepolti. In tal senso,<br />
seguendo gli esempi precedenti,<br />
la strada potrebbe essere stata<br />
costretta ad una leggera deviazione<br />
per evitare degli elementi<br />
affioranti, oppure il terreno<br />
potrebbe essere incolto per la<br />
presenza di strutture sepolte,<br />
con conseguente crescita di vegetazione<br />
infestante.<br />
Appartengono alla categoria<br />
delle tracce da sopravvivenza,<br />
invece, gli elementi antichi che<br />
(edifici, viabilità, assetti agrari,<br />
ecc.), influenzando gli sviluppi<br />
successivi, persistono nel paesaggio<br />
e nell’urbanistica attuale.<br />
Ne sono un esempio le divisioni<br />
centuriali della Pianura Padana<br />
che, con le loro strade rettilinee<br />
ad incroci ortogonali, ancora<br />
caratterizzano il panorama agrario<br />
attuale o la struttura regolare<br />
delle antiche colonie romane<br />
(Firenze, Torino, Aosta, ecc.) o<br />
magno greche (Napoli), come<br />
anche la stessa Piazza Navona a<br />
Roma, la cui geometria è determinata<br />
dal più antico stadio di<br />
Domiziano.<br />
Come appare evidente da<br />
quanto sopra descritto, l’individuazione<br />
di una traccia sulla<br />
fotografia ci permette di ipotizzare<br />
la presenza di una struttura<br />
interrata ma, dalla sola lettura<br />
delle immagini, non è possibile<br />
definirne la natura né, tantomeno,<br />
la datazione. In linea di<br />
principio generale, tracce con<br />
forme geometriche ben definite<br />
(lineari, circolari o ad angoli<br />
retti), con un buon margine di<br />
certezza si possono attribuire<br />
a fattori antropici escludendo,<br />
dunque, la possibilità di anomalie<br />
di natura geologica (tra<br />
quest’ultime vanno considerate<br />
le tracce dei paleoalvei). Questa<br />
considerazione, comunque, non<br />
garantisce che una lunga traccia<br />
rettilinea possa essere attribuita<br />
ad una strada d’età romana: anche<br />
un percorso d’età moderna,<br />
dismesso ed abbandonato, o il<br />
tracciato di un metanodotto<br />
determina sulla fotografia aerea<br />
una traccia da vegetazione. È<br />
dunque necessario, prima di<br />
muovere interpretazioni non<br />
supportate da riscontri oggettivi,<br />
eseguire un esame autoptico del<br />
terreno per stabilirne la natura e<br />
la cronologia della traccia aerofotografica.<br />
Fig. 3 - I circoli di Acquaviva di Cagli evidenziati dalla vegetazione (da Baldelli, Pocobelli 2015).<br />
Le false tracce<br />
Abbiamo accennato che le tracce<br />
con forme geometriche regolari<br />
sono, in linea di massima,<br />
da attribuire alla mano dell’uomo.<br />
È però altrettanto vero che<br />
esistono alcune forme in natura<br />
che possono trarre in inganno.<br />
In una recente ricerca, ho avuto<br />
modo di analizzare all’Aerofototeca<br />
le fotografie della zona<br />
di Cagli (loc. Acquaviva) dove<br />
l’allora ispettore di zona della<br />
Soprintendenza delle Marche,<br />
Gabriele Baldelli, era stato in-<br />
44 <strong>GEOmedia</strong> n°6-<strong>2020</strong>
AEROFOTOTECA<br />
formato della presenza di tracce<br />
circolari da vegetazione su alcune<br />
immagini dall’alto. Lo studio<br />
delle foto aeree, a partire dai voli<br />
effettuati dalla RAF nel 1944,<br />
confermava la presenza di una<br />
gran quantità di anomalie circolari,<br />
peraltro in numero maggiore<br />
rispetto le foto più recenti,<br />
alcune anche di notevoli dimensioni<br />
(circa m 50 di diametro).<br />
Sulla base di comparazioni con<br />
le tracce dei tumuli di Cerveteri<br />
e di Tarquinia e dei circoli funerari<br />
della non lontana Matelica,<br />
in prima battuta si è ipotizzato<br />
potessero anch’esse riferirsi a<br />
sepolture monumentalizzate.<br />
Con grande sorpresa, invece,<br />
lo scavo della Soprintendenza<br />
ha dimostrato che i circoli più<br />
grandi erano dovuti a profondi<br />
fossati difensivi con sezione a<br />
“V”, al centro di uno dei quali<br />
si sono individuati i buchi dei<br />
pali di una capanna rettangolare<br />
con parete di fondo absidata<br />
d’età picena, smentendo di fatto<br />
l’ipotesi formulata sulla sola<br />
analisi delle anomalie aerofotografiche.<br />
Ampliando la ricerca, al confine<br />
tra Marche ed Umbria, sulle<br />
immagini aeree si sono riscontrate<br />
altre tracce da vegetazione<br />
anch’esse di forma circolare.<br />
La ricognizione di superficie<br />
e le informazioni raccolte sul<br />
posto, in questo caso, hanno<br />
però dimostrato trattarsi di un<br />
fenomeno naturale non determinato<br />
da interventi antropici.<br />
Tali tracce sono infatti causate<br />
da alcune particolari specie di<br />
funghi (basidiomiceti saprotrofi)<br />
le cui radici – le ife – entrando<br />
in simbiosi con la vegetazione<br />
erbosa possono favorirne la crescita,<br />
che quindi risulterà più rigogliosa<br />
e verdeggiante, oppure<br />
determinarne l’essicazione. La<br />
caratteristica particolare, però,<br />
è che tali formazioni micetiche<br />
hanno la peculiarità di svilupparsi<br />
creando dei veri e propri<br />
Fig. 4 - I “cerchi delle streghe”, anomalie da vegetazione determinate da specie di funghi: in stato di<br />
quiescenza (a sinistra) e in “fioritura” (a destra) (public domain images).<br />
BIBLIOGRAFIA<br />
F. Piccarreta, Manuale di fotografia aerea: uso archeologico,<br />
Roma 1987<br />
G. Alvisi, La fotografia aerea nell’indagine archeologica,<br />
Roma 1989<br />
F. Piccarreta, G. Ceraudo, Manuale di aerofotografia<br />
archeologica, Bari 2000<br />
M. Guaitoli (a c. di), Lo sguardo di Icaro. Le collezioni<br />
dell’Aerofototeca Nazionale per la conoscenza del<br />
territorio (cat. mostra), Roma 2003<br />
C. Musson, R. Palmer, S. Campana, In volo nel<br />
passato. Aerofotografia e cartografia archeologica,<br />
Firenze 2005<br />
G. Ceraudo (a c. di), Archeologia aerea. Studi di<br />
aerotopografia archeologica (rivista specialistica dal<br />
2004)<br />
G. Baldelli, G.F. Pocobelli, I fossati circolari di Acquaviva<br />
di Cagli (PU): analisi aerofotografica e saggi<br />
d’accertamento, in AAerea 9, 2015, pp. 44-56<br />
cerchi regolari che si ampliano<br />
nel tempo, fino a raggiungere<br />
dimensioni anche di decine di<br />
metri di diametro, determinando<br />
quel fenomeno che nella tradizione<br />
popolare è noto con il<br />
nome di “cerchi delle streghe” o<br />
“delle fate” (fairy o elf circles nel<br />
mondo anglosassone). Queste<br />
piante, di cui il fungo costituisce<br />
il frutto o piuttosto il “fiore”,<br />
nel periodo di quiescenza<br />
sono sostanzialmente invisibili<br />
tra la vegetazione. Sulle fotografie,<br />
tuttavia, l’effetto sarà una<br />
traccia da vegetazione del tutto<br />
simile a quelle riscontrate presso<br />
Cagli. Dunque, in questi casi,<br />
per evitare una interpretazione<br />
errata dell’anomalia, oltre al<br />
controllo a terra, risulta assolutamente<br />
determinante lo studio<br />
approfondito delle fotografie<br />
aeree storiche: circoli che nel<br />
tempo non cambiano dimensione<br />
non possono certo essere<br />
ricondotti a "streghe".<br />
ABSTRACT<br />
How do archaeologists use aerial photographs? How<br />
can the marks of buried ancient structures be identified?<br />
Do all the marks in aerial photographs refer to<br />
archaeological structures? Where are WWII RAF aerials<br />
to be found in Italy? Answers to these questions<br />
are given by an archaeologist specialised in aerial photo<br />
interpretation, teacher at the University of Florence<br />
Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici.<br />
PAROLE CHIAVE<br />
Fotografia aerea; archeologia; tracce archeologiche;<br />
RAF; Aerofototeca Nazionale<br />
AUTORE<br />
Giorgio F. Pocobelli<br />
giorgiofranco.pocobelli@cnr.it<br />
Archeologo e aerofotointerprete, ricercatore CNR -<br />
Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale, docente<br />
Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici dell’Università<br />
di Firenze<br />
<strong>GEOmedia</strong> n°6-<strong>2020</strong> 45
AGENDA<br />
26 – 28 Aprile 2021<br />
ARQUEOLOGICA 2.0<br />
&GEORES<br />
Valencia (Spain)<br />
www.geoforall.it/kfcxf<br />
5 – 7 Maggio 2021<br />
DRONITALY - Working<br />
with Drones<br />
Bologna (Italy)<br />
www.geoforall.it/kfy44<br />
10-14 Maggio 2021<br />
Conferenza Esri Italia<br />
Digital e Week<br />
Roma (Italy)<br />
www.geoforall.it/kyp8p<br />
19 – Maggio 2021<br />
GEO Business <strong>2020</strong><br />
London (UK)<br />
www.geoforall.it/kf4yh<br />
15 - 18 giugno 2021<br />
Conferenza ASITA 2021<br />
Genova<br />
www.geoforall.it/kyp6f<br />
19 – 23 Luglio 2021<br />
30th International<br />
Cartographic Conference<br />
Firenze (Italy)<br />
www.geoforall.it/kfurw<br />
27 – 30 Settembre<br />
GIScience 2021<br />
2021 Poznan (Poland)<br />
www.geoforall.it/kfrkk<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
LEICA BLK360°<br />
L’imaging laser scanner che semplifica<br />
il modo in cui gli spazi vengono misurati,<br />
progettati e documentati.<br />
La nuova dimensione nella tecnologia di misura<br />
Registra le scansioni e visualizza i dati sul campo in pochi istanti, per essere sicuri di aver<br />
catturato tutto ciò che vi serve prima di lasciare il sito di lavoro.<br />
Genera automaticamente immagini panoramiche a 360° con supporto HDR e flash integrato per<br />
immagini nitide anche in ambienti con scarsa illuminazione.<br />
Sensore per immagini termiche FLIR ® , nei 30 secondi in cui il BLK360° sta catturando le sue<br />
immagini HDR sferiche, viene anche generata un’immagine termica panoramica da 70° V x 360°O.<br />
Nuvole di punti ad alta precisione: 360.000 punti/sec. con risoluzione personalizzabile.<br />
Dimensioni al minimo: solo 16,5 cm x 10 cm con un peso di 1 Kg.<br />
Teorema Milano è in grado di offrire una soluzione “chiavi in mano” che include: BLK360° + software<br />
ReCap Pro, iPad Pro 12,9”, kit di accessori, training formativi da parte di tecnici specialisti.<br />
Contattaci, scoprirai molto di più.
Sede in Italia<br />
Più di 100 distributori nel mondo<br />
Una linea di prodotti Made in Italy<br />
Dove siamo Chiamaci Contaaci<br />
Seguici sui Social<br />
Viale dell’Industria 53<br />
20037, Paderno Dugnano (MI)<br />
Tel. +39 02 78619201<br />
www.stonex.it<br />
info@stonex.it - italia@stonex.it