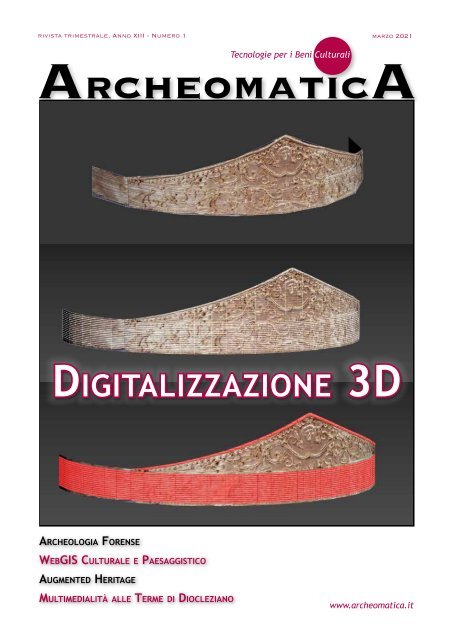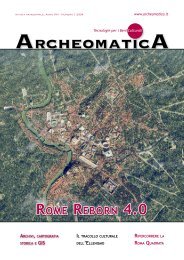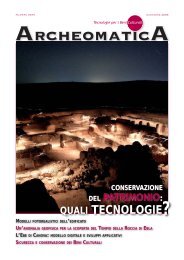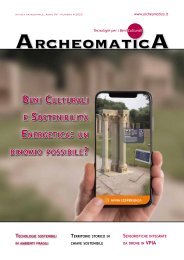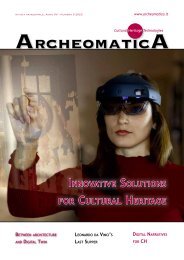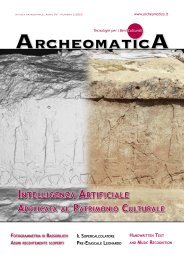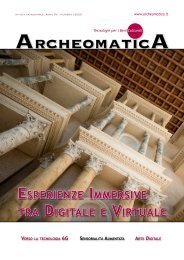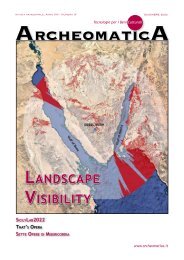Archeomatica 1 2021
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
ivista trimestrale, Anno XIII - Numero 1 marzo <strong>2021</strong><br />
ArcheomaticA<br />
Tecnologie per i Beni Culturali<br />
Digitalizzazione 3D<br />
Sczzzzzz<br />
Archeologia Forense<br />
WebGIS Culturale e Paesaggistico<br />
Augmented Heritage<br />
Multimedialità alle Terme di Diocleziano<br />
www.archeomatica.it
EDITORIALE<br />
Tecniche di Riconoscimento Fotografico<br />
In questo numero di <strong>Archeomatica</strong> scopriamo o ricordiamo, attraverso i suoi autori nelle diverse<br />
applicazioni, alcune abilità e facilitazioni che la georeferenziazione, la modellazione 3D, il rendering,<br />
la realtà aumentata e infine l’intelligenza artificiale consentono di svolgere in parziale automazione,<br />
ma che in tempi ancora recenti erano considerate una prerogativa della mente umana, anche<br />
geniale, enimigmistica, su base neuronale, abbastanza rara e parte consistente di una formazione<br />
professionale. Ritrovare le persone, ricostruire un oggetto prezioso disperso, identificare un territorio<br />
attraverso i suoi mutamenti, ripristinare in anastilosi virtuale un sito storico o archeologico perfino<br />
invisibile all’occhio umano e anche isolare un virus sono tutti traguardi raggiungibili con la rapidità<br />
di un test dalla potenza d’immagazzinamento di una banca dati computerizzata in uno smartphone.<br />
Per una rivista che si addentra nella studio e nella ricerca tecnologica di beni culturali è immediato<br />
chiedersi a che punto sia il riconoscimento fotografico. Una tecnica fondamentale nel recupero degli<br />
oggetti d’arte dispersi, distrutti, smarriti, rubati o anche solo esportati o ritrovati nel tentativo<br />
di andare incontro ad un mercato e ad un’offerta migliore per chi voglia valorizzare una risorsa<br />
economica peculiare al paese, turisticamente forse il più sviluppato al mondo, se si eccettua lo<br />
sforzo di valorizzazione compiuto dagli Stati Uniti, sul piano degli acquisti di opere d’arte: proteggere<br />
un pezzo della storia e l’interesse di beni che ancora possono essere privati. Debbano cioé poter<br />
appartenere ad un individuo e ad ogni individuo in una comunità quanto estesa, che possa e voglia<br />
mantenerlo proprio perché intrinsecamente, per definizione, non solo superfluo e sregolato, quanto<br />
utile e fruibile. A questo scopo esiste dal 1968 in Italia, come tutti sanno, il Nucleo di Tutela delle<br />
opere d’arte, che si avvale, nei ritrovamenti, di una banca dati di centinaia di migliaia di oggetti<br />
d’arte spariti che consente di identificarli nell’eventualità di una loro destinazione fortuita, con<br />
tecnologie di documentazione del bene analoghe a quelle delle banche dati amministrative regionali<br />
e del Ministero della Cultura, che devono intervenire conservativamente in ogni casualità di rischio<br />
e misconoscenza del suo stato di degrado relativo, non solo in caso di calamità, come avvenuto nel<br />
territorio delle Marche, e illustrato in questo numero fino alla realtà di crollo totale degli edifici di un<br />
quartiere, ma nello svolgersi di eventi e nella routine dell’alta frequentazione. Non è detto, infatti,<br />
che un museo che non apra al pubblico conservi al meglio le sue opere: fra i casi di dispersione di<br />
oggetti artistici ci sono anche quelle di abbandono della memoria. A questo proposito, è esemplare<br />
il lavoro svolto dal Museo delle Terme di Diocleziano, un museo a giardino non solo affollato dai<br />
visitatori, ma sempre bersagliato dalle mire di turisti in caccia di souvenirs su commissione. In questo<br />
numero, con il rifacimento della banca dati del Louvre, che ora si presenta on line autonomamente<br />
dalle banche dati nazionali Atlas e Joconde in una veste nuova, più virtuale, più dedicata alla fruizione<br />
in dettaglio, anche competitiva con i musei statunitensi, è importante accennare qui che l’ICCD,<br />
ha a sua volta sviluppato on line un nuovo interfaccia del Catalogo Generale dei Beni Culturali che<br />
consente l’identificazione, per un pubblico non necessariamente colto o introdotto alle dinamiche<br />
computerizzate con App su smartphone implementate, di oltre un milione di schede di opere d’arte<br />
che costituiscono il patrimonio protetto dallo stato italiano, un sistema che a partire dagli anni<br />
Settanta ha conosciuto innumerevoli rivoluzioni di tecnologie di archiviazione, sempre fondate sugli<br />
stessi principi costituzionali di fruibilità pubblica, ma anche di smart working per ricercatori, DAD,<br />
disabili e turisti. Tutti sanno che l’Intelligenza Artificiale riconosce una fotografia marcata ed è in<br />
grado di intercettarla in qualsiasi banca dati connessa, molto pochi ancora sono addentrati, viceversa,<br />
nella simulazione ottenibile da una fotografia, perfino da una stampante 3D, di colori e di valori tattili<br />
o uditivi, percettivi, nel senso più ampio, dell’oggetto artistico fino alla sua sofisticazione materiale,<br />
prima di tutto dell’immagine in rete: la tentazione di Instagram è forse il campione di questa presa<br />
di realtà della vita artistica della fotografia con sue regole di riconoscimento estetico. Nel saggio<br />
L’opera d’arte nella sua riproducibilità tecnica (1935) Walter Benjamin consolidava la fotografia in<br />
bianco e nero, esaltatane la valenza simultanea di cronaca ed arte, come strumento di studio nella<br />
sua pretesa di obbiettività, una volta giunta alla stampa tipografica. Naturale che un dipinto, come<br />
accaduto all’Ecce homo tolto di recente all’Asta di Ansorena a Madrid, per entrare nell’attualità,<br />
non venga immediatamente riconosciuto nella fotografia in bianco e nero pubblicatane da Roberto<br />
Longhi su Paragone nel 1954, dicendolo derivazione dall’Ecce homo di Palazzo Bianco a Genova, che<br />
per primo attribuiva a Caravaggio; inaspettato invece che il valore irrisorio di base d’asta del quadro<br />
seicentesco, si dice 1500 euro, sia massificato al punto tale da raggiungere appena la quotazione<br />
che avrebbe la sua fotografia originale, pubblicata da Longhi, fra i collezionisti e gli amatori. Forse<br />
solo questo dovrebbe far riflettere, attraverso la linea, su quanti e quali fossero i grandi artisti del<br />
Seicento, anche italiani, che gli storici successivi riconobbero pari a Caravaggio, tanto da ingannare<br />
l’alta risoluzione.<br />
Buona lettura,<br />
Francesca Salvemini
IN QUESTO NUMERO<br />
DOCUMENTAZIONE<br />
6 Il Tesoro di Sant’Eufemia<br />
rinasce in 3D - Esempio di<br />
digitalizzazione di reperti<br />
non direttamente fruibili<br />
di Francesco La Trofa, Gabriele<br />
Simonetta, Felicia Villella<br />
L'immagine di copertina di questo numero<br />
è composta da un insieme di figure estratte<br />
dell'articolo "Il Tesoro di Sant'Eufemia rinasce<br />
in 3D", che raffigurano il processo di digitalizzazione<br />
del diadema. Si tratta della vista<br />
assonometrica del risultato della mappatura<br />
unwrap, dell'incremento di dettaglio sulla geometria<br />
di base e della selezione dei dettagli<br />
aggiuntivi del diadema.<br />
16 Multimedialità alle<br />
Terme di Diocleziano<br />
2010-2020: 10 anni di<br />
esperienze al Museo<br />
Nazionale Romano<br />
di Carlotta Caruso<br />
Segui l'account di <strong>Archeomatica</strong><br />
su Twitter, Facebook e Instagram<br />
ArcheomaticA<br />
Tecnologie per i Beni Culturali<br />
Anno XIII, N° 1 - MARZO <strong>2021</strong><br />
<strong>Archeomatica</strong>, trimestrale pubblicata dal 2009, è la prima rivista<br />
italiana interamente dedicata alla divulgazione, promozione<br />
e interscambio di conoscenze sulle tecnologie per la tutela,<br />
la conservazione, la valorizzazione e la fruizione del patrimonio<br />
culturale italiano ed internazionale. Pubblica argomenti su<br />
tecnologie per il rilievo e la documentazione, per l'analisi e la<br />
diagnosi, per l'intervento di restauro o per la manutenzione e,<br />
in ultimo, per la fruizione legata all'indotto dei musei e dei<br />
parchi archeologici, senza tralasciare le modalità di fruizione<br />
avanzata del web con il suo social networking e le periferiche<br />
"smart". Collabora con tutti i riferimenti del settore sia italiani<br />
che stranieri, tra i quali professionisti, istituzioni, accademia,<br />
enti di ricerca e pubbliche amministrazioni.<br />
Direttore<br />
Renzo Carlucci<br />
dir@archeomatica.it<br />
Direttore Responsabile<br />
Michele Fasolo<br />
michele.fasolo@archeomatica.it<br />
Comitato scientifico<br />
Annalisa Cipriani, Maurizio Forte,<br />
Bernard Frischer, Giovanni Ettore Gigante,<br />
Mario Micheli, Stefano Monti,<br />
Francesco Prosperetti, Marco Ramazzotti,<br />
Antonino Saggio, Francesca Salvemini,<br />
Rodolfo Maria Strollo<br />
Redazione<br />
Maria Chiara Spezia<br />
redazione@archeomatica.it<br />
Licia Romano<br />
licia.romano@archeomatica.it<br />
Valerio Carlucci<br />
valerio.carlucci@archeomatica.it<br />
Luca Papi<br />
luca.papi@archeomatica.it
22 Un sistema Web-GIS dei<br />
Beni di Interesse Culturale e<br />
Paesaggistico nelle Marche<br />
di Annalisa Conforti, Giovanni<br />
Issini, Camilla Tassi, Sara Trotta,<br />
Luigi Federico D’Amico, Eva Savina<br />
Malinverni<br />
RUBRICHE<br />
32 AZIENDE E<br />
PRODOTTI<br />
Soluzioni allo Stato<br />
dell'Arte<br />
35 RECENSIONE<br />
36 AGORÀ<br />
Notizie dal mondo delle<br />
Tecnologie dei Beni<br />
Culturali<br />
28 L'Archeologia<br />
Forense e<br />
la Ricerca<br />
di Persone<br />
Scomparse<br />
di P. M. Barone<br />
42 EVENTI<br />
INSERZIONISTI<br />
BMTA 43<br />
Codevintec 39<br />
ESRI 44<br />
Geomax 26<br />
Gter 35<br />
HUBSTRACT 27<br />
NAIS 21<br />
Planetek 2<br />
Teorema 42<br />
una pubblicazione<br />
Science & Technology Communication<br />
Science & Technology Communication<br />
Diffusione e Amministrazione<br />
Tatiana Iasillo<br />
diffusione@archeomatica.it<br />
MediaGEO soc. coop.<br />
Via Palestro, 95<br />
00185 Roma<br />
tel. 06.64.87.12.09<br />
fax. 06.62.20.95.10<br />
www.archeomatica.it<br />
Progetto grafico e impaginazione<br />
Daniele Carlucci<br />
daniele@archeomatica.it<br />
Editore<br />
MediaGEO soc. coop.<br />
<strong>Archeomatica</strong> è una testata registrata al<br />
Tribunale di Roma con il numero 395/2009<br />
del 19 novembre 2009<br />
ISSN 2037-2485<br />
Stampa<br />
System Graphic Srl<br />
Via di Torre Santa Anastasia 61 00134 Roma<br />
Condizioni di abbonamento<br />
La quota annuale di abbonamento alla rivista è di<br />
€ 45,00. Il prezzo di ciascun fascicolo compreso<br />
nell’abbonamento è di € 12,00.<br />
Il prezzo di ciascun fascicolo arretrato è di<br />
€ 15,00. I prezzi indicati si intendono Iva inclusa.Per<br />
abbonarsi: www.archeomatica.it<br />
Gli articoli firmati impegnano solo la responsabilità<br />
dell’autore. È vietata la riproduzione anche parziale<br />
del contenuto di questo numero della Rivista<br />
in qualsiasi forma e con qualsiasi procedimento<br />
elettronico o meccanico, ivi inclusi i sistemi di<br />
archiviazione e prelievo dati, senza il consenso scritto<br />
dell’editore.<br />
Data chiusura in redazione: 20 aprile <strong>2021</strong>
DOCUMENTAZIONE<br />
Il Tesoro di Sant’Eufemia rinasce in 3D<br />
Esempio di digitalizzazione di reperti non direttamente fruibili<br />
di Francesco La Trofa, Gabriele Simonetta, Felicia Villella<br />
Fig. 1 – Il tesoro di Sant’Eufemia, immagine d’archivio.<br />
Gli strumenti digitali consentono di ripensare<br />
radicalmente i modelli di fruizione museali, grazie alla<br />
possibilità di arricchire le collezioni degli istituti della<br />
cultura e generare nuove esperienze per il pubblico.<br />
Facendo riferimento al caso studio del Tesoro di<br />
Sant’Eufemia, un gruppo di gioielli in oro di epoca<br />
ellenistica rinvenuti fortuitamente in Calabria verso la<br />
fine dell’Ottocento, oggi conservato presso il British<br />
Museum di Londra, si è sperimentato un processo di<br />
ricostruzione tridimensionale del reperto principale, il<br />
diadema, attraverso l’elaborazione delle sole immagini<br />
disponibili in archivio.<br />
I<br />
risultati ottenuti dalla ricerca<br />
proposta mirano ad ampliare<br />
l’offerta culturale dei tradizionali<br />
istituti della cultura.<br />
Nell’ottica di un continuo aggiornamento<br />
dei contenuti e in<br />
relazione anche alle recenti restrizioni<br />
imposte dall’emergenza<br />
sanitaria, è apparso indispensabile<br />
dotare i piccoli e grandi<br />
musei italiani di ogni strumento<br />
che possa favorire la fruizione<br />
dei beni al di là della chiusura<br />
fisica dei suddetti luoghi, oltre<br />
che considerare quei casi in cui<br />
i reperti non possano essere direttamente<br />
fruibili a causa di innumerevoli<br />
variabili.<br />
Il lavoro nasce da una esigenza<br />
iniziale che ben si sposa con la<br />
recente situazione imposta al sistema<br />
museale nazionale: il caso<br />
studio del Tesoro di Sant’Eufemia.<br />
Scoperto alla fine del XIX secolo<br />
in circostanze non del tutto<br />
chiare, rappresenta un unicum<br />
sia per la tipologia dei reperti<br />
inclusi nella collezione sia per la<br />
vicenda legata alla vendita del<br />
Tesoro per il British Museum di<br />
Londra che ha privato, in tempi<br />
non sospetti, di un gruppo di reperti<br />
unici nel loro genere il Museo<br />
archeologico Lametino, sito<br />
a Lamezia Terme in provincia di<br />
Catanzaro.<br />
Il gruppo di gioielli in oro del<br />
periodo magnogreco rappresenta<br />
un ritrovamento eccezionale,<br />
testimone delle maestranze orafe<br />
del tempo e della ricchezza<br />
del popolo che ha abitato questi<br />
luoghi: la possibilità di visionare<br />
in situ una simile testimonianza<br />
andrebbe non solo a beneficio<br />
del sistema museale ma di tutto<br />
il turismo culturale e accademico<br />
che si genererebbe di riflesso.<br />
6 ArcheomaticA N°1 marzo <strong>2021</strong>
Tecnologie per i Beni Culturali 7<br />
Secondo le premesse è apparso, quindi, chiaro come puntare<br />
l’attenzione a reperti del genere prospetterebbe un ottimo<br />
risultato sia dal punto di vista scientifico, permettendo<br />
di riprodurre la collezione potendone studiare le fattezze<br />
e la lavorazione, sia da un punto di vista della fruizione,<br />
allargando la possibilità al museo stesso di dedicare parte<br />
di una delle sale alla sezione didattico-tattile, allineandosi<br />
con il processo di inclusione totale a cui il sistema museale<br />
nazionale sta via via implementandosi, oltre che di un reparto<br />
dedito alla realtà aumentata.<br />
Per queste ragioni, lo studio ha usato una serie di immagini<br />
di archivio gratuitamente accessibili sul sito ufficiale del<br />
British Museum per produrre una ricostruzione del diadema<br />
del Tesoro, il pezzo maggiormente evocativo dell’intera collezione;<br />
riservandosi in futuro l’ampliamento della ricostruzione<br />
all’intera collezione di ori.<br />
LA COLLEZIONE: ANAMNESI<br />
Il Tesoro di Sant’Eufemia è costituito da un gruppo di gioielli<br />
in oro: un diadema, una lunga collana con protomi leonine e<br />
un pendente in oro a castone ovale, un terminale di collana,<br />
sei catenelle con tre pendenti probabilmente montate in<br />
origine con il pendente ovale, un frammento di catenina,<br />
un pendente a protome femminile bifronte, tre terminali<br />
di orecchini con protomi femminili, un anello scarabeo, un<br />
anello ovale con busto di Atena, sei lamine probabilmente<br />
con funzione di cintura, sei pendenti per collana insettiformi,<br />
due dischi e una moneta in bronzo con Persefone che, a<br />
causa della sua datazione, potrebbe non essere direttamente<br />
collegata al Tesoro.<br />
Le circostanze sul ritrovamento risentono fortemente sia<br />
delle modalità attraverso cui le testimonianze ci arrivano<br />
sia perché in più punti le dicerie si fondono con i fatti real-<br />
Fig. 2 – Il tesoro di Sant’Eufemia: il diadema.<br />
mente accaduti: i documenti tramandano che un gruppo di<br />
gioielli sarebbe stato rinvenuto nei primi giorni di aprile del<br />
1865 in seguito ad una pioggia di notevole entità in un uliveto<br />
nei pressi del quartiere odierno di Sant’Eufemia Vetere,<br />
ai piedi di un fondo detto Elemosina, raccolti da Giovanni<br />
Giudice mentre era alla ricerca di legna. Lo stesso si sarebbe<br />
fatto abbindolare da una coppia di compaesani convincendolo<br />
a portarli sul luogo del ritrovamento, perpetuando<br />
la ricerca tanto da rinvenire anche ceramiche e resti di ossa<br />
umane, il cui valore non è stato assolutamente compreso.<br />
Questi ultimi vennero consegnati al custode del fondo di<br />
proprietà di Pasquale Francica, il quale continuò la ricerca,<br />
portando alla luce ulteriori monili in oro che spezzettò per<br />
rivendere ad un orefice locale.<br />
Fig. 3 - Photo gallery d'archivio: immagini selezionate per la ricostruzione 3D.
Solo alcuni mesi dopo il proprietario del fondo venne a conoscenza<br />
dei fatti e cercò di recuperare il tesoro o quello<br />
che ne rimaneva: parte in realtà era già stato fuso.<br />
Vent’anni più tardi un erede della famiglia Francica, Antonio,<br />
fece pubblicare un catalogo per la vendita del tesoro<br />
sorbendo il successo desiderato, tanto che un antiquario<br />
romano, Vincenzo Vitalini, lo acquistò per rivenderlo poi al<br />
British Museum nel 1896; anche se solo nel 1985 l’anello<br />
scarabeo entrò nell’entourage londinese dopo aver soggiornato<br />
in tre collezioni private.<br />
I documenti che giungono fino ai giorni nostri sono stati sottoscritti<br />
dal sindaco di Gizzeria, di Sambiase e di Nicastro,<br />
oltre che da Antonio Francica; si tratta di versioni che presentano<br />
sfumature differenti e che consentono di quantificare<br />
da un punto di vista materiale a quanto ammontasse<br />
l’intero tesoro ritrovato, oltre che alludere alla possibilità<br />
che il sito indagato coincidesse con il sepolcro del tiranno<br />
Agatocle, ivi sepolto con la sua armatura, come testimoniato<br />
da una moneta bronzea che riportava l’incisione Agatocle<br />
Basileo, oggi non pervenuta.<br />
GLI STUDI ARCHEOLOGICI E LO STATO DELL’ARTE<br />
Lo studio ha volto la sua attenzione sul pezzo più rappresentativo<br />
della collezione: il diadema aureo. Si tratta di una<br />
lunga fascia in lamina d’oro saldata ad un frontone triangolare;<br />
la fascia presenta una scanalatura tripartita, ciascuna<br />
delle scanalature presenta una ulteriore tripartizione e tre<br />
gruppi di cerchi punzonati; le estremità, infine, presentano<br />
due ganci a spirale. Sia il frontone che la lamina sono riccamente<br />
decorati da volute floreali simmetriche composte<br />
sia da spirali perlinate che steli lisci: è possibile individuare<br />
anche la tipologia floreale proposta, piccole rose e fiori a<br />
calice. La parte apicale del frontone presenta una figura<br />
antropomorfa, forse il titano Elio, oppure una figura apotropaica,<br />
una testa di Gorgone.<br />
La presenza di diversi decori che riconducono alla spirale<br />
ha permesso di identificare questa decorazione come tratto<br />
distintivo di più pezzi della collezione, portando gli studiosi<br />
del settore a ipotizzare un unico maestro orafo che avrebbe<br />
realizzato tutti i monili, denominato nei cataloghi Maestro<br />
di Sant’Eufemia, il quale li avrebbe realizzati tra il 330 e il<br />
300 a. C.; ipotesi sostenuta anche dal ritrovamento nelle<br />
vicinanze dell’hydria in località Cerzeto, una ceramica riccamente<br />
decorata che riporta tra le sue figure decorazioni<br />
riconducibili agli ori, oggi conservata tra le sale del Museo<br />
archeologico Lametino.<br />
È curioso notare, inoltre, che il diadema presenta una riparazione<br />
antica, quindi si tratta di un gioiello usato realmente<br />
in vita dal suo possessore.<br />
Gli studi degli ori della Magna Grecia aprono un settore particolarmente<br />
battuto e rimandano senza ombra di dubbio<br />
agli Ori di Taranto esposti nel Museo archeologico della città.<br />
Il design dei gioielli, così come lo definiremmo oggi, è ampiamente<br />
omogeneo tra i ritrovamenti delle colonie della<br />
Magna Grecia, questo lascia intendere la presenza di pochi<br />
centri di produzione orafa, uno tra questi potrebbe proprio<br />
essere quello del Maestro di Sant’Eufemia attivo sul finire<br />
del IV secolo a. C. e che si va ad affiancare ai grandi centri<br />
produttivi come quello di Ginosa, di Crispiano e di Canosa.<br />
Un’altra teoria vuole che l’intera collezione, riconducibile<br />
sì ad un unico artigiano, provenga, invece, proprio dai<br />
maggiori centri di produzione pugliese.<br />
LA FRUIZIONE DEI REPERTI MUSEALI TRA ESPERIENZA<br />
FISICA, VIRTUALE ED IBRIDA<br />
La digitalizzazione delle collezioni museali apre allo sviluppo<br />
di nuove esperienze multisensoriali per allestimenti multimediali<br />
ed interattivi in presenza in grado di coinvolgere il<br />
pubblico: dalle gallerie interattive delle opere digitali fino alle<br />
applicazioni in realtà aumentata per aggiungere informazioni<br />
contestuali all’allestimento fisico.<br />
Allo stesso modo, i tour virtuali consentono di raggiungere<br />
online un pubblico altrimenti impossibile da coinvolgere, sia<br />
come alternativa ad una visita tradizionale il cui accesso è interdetto,<br />
sia quale efficace strumento di marketing, in grado<br />
di aumentare la popolarità dell’istituzione e dell’offerta museale.<br />
Il lockdown ha segnato un crollo drammatico degli ingressi,<br />
quantificabili oltre il 70% per la maggior parte dei principali<br />
musei, a partire dal Louvre, che secondo alcune stime avrebbe<br />
perso circa 90 milioni di euro soltanto nel corso del 2020,<br />
Fig. 4 - Creazione della geometria di base. Vista planimetrica e laterale del cilindro di proiezione.<br />
8 ArcheomaticA N°1 marzo <strong>2021</strong>
Tecnologie per i Beni Culturali 9<br />
Fig. 5 - Vista assonometrica. Risultato della proiezione della foto sulla geometria di base.<br />
bilanciati soltanto in parte da 46 milioni di ristori previsti dal<br />
governo francese.<br />
Tuttavia, i lockdown hanno indubbiamente accelerato il percorso<br />
di digitalizzazione in ambito museale, sino a quel momento<br />
esplorato soltanto in via marginale. Particolarmente significativi<br />
i risultati fatti registrare dal Museo Egizio di Torino.<br />
Pur a fronte di un calo di visitatori del 72%, dovuto al periodo<br />
limitato di apertura (solo 185 giorni su 365) e del limitato afflusso<br />
turistico verso il capoluogo piemontese: il museo torinese<br />
ha registrato oltre un milione di visite virtuali attraverso la<br />
produzione di nuove esperienze. In particolare, le “Passeggiate<br />
con il direttore”, hanno consentito agli spettatori virtuali<br />
di visitare le sale del Museo Egizio con la guida autorevole di<br />
Christian Greco. La particolarità del format, costituito da due<br />
ore di visita e trenta minuti di interazione diretta tra il pubblico<br />
e l’egittologo ha riscosso un grande successo anche dal<br />
punto di vista commerciale. Tra le numerose iniziative digitali,<br />
il Museo Egizio ha prodotto una visita virtuale della mostra<br />
“Archeologia Invisibile”, che vede il contributo di numerose<br />
tecnologie 3D, che vanno dalla scansione del reperto alle TAC<br />
per analizzare in maniera non distruttiva il materiale archeologico.<br />
L’allestimento prevede sia ricostruzioni virtuali in 3D che<br />
la riproduzione in scala 1:1 dei gioielli e dei monili perfettamente<br />
conservati all’interno di una coppia di sarcofagi.<br />
Gli strumenti digitali, quindi, consentono di creare nuovi format<br />
per valorizzare gli asset museali in moltissimi modi. La<br />
digitalizzazione delle collezioni costituisce inoltre una notevole<br />
opportunità per rendere finalmente accessibili al pubblico<br />
l’intero patrimonio artistico e culturale che giace nei depositi,<br />
non trovando spazio nelle sale espositive.<br />
Fig. 6 - Vista assonometrica. Selezione dell’area di interesse geometrico e creazione dei vincoli geometrici.
Se gli effetti e le limitazioni della pandemia Covid-19 hanno<br />
proposto il modello di fruizione virtuale quale unico realmente<br />
disponibile durante le fasi più dure dei lockdown,<br />
l’attesissimo new normal dovrebbe fare tesoro delle esperienze<br />
digitali per riprogrammare i modelli di business nella<br />
direzione di sfruttare le tecnologie digitali per valorizzare<br />
nel modo migliore tutte le collezioni e le risorse di cui i musei<br />
dispongono, sia in presenza, con allestimenti innovativi,<br />
che online, grazie alle potenzialità dei tour virtuali e alla<br />
generazione di nuovi contenuti multimediali, capaci di raccontare<br />
storie di straordinario valore ed interesse.<br />
LA DIGITALIZZAZIONE DELLE FONTI INDIRETTE<br />
La disponibilità fisica del reperto consente vari approcci<br />
strumentali per creare il suo equivalente digitale, che nel<br />
caso della scansione 3D consente di ricostruire un modello<br />
3D metrologicamente fedele all’originale. Una collezione<br />
virtuale o una collezione ibrida, costituita in parte da reperti<br />
fisici e in parte digitali costituisce una base di offerta potenzialmente<br />
molto efficace per sviluppare nuove esperienze<br />
museali. In questo contesto rientrano anche quelle opere<br />
che non sono fisicamente disponibili per un’operazione di<br />
rilievo diretto. Si pensi a reperti conservati altrove o andati<br />
irrimediabilmente perduti.<br />
Dal punto di vista tecnologico, l’obiettivo della presente<br />
ricerca è incentrato nella sperimentazione di un metodo<br />
capace di ricreare un modello 3D il più fedele possibile<br />
ad un elemento non disponibile, attraverso l’impiego delle<br />
sole fonti indirette: le immagini del diadema del Tesoro di<br />
Sant’Eufemia.<br />
Lo spunto per questo approccio è derivato dal progetto<br />
Rekrei, dove il crowdsourcing delle immagini disponibili in<br />
rete ha consentito ad un team di ricostruire, grazie alla fotogrammetria<br />
3D, una serie di modelli digitali dei reperti<br />
compromessi dalla furia iconoclasta dell’ISIS durante la sua<br />
occupazione in Siria e nei luoghi settentrionali dell’Iraq.<br />
In particolare, la sperimentazione sul diadema ha consentito<br />
di provare delle alternative di metodo per riprodurre digitalmente<br />
un modello che, pur limitato nelle sue dimensioni, risulta<br />
particolarmente complesso per via della sua morfologia<br />
e della varietà materica da cui è composto.<br />
In questo caso, le immagini disponibili non erano certamente<br />
sufficienti per completare con successo un processo ricostruttivo<br />
basato sulla fotogrammetria 3D, per cui si è preferito<br />
procedere nella costruzione delle reference su cui impostare<br />
una modellazione from scratch, basata sul ricalco delle<br />
varie proiezioni ortogonali ricavate a partire dalle immagini.<br />
Se affrontato da un modellatore 3D dotato di competenze<br />
ed esperienza, oltre al supporto di uno studioso in grado di<br />
identificare con certezza, o con la maggior precisione possibile<br />
le caratteristiche delle varie parti del reperto originale,<br />
questo metodo può costituire un’ottima opportunità<br />
per creare delle collezioni digitali utili a tutte le circostanze<br />
in cui non è fondamentale una precisione metrologica ma è<br />
sufficiente un’elevata identità visiva.<br />
Il modello 3D full color texturizzato può essere utilizzato per<br />
la generazione di immagini, video, contenuti multimediali<br />
interattivi ed esperienze immersive (AR, VR). Allo stesso<br />
modo è possibile realizzare copie fisiche ad alta risoluzione<br />
grazie alla combinazione di varie tecnologie di stampa 3D<br />
con sistemi di produzione tradizionale, in grado di riprodurre<br />
le forme e i materiali previsti, reinterpretando con l’artigianato<br />
digitale lo stesso approccio che avrebbe avuto l’artigiano<br />
orafo del tempo per ottenere, anche in questo caso, un’identità<br />
visiva soddisfacente rispetto al reperto originale.<br />
Una ulteriore opportunità che la ricostruzione digitale basata<br />
sulle fonti indirette può consentire è la creazione dei<br />
modelli tattili. In questo caso l’identità visiva non costituisce,<br />
per ovvie ragioni, il requisito principale, mentre risulta<br />
auspicabile reinterpretare il modello originale per garantire<br />
al pubblico ipovedente un modello digitale dove sia semplice<br />
riconoscere in modo corretto le differenze tra le varie parti<br />
dell’oggetto, oltre alla percezione del suo insieme.<br />
Fig. 7 - Vista frontale dell’editor di mappatura Unwrap. La foto viene deformata fino a farla coincidere con la geometria.<br />
10 ArcheomaticA N°1 marzo <strong>2021</strong>
Tecnologie per i Beni Culturali 11<br />
Fig. 8 - Vista assonometrica del risultato della mappatura Unwrap.<br />
Fig. 9 - Vista assonometria dell’incremento di dettaglio sulla geometria di base.<br />
Fig. 10 - Selezione dei dettagli aggiuntivi.
Fig. 11 – (a) Foto originale da archivio, (b) Foto convertita in bianco e nero, (c) Incremento del contrasto per la definizione dei dettagli.<br />
RICREARE UNA COLLEZIONE DIGITALE IN 3D:<br />
IL DIADEMA DEL TESORO DI SANT’EUFEMIA<br />
La ricostruzione di un qualsiasi bene parte sempre da una<br />
solida base di reference, necessarie per definire tutte le<br />
caratteristiche geometriche e/o materiche dell’oggetto. Da<br />
questa fase dipende la fedeltà di ricostruzione e il grado di<br />
approssimazione con il quale l’oggetto viene restituito nella<br />
sua versione virtuale.<br />
La ricostruzione from scratch è una ricostruzione geometrica<br />
manuale basata sul posizionamento ad hoc di reference<br />
fotografiche sul piano di lavoro digitale. Questo metodo si<br />
basa sul principio delle proiezioni ortogonali, per cui avendo<br />
almeno due foto dell’ oggetto, una frontale e una laterale, è<br />
possibile definirne l’ingombro generale e le sue proporzioni<br />
di massima.<br />
Nel caso del diadema, non è stato possibile ottenere questo<br />
tipo di informazioni, per cui è stato necessario definire un<br />
metodo alternativo per la ricostruzione. Oltre all’impiego<br />
delle fonti fotografiche d’archivio, le altre informazioni utilizzate<br />
per la ricostruzione sono le misurazioni effettuate da<br />
studi precedenti: l*p*h e geometria sottesa di base. Per la ricostruzione<br />
è stato utilizzato il software Autodesk 3DS MAX,<br />
dotato di strumenti che consentono di ricostruire oggetti tridimensionali<br />
partendo, appunto, da photo reference.<br />
Definiti gli ingombri, lo step successivo è stato quello di proiettare<br />
la foto reference sulla geometria appena creata, tramite<br />
mappatura Unwrap.<br />
Questa operazione, che consente di deformare la foto sulla<br />
geometria stessa, ci permette di dettagliare e “bloccare”<br />
per step successivi alcuni punti cardine del diadema.<br />
Una volta originata la geometria di base è possibile concentrarsi<br />
sulla ricostruzione dei dettagli del reperto. Analizzando<br />
e studiando approfonditamente il diadema sono stati<br />
riscontrati due livelli di dettaglio: uno di tipo geometrico e<br />
uno di tipo ornamentale.<br />
Per la ricostruzione dei dettagli geometrici si è proceduto,<br />
in primis, alla ricostruzione tramite gli strumenti “taglio ed<br />
estrusione” della geometria.<br />
12 ArcheomaticA N°1 marzo <strong>2021</strong>
Tecnologie per i Beni Culturali 13<br />
Fig. 12 – (a) Mesh di base definitiva. Esempio di proiezione della mappa di displace con intensità pari a zero; (b) Mesh di base definitiva. Esempio di proiezione della<br />
mappa di displace con intensità pari 0,001 cm; (c) Mesh di base definitiva. Esempio di proiezione della mappa di displace con intensità pari 0,1 cm. Effetto sovradimensionato<br />
per dimostrazione; (d) Mesh di base definitiva. Esempio di proiezione della mappa di displace con intensità pari 0,04. Valore corretto di applicazione.<br />
Data la grande ricchezza dei dettagli, in relazione alla documentazione<br />
disponibile, è sin da subito emersa la complessità<br />
nel riuscire a definire tutti i decori tramite un processo<br />
di ricostruzione geometrica. Per questo motivo si è scelto<br />
di provare un primo passaggio, con l’estrusione dei dettagli<br />
tramite mappa, con una tecnica nota col nome di displace.<br />
Il metodo consiste nel generare un’estrusione della geometria<br />
attraverso un gradiente bianco e nero di una generica<br />
mappa: il nero per il software rappresenta informazione 0,<br />
mentre il bianco informazione 1. Partendo da questo principio<br />
il lavoro è stato quello di convertire la foto di riferimento<br />
in B/N e successivamente, tramite strumenti di editing<br />
foto, è stato possibile contrastare l’immagine fino ad ottenere<br />
una buona visibilità dei dettagli.<br />
In seguito all’ottenimento della mappa di riferimento, è<br />
stata aumentata la definizione della geometria e, in displace,<br />
definito il grado di intensità dei dettagli presenti sul<br />
diadema.<br />
Gli ultimi elementi mancanti per completare il modello<br />
sono i decori floreali presenti sui lati e l’effige antropomorfa<br />
posizionata sull’asse di simmetria. Per la ricostruzione di<br />
questi elementi è stata sufficiente una semplice ricostruzione<br />
geometrica da reference fotografica.<br />
Il risultato ottenuto consente di avere un modello digitale<br />
del reperto utile per un approfondimento degli studi. Dal<br />
punto di vista della modellazione 3D, il soddisfacente esito<br />
della ricostruzione geometrica consente di procedere e<br />
definire ulteriormente il livello di dettaglio dell’apparato<br />
decorativo, con una serie di ipotesi alternative, utili a valutare,<br />
caso per caso, quale sia la soluzione più idonea per le<br />
varie situazioni che si prospettano.<br />
CONCLUSIONI<br />
Scopo dello studio è quello di dimostrare come sia possibile<br />
arricchire le collezioni museali degli istituti della cultura<br />
usufruendo delle più recenti tecniche di ricostruzione 3D.<br />
Il caso studio in esame si riferisce al Tesoro di Sant’Eufemia,<br />
un gruppo di gioielli in oro di epoca magnogreca rinvenuti in<br />
Calabria, conservati nel British Museum di Londra. Il lavoro,<br />
nello specifico, si è incentrato sulla ricostruzione tridimensionale<br />
del diadema della collezione attraverso l’elaborazione<br />
delle sue immagini di archivio.<br />
Per la ricostruzione tridimensionale è stato utilizzato il software<br />
Autodesk 3DS MAX. Tale software è dotato di strumenti<br />
che consentono di ricostruire oggetti tridimensionali<br />
da photo reference. La procedura, nel caso di ricostruzione<br />
da foto di archivio, è totalmente manuale. Non si tratta,<br />
infatti, di ricostruzione da rilevazione diretta (che consente<br />
di ricorrere a tecniche tramite fotogrammetria o rilevazione<br />
grafica 3D), ma di ricostruzione manuale tramite deformazione<br />
delle immagini e conseguente ricostruzione della<br />
mesh.<br />
Definita la geometria di base, si è proceduto successivamente<br />
alla proiezione dei dettagli sulla mesh per la ricostruzione<br />
degli stessi tramite deformazione della geometria da<br />
foto.<br />
Il risultato ottenuto ha carattere del tutto preliminare e<br />
dimostrativo: le immagini prodotte sono il principio di una<br />
serie di declinazioni che permetterebbero di ampliare le<br />
applicazioni di fruizione di un bene: dalla possibilità di realizzare<br />
materialmente il diadema attraverso l’ausilio della<br />
stampa 3D e di aprirsi al mondo del tattile secondo il principio<br />
dell’inclusione totale, all’uso della realtà virtuale immersiva<br />
e della realtà aumentata per una esperienza diretta<br />
e di interazione con i contenuti, al passo con le aspettative<br />
dei visitatori attuali.<br />
Il fine ultimo è quello di permettere di inserire all’interno<br />
delle collezioni museali reperti non fruibili direttamente,<br />
sia perché esposti in luoghi differenti rispetto a quello del<br />
ritrovamento, sia perché di particolare pregio e soggetti a<br />
maggiori restrizioni.
Fig. 13 - Mesh di base definitiva. Aggiunta dei dettagli mancanti.<br />
Fig. 14. - Foto (Render 3D) della ricostruzione virtuale del Diadema in modalità Clay.<br />
Fig. 15 - Foto (Render 3D) della ricostruzione virtuale del Diadema.<br />
14 ArcheomaticA N°1 marzo <strong>2021</strong>
Tecnologie per i Beni Culturali 15<br />
Bibliografia<br />
C. Gattuso, F. Villella, La Cattedrale di Lamezia Terme (CZ) protocollo<br />
di diagnosi: il connubio tra le tecniche 2D per la mappatura del degrado<br />
e la ricostruzione 3D dei particolari architettonici del complesso,<br />
in Campanella L., Piccioli C., Atti del Convegno Diagnosis of Cultural<br />
Heritage (Napoli, NH Ambassador 13-14 Dicembre 2012), Ethos ed.,<br />
Napoli 2012.<br />
De Sensi Sestito G., Mancuso S., Il Lametino antico e Terina-Magna<br />
Grecia dall’età protostorica all’età romana, in Mazza F. (ed.), Lamezia<br />
Terme. Storia, Cultura, Economia, Rubbettino Editore, Soveria Mannelli<br />
2001, pp. 25-57.<br />
Dyfri W. (a cura di), Il tesoro di Santa Eufemia. Gioielli lametini al<br />
British Museum, traduzione di Baiocchi M., Donselli ed., Roma 1998.<br />
Gaiani M., Benedetti B., Remondino F. (a cura di), Modelli digitali 3D<br />
in archeologia: il caso di Pompei, Edizioni della Normale, Pisa 2010.<br />
Gattuso C., Gattuso P., Bruno F., Villella F., Marino Picciola R., Scientific<br />
methodology for diagnosis and restoration of the church in the complex<br />
of Serra San Bruno chaterhouse, in Sciense and tecnology for Cultural<br />
Heritage 21 (1-2), Fabrizio Serra Editore, Pisa 2012.<br />
Guzzo P. G., Oreficerie della Magna Grecia, Taranto 1993, p. 312 e<br />
catalogo.<br />
Mancuso S., Il tesoro di Sant’Eufemia: nuovi dati sulla scoperta, in De<br />
Sensi Sestito G. (ed.), Fra l’Amato e il Savuto, Studi sul lametino, Tomo<br />
II, Rubbettino Editore, Soveria Mannelli 1990, pp. 209-236.<br />
Mannarella O., Simonetta G., Celentano D., Lo spazio animato.<br />
Videocomunicare l’architettura, in Macrì V., Quistelli C. L. (ed.), Tra<br />
presentazione e simulazione, Aracne ed., Reggio Calabria 2010, pp.<br />
74-82.<br />
Marshall F. H., Catalogue of Finger Rings, Greek, Etruscan, and Roman,<br />
in the Departments of Antiquities, British Museum, London 1907,<br />
catalogo.<br />
Marshall F. H., Catalogue of the Jewellery, Greek, Etruscan, and<br />
Roman, in the Departments of Antiquities, British Museum, London<br />
1911, pp. 38-39 e catalogo.<br />
Spadea R, Fonti su un insediamento nella piana di Sant’Eufemia<br />
Lamezia (Terina?), in “Klearkos”, XXI, 1979, pp. 5-53.<br />
Spadea R., L’area di Piano della Tirena e di S. Eufemia Vetere, in<br />
Maddoli G. (ed.), Temesa e il suo territorio, Atti del Convegno di<br />
Perugia e Trevi (30-31 Maggio 1981), ISAMG - Istituto per la Storia e<br />
l’Archeologia della Magna Grecia, Taranto 1982, pp. 79-89.<br />
Spadea R., Prime voci di un abitato in contrada Iardini di Renda (S.<br />
Eufemia Vetere), in De Sensi Sestito G. (ed.), La Calabria Tirrenica<br />
nell’antichità. Nuovi documenti e problematiche storiche, Atti del<br />
Convegno (Rende - Università della Calabria, 23-25 Novembre 2000),<br />
Rubbettino Editore, Soveria Mannelli 2008, pp. 413-420.<br />
Stanco F., Tanasi D., Privitera S., Reconstructing the Past. Il 3d<br />
modeling nella ricerca archeologica, in Bezzi L., Francisci D., Grossi P.,<br />
Lotto D. (ed.), Open Source, Free Software XXI, 1979, pp. 5-53.<br />
Van Den Driessche B., Le trésor de bijouterie de Santa Eufemia, in<br />
L’Antiquité Classique, 1973, pp. 552-563.<br />
Williams D., Ogden J., Greek Gold. Jewellery of the Classical World,<br />
BMP, London 1994.<br />
SITOGRAFIA<br />
https://3dstories.protocube.it/archeologia-3d-invisibile-museo-egizio/<br />
https://3dstories.protocube.it/project-mosul-3d/<br />
https://knowledge.autodesk.com/it/download<br />
https://knowledge.autodesk.com/it/support/3ds-max?sort=score https://museoegizio.it/esplora/mostre/archeologia-invisibile/<br />
https://www.artribune.com/arti-visive/<strong>2021</strong>/01/annata-orribile-musei-parigi-louvre/<br />
https://www.treddi.com/cms/making-of/making-of-a-day-at-the-sleepy-village/4832/<br />
Photo credit: le immagini del Tesoro di Sant’Eufemia appartengono al British<br />
Museum e sono liberamente consultabili al link https://www.britishmuseum.<br />
org/collection/object/G_1896-0616-1<br />
Abstract<br />
Digital tools can bring to rethink radically the models of museum use, thanks<br />
to the possibility of enriching the collections that can generate new experiences<br />
for the public. The case study of the Treasury of Sant Eufemia, a group<br />
of vintage gold hellenistic jewels, found fortuitously in Calabria towards the<br />
late nineteenth century and now preserved in the British Museum in London,<br />
has experienced a process of three-dimensional reconstruction through the<br />
processing of images usually available only in the storage area of the museum.<br />
Parole chiave<br />
Archeologia; musei; digitale; ricostruzione 3D; documentazione; tecnologie beni<br />
culturali<br />
Autore<br />
Francesco La Trofa<br />
Gabriele Simonetta<br />
Felicia Villella<br />
licia.villella@tiscali.it
DOCUMENTAZIONE<br />
Multimedialità alle Terme di Diocleziano<br />
2010-2020: 10 anni di esperienze al Museo Nazionale Romano<br />
di Carlotta Caruso<br />
Dal 2010 a oggi il Museo Nazionale<br />
Romano alle Terme di Diocleziano<br />
ha rinnovato l’allestimento<br />
dei propri spazi e dei propri<br />
musei implementando il ricorso<br />
a nuove e diverse tecnologie. Si<br />
passano in rassegna i principi,<br />
le metodologie messe in atto e<br />
le scelte operate, mettendo in<br />
evidenza i benefici offerti dai<br />
diversi apparati impiegati.<br />
Fig. 1 - 2010: nuovo allestimento per il Museo (al centro l’allestimento della mappa da via Anicia).<br />
Le Terme di Diocleziano sono la sede storica del Museo<br />
Nazionale Romano fin dal momento della sua istituzione<br />
nel 1889. Il complesso monumentale comprende<br />
non solo le strutture dell’antico stabilimento termale, il più<br />
esteso dell’antichità, ma anche parte degli ambienti della<br />
Certosa annessa a Santa Maria degli Angeli che, per volere<br />
di Papa Pio IV, fu costruita riutilizzando e trasformando le<br />
strutture antiche. Oggi la visita comprende, quindi, non solo<br />
parte degli spazi delle Terme e della Certosa ma anche due<br />
musei: il Museo di Protostoria dei Popoli Latini e il Museo<br />
della Comunicazione Scritta dei Romani.<br />
Negli scorsi anni, a partire dal 2010, è stato dato il via a<br />
una serie di interventi che hanno permesso, da una parte il<br />
restauro e la riapertura di alcuni degli ambienti monumentali,<br />
dall’altra il rinnovamento dell’allestimento del Museo<br />
della Comunicazione Scritta dei Romani. In entrambi i casi,<br />
nell’elaborazione dei diversi progetti allestitivi, è stato dato<br />
notevole incremento al ricorso di strumenti di tipo tecnologico,<br />
impiegati per facilitare l’aspetto della comunicazione.<br />
La tecnologia non ha sostituito i mezzi tradizionali (didascalie<br />
e pannelli di sala) ma a questi si è aggiunta integrandoli e<br />
divenendo, essa stessa, parte dell’allestimento. Allo stesso<br />
tempo, la condizione ideale di progettare contemporaneamente<br />
l’allestimento museografico e la comunicazione di<br />
tipo multimediale ha permesso di identificare, di volta in<br />
volta, gli apparati e le metodologie più adeguate al singolo<br />
caso, tenendo anche conto del progressivo sviluppo delle<br />
tecnologie che si è avuto nel corso di quest’ultimo decennio.<br />
In tutti gli interventi realizzati, le scelte del Museo sono<br />
state indirizzate verso apparecchiature semplici e resistenti,<br />
capaci di lavorare per un elevato numero di ore al giorno<br />
(almeno 11), 6 giorni su 7 (escluso quindi il solo giorno di<br />
chiusura); si è inoltre cercato di individuare strumenti che<br />
non richiedessero aggiornamenti di sistemi e/o frequenti<br />
interventi di manutenzione, cercando di ridurre al minimo<br />
la possibilità di trovarsi di fronte al desolante spettacolo<br />
di un elemento spento o mal funzionante. Un altro requisito<br />
considerato come indispensabile, soprattutto nei primi<br />
interventi che, come si è detto, risalgono a più di 10 anni<br />
fa, è stata la facilità di utilizzo, sia da parte del visitatore,<br />
sia da parte del personale di vigilanza; nella maggior parte<br />
dei casi, infatti, è questo personale, non specializzato,<br />
che deve confrontarsi con le domande del pubblico e con<br />
gli eventuali problemi di malfunzionamento. E’ stata data<br />
dunque la preferenza ad apparati che richiedessero un’in-<br />
16 ArcheomaticA N°1 marzo <strong>2021</strong>
Tecnologie per i Beni Culturali 17<br />
terazione minima e che presentassero un funzionamento<br />
semplice e immediato; non è da trascurare, infatti, che<br />
l’attuale familiarità verso apparati digitali, anche di media<br />
complessità, è il risultato del rapido sviluppo tecnologico di<br />
questi ultimi anni.<br />
Il rinnovamento del “Museo Epigrafico” ha privilegiato, in<br />
particolare l’aspetto della comunicazione; la ridenominazione<br />
“Museo della Comunicazione Scritta dei Romani” aveva<br />
l’obiettivo di rendere immediatamente comprensibile<br />
l’oggetto dell’esposizione, ritenendo il termine “epigrafico”<br />
non di uso comune nel linguaggio corrente. L’idea di<br />
fondo di questo processo era comunicare in modo più semplice<br />
e diretto una categoria di reperti che, proprio nella<br />
comunicazione, ha la sua ragion d’essere, ossia le iscrizioni.<br />
Questo rinnovamento ha preso le mosse proprio dalla prima<br />
sala, dove si è scelto non solo di presentare in modo più agile<br />
la varietà dei reperti ma anche di fornire, fin dall’ingresso<br />
nel Museo, una chiave di lettura con cui affrontare tutti i<br />
documenti esposti. I reperti spiegano al visitatore “chi scrive”,<br />
“cosa si scrive” e “come si scrive” mediante brevissime<br />
didascalie, scritte a grandi lettere. Per due documenti,<br />
tuttavia, le informazioni richiedevano un approfondimento:<br />
la cosiddetta mappa di via Anicia e un’iscrizione sepolcrale<br />
caratterizzata dalla minuta graffita in scrittura corsiva sul<br />
retro della lastra (fig. 1).<br />
Entrambi i documenti potevano offrire ulteriori spunti che,<br />
con metodi tradizionali, avrebbero richiesto lunghi pannelli<br />
esplicativi: si è dunque scelto di affidare questi contenuti<br />
a due brevi filmati senza audio. Il primo mostra il rapporto<br />
tra la mappa e la più nota Forma Urbis di età severiana, una<br />
ricostruzione 3D del tempio raffigurato in pianta e il relativo<br />
contesto topografico, mentre il secondo rivela l’immagine<br />
della minuta (quasi invisibile data la sottigliezza del tratto)<br />
e tutto il processo di preparazione e realizzazione di un’iscrizione<br />
attraverso le riprese video di una scalpellina che,<br />
ancora oggi, lavora secondo le tecniche antiche.<br />
Per questi video, la scelta del device è ricaduta su una<br />
semplice cornice digitale, di quelle comunemente in commercio;<br />
nello specifico, il modello scelto aveva la massima<br />
dimensione all’epoca disponibile sul mercato, 15 pollici, e<br />
una risoluzione di 1024 x 768 Pixel. I video sono caricati su<br />
una Memory Card che, una volta inserita, attiva la modalità<br />
“Auto Slideshow”, scorrendo quindi in loop, senza che sia<br />
necessario alcun intervento; anche l’accensione e lo spegnimento<br />
delle cornici si effettuano contestualmente all’illuminazione<br />
del Museo. Dal momento che le cornici dovevano<br />
accompagnare dei reperti chiusi in teca, sono state fatte<br />
delle prove preliminari per valutare eventuali problemi di<br />
surriscaldamento che, tuttavia, non si sono verificati. La<br />
semplicità del device è stata però “compensata” dall’alto<br />
livello dei filmati, per realizzare i quali sono state utilizzate<br />
raffinate tecnologie: modellazione tridimensionale con<br />
camera virtuale, grafica 2D e 3D, e vere e proprie riprese<br />
cinematografiche. I video sono molto brevi (al di sotto del<br />
minuto) per non costringere l’utente a fermarsi per un tempo<br />
troppo lungo e sono strutturati in modo da catturare l’attenzione<br />
e trattenerla per il breve tempo necessario; è noto<br />
infatti che i visitatori siano spesso infastiditi dalla “forzata”<br />
lunga permanenza di fronte a un singolo reperto, anche se<br />
il video esplicativo è finalizzato a facilitare la fruizione del<br />
reperto stessa.<br />
La felice esperienza con questo tipo di apparecchiatura ha<br />
portato a servirsi nuovamente di questi strumenti in un successivo<br />
intervento del 2013, la sala 5 del Museo, dove sono<br />
esposti reperti provenienti dall’area in antico identificata<br />
dal toponimo Curiae Veteres, a breve distanza dal luogo<br />
in cui sorgerà il Colosseo. Le complesse vicende dell’area,<br />
Fig. 2 - Sala 5 del Museo: la cornice digitale inserita nella struttura allestitiva.<br />
dove sorgeva un tempio restaurato a seguito di un incendio<br />
dall’imperatore Claudio e poi definitivamente distrutto dal<br />
grande incendio neroniano, e, a breve distanza, un piccolo<br />
monumento dedicato dai musicisti dell’esercito alla famiglia<br />
imperiale, sono narrate al pubblico da due filmati in<br />
modalità esclusivamente visiva. In questo caso, le cornici<br />
digitali sono state inserite non in teca ma all’esterno, direttamente<br />
nella struttura espositiva in lamiera che sostiene<br />
i frammenti epigrafici e architettonici rinvenuti nell’area<br />
(fig. 2).<br />
Ricostruzioni 3D e sequenze filmiche permettono non solo<br />
di riconoscere e ricollocare i frammenti in strutture non più<br />
esistenti ma anche di riconoscere un luogo noto da monumenti<br />
costruiti successivamente e, al contempo, di identificare<br />
i personaggi menzionati dalle iscrizioni.<br />
Tra il 2010 e il 2013 si conta un ulteriore intervento che si<br />
è servito di differenti tipi di tecnologie: nel 2012, infatti,<br />
è stata rinnovata la sala 7 del Museo, dedicata all’illustrazione<br />
delle carriere di senatori e cavalieri. Per facilitare la<br />
comprensione dell’argomento, che può risultare complesso<br />
Fig. 3 - Sala 7: video e story-telling.
Fig. 4 - Sala del plastic con proiezione.<br />
a visitatori privi di competenze specialistiche, si è scelto<br />
questa volta di ricorrere al mezzo dello story-telling. Sono<br />
stati individuati quattro documenti particolarmente rappresentativi<br />
e su questi sono stati costruiti dei veri e propri brevi<br />
film, della durata media di 5 minuti: sono dunque gli stessi<br />
protagonisti delle iscrizioni a raccontare le loro carriere e<br />
a farne capire le diverse tappe. Le ricostruzioni, realizzate<br />
attraverso riprese cinematografiche, con attori reali e voci<br />
recitanti sono state affidate, questa volta a computer touch<br />
screen che permettono al visitatore la scelta della lingua<br />
dell’audio, italiano o inglese. E’ interessante notare come<br />
nel 2012 la tecnologia touchscreen fosse ancora talmente<br />
poco diffusa che molti visitatori non riuscivano ad avviare<br />
i video; l’attivazione, infatti, era conseguente alla scelta<br />
della lingua, segnalata da una semplice bandierina. E’ stato<br />
dunque necessario aggiungere un ulteriore simbolo e la<br />
scritta “avvio” e “start” al di sotto delle bandierine stesse.<br />
Una tecnologia che si è rivelata di grande interesse è quella<br />
impiegata per l’audio: si è infatti fatto ricorso alle cosiddette<br />
“docce sonore”, degli speaker direzionali montati sul<br />
soffitto che, proprio come le docce con l’acqua, proiettano<br />
il suono dall’alto. Ciò che caratterizza questi apparati è la<br />
capacità di diffondere il suono in un raggio estremamente<br />
circoscritto, non oltre un paio di metri. In questo modo è<br />
possibile permettere a più visitatori contemporaneamente<br />
di fruire dei filmati senza disturbi o interferenze (fig. 3).<br />
Nel 2014, grazie alla celebrazione del bimillenario Augusteo,<br />
il complesso monumentale delle Terme di Diocleziano<br />
ha arricchito la sua offerta culturale restituendo alla pubblica<br />
fruizione oltre 3200 metri quadrati di spazi espositivi.<br />
Anche in questo caso sono stati numerosi gli apporti in chiave<br />
tecnologica.<br />
All’interno del Museo, è stata rinnovata la sala dedicata alla<br />
magia e alla fonte sacra di Anna Perenna, un sito in cui si<br />
svolgevano riti di magia nera: anche in questo caso gli apparati<br />
di comunicazione tradizionali sono stati affiancati da<br />
due diversi filmati, uno con audio e uno solo visivo. Il primo<br />
propone un’accurata ricostruzione 3D della fonte sacra e<br />
un’animazione cinematografica, con audio, delle testimonianze<br />
letterarie relative alle celebrazioni in onore di Anna<br />
Perenna; il secondo video mostra invece la fabbricazione<br />
delle cosiddette “bamboline magiche” (figurine in materia-<br />
Fig. 5 - Le Terme con gli occhi di Diocleziano.<br />
18 ArcheomaticA N°1 marzo <strong>2021</strong>
Tecnologie per i Beni Culturali 19<br />
le organico la cui funzione è stata più volte accostata alle<br />
bamboline voodoo) e dei loro contenitori magici. I due video<br />
sono trasmessi da due pc all in one che permettono la trasmissione<br />
dei video in loop.<br />
Il nuovo percorso espositivo del monumento, invece, si apre<br />
con una significativa proiezione che si affianca a un plastico<br />
ricostruttivo delle Terme di Diocleziano realizzato in gesso<br />
agli inizi del Novecento. Attraverso due videoproiettori e un<br />
computer con software e hardware Watchout, per gestione<br />
a sincrono di immagini video, le singole zone del plastico<br />
vengono evidenziate da un fascio di luce proiettato dall’alto<br />
mentre, sulla parete antistante, scorre una ricostruzione 3D<br />
dei corrispondenti spazi del monumento, con particolare attenzione<br />
agli apparati decorativi della piscina monumentale,<br />
e la collocazione rispetto alla città moderna; il complesso<br />
delle Terme è infatti talmente esteso da comprendere<br />
anche zone al di fuori degli spazi del Museo (basti pensare<br />
alla grande esedra di Piazza della Repubblica o alla Basilica<br />
di Santa Maria degli Angeli) (fig. 4).<br />
Nel piccolo chiostro della Certosa, costruito occupando un<br />
terzo dell’invaso della monumentale piscina, un sistema<br />
a quattro led wall outdoor permette ai visitatori di comprendere<br />
il rapporto tra le strutture romane e quelle rinascimentali,<br />
mostrando una ricostruzione 3D delle diverse<br />
fasi di vita del monumento. Il chiostro piccolo, che ospita<br />
alcuni tra i più importanti documenti della religione romana,<br />
contiene altre cinque installazioni a corredo di questi<br />
documenti; tre filmati, di cui uno solo con audio, e due installazioni<br />
solo audio. I filmati presentano rispettivamente<br />
la situazione del santuario degli Arvali alla Magliana, da cui<br />
provengono le iscrizioni esposte in tre bracci del chiostro,<br />
il complesso rito praticato da questo collegio sacerdotale<br />
e un breve film in cui l’imperatore Augusto “in persona”<br />
racconta la sua politica religiosa di recupero degli antichi<br />
culti, come quello, appunto, degli arvali. Gli apparecchi utilizzati<br />
sono, ancora una volta dei pc all in one. Le installazioni<br />
audio, invece, danno voce, nel vero senso della parola,<br />
alle iscrizioni esposte: attraverso casse nascoste all’interno<br />
delle strutture espositive, si diffonde nel chiostro il carme<br />
rituale degli arvali, una delle più antiche testimonianze in<br />
lingua latina incisa proprio su una delle iscrizioni del collegio<br />
sacerdotale, declamata da un coro di voci maschili<br />
(i Cantori di San Carlo); il Laboratorio di Voci Bianche di<br />
Santa Cecilia, invece, ha prestato la voce ai bambini che<br />
nel 17 a.C. intonarono il carmen saeculare, il carme rituale<br />
composto dal poeta Orazio in onore delle cerimonie dei Ludi<br />
Saeculares, i cui rendiconti sono incisi su un grande pilastro<br />
esposto nel chiostro.<br />
Nel 2018 è stata finalmente resa disponibile al pubblico la<br />
“audio-video-guida” Le Terme con gli occhi di Diocleziano,<br />
un’applicazione di realtà immersiva con ricostruzione 3D a<br />
360 gradi che permette un’immediata comprensione delle<br />
architetture del complesso data la perfetta sovrapponibilità<br />
tra la visione reale del monumento e quella virtuale (fig. 5).<br />
I device impiegati sono stati, in origine, dei visori View Master,<br />
visori VR con uno smartphone inserito all’interno di<br />
essi, corrispondenti agli standard dei Cardboard Virtual Reality;<br />
si è scelto di acquistare un modello progettato per<br />
bambini, puntando sempre alla facilità di utilizzo e, allo<br />
stesso tempo alla resistenza agli urti. Il progetto originario<br />
prevedeva la possibilità per i visitatori di scaricare l’app di<br />
realtà immersiva sul proprio telefono e di fruirne munendosi<br />
di un Cardboard Virtual Reality fai da te in cartoncino<br />
da acquistare nel bookshop del Museo; la mancanza di una<br />
rete wifi interna al Museo e le grandi dimensioni dell’app,<br />
difficilmente scaricabili su cellulari spesso già pieni di dati,<br />
hanno tuttavia reso preferibile fornire ai visitatori visori già<br />
predisposti che possono essere noleggiati in biglietteria e<br />
restituiti alla fine della visita. Già nel 2019 i visori sono stati<br />
sostituiti con un modello di qualità superiore.<br />
Fig. 6 - Terme di Diocleziano in 5G: la palestra nord orientale.
Nel 2018 le Terme di Diocleziano hanno inoltre preso parte<br />
al progetto “Roma 5G”, rappresentando il primo use case<br />
a Roma nell’ambito della sperimentazione di questa tecnologia<br />
applicata al patrimonio culturale. Con il sostegno<br />
di Fastweb, Ericsson e il Consiglio Nazionale delle Ricerche<br />
- IBAM (Istituto per i Beni Archeologici e Monumentali), a<br />
complemento dell’app Le Terme con gli occhi di Diocleziano,<br />
è stata realizzata una ricostruzione dell’area della palestra<br />
nord-occidentale con panorami a 360°, visione stereoscopica<br />
e scene animate; la connessione ad alta velocità<br />
offerta dalla rete 5G permette di fruire di visualizzazioni di<br />
realtà virtuale e immersiva di qualità estremamente raffinata<br />
(fig. 6).<br />
Da ultimo, nel 2019, le Terme di Diocleziano hanno preso<br />
parte al progetto Castro Pretorio, l’evoluzione di un rione,<br />
realizzato dall’Hotel The St. Regis Rome, un’installazione<br />
immersiva che racconta la storia dell’area intorno all’Hotel<br />
partendo proprio dalle Terme di Diocleziano e, in particolare,<br />
dall’Aula Ottagona. Nell’Aula, dove sono state predisposte<br />
delle sedute, il pubblico può fruire dell’esperienza<br />
immersiva tramite visori da noleggiare sul posto.<br />
Questa sintetica rassegna delle tecnologie impiegate nel<br />
Museo permette anche di effettuare un bilancio in termini<br />
di resa e benefici: in primo luogo si deve constatare che si<br />
è certamente rivelato vincente l’approccio iniziale, ossia<br />
la scelta di tecnologie semplici e resistenti che hanno permesso<br />
di investire più sui contenuti e la relativa realizzazione,<br />
che sui device. In particolare, i filmati senza audio si<br />
sono rivelati ottimi strumenti per comunicare con semplicità<br />
contenuti anche complessi, superando brillantemente<br />
il problema delle barriere linguistiche; la loro efficacia è<br />
stata apprezzata anche dal pubblico delle persone sorde<br />
(si noti che, per il pubblico con disabilità visiva, invece, il<br />
Museo mette in atto una serie di strategie specifiche, prima<br />
tra tutti la possibilità di esplorare tattilmente tutti gli<br />
originali conservati fuori teca, una possibilità certamente<br />
più efficace di molte delle iniziative, anche in chiave tecnologica,<br />
proposte dai Musei in questi anni). Nonostante la<br />
loro semplicità, le cornici digitali hanno dimostrato di essere<br />
assolutamente rispondenti alle aspettative in termini di<br />
resistenza e durata: nel corso di questi 11 anni è stato necessario<br />
sostituirle una sola volta per raggiunti limiti di fine<br />
vita. Computer e tecnologie più sofisticate offrono indubbiamente<br />
livelli di coinvolgimento maggiori che richiedono<br />
tuttavia, non solo una maggiore spesa iniziale ma anche la<br />
necessità di una costante verifica e attività di manutenzione<br />
che i fondi dei musei statali non sempre sono in grado di sostenere.<br />
Un approccio semplice, che investa con la dovuta<br />
attenzione sull’alta qualità dei contenuti, rimane a nostro<br />
avviso, sempre la scelta migliore.<br />
Bibliografia<br />
F. Antinucci, La comunicazione museale: la tecnologia al servizio del<br />
museo, in Forma Urbis, XXI, maggio 2016, pp. 43-35.<br />
C. Borgognoni-C. Caruso, Ridare voce alle parole: il Museo della<br />
Comunicazione Scritta dei Romani presso le Terme di Diocleziano,<br />
in MUSEUM.DIÀ, II° CONVEGNO INTERNAZIONALE DI MUSEOLOGIA,<br />
Chronos, Kairòs e Aion. Il tempo dei musei, Atti dell’incontro<br />
internAzionAle di Studi, Roma 26-28 maggio 2016, pp. 221-239.<br />
Note di chiusura<br />
Il contributo sintetizza la relazione presentata in occasione del forum Technology<br />
for all, nella sezione "Multimedialità e fruizione: efficacia dei sistemi AR, VR<br />
e MR" (dicembre 2019).<br />
Abstract<br />
Between 2010 and 2020 the National Roman Museum - Baths of Diocletian<br />
renewed the layout of the Museum of Written Communication of the Romans<br />
and the spaces of the monumental complex. In this general revision of its<br />
equipment, the use of technologies had a great importance at the service<br />
of museum communication to the public. Together with traditional systems<br />
(captions and room panels), the technological devices themselves became part<br />
of the set-up by integrating and completing the information in order to obtain<br />
engaging and effective methodologies.<br />
Parole chiave<br />
Multimedialità; tecnologia; apparati; musei; comunicazione.<br />
Autore<br />
Carlotta Caruso<br />
carlotta.caruso@beniculturali.it<br />
20 ArcheomaticA N°1 marzo <strong>2021</strong>
Tecnologie per i Beni Culturali 21
DOCUMENTAZIONE<br />
Un sistema Web-GIS dei Beni di Interesse<br />
Culturale e Paesaggistico nelle Marche<br />
di Annalisa Conforti, Giovanni Issini, Camilla Tassi, Sara Trotta, Luigi Federico D’Amico, Eva Savina Malinverni<br />
Il Segretariato del MiBACT<br />
per le Marche sta sviluppando<br />
un sistema Web-GIS<br />
del patrimonio culturale<br />
della Regione, in particolare<br />
riferito ai beni architettonici<br />
e paesaggistici, basato<br />
sulle banche dati storiche<br />
Fig. 1 - Distribuzione beni immobili di interesse culturale – Database VIC.<br />
dei vincoli e sul database<br />
dei siti coinvolti dagli<br />
eventi sismici del 2016. La<br />
fusione delle banche dati,<br />
insieme alla complessità ed<br />
eterogeneità degli stessi<br />
hanno costituito la sfida più<br />
significativa che ha richiesto<br />
in primis una comprensione<br />
critica dei parametri e<br />
successivamente, nell’ambito<br />
di una collaborazione<br />
di ricerca, la definizione<br />
e sperimentazione di un<br />
protocollo di correzione dei<br />
mismatch tra beni e riferimenti<br />
catastali.<br />
Il sisma che ha colpito il Centro-<br />
Italia nel 2016, oltre alla perdita<br />
di numerose vite umane, ha severamente<br />
danneggiato il ricco e diffuso<br />
patrimonio culturale della Regione<br />
Marche, sia nel perimetro del cratere<br />
che nel resto del territorio. Tra l’Agosto<br />
2016 e il Dicembre 2018 l’Unità di<br />
Crisi-Coordinamento Regionale del Segretariato<br />
regionale del MiBACT Marche<br />
(UCCR-Marche) ha organizzato ed<br />
espletato le attività emergenziali tra<br />
cui: la ricognizione dei danni di tutti<br />
i beni culturali per i quali erano state<br />
effettuate segnalazioni; l’esecuzione<br />
diretta o il monitoraggio delle opere<br />
di messa in sicurezza dei beni esposti<br />
a rischio di crolli; la selezione, schedatura<br />
e conservazione delle macerie<br />
prodotte dagli smontaggi dei beni; lo<br />
spostamento dei beni culturali mobili<br />
presso depositi d’emergenza. Al fine<br />
di mettere a disposizione degli attori<br />
coinvolti nel processo di ricostruzione<br />
i dati acquisiti e di attuare un’efficace<br />
azione di tutela del patrimonio<br />
danneggiato, nel 2019 il Segretariato<br />
Regionale del MIBACT per le Marche<br />
ha avviato l’implementazione di un<br />
sistema Web-GIS del patrimonio culturale<br />
delle Marche. L’obiettivo del<br />
sistema informativo è consentire la<br />
gestione, l’aggiornamento e la consultazione<br />
dei molteplici dati acquisiti<br />
tramite letture multilivello delle<br />
informazioni associate al dato geografico-territoriale.<br />
In termini di input,<br />
il sistema Web-GIS dei beni culturali<br />
delle Marche è costituito dall’unione<br />
di due banche dati di diversa natura e<br />
provenienza.<br />
Il portale, una volta ultimato, sarà in<br />
grado di mostrare agli enti pubblici e<br />
privati, coinvolti nel processo di ricostruzione<br />
ed ai professionisti, due<br />
principali informazioni riguardanti gli<br />
edifici che hanno subìto danni dopo il<br />
sisma del 2016: una territoriale, che<br />
posiziona geograficamente il bene, ed<br />
una informativa, che descrive l’oggetto<br />
in ogni sua parte con l’ausilio<br />
di foto (pre e post terremoto) e mostrando<br />
anche tutta la documentazione<br />
disponibile accedendo al relativo<br />
database.<br />
Nell’ambito di una convenzione di<br />
ricerca tra MiBACT Marche e dipartimento<br />
DICEA dell’Università Politecnica<br />
delle Marche, è stato sviluppato<br />
un protocollo di verifica e correzione<br />
dei mancati match tra i dati importati<br />
e quelli reali, applicato su un campio-<br />
22 ArcheomaticA N°1 marzo <strong>2021</strong>
Tecnologie per i Beni Culturali 23<br />
ne di Comuni del cratere sismico, i cui risultati sono illustrati<br />
nel paragrafo 3.<br />
Le banche dati del MiBACT Marche. Banca dati degli immobili<br />
oggetto di un procedimento di verifica di interesse<br />
culturale.<br />
L’art. 17 del D.Lgs. 42/2004 “Codice dei beni culturali e<br />
del paesaggio”, da qui in poi denominato Codice, pone<br />
l’attenzione sull’importanza della catalogazione dei beni<br />
culturali, ossia le cose immobili e mobili come definite<br />
e individuate negli artt. 10 e 11 e oggetto della parte II<br />
dello stesso testo normativo.<br />
Oltre ad essere una rilevante mole di beni di carattere<br />
assai vario (architettonici, archeologici, storico - artistici,<br />
archivistici e bibliografici), altrettanto varia è la<br />
modalità del riconoscimento del loro interesse culturale,<br />
perché avvenuta in tempi, storici e legislativi, modalità<br />
e da parte di soggetti diversi, pur se nell’ambito dello<br />
stesso Ministero: i cosiddetti vincoli sono costituiti sia da<br />
dichiarazioni di culturalità ai sensi delle differenti leggi<br />
di tutela emanate dal 1900 in poi (piuttosto generiche<br />
soprattutto nella localizzazione del bene), sia da provvedimenti<br />
espressi emanati da parte di svariati uffici del<br />
Ministero, sia quelli validi per tutti quei beni non dotati<br />
di uno specifico provvedimento espresso ma per i quali,<br />
aventi determinate caratteristiche ai sensi dell’art. 10<br />
comma 1 del Codice, l’interesse culturale è ritenuto sussistere<br />
ex se, fino all’espletamento del procedimento amministrativo<br />
della verifica dell’interesse ai sensi dell’art.<br />
12 (i cosiddetti vincoli “ope legis”).<br />
Vanno inoltre considerati i beni paesaggistici, come definiti<br />
e tutelati nella parte III del Codice, anch’essi dichiarati<br />
di notevole interesse pubblico tramite provvedimento<br />
espresso o tutelati per legge. L’art. 143 evidenzia<br />
infatti l’importanza della ricognizione, delimitazione e<br />
individuazione di tali beni come atto imprescindibile alla<br />
pianificazione paesaggistica.<br />
L’attività di catalogazione di tutto ciò che a vario titolo,<br />
come sopra evidenziato, attesta la culturalità di un bene,<br />
si è più facilmente concentrata sulle dichiarazioni di interesse,<br />
quindi sui provvedimenti espressi (compresi quelle<br />
derivanti da verifica dell’interesse positiva, che consolida<br />
definitivamente la natura di bene culturale prima presunta<br />
quale misura cautelare a carattere provvisorio, e<br />
negativa, che opera da condizione risolutiva), anche se<br />
gli elenchi descrittivi dei beni culturali di proprietà predisposti<br />
dagli enti pubblici (e assimilati) ai sensi dell’art.<br />
4, comma 3, L. 1089/1939 e dall’art. 5, D.Lgs. 29 ottobre<br />
1999, n. 490 costituiscono una fonte di informazioni da<br />
sempre tenuta in debita considerazione.<br />
Proprio perché la natura dei dati presenti in tali atti è<br />
molto varia, dalla massima genericità delle prime dichiarazioni<br />
di interesse degli inizi del ‘900 ad una sempre<br />
maggior precisione, soprattutto in merito alla localizzazione<br />
e alla presenza di un corredo fotografico significativo,<br />
le banche dati realizzate, prima cartacee e poi<br />
digitali (per lo più in formato excel corredate a volte da<br />
scansioni in .pdf degli atti), si sono man mano arricchite<br />
di una serie di informazioni relative al bene sottoposto<br />
a tutela e da ulteriori informazioni di carattere amministrativo<br />
relative al procedimento, anch’esso in evoluzione,<br />
connesso alla dichiarazione. Ne conseguono due<br />
ordini di problematiche: come reperire le informazioni<br />
mancanti, nei casi di dichiarazioni spesso datate e molto<br />
sintetiche e, come tenere aggiornati i dati, che naturalmente<br />
mutano negli anni successivi alla dichiarazione,<br />
che possono riguardare indirizzo del bene, riferimenti<br />
catastali, proprietà, collocazione di eventuali beni mobili<br />
Fig. 2 - Distribuzione beni oggetto di rilievo danni su intero territorio<br />
regionale– Database UCCR.<br />
ivi conservati, per arrivare anche a mutamento di Comune<br />
di appartenenza (si pensi alle unioni dei Comuni che<br />
comportano un cambio di denominazione). D’altra parte,<br />
le necessità di interrogazione possono essere dettate da<br />
esigenze molteplici e in continua evoluzione, anche inseguendo<br />
il variare delle procedure amministrative e delle<br />
relative attività di monitoraggio, sia della pubblica amministrazione<br />
che delle specifiche attività di tutela.<br />
La geolocalizzazione dei beni immobili, anche nel caso si<br />
tratti di contenitori di beni mobili, collegata ad uno o più<br />
database delle informazioni sopra descritte, costituisce<br />
un ulteriore passo in avanti nell’attività di catalogazione,<br />
la cui utilità è facilmente comprensibile sia per l’attività<br />
ordinaria del MIBACT, che, ancor più, in situazione emergenziale,<br />
quando ci si trova ad operare in contesti in cui<br />
i danni sono tali da non aver più punti di riferimento utili<br />
perfino all’individuazione del bene stesso (Fig. 1).<br />
BANCA DATI UCCR: IL PATRIMONIO DANNEGGIATO E IL SISTE-<br />
MA GESTIONALE DEL SISMA 2016: IL MODELLO MARCHE<br />
In considerazione dello sciame sismico che ha interessato<br />
il Centro-Italia e dei gravissimi danni riportati dal patrimonio<br />
culturale delle Marche, è evidente che la mole dei<br />
Fig. 3 - Ubicazione dei Comuni campioni con riferimento al territorio regionale.
Fig. 4 - Particolare del centro storico di Visso (MC). I poligoni arancio provengono dai db dell’UCCR, mentre quelli viola provengono dal db Vincolo di<br />
interesse culturale.<br />
dati da gestire è stata di portata inaspettatamente considerevole<br />
e che i database inizialmente impostati in formato<br />
excel e cartacei non fossero adeguati al complesso<br />
lavoro di coordinamento richiesto all’UCCR-Marche: per<br />
questo motivo, quest’ultima ha attivato subito una collaborazione<br />
con le UCCR Lombardia ed Emilia-Romagna,<br />
in virtù della loro esperienza nell’ambito dell’emergenza<br />
sismica del 2012. Il risultato di questa attività di confronto<br />
e lavoro congiunto, è stata la realizzazione di un<br />
software gestionale denominato ES_Mibac, realizzato con<br />
Microsoft Access, collegato ad un database centralizzato<br />
su una risorsa server per consentirne l’implementazione<br />
simultanea dei beni censiti. Il software è stato impostato<br />
sulla base dell’anagrafica di ciascun immobile affiancata<br />
via via ad una banca dati ben più ampia. Successivamente<br />
il sistema di catalogazione è stato costruito e rimodulato<br />
a seconda dell’evolversi degli eventi calamitosi e dunque<br />
adattandolo ai dati relativi a danni sempre più consistenti<br />
a carico del patrimonio culturale, spesso di diversa natura,<br />
da monitorare anche ad intervalli temporali differenziati.<br />
Il software, quindi, ha inglobato i dati prodotti da tutte<br />
le attività svolte su ciascun bene, dietro il coordinamento<br />
dell’UCCR – Marche. Ci si riferisce in particolare a: sopralluoghi,<br />
rilievo dei danni, attività di messa in sicurezza,<br />
GTS, spostamento dei beni mobili. Successivamente, procedendo<br />
con la digitalizzazione dell’archivio cartaceo, la<br />
scheda di ogni bene monumentale colpito dal sisma nel<br />
territorio regionale è diventata associabile agli atti relativi<br />
a ciascuna attività svolta e alle relative, importantissime,<br />
immagini (Fig. 2).<br />
LO SVILUPPO DEL WEB<br />
GIS MiBACT Marche:<br />
i sistemi Web-GIS per il patrimonio culturale<br />
La rapida evoluzione delle tecnologie digitali per il processamento<br />
dei dati a connotazione spaziale, associate<br />
all’utilizzo di informazioni di diversa natura (BigData) ha<br />
fatto maturare l’esigenza di creare appositi strumenti per<br />
la gestione dei dati geografici in sperimentazioni interdisciplinari.<br />
Un sistema GIS dedicato al patrimonio culturale,<br />
definito come un modello spaziale di archiviazione, elaborazione<br />
e gestione delle informazioni, ha, oggigiorno,<br />
enormi potenzialità per la creazione di modelli predittivi<br />
e simulazioni dinamiche o per la riproducibilità dei dati<br />
che consentono di rappresentare, ripercorrendo a ritroso,<br />
le varie fasi della ricerca, integrandole in un’ottica interdisciplinare<br />
con altri ambiti di gestione e analisi spaziale,<br />
quali la pianificazione territoriale, la protezione civile, il<br />
monitoraggio ambientale, la cartografia del rischio (Letellier<br />
et al., 2007). Ma ormai da decenni la possibilità di<br />
condividere e allargare la consultazione del dato ad un<br />
panorama di esperti a vario titolo ha introdotto la soluzione<br />
Web-GIS (talvolta sostituito da Web-based GIS, Online<br />
GIS, Distributed GIS). Termine utilizzato per indicare<br />
l’impiego via Internet/Intranet di funzionalità proprie dei<br />
GIS, in grado di rendere disponibile l’informazione georeferita<br />
ad utenti in remoto e di poter impiegare in soluzioni<br />
WMS la cartografia di base su cui georeferite le aree<br />
indagate. La possibilità di effettuare azioni da remoto e<br />
l’accessibilità ai dati da parte di una utenza “allargata”<br />
ha così influenzato il mondo dei Sistemi Informativi Geografici,<br />
determinando lo sviluppo di software dedicato per<br />
le relative applicazioni in rete (Oliviero et al., 2006). Inizialmente<br />
si parlava di visualizzazione di pagine internet<br />
di tipo statico, a cui si sono poi aggiunte operazioni di<br />
analisi spaziale, indicando nei Web-GIS un sistema complesso<br />
in grado di svolgere le stesse operazioni di un GIS<br />
ma con accesso da remoto (Painho et al., 2001). Si possono<br />
così segnalare formati e standard utilizzabili per la<br />
pubblicazione in rete della cartografia: HTML, SVG, GML<br />
(Generalized Markup Language) e fare così riferimento agli<br />
standard dell’OCG, con formati sempre più caratterizzati<br />
dalla capacità di includere in ogni entità sia le informazioni<br />
di tipo spaziale che i relativi attributi (tradizionalmente<br />
inseriti nei database alfanumerici collegati). In relazione<br />
ai livelli di complessità caratterizzanti le applicazioni che<br />
prevedono l’utilizzo di cartografie in rete (Internet Mapping<br />
Applications), è possibile individuare differenti servizi<br />
erogabili e diverse tipologie di azioni (Data Management,<br />
Visualisation, Retrieval, GIS Analysis), tali da operare una<br />
distinzione tra Geodata Server, Map Server, Online Retrieval<br />
System, Online GIS, GIS Function Server (Rinner, 1998).<br />
24 ArcheomaticA N°1 marzo <strong>2021</strong>
Tecnologie per i Beni Culturali 25<br />
IMPLEMENTAZIONE DEL WEB-GIS<br />
Campione di Comuni del cratere sisma 2016<br />
Nell’ambito della convenzione di ricerca richiamata nel<br />
paragrafo 1, il Web-GIS è stato implementato tramite l’importazione<br />
delle relative banche dati su un campione di<br />
Comuni del cratere sismico delle Marche: Visso, Castelsantangelo<br />
sul Nera, Ussita, Arquata del Tronto, Acquasanta<br />
Terme e Montemonaco (Fig. 3). Questo campione<br />
rappresenta circa il 10% della totalità dei beni presenti<br />
nei due database principali. La sperimentazione ha avuto<br />
quindi lo scopo di definire un protocollo di implementazione,<br />
verificare quali tipo di errori questa implementazione<br />
avrebbe prodotto, ed avere dati utili alla quantificazione<br />
dell’entità del lavoro richiesto per l’implementazione dei<br />
dati dell’intera Regione. Il sistema Web-GIS di riferimento,<br />
ovvero quello sviluppato per il Segretariato Regionale Mi-<br />
BACT per l’Emilia-Romagna, è classificabile come Map Server<br />
in quanto permette semplici funzioni, come zooming<br />
e planning, seppure sia stato integrato da una funzione di<br />
ricerca e posizionamento insieme a un sistema di segnalazioni<br />
(Shaig, 2001).<br />
CRITICITÀ E PROTOCOLLO DI CORREZIONE DATI<br />
Dopo le fasi di rilievo dei danni e la rispettiva catalogazione<br />
sono seguite le fasi di importazione dei dati e gestione<br />
degli stessi. Alla fase di importazione spesso seguono errori<br />
tra i dati e la base scelta. In questo caso la base che<br />
è stata utilizzata proviene dal Catasto Nazionale. Per cui i<br />
beni corrisponderanno alle Particelle di cui sono composti.<br />
I casi di mancato match dopo l’importazione hanno riguardato:<br />
4 Beni non georeferenziati, in cui nessuna particella corrispondeva<br />
a quelle realmente esistenti. Solitamente<br />
questi errori sono legati a refusi di battitura durante<br />
l’inserimento dei dati dalle schede di rilievo agli elenchi<br />
digitali.<br />
4 Beni con “buchi”, che indicavano la mancanza di Particelle,<br />
per cui è stato necessario aggiungere manualmente<br />
le Particelle mancanti.<br />
4 Beni “sparsi”, cioè molto estesi, dove è stato fissato<br />
come parametro l’estensione della diagonale tra il centro<br />
di una Particella e dell’altra.<br />
4 Beni multi-poligono, si è trattato di beni formati da più<br />
parti di poligono. In alcuni casi si ritrovano errori macroscopici,<br />
cioè beni formati da Particelle anche molto<br />
distanti tra di loro.<br />
4 Casi in cui due (o più) beni insistevano sulla stessa particella<br />
del catasto.<br />
4 Casi in cui le coordinate catastali erano riferite ad un<br />
Comune che aveva subito la fusione con altre amministrazioni<br />
comunali adiacenti.<br />
È stata riscontrata un’incidenza media degli errori pari al<br />
25% dei beni per Comune.<br />
Le cause di questi errori possono essere attribuite alla<br />
base catastale, riferita al 2013, ad errori di scrittura nel<br />
database e, infine, alla non chiarezza dei dati inseriti nelle<br />
schede di rilievo durante i sopralluoghi nei siti danneggiati<br />
dal sisma.<br />
Il protocollo di correzione ha previsto innanzitutto la verifica<br />
dei dati mancanti, cioè quelli per cui non è stata<br />
trovata automaticamente la Particella corrispondente. Per<br />
rendere la ricerca più agibile è stato creato un plug-in, dal<br />
Dott. Francesco Marucci di Cooperativa Alveo di Bologna,<br />
nominato “Ricerca catastale” il quale, dopo aver inserito<br />
i dati catastali, cioè Provincia (non la Regione in quanto<br />
tutti i dati fanno sempre parte della Regione Marche),<br />
Comune, Foglio e Particella, procede alla selezione della<br />
particella cercata.<br />
I casi di mancato match precedentemente elencati non potevano<br />
essere corretti automaticamente per cui sono stati<br />
individuati singolarmente gli elementi, utilizzando il plugin<br />
di ricerca e verificata l’esistenza o meno della Particella.<br />
Nel caso in cui i dati non risultassero corretti il bene è<br />
stato cercato utilizzando la maschera del database UCCR<br />
o tramite verifica dei dati trascritti nelle schede di rilievo.<br />
UNIONE DELLE BANCHE DATI<br />
Lo scopo finale delle operazioni di correzione è stato quello<br />
di unire il database dell’UCCR, composto sia da beni<br />
culturali tutelati in quanto oggetto di provvedimento di<br />
verifica di interesse, sia da beni oggetto di tutela cosiddetta<br />
“ope legis”, cioè i beni culturali dichiarati tali in forza<br />
dell’art.12 c.1 del Dlg.s 42/2004 (Codice dei beni culturali<br />
e del paesaggio), e il database VIC (Verifiche di Interesse<br />
Culturale), ovvero la totalità dei beni già sottoposti a decreto<br />
di vincolo prima del terremoto (fig. 4).<br />
Per completare quest’ultima fase è stato creato un nuovo<br />
tool “Unione UCCR-VIC”, che mostra la denominazione del<br />
bene nei due database e permette l’unione delle informazioni.<br />
Una volta che questo legame è stato creato, si è proceduto<br />
alla fusione dei due database, mantenendo tutte le<br />
informazioni di entrambi (oppure facendo delle scelte che<br />
li completino). Inoltre, nell’ambito dei Comuni campione,<br />
sono stati riscontrati diversi casi di beni presenti solo in<br />
uno dei due database, che sono stati quindi integrati in un<br />
database unico finale.<br />
Un caso specifico di corrispondenza tra beni appartenenti<br />
alle due banche dati è stato quello in cui, per lo stesso<br />
bene, veniva indicato un nome differente. Questa situazione<br />
si può spesso riscontrare nell’utilizzo diverso delle<br />
abbreviazioni (ad esempio Chiesa di Santa Maria Assunta /<br />
Chiesa di S.M. Assunta), oppure perché alcuni beni storicoartistici<br />
vengono denominati in modo diverso in base agli<br />
usi locali (ad es. Palazzo dei Priori / Palazzo del Comune).<br />
In questo caso il protocollo ha previsto il mantenimento di<br />
entrambe le denominazioni, essendo la corrispondenza tra<br />
beni determinata in termini di consistenza catastale.<br />
CONCLUSIONI E SVILUPPI FUTURI<br />
L’esperienza illustrata nel presente articolo evidenzia<br />
come l’implementazione di un Web-GIS a partire da dati<br />
acquisiti e classificati con criteri “tradizionali” e tramite<br />
metodi differenziati risente di molteplici criticità che<br />
spesso sono risolvibili solo tramite laboriosi processi di correzione<br />
manuale dato per dato. Al fine di allineare la filiera<br />
acquisizione-elaborazione-archiviazione alla gestione e<br />
fruizione finale delle informazioni nel Web-GIS, il Segretariato<br />
Regionale del MiBACT per le Marche intende riprogettare<br />
anche la fase di creazione dei dati in modo tale che le<br />
informazioni siano immediatamente inserite nel Web-GIS.<br />
Sia nell’attività ordinaria che in quella emergenziale i dati<br />
vengono prodotti sempre nell’ambito di procedimenti tecnico-amministrativi<br />
che dovranno essere quindi integrati<br />
nel sistema Web-GIS sin dalla fase iniziale rappresentata<br />
dall’avvio d’ufficio o su istanza di parte. Su questo aspetto<br />
si concentreranno gli sviluppi del sistema nel corso del<br />
<strong>2021</strong> al fine di strutturare un sistema informativo integrato<br />
che porterà benefici sia a livello “interno” all’Ente, sia a<br />
livello di fruizione esterna da parte degli operatori e della<br />
cittadinanza.
Bibliografia<br />
Rinner, C. (1998). Online maps in Geomed. In Proceeding of the GIS<br />
PlaNET 98 Workshop.<br />
Painho, M., Peixoto, M., Cabral, P., & Sena, R. (2001). WebGIS as a<br />
teaching tool. Proceedings of the ESRI UC, 9-13.<br />
Shaig, A. (2001, December). An Overview of Web based Geographic<br />
Information Systems. In The 13th Annual Colloquium of the Spatial<br />
Information Research Centre. Dunedin: University of Otago.<br />
Oliviero, C., Parente, C., & Santamaria, R. (2006) La Cartografia In Rete<br />
E Nelle Applicazioni WebGIS.” ·<br />
Letellier, R., Schmid, W., & LeBlanc, F. (2007). Guiding Principles,<br />
Recording Documentation and Information Management for the<br />
Conservation of Heritage Places. Paul Getty Trust, Getty Conservation<br />
Institute: Los Angeles, USA, 36-38.<br />
Circolare n. 24/2012 in cui si rende noto il Decreto n. 7/2012 del MiBAC<br />
Direttiva MiBACT - 23 Aprile 2015<br />
Parole Chiave<br />
Web-GIS; valorizzazione; patrimonio culturale; visualizzazione dati; GIS<br />
Autore<br />
Annalisa Conforti<br />
annalisa.conforti@beniculturali.it<br />
Segretariato Regionale del MiBACT per le Marche<br />
Luigi Federico D’Amico<br />
S1102056@studenti.univpm.it<br />
DICEA – Università Politecnica delle Marche<br />
Giovanni Issini<br />
giovanni.issini@beniculturali.it<br />
Segretariato Regionale del MiBACT per le Marche<br />
Abstract<br />
The Italian Ministry of Culture regional branch in Marche region is developing<br />
a Web-GIS system dedicated to the local cultural heritage, focused to architectural<br />
and landscape sites. The informative system is based on two main<br />
datasets: the regional listed architectural heritage sites and the architectural<br />
heritage sites affected by 2016 earthquake events. The data processing and<br />
the following datasets merging arose challenging issues linked to the complexity<br />
of the information associated to each architectural site. Through a<br />
research partnership the project team firstly defined a method based on the<br />
critical understanding of the cultural features of the sites. Subsequently the<br />
data processing procedure was codified through a mismatch control protocol,<br />
tested over a sample of the sites.<br />
Eva Savina Malinverni<br />
e.s.malinverni@staff.univpm.it<br />
DICEA – Università Politecnica delle Marche<br />
Camilla Tassi<br />
camilla.tassi@beniculturali.it<br />
Segretariato Regionale del MiBACT per le Marche<br />
Sara Trotta<br />
sara.trotta@beniculturali.it<br />
Segretariato Regionale del MiBACT per le Marche<br />
Works when you do<br />
X-PAD Ultimate<br />
Tutto in un unico software<br />
X-PAD Ultimate è un software modulare, facile da usare per lavori<br />
topografici e del cantiere, come rilievi, tracciamenti, catasto,<br />
controlli BIM, strade, mappe, batimetria e GIS.<br />
Il software è disponibile sulla piattaforma Android e porta le<br />
migliori tecnologie direttamente in campo nella tua mano: una<br />
completa visualizzazione 3D ed un sistema CAD per visualizzare e<br />
modificare i disegni, integrazione dei tuoi dati con tutte le tipologie<br />
di mappe, supporti per la realtà aumentata e molto altro.<br />
XPad Ultimate ti assicura la produttività e ti permette di avere una<br />
perfetta integrazione con tutti gli strumenti.<br />
Disponibile in due versioni, una dedicata a chi lavora nel campo<br />
della topografia ed una dedicata alle imprese di costruzioni,<br />
offrendo ad entrambi delle caratteristiche dedicate.<br />
26 ArcheomaticA N°1 marzo <strong>2021</strong><br />
geomax-positioning.it<br />
©2020 Hexagon AB and/or its subsidiaries<br />
and affiliates. All rights reserved.
Tecnologie per i Beni Culturali 27<br />
Ogni oggetto, ogni luogo, ogni gesto<br />
racconta l'emozione di una storia<br />
hubstract.org<br />
Hubstract - made for art è uno studio creativo: autori digitali, videomakers, designers e storytellers<br />
realizzano percorsi di visita, allestimenti, eventi e contenuti combinando le nuove tecnologie e i<br />
linguaggi digitali alle esperienze tradizionali.<br />
hubstract.madeforart<br />
hubstract<br />
hubstract
ARCHEOLOGIA FORENSE<br />
L'Archeologia Forense e la<br />
Ricerca di Persone Scomparse<br />
Non solo ricostruzioni sulla scena del crimine ma anche<br />
sostanziale aiuto per ritrovare persone scomparse<br />
di P. M. Barone<br />
Fig. 1 - Schema riassuntivo della XXIV Relazione del Commissario Straordinario per le persone scomparse (Commissario Straordinario <strong>2021</strong>:<br />
https://www.interno.gov.it/sites/default/files/<strong>2021</strong>-02/xxiv_relazione_annuale_2020_compressed.pdf).<br />
Come già trattato in questa rivista (Barone 2020), l’archeologia forense non si occupa solo della<br />
ricostruzione di dinamiche criminali all’interno di una scena del crimine (Groen et al. 2015; Barone<br />
e Groen 2018), ma anche di aiutare le forze dell’ordine nella ricerca di persone scomparse<br />
(Barone et al., <strong>2021</strong>a; Barone et al. <strong>2021</strong>b).<br />
Questo sembrerebbe un argomento completamente avulso dall’archeologia tradizionale ed in parte lo<br />
è. Per questo è importante sottolineare l’aggettivo “forense” ogniqualvolta ci addentriamo nei meandri<br />
della criminalistica all’interno di un contesto legale. L’Archeologia tradizionale ovviamente è ben<br />
lungi da occuparsi di questi aspetti, ma la sua attitudine intrinsecamente olistica di approcciarsi allo<br />
studio del territorio, la rende una perfetta candidata per chi voglia declinare questa disciplina in ambito<br />
giuridico. È importante sottolineare, però, che è necessaria una specifica formazione ed esperienza<br />
in entrambi i settori (quello delle scienze archeologiche e quello delle scienze giuridiche). Improvvisarsi<br />
in tale settore o millantare crediti porta solo nocumento a se stessi, in primis, e alla comunità.<br />
L’ambito della ricerca delle persone scomparse risponde proprio alla necessità di avere un approccio<br />
eticamente e professionalmente probo e corretto per non incorrere non solo in atteggiamenti lesivi<br />
dell’integrità e dell’emotività degli attori coinvolti, ma anche in eventuali sanzioni legali (Barone e Di<br />
Maggio 2019).<br />
28 ArcheomaticA N°1 marzo <strong>2021</strong>
Tecnologie per i Beni Culturali 29<br />
La scomparsa delle persone è un fenomeno<br />
complesso, dinamico e multidimensionale<br />
che mette in evidenza<br />
una questione sociale e, per poterne<br />
monitorare l’evoluzione, necessita di<br />
un’analisi costante. Questo lavoro è<br />
svolto dal Commissario Straordinario<br />
per le Persone Scomparse presso il<br />
Ministero dell’Interno, che ogni anno<br />
pubblica sul sito del Ministero un report<br />
aggiornato con i dati aggregati e<br />
disaggregati delle persone scomparse<br />
in Italia. In particolare, i dati complessivi<br />
sul fenomeno - a partire dal<br />
1° gennaio 1974 e fino al 31 dicembre<br />
2020 - sono distinti per macroaree<br />
di riferimento, ovvero per fasce<br />
di età, per genere, per nazionalità e<br />
per motivazione della scomparsa. Le<br />
denunce di scomparsa registrate dalle<br />
Forze dell’ordine, dal 1° gennaio<br />
1974 fino al 31 dicembre 2020, sono<br />
258552. Di queste, 195710 riguardano<br />
soggetti che sono stati ritrovati, mentre risultano ancora<br />
da ritrovare 62842 scomparsi (Commissario Straordinario<br />
<strong>2021</strong>) (Figura 1).<br />
La geolocalizzazione è di primaria importanza in questo<br />
ambito. Geolocalizzazione, in generale, significa poter<br />
trovare persone, animali, mezzi e cose in tempo reale e<br />
con un’ottima precisione. Sinonimo di RTLS (Real Time Location<br />
Systems – Sistemi di Localizzazione in Tempo Reale),<br />
la geolocalizzazione permette non solo di innescare una<br />
tracciabilità e una rintracciabilità che offre informazioni<br />
preziose e strategiche a supporto della gestione, ma anche<br />
di creare nuovi servizi con valore aggiunto nell'ambito della<br />
ricerca persone scomparse (Barone et al., 2020; Barone<br />
et al., <strong>2021</strong>b).<br />
Fig. 2 - Domande "geografiche" da porre per ricostruire un corretto locus operandi.<br />
Telefonini, social network, persino le chiavi della macchina<br />
con transponder sono tutti sistemi che permettono una<br />
geolocalizzazione precisa di una persona. Esistono poi applicazioni<br />
che rintracciano telefonini spenti o senza campo<br />
utilizzando solo tre parole (https://what3words.com/) oppure<br />
mediante quella che si chiama profilazione geografica<br />
(locus operandi) o ancora attraverso l'analisi delle immagini<br />
satellitari. Vediamoli nel dettaglio di seguito.<br />
Per lavorare con la geolocalizzazione bisogna avere conoscenze<br />
di telerilevamento, geofisica, GIS e geoarcheologia<br />
oltre a conoscere bene il territorio e gli strumenti informatici<br />
e digitali relativi. Più nel dettaglio, se una persona<br />
è scomparsa in un fiume, per esempio, per prima cosa si<br />
dovrebbe capire la velocità media del corso d’acqua e ve-<br />
Fig. 3 - Un esempio reale di locus operandi. Il punto bianco risulta essere il punto di ritrovamento della persona scomparsa che rientra nell’area individuata<br />
dalla profilazione geografica.
dere se sfocia in un mare o in un lago e magari posizionare<br />
delle grate a mo’ di chiusa per permettere di “filtrare”<br />
qualsiasi cosa che non sia acqua. Contestualmente, attraverso<br />
l’analisi delle immagini satellitari temporali, usando<br />
specifici filtri, si possono individuare anomalie relative a<br />
corpi che si muovono giornalmente lungo il corso d’acqua<br />
e quindi avere la possibilità di dirottare le ricerche in un<br />
punto preciso (Barone <strong>2021</strong>b). L’approccio che potrebbe<br />
essere più promettente è quello che viene definito con il<br />
termine an glosassone Geographic Profiling. Se questa tecnica<br />
è nota negli ambienti forensi come metodica per la<br />
pre venzione del crimine seriale (Rossmo, 2000), non è stato<br />
mai applicato finora alla ricerca di persone scomparse<br />
con il termine di locus operandi.<br />
Per comprendere meglio il potenziale della profilazione<br />
geografica o locus operandi come “agente intelligente”<br />
nella ricerca delle persone scomparse, biso gna prima capire<br />
la sua storia e di cosa si tratta. La profilazione geografica<br />
è un metodo criminologico utilizzato per individuare<br />
approssimativamente l’area in cui risiede un criminale seriale.<br />
Sebbene sia uno strumento di organizzazione utile e<br />
un campo sempre più popolare, questo metodo è costantemente<br />
aggiornato poi ché le basi matematiche sono costantemente<br />
perfezionate. Tra gli altri calcoli matematici<br />
avanzati, i calcoli di base implicano l’applicazione della<br />
formula della distanza e la ricerca del centroide (Barone<br />
et al., 2020). Oggi questa tecnica è spesso utilizzata in ambito<br />
criminologico e la maggior parte dei proventi destinati<br />
alla ricerca, sono dedicati all’in dividuazione di software<br />
computazionali più potenti con lo scopo di realizzare aree<br />
sempre più precise (Barone et al., 2020).<br />
Come visto, il locus operandi risulta un’arma molto utile<br />
per le forze dell’ordine per la predizione di crimini futuri.<br />
È evidente come questo approccio abbia il potenziale<br />
di ridurre drasti camente le zone di ricerca a pochi<br />
km2, quando normalmente vengono ricoperti molti ettari,<br />
molto spesso con esiti negativi. Il principio è similare al<br />
tradizionale Geographic Profiling, ma inve ce di concentrare<br />
l’attenzione sul criminale e la sua zona di interesse o<br />
hot zone, ci si sof ferma ad analizzare le zone frequentate<br />
dalla persona scomparsa prima della sparizione. Le<br />
informazioni della polizia devono essere molto accurate e<br />
per questo sarebbe bene, al momento della denuncia della<br />
persona scomparsa, porre le domande in Figura 2 (Barone<br />
et al., <strong>2021</strong>). Per ottenere, conseguentemente, una profilazione<br />
geografica efficace, è necessario ela borare i dati<br />
geografici utilizzando la geometria computazionale (Barone<br />
et al., <strong>2021</strong>a; Barone et al. <strong>2021</strong>b). In tutto il mondo i<br />
sistemi di ricerca si stanno sempre più perfezio nando, anche<br />
con l’utilizzo di nuove tecnologie (Barone e Di Maggio,<br />
2019a; Barone e Di Maggio, 2019b; Pensieri et al., 2020),<br />
ma l’impiego dell’intelligenza artificiale in questo settore<br />
spe cifico è ancora sottostimato anche se potrebbe essere<br />
fondamentale per la cosiddetta spatial analysis e la creazione<br />
di modelli predittivi riducendo l’areale di ricerca<br />
con una buona approssimazione (Barone et al., <strong>2021</strong>a; Barone<br />
et al. <strong>2021</strong>b) (Figura 3).<br />
In casi in cui i risvolti delle indagini portano a pensare alla<br />
morte e possibile occultamento del cadavere della persona<br />
scomparsa, tali metodi prevedono un’analisi territoriale<br />
mediante telerilevamento, ovvero utilizzando immagini<br />
satellitari, da aereo o drone per poter non solo analizzare<br />
il territorio della scomparsa da remoto ma anche poter evidenziare<br />
tramite immagini a cronologia differente (ovvero<br />
prima e dopo la scomparsa) eventuali cambiamenti del<br />
territorio mediante una serie di filtri multispettrali come<br />
il vicino-infrarosso, l’NDVI (l’indice di crescita della vegetazione),<br />
l’NDWI (l’indice di variazione dei bacini idrici)<br />
o il LiDAR in aree boschive (Barone et al., <strong>2021</strong>b). Queste<br />
preliminari analisi eseguite al computer sono necessarie<br />
per prepararsi a recarsi in loco e permettono un notevole<br />
restringimento del campo di ricerca favorendo un’investi-<br />
Fig. 4 - Questa figura mostra la copertura mediatica internazionale del caso italiano (a), la regione italiana dove è avvenuta la scomparsa (b), un'immagine<br />
NIR della zona della scomparsa con i dettagli dell'anomalia relativa al corpo senza vita della madre (c).<br />
30 ArcheomaticA N°1 marzo <strong>2021</strong>
Tecnologie per i Beni Culturali 31<br />
gazione autoptica dei luoghi più precisa e focalizzata. Tale<br />
ricognizione può aiutare nella creazione di un’ulteriore<br />
mappa che aiuta a ridurre ancora di più la ricerca sul campo.<br />
Tale mappa è la cosiddetta RAG map (Red Amber Green<br />
map) o mappa a semaforo in cui si evidenziano i settori in<br />
cui è molto, mediamente e poco probabile la presenza di<br />
un occultamento di un eventuale cadavere. Nelle ristrette<br />
zone dedotte dalle suddette analisi, è possibile effettuare<br />
un ulteriore controllo mediante indagini geofisiche (nella<br />
fattispecie mediante georadar) che in maniera del tutto<br />
non invasiva e ripetibile permette di avere un’interpretazione<br />
abbastanza accurata del sottosuolo (Barone et al.,<br />
<strong>2021</strong>a; Barone et al. <strong>2021</strong>b).<br />
Successivamente a tutte le metodologie impiegate ed illustrate<br />
finora, in maniera assolutamente non distruttiva/<br />
invasiva, si può avere un’area molto circoscritta di ricerca<br />
con un’alta probabilità di individuare il target investigativo.<br />
A questo punto solo uno scavo stratigrafico/scientifico<br />
(che segue le procedure archeologiche) e non arbitrario (a<br />
ruspa o con mezzi impropri) permette di collezionare tutte<br />
le evidenze necessarie per ricostruire propriamente la<br />
scena del crimine ed eventualmente, avere una cronologia<br />
relativa traendone le dovute considerazioni (Barone 2020;<br />
Barone 2016; Barone e Di Maggio, 2019b).<br />
Alla luce di quanto detto, è auspicabile compiere degli<br />
sforzi per raccogliere e registrare questo tipo di informazioni<br />
con la massima accuratezza e celerità possibili:<br />
mai muoversi dalle centrali operative senza aver attuato i<br />
passaggi illustrati precedentemente. L'utilizzo, quindi, di<br />
tecniche che vanno dalla macroscala alla microscala, identificando<br />
tutte le peculiarità e le informazioni utili alla<br />
ricerca, riducendo l'uso delle risorse umane, la possibilità<br />
di limitare i tempi di intervento e la capacità di operare<br />
in condizioni difficili e / o di pericolo per le squadre di<br />
soccorso sono alla portata economica di tutti oggigiorno.<br />
Riassumendo, quindi: i) Google e i principali social network,<br />
se non disattivata di proposito, hanno una localizzazione<br />
costante. In caso di persona scomparsa, è sufficiente<br />
entrare nel suo account (se ne ha uno, naturalmente); ii)<br />
What3words all’estero è una app cosiddetta a due uscite,<br />
ovvero l’utente può inviare tramite app la sua posizione<br />
oppure la centrale operativa può collegarsi allo smartphone<br />
della persona scomparsa anche se è spento o non raggiungibile;<br />
in seguito, iii) il locus operandi permette, attraverso<br />
un’analisi predittiva (tipo quella del film Minority<br />
Report con Tom Cruise) di capire e definire, in base ai luoghi<br />
visitati normalmente, quale può essere la zona in cui è<br />
scomparsa la persona; infine, iv) lo studio delle immagini<br />
satellitari può essere di fondamentale aiuto essendo acquisite<br />
non solo ogni giorno ma anche in differenti bande o<br />
frequenze che permettono talvolta di vedere “l’invisibile”<br />
(Figura 4). Ovviamente questo porta a focalizzare le ricerche<br />
per altre unità come georadar, unità cinofile e ricognitori<br />
di terra esperti (anche detti field-walkers) (Groen et<br />
al. 2015; Barone & Groen 2018; Barone e Di Maggio 2017;<br />
Barone e Di Maggio 2019a; Barone et al., <strong>2021</strong>a; Barone et<br />
al. <strong>2021</strong>b).<br />
In conclusione, l’auspicio è quello che, così come avviene<br />
all’estero, anche in Italia si riesca a diffondere in maniera<br />
capillare l’apporto delle conoscenze prettamente archeologiche<br />
di analisi spaziale e geolocalizzazione che risultano<br />
di fondamentale importanza se declinate in ambito forense<br />
con particolare riguardo al supporto per le ricerche<br />
di persone scomparse.<br />
Bibliografia<br />
Barone, P.M. 2016 Understanding Buried Anomalies: A Practical<br />
Guide to GPR; LAP LAMBERT Academic Publishing: Saarbrücken,<br />
Germany; ISBN 978-3-659-93579-4.<br />
Barone, P.M. 2020 Contestualizzare l’Archeologia Forense; <strong>Archeomatica</strong><br />
- Tecnologie per i Beni Culturali, Anno XII - Numero<br />
2 Giugno<br />
Barone, P.M.; Di Maggio, R.M. 2019 Dealing with Different Forensic<br />
Targets: Geoscientists at Crime Scenes, Geological Society,<br />
Special Publications: London, 492. DOI: 10.1144/SP492-2017-<br />
274.<br />
Barone, P.M.; Di Maggio, R.M. 2019 Forensic Geophysics:<br />
Ground Penetrating Radar (GPR) Techniques and Missing<br />
Persons Investigations. Forensic Sci. Res.,4, 337–340. doi:<br />
10.1080/20961790.2019.1675353<br />
Barone, P.M.; Di Maggio, R.M. 2019 Low-Cost CSI Using Forensic<br />
GPR, 3D Reconstruction, and GIS. J. Geogr. Inf. Syst. 11, 493–<br />
499, doi: 10.4236/jgis.2019.115030<br />
Barone P.M., Di Maggio R.M. & Mesturini S. <strong>2021</strong> Materials<br />
for the study of the locus operandi in the search for<br />
missing persons in Italy, Forensic Sci. Res., 1, 1–7. doi:<br />
10.1080/20961790.2020.1854501<br />
Barone PM, Di Maggio RM, Mesturini S. <strong>2021</strong> Forensic Geoarchaeology<br />
in the Search for Missing Persons. Forensic Sciences, 1(1),<br />
8-15. doi: 10.3390/forensicsci1010003<br />
Barone, P.M.; Groen, W.J.M. 2018 Multidisciplinary Approaches<br />
to Forensic Archaeology: Topics discussed During the European<br />
Meetings on Forensic Archaeology (EMFA); Springer, ISBN 978-3-<br />
319-94397-8.<br />
Barone P.M., Mesturini S., Pensieri M.G., Volpini L. 2020 L’AI nella<br />
ricerca delle persone scomparse in A.F. Uricchio, G. Riccio,<br />
U. Ruffolo (a cura di) Intelligenza artificiale tra etica e diritti.<br />
Prime riflessioni a seguito del libro bianco dell’Unione europea,<br />
Carucci Editore.<br />
Commissario Straordinario del Governo per le persone scomparse,<br />
XXIV Relazione annuale, (1° gennaio 2020 – 31 dicembre<br />
2020, Ministero dell’Interno, <strong>2021</strong>.<br />
Di Maggio, R.M., Barone, P.M. (eds.) 2017 Geoscientists at Crime<br />
Scenes: A Companion to Forensic Geoscience; Soil Forensics;<br />
Springer International Publishing, ISBN 978-3-319-58047-0.<br />
Groen, W.J.M.; Marquez-Grant, N.; Janaway, R. 2015 Forensic Archaeology:<br />
A Global Perspective; Wiley, ISBN 978-1-118-74598-4.<br />
Pensieri, M.G.; Garau, M.; Barone, P.M. 2020 Drones as an Integral<br />
Part of Remote Sensing Technologies to Help Missing People.<br />
Drones, 4, 15. doi: 10.3390/drones4020015<br />
Rossmo, D.K. 2000 Geographic Profiling; CRC Press: Boca Raton,<br />
FL, USA.<br />
Abstract<br />
Forensic archaeology and the search for missing persons, not only reconstructions on the crime<br />
scene but also substantial help to find missing persons.<br />
Parole chiave<br />
Archeologia forense; geolocalizzazione; RTLS; persone scomparse<br />
Autore<br />
P. M. Barone<br />
p.barone@aur.edu
AZIENDE E PRODOTTI<br />
• Vulcanologia e Monitoraggio sismico<br />
• Geofisica Marina e Rappresentazione dei fondali e<br />
delle coste<br />
• 3D Imaging e Telerilevamento<br />
• Navigazione e posizionamento di precisione<br />
• Qualificato laboratorio di assistenza tecnica<br />
www.codevintec.it<br />
PROGETTO AMOR - ADVANCED MULTIMEDIA AND OBSER-<br />
VATION SERVICES FOR THE ROME CULTURAL HERITAGE<br />
CHI CI PENSA AGLI INESPLOSI IN MARE?<br />
Interessante sessione di Archeologia Marina al 4° Convegno<br />
dei Geologi Marini. Affezionata all’evento, Codevintec<br />
ha partecipato con un paper dal titolo “L’importanza<br />
di indagini OBI-UXO accurate in mare" presentato<br />
da Nicola Catalano. Il fatto che un ordigno sia rimasto<br />
sul fondale o nascosto sotto, inesploso per anche 100<br />
anni, non lo rende meno pericoloso. È importante elaborare<br />
uno studio del rischio - specifico per il sito di<br />
indagine – prima di qualsiasi indagine intrusiva. Cos’è il<br />
rischio mitigato, e rischio residuo? Cosa può, cosa non<br />
può essere individuato, e qual è lo strumento adatto?<br />
Pianificare e condurre un’indagine magnetometrica<br />
mirata è uno dei mezzi più efficienti per mitigare il<br />
rischio di incorrere in un ordigno bellico inesploso (OBI,<br />
anche detto UXO).<br />
Il magnetometro marino di casa Geometrics G-882, è<br />
l’unico che soddisfa gli standard richiesti per la bonifica<br />
degli OBI nel Mare del Nord. Si tratta di un magnetometro<br />
ai vapori di Cesio ad altissima risoluzione, adatto<br />
all’utilizzo in acque profonde e superficiali e capace<br />
di interfacciarsi con i Side Scan Sonar più diffusi per il<br />
traino. Così da unire i due rilievi.<br />
Un’altra componente per le indagini OBI è il software<br />
per l’elaborazione e l’analisi dei dati magnetometrici<br />
acquisiti. Oasis Montaj, con i suoi moduli UXO Marine<br />
Mag e UXO Marine Grad appositamente sviluppati, ad<br />
oggi è il software di riferimento per le indagini magnetometriche<br />
marine.<br />
Ma non solo: software completo, sviluppato grazie alla<br />
conoscenza degli OBI e migliorato grazie all’attenzione<br />
che il produttore Seequent presta ai riscontri ricevuti<br />
dai clienti. Ottimizza e snellisce il processamento dei<br />
dati: dall’import, al picking dei target, fino al calcolo<br />
di dimensione e profondità degli stessi, per arrivare<br />
alla creazione di liste di mappe e liste di target con<br />
relative coordinate.<br />
La sessione Geoarcheologia Marina e costiera è stata<br />
moderata da Maria Rosaria Senatore, Pietro P. Aucelli,<br />
Paolo Orrù, Rita Melis.<br />
Chi è Codevintec?<br />
Codevintec è riferimento per strumenti ad alta tecnologia<br />
nelle Scienze della Terra e del Mare:<br />
• Geofisica terrestre e Studio del sottosuolo<br />
Il progetto AMOR - Advanced Multimedia and Observation<br />
services for the Rome cultural heritage - è una iniziativa<br />
NAIS nell'ambito del programma ARTES 20 IAP 5G<br />
per L'ART Business Applications Programme dell'Agenzia<br />
Spaziale Europea (ESA), cofinanziato dall'Agenzia spaziale<br />
Italiana (ASI). Le attività del progetto sono iniziate a<br />
novembre 2020 e avranno una durata di 24 mesi.<br />
AMOR si propone di supportare sia le Istituzioni responsabili<br />
dei Beni Culturali (Soprintendenza speciale Archeologia,<br />
Belle Arti e Paesaggio di Roma; Sovrintendenza<br />
capitolina ai Beni Culturali di Roma) sia i visitatori, in<br />
termini di:<br />
• Salvaguardia, tramite ispezione / monitoraggio multimodale<br />
del sito;<br />
• Fruizione, attraverso soluzioni avanzate di fruizione;<br />
Le tecnologie abilitanti AMOR comprendono:<br />
• Osservazione della Terra da satellite, utilizzata per:<br />
- identificazione e mappatura delle criticità,<br />
- valutazione dello stato di conservazione;<br />
• Navigazione satellitare utilizzata per il tracciamento<br />
dei visitatori (anonimizzato) e la derivazione dell'analisi<br />
dei dati;<br />
• Piattaforme aeree (sistemi UAV), dotate di sensori<br />
scelti sulla base di:<br />
- specificità della missione,<br />
- risoluzione spaziale più elevata;<br />
• Tecnologia GPR (Ground Penetrating Radar) utilizzata<br />
per:<br />
- prospezioni del sottosuolo;<br />
32 ArcheomaticA N°1 marzo <strong>2021</strong>
Tecnologie per i Beni Culturali 33<br />
- indagini sotto la superficie di strutture verticali (muri,<br />
colonne, ecc.);<br />
• Tecnologia 5G, che consente soluzioni di fruizione AR.<br />
Le aree pilota, comprese nel centro storico di Roma (sito<br />
Unesco dal 1980), sono:<br />
• Terme di Caracalla;<br />
• Mura Aureliane (parte di);<br />
Il team proponente è composto da:<br />
- NAIS (Nextant Applications and Innovative Solutions)<br />
(Prime Contractor)<br />
- ICR (Istituto per la conservazione e il restauro)<br />
- CNR - IREA (Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto<br />
per Il Rilevamento Elettromagnetico dell'Ambiente)<br />
- CoopCulture<br />
- ESRI<br />
- NITEL<br />
L’ARCHEOLOGIA VISTA DAL DRONE...<br />
Con DJI Mini sono state fatte 3 missioni a 25 metri, di 10<br />
minuti ciascuna.<br />
Con le prime 2 missioni nadirali, andando ad incrociare i<br />
2 voli precedenti, la terza missione invece è stata effettuata<br />
con un volo circolare e la camera inclinata di 45°.<br />
Si è cercato di effettuare scatti fotografici con una sovrapposizione<br />
almeno del 70%.<br />
Sono stati posizionati N°10 caposaldi rilevati con strumentazione<br />
GNSS, operazione necessaria sia per riferire<br />
il rilievo alle altre campagne di misura sia per migliorare<br />
le accuratezze del rilievo fotogrammetrico.<br />
Sono state eseguite ben 862 foto, un numero elevato di<br />
fotogrammi indispensabili per ottenere i risultati in fotografia<br />
qui sotto.<br />
Il tutto è stato elaborato con software 3DF-Zephyr.<br />
3DF-Zephyr si è dimostrato vincente per l’elaborazione<br />
di questo rilievo grazie ai suoi algoritmi brevettati.<br />
Infatti l’algoritmo SASHA è dedicato all’estrazione delle<br />
mesh e permette di ottenere un modello 3D con bordi<br />
nitidi e margini netti!<br />
Dal modello generato, sempre nell’ambiente 3DF Zephyr,<br />
è stato possibile estrarre le curve di livello e sezioni in<br />
punti strategici dell’area del cantiere.<br />
Per saperne di più sulla fotogrammetria e sull’elaborazione<br />
con il software 3DF-Zephyr chiama lo 055 8954766<br />
Oggi vogliamo parlare di un caso studio avvenuto in un<br />
cantiere sito a Verona. Verona ha attraversato da protagonista<br />
le epoche storiche, la sua posizione strategica<br />
l’ha spesso salvata da devastazioni. I conquistatori avevano<br />
interesse a conservare una città fortificata integra,<br />
di cui servirsi per il dominio sul territorio. Il centro storico<br />
di questa fantastica città è caratterizzato da molte<br />
testimonianze, resti, monumenti ed edifici di ogni epoca<br />
e stile.<br />
Per numero di reperti è seconda solo a Roma. Come<br />
spesso accade nei centri storici italiani, buona parte dei<br />
reperti sono sottoterra, dai due ai tre metri al di sotto<br />
dell’attuale piano stradale.<br />
E’ quello che è successo nell’ennesimo cantiere della città<br />
Scaligera nei pressi di Borgo Venezia.<br />
Durante la fase di scavo per la predisposizione al cantiere<br />
di un nuovo fabbricato, i lavori si sono improvvisamente<br />
bloccati per il ritrovamento di uno scheletro umano di<br />
circa 2000 anni fa….<br />
Ovviamente sono intervenuti tempestivamente una squadra<br />
di archeologi, progettisti, architetti e topografi rilevatori.<br />
La scelta è stata quella di fare immediatamente un volo<br />
con il drone per sorvolare tutta l’area del cantiere e riferire<br />
tutto il rilievo con le precedenti campagne di misura.<br />
NUOVO DRONE DJI MAVIC 2 ENTERPRISE CON CAMERA<br />
TERMICA PER OPERAZIONI CRITICHE<br />
La DJI, azienda cinese leader nel mercato dei droni per<br />
scopi ludici, oramai affermata anche nel campo dei droni<br />
per operazioni più complesse, molto utili anche nel campo<br />
del Patrimonio Culturale, ha il suo nuovo prodotto: DJI<br />
Mavic Enterprise Advanced. Le novità rispetto ai precedenti<br />
droni enterprise sono molteplici tra cui la camera,<br />
il sistema di posizionamento e vari accessori. La camera<br />
con un sensore da 1/2'' 48 MP, zoom digitale fino a 32x e<br />
una camera termica con risoluzione 640x512, frame rate<br />
di 30 Hz e zoom digitale fino a 16x può tornare molto utile<br />
nell'analisi termografica con notevoli applicazioni nello<br />
studio dei manufatti architettonici, specie se storici,<br />
perché consente di vedere al di là della superficie opaca<br />
scoprendo, ad esempio, discontinuità materiali e strutturali<br />
e quindi la presenza di cavità, vuoti, tamponature,<br />
occlusioni o anche antiche aperture. Un'altra utilità può
AZIENDE E PRODOTTI<br />
essere anche una ripresa termografica di pareti e soffitti<br />
di ampia estensione per il rilievo del grado di umidità,<br />
dovuto ad infiltrazioni non definibili dalla colorazione degli<br />
intonaci, con indubbio vantaggio per stabilire ampiezza<br />
e profondità d’intervento su affreschi, tinteggiature<br />
e crescita spontanea di vegetazione a macchia sui tratti<br />
murari di rovine ed edifici storici e le relative variazioni<br />
subite nel corso del tempo.<br />
Di seguito il commento di uno dei responsabili della DJI:<br />
“Abbiamo notato che i nostri consumatori Enterprise<br />
hanno utilizzato Mavic 2 Enterprise per condurre ispezioni<br />
industriali dove una migliore precisione e risoluzione<br />
maggiore per sensori termici e di visualizzazione<br />
rappresentavano funzioni essenziali per operare in modo<br />
preciso. Grazie ai nuovi aggiornamenti, Mavic 2 Enterprise<br />
Advanced si trasforma nel drone must-have ideale<br />
per questo tipo di ispezioni complesse,” dice Christina<br />
Zhang, responsabile DJI per le strategie aziendali. “I professionisti<br />
dell'ispezione saranno in grado di individuare<br />
difetti e anomalie con maggiore dettaglio ed eseguire<br />
operazioni e manutenzione in modo più efficace. Infine,<br />
i primi soccorritori e i vigili del fuoco saranno in grado di<br />
localizzare rapidamente le vittime, identificare i punti<br />
caldi e schermare i rischi di incendio per redigere piani<br />
di salvataggio mirati, mantenendo il personale al sicuro ".<br />
Specifiche della camera termica<br />
Grazie ai suoi doppi sensori avanzati con una telecamera<br />
con risoluzione termica HD 640×512 px e una telecamera<br />
visiva da 48 MP con un sensore CMOS da 1/2 ", i professionisti<br />
saranno in grado di prendere decisioni informate<br />
identificando rapidamente gli oggetti sul posto. La termocamera<br />
presenta un frame rate di 30 Hz e consente<br />
una precisione di misurazione della temperatura di ± 2<br />
° C. I piloti possono passare da feed visivi, termici o con<br />
vista divisa per diverse esigenze di progetto. Mavic 2 Enterprise<br />
Advanced può acquisire immagini HD e video 4K<br />
da una distanza di sicurezza. I suoi sensori della telecamera<br />
ad alta risoluzione supportano uno zoom digitale<br />
32x e uno zoom termico 16x, consentendo agli operatori<br />
di concentrarsi sui dettagli che contano sulle missioni di<br />
ispezione aerea.<br />
Altre caratteristiche<br />
Spot Meter – Visualizza la temperatura media di un oggetto,<br />
aiutando i piloti a mantenere una distanza di sicurezza<br />
durante il monitoraggio di oggetti critici o pericolosi.<br />
Area Measurement – Individua i punti con valori di temperatura<br />
minima, media e massima, così come le corrispondenti<br />
posizioni di ciascuna area, permettendo agli<br />
ispettori il rilevamento rapido di soggetti e determinare<br />
eventuali aree surriscaldate.<br />
Sistema di posizionamento centimetrico<br />
Il nuovo DJI Mavic 2 Enterprise Advanced può essere dotato<br />
di un modulo DJI RTK (disponibile separatamente) che<br />
raggiunge una precisione al centimetro e supporta NTRIP,<br />
che consente al drone di resistere alle interferenze elettromagnetiche<br />
rendendolo ideale per le ispezioni powerline.<br />
Gli operatori possono creare fino a 240 waypoint per<br />
condurre missioni di ispezione automatizzate e dettagliate<br />
in ambienti complessi. Il formato leggero e portatile di<br />
Mavic 2 Enterprise Advanced offre la massima agilità in<br />
quanto può decollare in meno di un minuto e sfrecciare<br />
attraverso ambienti operativi complessi grazie a velocità<br />
di salita e discesa più elevate.<br />
Accessori utili<br />
Faro – Il faretto con una luminosità di 2.400 lumen aiuta<br />
le operazioni di notte e in condizioni di luce scarsa o<br />
diurne complesse come nebbia e fumo.<br />
Speaker – Un altoparlante con una proiezione massima di<br />
100 decibel (1 m di distanza) è in grado di memorizzare<br />
più registrazioni vocali e riprodurre clip in loop consentendo<br />
la comunicazione con le squadre di terra durante<br />
le situazioni di emergenza per operazioni efficienti.<br />
Lampeggiante – Conforme agli standard di certificazione<br />
FAA (Federal Aviation Administration) per la segnalazione<br />
notturna, il lampeggiante M2E è dotato di una potente<br />
luce stroboscopica visibile fino a 4,8 km di distanza. Aumenta<br />
la sicurezza delle operazioni notturne o in condizioni<br />
di scarsa luminosità, segnalando la presenza del<br />
drone ai piloti di altri velivoli nelle vicinanze.<br />
DJI Smart Controller – E’ dotato di un display ultra-luminoso<br />
1080p da 5,5 pollici per visualizzare immagini nitide<br />
anche sotto la luce solare diretta.<br />
34 ArcheomaticA N°1 marzo <strong>2021</strong>
TELERILEVAMENTO<br />
Tecnologie per i Beni Culturali<br />
RECENSIONE<br />
AUGMENTED HERITAGE<br />
dall'oggetto esposto<br />
all'oggetto narrato<br />
a cura di Aracne Editrice<br />
AUTORE: DONATO MANIELLO<br />
PREFAZIONE: SANDRA LUCENTE<br />
EDITORE: EDIZIONI LE PENSEUR<br />
PAGINE: 304<br />
PREZZO: € 34<br />
ISBN: 978-88-95315-69-0<br />
In quanti modi è possibile "aumentare" la realtà? La<br />
tecnologia è l'unico modo in cui è possibile raggiungere<br />
questo obiettivo? È possibile parlare di etica digitale<br />
applicata ai beni culturali? Nella prima parte<br />
del volume l'autore affronta queste tematiche in un<br />
percorso sistematico analizzandone le reciproche influenze<br />
per poi introdurre la Spatial Augmented Reality<br />
(SAR), affrontando - in modo teorico - i metodi ad<br />
oggi disponibili con cui è possibile far coincidere scena<br />
reale e modello digitale attraverso l'approccio video<br />
proiettivo. La seconda parte è dedicata all'approfondimento<br />
della SAR sul patrimonio artistico e culturale,<br />
analizzando la parte relativa al metodo e alla progettazione<br />
che ha ispirato le installazioni, curate dallo<br />
stesso autore. Il volume, sintesi dei precedenti scritti<br />
dallo stesso autore, da cui sono eslcuse tutte le parti<br />
manualistiche, amplia con ulteriori approfondimenti<br />
il tema dell’Augmented Heritage, è rivolto a tutti gli<br />
studiosi che desiderano avere un approfondimento<br />
sistematico, teorico e di indirizzo su tale disciplina,<br />
attraverso uno sguardo quanto più ampio possibile sui<br />
metodi culturali della progettazione multimediale.<br />
MONITORAGGIO 3D<br />
GIS E WEBGIS<br />
www.gter.it<br />
info@gter.it<br />
GNSS<br />
FORMAZIONE<br />
RICERCA E INNOVAZIONE
AGORÀ<br />
Monitoraggio sismico in tempo<br />
reale per il Tempio di Nettuno a<br />
Paestum – Il tempio meglio conservato<br />
della Magna Grecia da<br />
marzo <strong>2021</strong> è soggetto a un monitoraggio<br />
sismico continuo grazie<br />
a una collaborazione tra il Parco<br />
Archeologico di Paestum e Velia<br />
e il dipartimento di Ingegneria<br />
Civile dell’Università di Salerno.<br />
Quattordici punti di misura, realizzati<br />
con sensori di ultima tecnologia,<br />
sviluppati nell’ambito<br />
della ricerca sulle onde gravitazionali,<br />
sono stati posizionati sulle<br />
parti alte dell’edifico di V sec.<br />
a.C. e nel sottosuolo, per misurare<br />
in tempo reale ogni minimo<br />
movimento della struttura millenaria.<br />
La precisione degli accelerometri<br />
è tale da poter registrare<br />
non solo attività sismiche,<br />
ma anche l’impatto del traffico e<br />
persino del vento sul tempio. Tali<br />
dati, dal momento che vengono<br />
raccolti in maniera sistematica,<br />
aiuteranno a elaborare un modello<br />
del comportamento dinamico<br />
dell’edifico e saranno fondamentali<br />
per rintracciare cambiamenti<br />
strutturali, non visibili a occhio<br />
nudo, che potrebbero rappresentare<br />
un rischio.<br />
“Si tratta di un’integrazione<br />
virtuosa tra ricerca applicata e<br />
tutela – commenta l’Ing. Luigi<br />
Petti dell’Ateneo salernitano -<br />
che impiega tecnologie e sensori<br />
altamente innovativi, sviluppati<br />
dal Professore Fabrizio Barone<br />
per applicazioni nei settori della<br />
sismologia e della geofisica, integrando<br />
le conoscenze di molti<br />
settori scientifici, tra cui l’archeologia,<br />
l’architettura, la geologia<br />
e l’ingegneria strutturale. Tali<br />
attività rientrano in un progetto<br />
di ricerca più ampio, a cui partecipano,<br />
tra l’altro, le Università<br />
di Roma La Sapienza e di Kassel<br />
in Germania. È, inoltre, iniziata<br />
una collaborazione con l’ISPRA<br />
per attività di monitoraggio sui<br />
beni culturali”.<br />
Il sistema di monitoraggio è stato<br />
progettato dall’arch. Antonella<br />
Manzo, già responsabile dell’ufficio<br />
UNESCO del Parco archeologico,<br />
in collaborazione con il<br />
professore Luigi Petti del Dipartimento<br />
di Ingegneria civile dell’Università<br />
di Salerno; i lavori sono<br />
stati diretti dall’arch. Luigi Di<br />
Muccio della Soprintendenza<br />
ABAP di Caserta e Benevento.<br />
I dati sono stati immessi in rete<br />
sul sito del Parco<br />
Il datacenter dell’Università di<br />
Salerno, d’intesa con il Parco archeologico,<br />
consentirà l’accesso<br />
ai dati a enti di ricerca da tutto il<br />
mondo, previa stipula di una convenzione<br />
non onerosa. Intanto,<br />
una parte dei dati è accessibile<br />
liberamente in tempo reale sulla<br />
pagina del sito istituzionale del<br />
Parco Archeologico di Paestum e<br />
Velia:<br />
www.museopaestum.beniculturali.it/monitoraggio-sismico-deltempio-di-nettuno/<br />
“In questa maniera – commenta<br />
Maria Boffa, funzionaria per la<br />
comunicazione del Parco – ci si<br />
può connettere da tutto il mondo<br />
per seguire il comportamento<br />
dinamico del tempio di Nettuno<br />
in tempo reale. Ovviamente i dati<br />
messi on line sono in uno stato<br />
‘crudo’ e parziale e per accedere<br />
ai dataset completi bisogna<br />
effettuare un’apposita richiesta.<br />
Per avere un’idea di cosa esattamente<br />
stiamo parlando, si può<br />
fare una prova e osservare in video<br />
una oscillazione del monumento<br />
in diretta proprio nell’orario<br />
di transito del Frecciarossa,<br />
oppure quando la situazione meteorologica<br />
a Paestum non è delle<br />
migliori. In tal modo, speriamo<br />
di sensibilizzare il pubblico verso<br />
un campo di ricerca che a lungo<br />
è stato riservato agli addetti ai<br />
lavori e far capire come la tecnologia<br />
può aiutare nella tutela del<br />
patrimonio”.<br />
Novità dagli scavi lungo le fondazioni<br />
Per il posizionamento dei sensori<br />
nel sottosuolo sono stati effettuati<br />
nuovi scavi lungo le fondazioni<br />
del monumento. Le indagini, coordinate<br />
dai funzionari archeologi<br />
Daniele Rossetti e Francesco<br />
Scelza, hanno riservato più di<br />
una sorpresa agli studiosi. “Può<br />
36 36 ArcheomaticA N°1 marzo <strong>2021</strong>
Tecnologie per i Beni Culturali 37<br />
sembrare strano – sottolinea il<br />
direttore del Parco archeologico,<br />
Gabriel Zuchtriegel – ma sono i<br />
primi scavi stratigrafici controllati<br />
e documentati in maniera corretta<br />
sul tempio di Nettuno, uno<br />
dei monumenti dorici più famosi<br />
del mondo antico. E a volte sono<br />
proprio i monumenti più celebri<br />
- che sembrano stranoti anche<br />
se in realtà non lo sono - che nascondono<br />
ancora delle sorprese.<br />
Nel nostro caso, è soprattutto<br />
la cronologia che abbiamo potuto<br />
chiarire grazie alla fortuna di<br />
trovare una stratigrafia intatta<br />
che ancora contiene la storia del<br />
cantiere del tempio. In passato,<br />
Dieter Mertens ipotizzò sulla base<br />
di alcuni dettagli del podio che il<br />
tempio originariamente fosse stato<br />
progettato come un periptero<br />
di 8 x 19 colonne, per poi essere<br />
riprogettato in una forma più<br />
‘moderna’ con 6 x 14 colonne. I<br />
nostri scavi hanno dimostrato che<br />
tutta la parte delle fondazioni<br />
effettivamente risale al periodo<br />
tardo-arcaico, circa mezzo<br />
secolo prima della terminazione<br />
del progetto intorno al 460 a.C.<br />
Come nelle grandi cattedrali del<br />
medioevo, anche qui dobbiamo<br />
immaginare un cantiere che si<br />
protraeva per più generazioni,<br />
con ripensamenti, aggiustamenti<br />
e cambiamenti in corso d’opera.<br />
Inoltre, lo scavo ci ha messo nella<br />
condizione di ricostruire come<br />
la costruzione del tempio abbia<br />
comportato una rimodulazione<br />
del paesaggio circostante. Prima<br />
di iniziare la costruzione, l’area<br />
dove sarebbe sorto il tempio era<br />
stata livellata, però senza abbassare<br />
il livello molto al di sotto del<br />
piano di campagna. Su un sottile<br />
strato di sabbia di mare, riscontrato<br />
in tutti e quattro i saggi<br />
lungo le fondazioni, furono poi<br />
messe le fondamenta che erano<br />
dunque quasi completamente al<br />
di sopra del piano di campagna.<br />
Solo successivamente furono coperti<br />
di terreno, creando così una<br />
specie di collinetta artificiale intorno<br />
al podio del tempio che<br />
si può apprezzare ancora oggi.<br />
Tutto ciò ha arricchito in maniera<br />
straordinaria la nostra conoscenza<br />
del tempio dorico meglio<br />
conservato della Magna Grecia; è<br />
un episodio che ancora una volta<br />
fa capire come tutela e ricerca<br />
siano due facce della stessa medaglia”.<br />
Il progetto finanziato con Artbonus<br />
I lavori per la messa in opera del<br />
sistema di monitoraggio sono stati<br />
finanziati con donazioni arrivate<br />
attraverso il portale Artbonus<br />
del Ministero della Cultura che<br />
prevede sgravi fiscali a chi sostiene<br />
la tutela e la valorizzazione<br />
di beni culturali. Tra i maggiori<br />
contribuenti la famiglia di Sabato<br />
D’Amico, titolare dell’omonima<br />
azienda di Pontecagnano, e Roberto<br />
Savarese di Sorrento Sapori<br />
e Tradizioni Srl.<br />
“Donare per la realizzazione del<br />
progetto di monitoraggio ci ha<br />
fatto sentire custodi della storia<br />
– dichiara Sabato D’Amico -.<br />
Con la nostra azienda cerchiamo<br />
di affermare il made in Italy in<br />
tutto il mondo e di contribuire<br />
allo sviluppo di questo territorio<br />
della Piana del Sele, così ricco di<br />
risorse naturali e di cultura. Essere<br />
un mecenate significa creare<br />
un rapporto saldo con importanti<br />
realtà come il Parco Archeologico<br />
di Paestum e Velia che quotidianamente<br />
tutelano e valorizzano i<br />
nostri beni culturali per scrivere<br />
un progetto di crescita di più ampio<br />
respiro che guarda al futuro”.<br />
Come evdenzia il direttore, il<br />
progetto, in virtù della sua polivalenza<br />
“è un esempio concreto<br />
di quanto si riesce a fare in<br />
un’ottica di integrazione virtuosa<br />
tra tutela, ricerca e coinvolgimento<br />
del territorio grazie alle<br />
possibilità che si sono aperte con<br />
la riforma dei beni culturali e con<br />
la legge Artbonus”.<br />
Fonte: www.museopaestum.beniculturali.it/
AGORÀ<br />
Il Louvre virtuale cambia – Il<br />
Louvre, il grande museo parigino,<br />
a causa della pandemia è chiuso<br />
da mesi. Un duro colpo per la cultura,<br />
la critica e la ricerca: ognuno<br />
che ami l’arte e’ consapevole<br />
che e’ creata per essere fruita.<br />
Ancora una volta la tecnologia va<br />
incontro all’arte, alla didattica<br />
e al turismo, si dimostra arte,<br />
e l’intera collezione parigina -<br />
composta da centinaia di migliaia<br />
di pezzi - è online, su un nuovissimo<br />
sito web, ma questa volta<br />
dedicato quasi esclusivamente al<br />
Louvre.<br />
Il database ‘Louvre Site des Collections’<br />
contiene, infatti, oltre<br />
alle sue opere, le sculture dei<br />
giardini del Carrousel e delle Tuileries,<br />
quelle del Musée National<br />
Eugène Delacroix e le opere recuperate<br />
dopo la seconda guerra<br />
mondiale. Per la prima volta il<br />
museo, forse il più visitato dai<br />
turisti che ci sia, compare scorporato<br />
dalle basi dei dati di Catalogo<br />
dei musei francesi denominate<br />
Atlas e Joconde, da decenni<br />
accessibili alle curiosità e alla ricerca<br />
degli appassionati di tutto<br />
il mondo e create a partire dagli<br />
anni Settanta.<br />
Sul sito le schede delle opere<br />
vengono periodicamente aggiornate<br />
nel campo bibliografico<br />
dagli esperti del museo e rese<br />
disponibili all’utente con una catalogazione<br />
abbinata a strumenti<br />
anche intuitivi e semplici. Inoltre<br />
è corredato da una mappa interattiva<br />
che consente ai visitatori<br />
di addentrarsi stanza per stanza.<br />
Un avviso ai naviganti circoscrive<br />
la bibliografia, che, senza<br />
pretendere di essere selettiva o<br />
esaustiva, e’ limitata alle attività<br />
più strettamente museali.<br />
Come di consueto, le collezioni<br />
possono essere approfondite in<br />
diversi modi: ricerca semplice o<br />
avanzata, album a tema e voci<br />
smistate per dipartimento curatoriale.<br />
In aggiunta, il sito stesso<br />
del museo è stato ottimizzato<br />
e diviso in tre sezioni principali:<br />
‘visiter’, ‘découvir’, ‘en ce moment’.<br />
«L’accessibilità è il cuore della<br />
nostra missione» ha ribadito<br />
Jean-Luc Martinez, direttore del<br />
museo, il quale è convinto che<br />
questa corsa digitale possa in<br />
qualche modo alleviare e non sostituire<br />
la mancanza di visite allo<br />
straordinario monumento francese.<br />
Come spesso accade, le revisioni<br />
parziali e gli aggiornamenti<br />
non sempre contribuiscono ad<br />
arricchire e ad approfondire la<br />
schedatura storica dell’oggetto<br />
artistico: a tutti gli esperti e’<br />
consigliabile accedere alle più<br />
vecchie basi dati per le vicende<br />
collezionistiche dell’opera, che il<br />
criterio di obiettività dei curatori<br />
ha deontologicamente e professionalmente<br />
mantenuto in linea,<br />
anche per quanto attiene alla<br />
documentazione fotografica, con<br />
l’alta definizione adottata veramente<br />
apprezzabile, a portata di<br />
mano per tutti gli interpreti.<br />
A campione, tra le opere più celebri<br />
della collezione, per quanto<br />
attiene in dettaglio alla Morte<br />
della Madonna di Caravaggio,<br />
la scheda di catalogo del Louvre<br />
finalmente pubblica la sua provenienza<br />
dalla collezione di Carlo<br />
I d’Inghilterra. Dato desunto<br />
dall’edizione del 1757, con una<br />
nota di Horace Walpole, dei due<br />
manoscritti di Oxford, che si<br />
datano al 1639, del Catalogo di<br />
Abraham van der Doort, curatore<br />
della raccolta reale, che vi descriveva:<br />
“Dorcas lying dead, by<br />
Michael Angel Caravagio”, venduta<br />
ad Everhard Jabach e da<br />
questi poi a Luigi XIV, sancita la<br />
prima appartenenza nel 1607 alla<br />
raccolta Gonzaga. L’accessibilità<br />
online del dato e’ oggi confrontabile<br />
in parte con il manoscritto<br />
legato di Van der Doort conservato<br />
dal Royal Collection Trust. La<br />
perplessità derivava dal significato<br />
di ‘Dorcas’, nome greco di Tabita<br />
e dall’interpretazione di Van<br />
der Doort e, conseguentemente<br />
di Walpole, del soggetto del Transito<br />
della Vergine come di una<br />
Resurrezione di Tabita, dagli Atti<br />
degli Apostoli.<br />
Ora, se e’ vero che artisti italiani<br />
come Raffaello, Leonardo, Michelangelo,<br />
Tiziano o Caravaggio<br />
appartengono ad ogni cultura e<br />
anche alla lingua francese, che<br />
nei secoli li ha ‘tradotti’, appropriandosene,<br />
e’ pur vero che l’uso<br />
ha restituito nel secolo scorso<br />
il nome in lingua originale di quasi<br />
ogni artista od autore incluso<br />
negli indici di catalogo redatti<br />
dagli schedatori di ogni parte<br />
del mondo, come prima voce del<br />
nome autore identificato. Non<br />
e’ ancora così per lo strumento<br />
parigino che accoglie come nomi<br />
d’autorità: Raphael, Leonard, Michelange,<br />
Titien, Caravage, che<br />
qualunque correttore automatico<br />
tenderà oggi a correggere. In<br />
fondo in fondo, automatismo per<br />
automatismo, e’ pur vero che lo<br />
stesso correttore non muterebbe<br />
immediatamente in Delacroix il<br />
pittore che per avventura scrivessimo<br />
‘Della Croce’. Sono banche<br />
dati storicizzate, oltre che<br />
38 ArcheomaticA N°1 marzo <strong>2021</strong>
Tecnologie per i Beni Culturali<br />
39<br />
una fonte preziosa per entrare<br />
nella cultura che le ha formate.<br />
Secondo una prassi corrente nei<br />
cataloghi museali, a chi li consulta<br />
converrà scorrere tutte le<br />
forme del nome accettate per<br />
avere una visione più completa<br />
della reale consistenza delle acquisizioni.<br />
Del resto, il catalogo<br />
museale da sempre ha accolto il<br />
principio storico dell’opera d’arte<br />
come documento inventariato,<br />
dalla quale, come dai dati della<br />
sua esposizione o meno e in quali<br />
raccolte, si dipanano le fonti<br />
biografiche sull’artista. Criterio<br />
fondamentale sotto il profilo critico,<br />
poiché il titolo soggettivo<br />
delle singole opere raramente e’<br />
rimasto immutato nel corso del<br />
tempo, anche se solo spostate<br />
da una parte all’arte dello stesso<br />
edificio: l’iconologia e’ la disciplina<br />
storico-artistica che identifica<br />
un’opera d’arte indicizzando<br />
inoltre gli innumerevoli appellativi<br />
che le siano stati attribuiti<br />
nei secoli, e non soltanto, talora,<br />
i disparati creatori.<br />
Una piacevole scoperta per il<br />
visitatore abituale, aneddotica<br />
gia’ per Stendhal, a ben vedere<br />
più di noi informato sull’origine<br />
delle più importanti raccolte europee,<br />
può essere quella che riguarda<br />
più da vicino la revisione<br />
dei dati di provenienza al Louvre<br />
di opere incluse nel Trattato di<br />
Tolentino: cioe’ il fatto che non<br />
vengano più archiviate nel sistema<br />
come ‘conquete de guerre’,<br />
ma semplicemente come ‘achat’,<br />
‘acquisto’. Pur sempre in cambio<br />
della vita del pontefice Pio VII,<br />
quando erano le opere d’arte italiana,<br />
e non così frequentemente<br />
i loro creatori, come accade oggi,<br />
a fuggire all’estero. Del resto il<br />
Ministero della Cultura italiano,<br />
ancora oggi, non fa che spiazzare<br />
i suoi direttori di museo, come se<br />
la lingua italiana, anche in tema<br />
di banche dati, non avesse saputo<br />
parlare all’arte e dell’arte che ha<br />
creato. Il Louvre, analogamente<br />
alla maggior parte dei più importanti<br />
musei italiani, e’ accessibile<br />
quindi, e non solo, si mostra<br />
per quello che e’: un laboratorio<br />
di assidua ricerca inestimabile ed<br />
inevitabilmente discutibile che<br />
non ha mai smesso di essere un<br />
evento.<br />
Sottocontrollo<br />
tel. +39 02 4830.2175<br />
info@codevintec.it<br />
www.codevintec.it<br />
Strumenti per:<br />
Indagini archeologiche<br />
e pre-scavo<br />
Mappatura di cavità<br />
e oggetti sepolti<br />
Ispezione di muri,<br />
colonne, pareti…<br />
CODEVINTEC<br />
Tecnologie per le Scienze della Terra<br />
Innovativi Georadar<br />
per indagini pre-scavo<br />
e profili 3D del sottosuolo
AGORÀ<br />
Zamani Project: la salvaguardia di<br />
siti in via di estinzione attraverso<br />
tecnologie all’avanguardia. – Il patrimonio<br />
culturale è il fondamento<br />
di ogni società e cultura. Con<br />
sede presso la School of Architecture<br />
Planning and Geomatics della<br />
Faculty of Enginerring & the Built<br />
Enviroment, Zamani Project è un<br />
gruppo di ricerca che ospita uno dei<br />
database più estesi al mondo di siti<br />
e strutture del patrimonio culturale<br />
africano, sviluppato utilizzando<br />
la più moderna tecnologia di documentazione.<br />
Con il sostegno delle<br />
Fondazioni Mellon, Saville e della<br />
tecnologia Epic Games, il progetto<br />
Zamani ha documentato più di<br />
250 strutture, siti d’arte rupestre e<br />
statue in 65 siti del patrimonio in<br />
18 paesi: in Africa, Medio Oriente,<br />
Sud-est asiatico ed Europa.<br />
Nel 2001 Heinz Ruther fondò il progetto,<br />
per sostenere i siti molto<br />
spesso privi di documenti, scarsamente<br />
documentati e minacciati<br />
da danni o distruzione. Il suo fine<br />
principale è lo sviluppo della consapevolezza<br />
del patrimonio, il<br />
senso di appartenenza e il rispetto<br />
verso le altre culture. Numerosi<br />
ricercatori e professionisti insieme<br />
al Word Monuments Fund e al Conservation<br />
Institute hanno collaborato<br />
al progetto. Non sono mere<br />
immagini, sono delle vere e proprie<br />
rappresentazioni dei siti puntuali e<br />
curate nei minimi dettagli. Attraverso<br />
l’utilizzo del laser scanner,<br />
fotogrammetria e droni, la struttura<br />
o l’oggetto viene rilevato nei<br />
suoi punti precisi. I dati sono utili<br />
al fine di generare modelli 3D, sistemi<br />
d’informazione geografica,<br />
sezioni, piante e tour panoramici.<br />
Inoltre con la parecipazione di industrie<br />
tecnologiche come Zoller e<br />
Frolich e l’utilizzo del software Reality<br />
Capture.<br />
In collaborazione con Word Monuments<br />
Fund, il progetto Zamani ha<br />
intrapreso due campagne per documentare<br />
le undici chiese rupestri di<br />
Lalibela in Etiopia. Le chiese furono<br />
costruite nella città di Roha, ribattezzata<br />
Lalibela in onore del re. Il<br />
luogo attualmente è una città monastica,<br />
isolata a 2.630 metri di altezza,<br />
protetta e circondata da una<br />
barriera naturale di montagne alte<br />
più di 4.000 metri nel cuore degli<br />
altipiani a nord dell’Etiopia, nella<br />
regione degli Amhara. Dal 1968 le<br />
chiese monolitiche furono dichiarate<br />
patrimonio dell’UNESCO: scavate<br />
nella roccia, costituiscono uno<br />
dei migliori esempi di arte etiope<br />
medievale, la cui costruzione viene<br />
comunemente datata tra il 1181 e<br />
il 1221. Circondate da fossati, sono<br />
scavate a 15 metri di profondità in<br />
una roccia molto fragile e, ricavate<br />
dalla materia circostante, sembrano<br />
sgorgare dalla terra. Heinz<br />
Ruther, nella seconda campagna<br />
sul campo intrapresa nel 2017, insieme<br />
al team ha svolto un’indagine<br />
dettagliata di follow-up di due<br />
delle chiese per rilevare e quantificare<br />
possibili deformazioni nelle<br />
strutture rocciose. I sacerdoti di<br />
Lalibela hanno inoltre riferito al<br />
Word Monuments Fund che pezzi di<br />
roccia cadevano dal soffitto durante<br />
la celebrazione dell’Epifania di<br />
Timkat. Il progetto Zamani è stato<br />
incaricato di scansionare la parte<br />
più sacra della chiesa, dove fu<br />
sepolto il Re Lalibela. Si tratta di<br />
una cappella scavata nel sottosuolo,<br />
parte della quale è al di sotto<br />
di un cortile. La morfologia della<br />
struttura è complessa, ma l’esperto<br />
di conservazione del patrimonio del<br />
World Monuments Fund ha spiegato<br />
che, collegando tutti i modelli del<br />
sito creati da Zamani, sono stati<br />
in grado di comprendere non solo<br />
i singoli modelli, ma anche vedere<br />
per la prima volta come si adattano<br />
nel loro insieme. Sono state fornite<br />
informazioni su un’area di circa 30<br />
cm di roccia tra la parte superiore<br />
dell’arco e il pavimento del cortile<br />
soprastante che era instabile. Una<br />
rivelazione incredibile che ha cambiato<br />
la modalità di conservazione<br />
in quella particolare area del sito.<br />
Senza l'utilizzo delle tecniche di<br />
scansione Lidar Light Detection and<br />
Ranging che Zamani ha impiegato,<br />
sarebbe stato molto difficile stabilirlo.<br />
Nell’agosto del 2019 il team<br />
del progetto Zamani ha documentato<br />
la House of Wonders a Stone<br />
Town, Zanzibar. Costruito nel 1883<br />
con colonnati metallici, è uno degli<br />
edifici più imponenti dell’antica<br />
Stone Town ed ospita oggi il Zanzibar<br />
National Museum of History &<br />
Culture. La sua struttura fu molto<br />
innovativa, il primo edificio a Zazibar<br />
ad avere l’elettricità ed il<br />
primo in Africa orientale ad avere<br />
un ascensore. Friedrich Klutsch,<br />
regista di documentari e direttore<br />
della compagnia cinematografica<br />
DEMAX, ha lavorato per 10 giorni<br />
con il team del progetto Zamani sul<br />
posto. DEMAX nel dettaglio sta producendo<br />
una serie di film incentrati<br />
sullo scambio avvenuto tra il Sultanato<br />
dell’Oman e l’Africa Orientale<br />
nel corso dei secoli e ha scelto<br />
la House of Wonders come spazio<br />
espositivo virtuale per gli elementi<br />
di questo scambio. DEMAX sta importando<br />
i dati del progetto Zamani<br />
in programmi software per creare<br />
immagini 3D generate dal computer<br />
per la loro serie di film. Lo stesso<br />
Klutsch ha affermato che è la prima<br />
volta che viene utilizzata la scansione<br />
LIDAR in questa misura e che<br />
la sua speranza risiede nello stabilire<br />
una connessione tra il pubblico<br />
moderno, la storia e il patrimonio.<br />
La scelta di lavorare con il progetto<br />
Zamani non è stata casuale: l’utilizzo<br />
di attrezzature all’avanguardia e<br />
la loro esperienza nella tecnologia<br />
di mappatura spaziale è ciò che<br />
Klutsch cercava.<br />
40 ArcheomaticA N°1 marzo <strong>2021</strong>
Tecnologie per i Beni Culturali<br />
41<br />
Dal 2005 al 2009 il progetto Zamani<br />
ha documentato spazialmente<br />
Kilwa Kisiwani, attraverso quattro<br />
campagne. Le strutture documentate<br />
includono: la Gereza, la<br />
Grande Moschea, l'Husuni Kubwa, il<br />
Makutani Building e la Moschea Malindi.<br />
Kilwa Kisiwani, città storica,<br />
situata a circa 300 Km a sud di Dar<br />
es Salaam, è il principale sito storico<br />
nel sud della Tanzania. Tra il XIII<br />
e il XVI secolo era una fiorente città<br />
commerciale, porto centrale per il<br />
commercio nell’ Oceano Indiano di<br />
avorio, oro, legname, porcellana,<br />
gioielli, perle e abbigliamento. Gli<br />
edifici storici furono costruiti con<br />
materiali calcarei mescolati con il<br />
corallo. Nel 1981 venne dichiarata<br />
patrimonio dell’umanità dall’UNE-<br />
SCO e nel 2004 è stato incluso tra i<br />
siti in pericolo. Difatti è in corso un<br />
rapido deterioramento a causa di<br />
diversi agenti quali la vegetazione<br />
e l’erosione. La consapevolezza e<br />
l’apprezzamento dei siti del patrimonio<br />
culturale è importante anche<br />
presso le comunità locali, poiché i<br />
materiali vengono spesso rimossi<br />
dalle strutture per essere utilizzati<br />
come materiale da costruzione.<br />
Il progetto Zamani è un valido sostegno<br />
per la conservazione di questi<br />
siti. Il suo team non si fermerà<br />
e continuerà a lavorare verso la<br />
visione di una società in cui le generazioni<br />
attuali e future abbiano<br />
accesso e proteggano il patrimonio<br />
culturale africano e internazionale.<br />
Sebbene il COVID-19 abbia impedito<br />
al team di intraprendere gran parte<br />
del lavoro sul campo pianificato per<br />
il 2020, hanno lavorato duramente<br />
per elaborare dati per la creazione<br />
di nuovi prodotti digitali, inclusa la<br />
documentazione per l’Iziko South<br />
African Museum. Quando tutto ritornerà<br />
alla normalità hanno in programma<br />
di documentare altri siti.<br />
L'uso delle nuove tecnologie in ambito<br />
archeologico è particolarmente<br />
significativo. La strumentazione<br />
tecnologica, se adeguatamente utilizzata,<br />
consente di ristabilire connessioni<br />
con un tempo remoto.<br />
Il database dei papiri del Museo<br />
Egizio di Torino – Visitando il Museo<br />
Egizio di Torino si ha la possibilità<br />
di ammirare moltissimi papiri<br />
che, tuttavia, sono solo una minima<br />
parte dell’enorme patrimonio papiraceo<br />
totale che ammonta a quasi<br />
700 manoscritti interi o riassemblati<br />
e oltre 17.000 frammenti. Numeri<br />
così alti palesano le grandi difficoltà<br />
nella conservazione e nello studio<br />
di documenti antichi di millenni<br />
e, di conseguenza, molto fragili.<br />
Per chi non lo sapesse, ormai da più<br />
di un anno, è possibile previa registrazione,<br />
consultare tutti questi<br />
antichi papiri tramite il database<br />
online.<br />
“Turin Papyrus Online Platform<br />
(TPOP)“ è quindi uno strumento<br />
fondamentale che, al momento,<br />
mette a disposizione dei professionisti<br />
che si registreranno al portale<br />
230 papiri, oltre a 50 documenti<br />
consultabili liberamente da chiunque.<br />
In ogni caso, il progetto prevede<br />
il continuo incremento degli<br />
open data pubblicati.<br />
Il catalogo virtuale comprende:<br />
numero d’inventario; foto ad alta<br />
definizione di entrambe le facce<br />
dei papiri; misure; trascrizione,<br />
traslitterazione in geroglifico e traduzione<br />
(al momento solo in inglese)<br />
dei testi contenuti; riferimenti<br />
bibliografici; informazioni sulla storia<br />
e sul contesto di ritrovamento<br />
dell’oggetto; approfondimenti sul<br />
restauro e sulle analisi tecnologiche<br />
effettuate.<br />
Come detto, l’apertura all’intera<br />
comunità scientifica internazionale<br />
permetterà che l’implementazione<br />
del database usufruisca non solo<br />
del lavoro dei curatori torinesi, in<br />
particolar modo della responsabile<br />
della collezione dei papiri, Susanne<br />
Töpfer, ma di chiunque lavori nel<br />
campo.<br />
Oltretutto a TPOP è stato da poco<br />
riconosciuto il prestigioso Premio<br />
del Patrimonio/Premi Europa Nostra<br />
2020 nella categoria ricerca.<br />
Questa la motivazione della<br />
giuria che ha assegnato il premio:<br />
“L'Europa ha numerose collezioni<br />
papirologiche e raccolte di<br />
papiri, una ricchezza documentaria<br />
che testimonia l'interesse europeo<br />
per l'Orientalismo, emerso nel XVIII<br />
secolo e presente fino al XIX secolo,<br />
che ha permeato la sua cultura<br />
materiale. Lo sviluppo di una tale<br />
piattaforma online, di libero accesso<br />
e ad alta risoluzione, è di grande<br />
valore per i musei, soprattutto in<br />
considerazione del suo potenziale<br />
di essere utilizzato per la creazione<br />
di un museo digitale europeo che<br />
riunirebbe un patrimonio disperso,<br />
una raccolta virtuale omogenea<br />
che sarebbe impossibile realizzare<br />
a livello materiale. L'applicazione<br />
di strumenti dell’era digitale contribuisce<br />
allo sviluppo della conoscenza,<br />
alla conservazione della<br />
cultura materiale e alla sua accessibilità,<br />
sia per gli studiosi che per<br />
il pubblico generale, promuovendone<br />
la diffusione”.
EVENTI<br />
10 - 14 MAGGIO <strong>2021</strong><br />
Conferenza Esri Italia <strong>2021</strong><br />
Digital Week<br />
Roma (Italy)<br />
www.geoforall.it/kyk4w<br />
21 - 25 GIUGNO <strong>2021</strong><br />
O3A - Optics for Arts,<br />
Architecture, and<br />
Archaeology VIII<br />
Germania (Digital)<br />
https://spie.org/<br />
19 – 23 LUGLIO <strong>2021</strong><br />
ICC - International<br />
Cartographic Conference<br />
<strong>2021</strong><br />
Firenze (Italy)<br />
www.geoforall.it/kfurw<br />
24 -27 AGOSTO <strong>2021</strong><br />
YOUNG RESEARCHER IN<br />
ARCHAEOMETRY<br />
EVORA (PORTUGAL)<br />
www.yra4.uevora.pt/<br />
8 – 9 SETTEMBRE <strong>2021</strong><br />
RESTAURO IN TOUR<br />
www.salonedelrestauro.com<br />
27 – 30 SETTEMBRE <strong>2021</strong><br />
GIScience <strong>2021</strong><br />
Poznan (Poland)<br />
www.giscience.org<br />
30 SETTEMBRE - 3 OTTOBRE<br />
<strong>2021</strong><br />
BMTA <strong>2021</strong><br />
PAESTUM<br />
www borsaturismoarcheologico.it/<br />
6 – 8 OTTOBRE <strong>2021</strong><br />
Dronitaly “Working with<br />
Drones” <strong>2021</strong><br />
Bologna (Italy)<br />
www.dronitaly.it<br />
20 - 22 OTTOBRE <strong>2021</strong><br />
MetroArchaeo<br />
Milano<br />
www.metroarcheo.com<br />
<strong>2021</strong><br />
Data da confermare<br />
2 - 4 NOVEMBRE <strong>2021</strong><br />
CHNT 26 - Conference on<br />
Cultural Heritage and New<br />
Technologies<br />
Vienna (Austria)<br />
https://www.chnt.at/<br />
18 - 19 NOVEMBRE <strong>2021</strong><br />
International Conference on<br />
Digital Heritage<br />
London (United Kingdom)<br />
shorturl.at/szACN<br />
Dal 1986 Teorema<br />
lavora a fianco dei professionisti<br />
per fornire la tecnologia topografica<br />
più avanzata,<br />
la migliore formazione tecnica<br />
ed una accurata assistenza post-vendita.<br />
LEICA GS18I<br />
IL NUOVO ROVER GNSS RTK<br />
INNOVATIVO E VERSATILE<br />
CON TECNOLOGIA<br />
VISUAL POSITIONING<br />
per maggiori<br />
informazioni<br />
Progettato per i professionisti del rilievo, al fine di misurare punti che prima non potevano<br />
essere misurati, in modo rapido e preciso con un sistema GNSS RTK.<br />
Adesso, è possibile acquisire rapidamente immagini dal sito e misurare punti direttamente<br />
in campo od in ufficio utilizzando le immagini.<br />
La fusione dei sensori GNSS e IMU in combinazione con una fotocamera, creano<br />
la tecnologia Visual Positioning, dando vita ad un rover GNSS RTK così potente e<br />
versatile, che vi consentirà di misurare tutto quello che vedete.<br />
Contattaci, scoprirai molto di più!<br />
Via A. Romilli, 20/8 20139 Milano • Tel. 02 5398739 • teorema@geomatica.it<br />
42 ArcheomaticA N°1 marzo <strong>2021</strong><br />
www.geomatica.it • www.disto.it • www.termocamere.com
Tecnologie per i Beni Culturali 43<br />
Paestum Salerno<br />
30 settembre - 3 ottobre <strong>2021</strong><br />
1998 2 021<br />
12 eventi<br />
unici al mondo<br />
tutti in una Borsa<br />
ArcheoExperience<br />
Laboratori di Archeologia<br />
Sperimentale per la divulgazione<br />
delle tecniche utilizzate dall’uomo<br />
nel realizzare i manufatti di uso<br />
quotidiano.<br />
ArcheoIncontri<br />
ArcheoStartUp<br />
Conferenze stampa<br />
Presentazione di nuove imprese<br />
e presentazioni di progetti culturali culturali e progetti innovativi<br />
e di sviluppo territoriale.<br />
nel turismo culturale e nella<br />
valorizzazione dei beni<br />
archeologici in collaborazione con<br />
l’Associazione Startup Turismo.<br />
Conferenze<br />
Organizzazioni Governative e<br />
di Categoria, Istituzioni ed Enti<br />
Locali, Associazioni Culturali<br />
e Professionali si confrontano<br />
su promozione del turismo<br />
culturale, valorizzazione,<br />
gestione e fruizione<br />
del patrimonio.<br />
International<br />
Archaeological Discovery Award<br />
“Khaled al-Asaad”<br />
Il Premio alla scoperta<br />
archeologica dell’anno intitolato<br />
all’archeologo di Palmira che<br />
ha pagato con la vita la difesa<br />
del patrimonio.<br />
Salone Espositivo<br />
Salone Internazionale unico<br />
al mondo che promuove le<br />
destinazioni turistico-archeologiche<br />
con 100 espositori, di cui 20 Paesi.<br />
da giovedì 30 settembre a sabato 2<br />
ottobre ore 10-19;<br />
domenica 3 ottobre ore 10-13<br />
ArcheoIncoming<br />
Spazio espositivo e Workshop con<br />
i tour operator che promuovono le<br />
destinazioni italiane per l’incoming<br />
del turismo archeologico.<br />
ArcheoLavoro<br />
Orientamento post diploma<br />
e post laurea con area<br />
espositiva dedicata alle<br />
Università per la presentazione<br />
dell’offerta formativa e delle<br />
figure professionali.<br />
ArcheoVirtual<br />
Mostra e Workshop internazionali<br />
di realtà virtuale e robotica in<br />
collaborazione con ISPC Istituto<br />
di Scienze del Patrimonio<br />
Culturale del CNR.<br />
Incontri con i Protagonisti<br />
Il grande pubblico con i più noti<br />
Divulgatori culturali, Archeologi,<br />
Direttori di Musei, Accademici,<br />
Giornalisti.<br />
Premi “Antonella Fiammenghi” Workshop con i buyer esteri<br />
“Paestum Mario Napoli”<br />
selezionati dall’ENIT e i tour<br />
“Sebastiano Tusa”<br />
operator nazionali<br />
Assegnati a personalità impegnate Incontro dei buyer esteri<br />
a favore dell’archeologia, del selezionati dall’ENIT (provenienti<br />
dialogo interculturale, del turismo da 8 Paesi Europei) e dei tour<br />
archeologico subacqueo e a laureati operator nazionali con l’offerta del<br />
con tesi sul turismo archeologico. turismo culturale.<br />
sabato 2 ottobre ore 10-14 | 15-18<br />
con il sostegno di<br />
in collaborazione con<br />
con il patrocinio di<br />
vettore ufficiale<br />
Ideazione e Organizzazione<br />
Leader srl<br />
info@bmta.it<br />
seguici su #BMTA<strong>2021</strong> www.bmta.it
10 – 14 maggio<br />
DIGITAL WEEK<br />
Scopri le ultime novità<br />
della tecnologia Esri<br />
alla Digital Week<br />
www.esriitalia.it