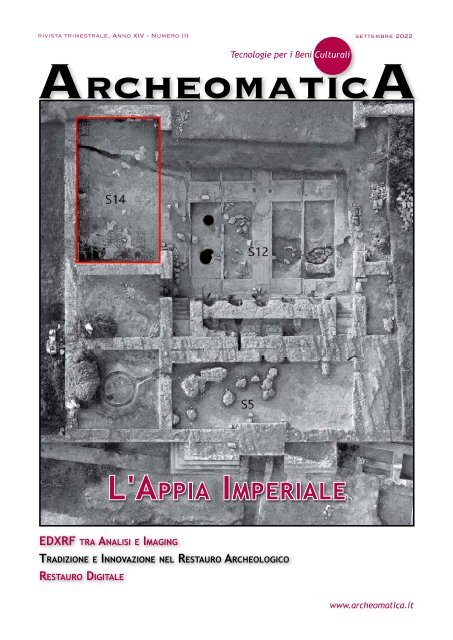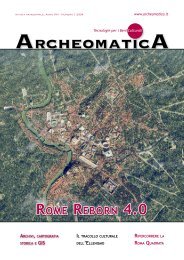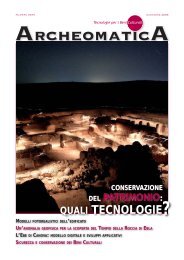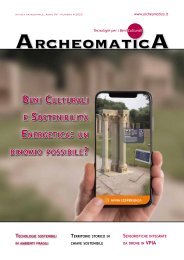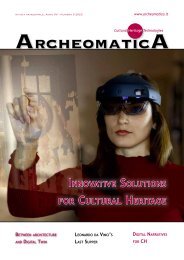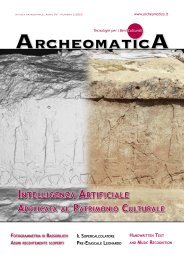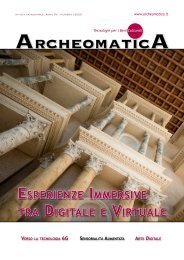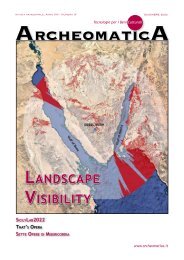Archeomatica 3 2022
Tecnologie per i Beni Culturali
Tecnologie per i Beni Culturali
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
ivista trimestrale, Anno XIV - Numero III settembre <strong>2022</strong><br />
ArcheomaticA<br />
Tecnologie per i Beni Culturali<br />
L'Appia Imperiale<br />
EDXRF tra Analisi e Imaging<br />
Tradizione e Innovazione nel Restauro Archeologico<br />
Restauro Digitale<br />
www.archeomatica.it
EDITORIALE<br />
Dalla Augmented Reality<br />
alla Augmented Sensoriality<br />
Cari lettori, <strong>Archeomatica</strong> ha partecipato alle celebrazioni del Centenario della nascita di Antonio<br />
Cederna, che si sono aperte il 27 settembre 2021 con la Conferenza stampa di Presentazione degli<br />
eventi organizzati da Italia Nostra nel Parco Regionale dell’Appia Antica. La Conferenza, tenuta da<br />
Simone Quilici, già Direttore del Parco Archeologico dell’Appia Antica, Mario Tozzi ed Ebe Giacometti,<br />
si è svolta nella sede dell’Archivio Cederna a Capo di Bove e ha incluso l’avvio della prima postazione<br />
sperimentale dell’Archeoguida accessibile nel Castrum Caetani-Cecilia Metella, progettata anche da<br />
<strong>Archeomatica</strong> e prevista snodarsi con una serie di punti d’informazione lungo tutto l’asse della via<br />
Appia Antica fino a Brindisi.<br />
Il programma delle manifestazioni ha inaugurato con una Festa interassociativa in musica nel Parco<br />
di Tor Fiscale, a cura di Camilla, Giulio e Giuseppe Cederna, con Marta Bonafoni e Marco Cacciatore,<br />
cui si deve l’ampliamento del Parco archeologico in collaborazione con le due Direzioni del Parco<br />
Archeologico e del Parco Regionale. Ha proseguito l’iniziativa con il Convegno di Studi sulla Via Appia<br />
da Roma a Brindisi nelle Sale Conferenze di Via Appia Antica 42 e 22, presentato da Alma Rossi e Simone<br />
Quilici e introdotto da Annalisa Cipriani di Italia Nostra con l’intervento dedicato all’eredità di Antonio<br />
Cederna dell’Associazione lungo più di mezzo secolo, insieme alla Soprintendenza Archeologica di Roma<br />
e con Adriano La Regina e Rita Paris, Premi Nazionali Umberto Zanotti Bianco, e, insieme da trent’anni<br />
e più, con il Parco Regionale dell’Appia antica.<br />
Nell’ambito del progetto intitolato Dalla Augmented Reality alla Augmented Sensoriality <strong>Archeomatica</strong>,<br />
in collaborazione con Italia Nostra (Sezione di Roma), Una Quantum Inc., Istituto Italiano per sordi,<br />
Istituto S. Alessio, VIII Municipio di Roma e il Parco Archeologico dell’Appia Antica ha contribuito con<br />
la propria esperienza alla realizzazione di Archeoguide in Realtà Sensoriale Aumentata, con lo scopo<br />
di dare forma ad un linguaggio di segni tattili e audiovisivi tramite l’interazione con le App, rivolto<br />
in prima battuta a coloro che, per volere della sorte, abbiano limitazioni sensoriali e linguistiche,<br />
ma anche futuribile, rivolto ad occhi che osservino la terra dal firmamento. L’insieme di postazioni<br />
lungo l’Appia Antica si inserisce nel contesto dei monumenti archeologici senza interferire con il loro<br />
stile e la loro tecnica, riprendendone a tutti gli effetti le caratteristiche di manualità artigianale<br />
tipiche del periodo storico dell’arte romana, dando vita ad un unicum sia dal punto di vista estetico<br />
che dell’utilità sociale. Le Archeoguide sono una esperienza prototipale, incise come sono a rilievo<br />
su pannelli di travertino: su di esse hanno preso forma quell’insieme di simboli ed emblemi che<br />
universalmente rappresentano la Tomba di Cecilia Metella come meta turistica e monumento storico,<br />
attraverso il linguaggio Braille che, per antonomasia, è sinonimo di inclusività. Rivolgendosi a quella<br />
parte di individui limitati nei sensi, risponde anche ad una necessità di comunicazione multilinguistica<br />
e polisemantica oltre la LIS. In questi pannelli informativi, nel corso del progetto, sono stati riprodotti<br />
alcuni fregi (di epoca classica) e stemmi (di epoca medievale) della Tomba sulla Via Appia per<br />
l’esplorazione tattile e la fruizione in Realtà Aumentata tramite QR-Code Tattile, i cui contenuti sono<br />
visibili e udibili anche su Smartphone.<br />
Durante il ciclo di conferenze, dedicate al Centenario della nascita di Antonio Cederna, era nata tra<br />
i partecipanti l‘idea di raccogliere su queste pagine alcuni dei contributi esposti in quelle sedi che<br />
anticipiamo in questo numero, che avrebbe dovuto prendere la forma di uno speciale dedicato all’Appia<br />
Antica, ma che, per mancanza di risorse, vede la luce solo parzialmente. Tra i contributi raccolti nella<br />
circostanza, pubblichiamo su <strong>Archeomatica</strong> 3-<strong>2022</strong> L’Appia Imperiale di Lucrezia Spera: una escursione<br />
sui cerimoniali romani della Tarda Antichità connessi con quelli imperiali e, inoltre, l’articolo di Cesare<br />
Crova Tradizione e Innovazione nel restauro archeologico. L’esempio dei Cantieri didattici dell’Istituto<br />
Centrale per il Restauro della Villa dei Quintili: una panoramica sui progetti di conservazione, che<br />
hanno interessato la Villa dei Quintili e il ruolo futuro dei cantieri didattici.<br />
Buona lettura,<br />
Valerio Carlucci
IN QUESTO NUMERO<br />
DOCUMENTAZIONE<br />
6 L’Appia imperiale<br />
di Lucrezia Spera<br />
In Copertina la Villa dei Quintili. Area S<br />
14. Vista zenitale (da Frontoni, Galli, Paris<br />
2020, p. 242.<br />
RESTAURO<br />
10 Tradizione e Innovazione<br />
nel Restauro Archeologico<br />
L’esempio dei cantieri<br />
didattici dell ’Istituto<br />
Centrale per il Restauro alla<br />
Villa dei Quintili<br />
di Cesare Crova<br />
Segui l'account di <strong>Archeomatica</strong><br />
su Twitter, Facebook e Instagram<br />
ArcheomaticA<br />
Tecnologie per i Beni Culturali<br />
Anno XIV, N° 3 - SETTEMBRE <strong>2022</strong><br />
<strong>Archeomatica</strong>, trimestrale pubblicata dal 2009, è la prima rivista<br />
italiana interamente dedicata alla divulgazione, promozione<br />
e interscambio di conoscenze sulle tecnologie per la tutela,<br />
la conservazione, la valorizzazione e la fruizione del patrimonio<br />
culturale italiano ed internazionale. Pubblica argomenti su<br />
tecnologie per il rilievo e la documentazione, per l'analisi e la<br />
diagnosi, per l'intervento di restauro o per la manutenzione e,<br />
in ultimo, per la fruizione legata all'indotto dei musei e dei<br />
parchi archeologici, senza tralasciare le modalità di fruizione<br />
avanzata del web con il suo social networking e le periferiche<br />
"smart". Collabora con tutti i riferimenti del settore sia italiani<br />
che stranieri, tra i quali professionisti, istituzioni, accademia,<br />
enti di ricerca e pubbliche amministrazioni.<br />
Direttore<br />
Renzo Carlucci<br />
dir@archeomatica.it<br />
Direttore Responsabile<br />
Michele Fasolo<br />
michele.fasolo@archeomatica.it<br />
Comitato scientifico<br />
Giuseppe Ceraudo, Annalisa Cipriani, Maurizio<br />
Forte, Bernard Frischer, Giovanni Ettore<br />
Gigante, Mario Micheli, Stefano Monti,<br />
Luca Papi, Marco Ramazzotti,<br />
Antonino Saggio, Francesca Salvemini,<br />
Rodolfo Maria Strollo<br />
Redazione<br />
Maria Chiara Spezia<br />
redazione@archeomatica.it<br />
Matteo Serpetti<br />
matteo.serpetti@archeomatica.it<br />
Valerio Carlucci<br />
valerio.carlucci@archeomatica.it
16 EDXRF tra analisi e imaging<br />
- Nuovi intriganti sviluppi nella<br />
diagnostica dei Beni Culturali<br />
Giovanni E. Gigante, Sergio A. Barcellos Lins<br />
di<br />
RUBRICHE<br />
30 AZIENDE E<br />
PRODOTTI<br />
Soluzioni allo Stato<br />
dell'Arte<br />
34 AGORÀ<br />
Notizie dal mondo delle<br />
Tecnologie dei Beni<br />
Culturali<br />
24 Ricostruzione<br />
Digitale 3D del<br />
Palazzo del<br />
Vescovado a Feltre -<br />
Ricostruzione storico -<br />
architettonica dal<br />
Medievo a giorni<br />
nostri<br />
a cura di Tre.Digital<br />
38 EVENTI<br />
INSERZIONISTI<br />
Esri 38<br />
Hubstract 39<br />
Geomax 33<br />
Nais Solutions 40<br />
Planetek 2<br />
Stonex 37<br />
Strumenti Topografici 9<br />
Virpleo 21<br />
una pubblicazione<br />
Science & Technology Communication<br />
Science & Technology Communication<br />
Diffusione e Amministrazione<br />
Tatiana Iasillo<br />
diffusione@archeomatica.it<br />
MediaGEO soc. coop.<br />
Via Palestro, 95<br />
00185 Roma<br />
tel. 06.64.87.12.09<br />
fax. 06.62.20.95.10<br />
www.archeomatica.it<br />
Progetto grafico e impaginazione<br />
Daniele Carlucci<br />
daniele@archeomatica.it<br />
Editore<br />
MediaGEO soc. coop.<br />
<strong>Archeomatica</strong> è una testata registrata al<br />
Tribunale di Roma con il numero 395/2009<br />
del 19 novembre 2009<br />
ISSN 2037-2485<br />
Stampa<br />
System Graphic Srl<br />
Via di Torre Santa Anastasia 61 00134 Roma<br />
Condizioni di abbonamento<br />
La quota annuale di abbonamento alla rivista è di<br />
€ 45,00. Il prezzo di ciascun fascicolo compreso<br />
nell’abbonamento è di € 12,00.<br />
Il prezzo di ciascun fascicolo arretrato è di<br />
€ 15,00. I prezzi indicati si intendono Iva inclusa.Per<br />
abbonarsi: www.archeomatica.it<br />
Gli articoli firmati impegnano solo la responsabilità<br />
dell’autore. È vietata la riproduzione anche parziale<br />
del contenuto di questo numero della Rivista<br />
in qualsiasi forma e con qualsiasi procedimento<br />
elettronico o meccanico, ivi inclusi i sistemi di<br />
archiviazione e prelievo dati, senza il consenso scritto<br />
dell’editore.<br />
Data chiusura in redazione: 30 settembre <strong>2022</strong>
DOCUMENTAZIONE<br />
L’Appia imperiale<br />
di Lucrezia Spera<br />
Nel ricordo del grosso impegno<br />
di Cederna per la salvaguardia<br />
del territorio della via Appia,<br />
si intende proporre un aspetto<br />
poco indagato del carattere di<br />
questo comparto suburbano, che<br />
conserva, per tutti i secoli della<br />
tarda antichità, un forte legame<br />
con la frequentazione imperiale.<br />
Fig.1<br />
Un ricco repertorio di fonti scritte (panegirici, chronica,<br />
disposizioni legislative…) permetteva, nel 2001, a<br />
Andrew Gillett, in un fortunato articolo nei Papers of<br />
the British School at Rome, di ricostruire la presenza quasi<br />
ininterrotta degli imperatori a Roma dal 401: un ‘ritorno’ con<br />
il programma di rilanciare il ruolo dell’antica capitale. I legami<br />
con i regnanti si propongono, nell’Urbe, in varie forme<br />
monumentali: lavori importanti nella residenza palatina, la<br />
promozione di cantieri qualificanti, come quello, dagli ultimi<br />
anni del IV secolo, per la costruzione della nuova basilica di<br />
San Paolo sulla via Ostiense, munita di un lungo portico dalla<br />
Mura Aureliane fino al santuario.<br />
Anche il suburbio, e in particolare la via Appia, si profila, in<br />
alcune aree, con un volto ‘imperiale’, e non solo attraverso<br />
i monumenti più noti precedenti alla fase che si intende esaminare<br />
(il sepolcreto nel sopratterra della catacomba di Pretestato,<br />
con il prestigioso sarcofago dell’imperatore Balbino,<br />
il mausoleo di Gallieno al IX miglio, il complesso di Massenzio<br />
al III). Una ricerca sull’area tra la villa dei Quintili e quella<br />
dei Sette Bassi ha infatti evidenziato la possibile presenza di<br />
un vasto comparto, nel V secolo, ultimi decenni dell’Impero<br />
di Occidente, connesso al cerimoniale di arrivo degli imperatori<br />
nell’Urbe.<br />
Nell’area extra muros alcuni Chronica che annotano gli eventi<br />
relativi ai decenni finali dell’Impero d’Occidente fissano<br />
l’esistenza di luoghi connessi ai cerimoniali della nomina,<br />
del consensus e dell’adventus imperiale. L’arrivo in Italia,<br />
nel 467, di Antemio, nominato a Costantinopoli da Leone, sarebbe<br />
stato introdotto, secondo la testimonianza riferita nel<br />
Chronicon di Cassiodoro, dall’assunzione del potere (suscepit<br />
imperium) tertio ab urbe miliario in loco Brontotas (Chron.<br />
1283, in MGH, AA XI, p. 158), un riferimento topografico che<br />
si ritrova variato (octavo miliario de Roma), ma sempre suburbano,<br />
in Idazio Lemico (Hyd. 235, in MGH, AA XI, p. 34).<br />
Ambientazione romana, più probabilmente che ravennate,<br />
soprattutto sulla base delle modalità dei riferimenti alle due<br />
città negli stessi testi, si deve ammettere per la nomina imperiale<br />
di Maioriano nel 457, il quale, nella versione dei Fasti<br />
Vindobonenses, levatus est in miliario VI in campo ad columellas<br />
(Fast. Vind. 583, in MGH, AA IX, p. 305).<br />
Il richiamo ad un sito localizzato a sei miglia dalla città, senza<br />
precisazioni ulteriori, ricorre anche (e non può essere casuale)<br />
nella descrizione fornita dal biografo di papa Vitaliano<br />
dell’ultimo adventus imperiale in Occidente, quello nel 663<br />
di Costante, accolto dal vescovo cum clero suo miliario VI<br />
ab urbe Roma (Liber pontificalis I, p. 343; analoga la testimonianza<br />
di Paolo Diacono, Hist. Lang. 5, 11: Cui sexto ab<br />
urbe miliario Vitalianus papa cum sacerdotibus et Romano<br />
populo occurrit), nonché nella più completa delle numerose<br />
variate testimonianze sulla morte di Valentiniano III contenuta<br />
negli additamenta alla Prosperi Continuatio Hauniensis<br />
(MGH, AA IX, p. 303): l’imperatore, egressum extra portam<br />
principem et in Campo Martio pro tribunali in sexto ad daus<br />
lauros residentem et ludo gestationis intentum, venne appunto<br />
assassinato dai due sicari inviati da Petronio Massimo.<br />
Nel frammento di Giovanni di Antiochia dedotto da Prisco lo<br />
stesso scenario fa da sfondo alla subitanea elezione dello<br />
stesso Petronio Massimo (Excerpta de insidiis 85, ed. C. de<br />
Boor, Excerpta Historica iussu Imp. Constantini Porphyrogeneti, Berlin<br />
1905, III 125). I termini dell’ambientazione da una parte<br />
fanno intravedere l’esistenza di un comparto suburbano di<br />
pertinenza imperiale (perciò segnato dal toponimo ad duas<br />
6 ArcheomaticA N°3 settembre <strong>2022</strong>
Tecnologie per i Beni Culturali 7<br />
Fig.2<br />
lauros), dotato di un complesso residenziale, di un circo, di<br />
un campo militare, peraltro ovvio per ogni stanziamento imperiale<br />
esterno alla città, ma rivelano anche, dall’altra, una<br />
suggestiva assonanza con il sobborgo imperiale costantinopolitano<br />
al settimo miglio della via Egnatia, l’Hebdomon, segnato<br />
dalla presenza di un Campo Marzio, di un tribunàlion,<br />
di una residenza di lusso, a partire dalla nomina di Valente<br />
luogo dell’elezione imperiale da cui il corteo muoveva per<br />
la città e il palazzo. Non ci si può sottrarre al fascino dell’ipotesi<br />
che nel V secolo Costantinopoli e Roma avessero per<br />
qualche verso gemellato fin nei dettagli le procedure dei cerimoniali,<br />
esportati dall’antica capitale nelle altre sedi ed in<br />
questa rientrati con gli adattamenti e le variazioni addotti<br />
nelle formalizzazioni della corte sul Bosforo, e che a Roma<br />
una postazione imperiale suburbana, funzionale allo svolgersi,<br />
anche solo saltuario, di peculiari eventi, si sia conformata,<br />
per significati e lemmi toponomastici, all’insediamento della<br />
soror d’Oriente.<br />
D’altra parte gli spazi suburbani partecipavano tradizionalmente<br />
al cerimoniale dell’accoglienza di un imperatore, e i<br />
panegirici rievocano spesso immagini di folle festose uscire<br />
dalle mura o, come quello del 312 per l’arrivo di Costantino<br />
ad Autun, le torri protendersi quasi ad abbracciare l’imperatore.<br />
Un’ipotesi di localizzazione per il sobborgo imperiale romano<br />
si può tentare partendo intanto dal dato topografico meglio<br />
circoscrivibile dell’arrivo di Costante da sud, da Napoli, ultima<br />
tappa prima dell’Urbe ricordata dalla biografia di Vitaliano,<br />
logicamente quindi dalla via Appia o anche, per l’ultimo<br />
tratto, dalla via Latina o Asinaria. Nel suburbio sud-est, in<br />
effetti, si può preferibilmente intravedere una qualche possibilità<br />
di inquadramento, considerata la particolare estensione<br />
della proprietà imperiale, costituitasi, anche sulla base<br />
dello studio ancora fondamentale di Filippo Coarelli del 1986<br />
(«L’Urbs e il suburbio», in A. Giardina (a cura di), Società<br />
Romana e Impero Tardoantico, II, Roma. Politica, economia,<br />
paesaggio urbano, Bari 1986, pp. 1-58), soprattutto dall’età<br />
severiana - come garantisce la forte incidenza di indicatori:<br />
sepolture di schiavi e liberti imperiali, sepolcreti di militari,<br />
iscrizioni onorarie, ritrovamenti di statue imperiali -,<br />
anche con l’acquisizione di prestigiosi complessi residenziali<br />
sottratti all’aristocrazia senatoria (di origine provinciale soprattutto),<br />
le ville dei Gordiani, di Centocelle, delle Vignacce,<br />
dei Sette Bassi, dei Quintili (fig. 1). Di tale vastissima<br />
proprietà, solo in parte alienata a favore della Chiesa in età<br />
costantiniana, o anche in qualche caso ridimensionata da<br />
passaggi all’aristocrazia senatoria, si può supporre una buona<br />
conservazione nel IV e V secolo, che si deduce anche dalla<br />
continuità d’uso dei complessi dei Quintili e dei Sette Bassi e,<br />
con minori evidenze monumentali, della villa delle Vignacce,<br />
ancora poco studiata, con caratteri di frequentazione ancora<br />
di lusso, conservando in loco lo spropositato repertorio<br />
di sculture, tra cui molti ritratti imperiali, progressivamente<br />
disperso solo nei secoli dell’età moderna (storia assai complessa<br />
di ritrovamenti; 600 statue solo quelle recuperate da<br />
Pio VI tra il 1783 e il 1792).<br />
A questa ampia area, estesa tra il IV miglio e il VI miglio dalla<br />
città, possono forse riferirsi le indicazioni delle fonti citate,<br />
alcune delle quali potevano derivare incertezze locative (così,<br />
ad esempio, le diverse testimonianze sul luogo di ratifica imperiale<br />
di Antemio) proprio dall’estensione notevole della<br />
proprietà o dalla mancata conoscenza diretta del territorio.<br />
Pare fornire un qualche sostegno a tale proposta locativa la<br />
facile relazione tra il singolare toponimo Brontotas, hapax<br />
utilizzato nella versione di Cassiodoro per l’adventus di Antemio<br />
e l’accezione di Zeus portatore di fulmini, Bronton, culto<br />
originario della Frigia e diffuso in Oriente, particolarmente<br />
in Mesia e Bitinia, ma pressoché sconosciuto in Occidente. Le<br />
sole iscrizioni scoperte in Italia provengono da Roma e quattro<br />
su cinque, due latine e due greche, dal VII km della via<br />
Appia nuova (figg. 2-3; la quinta, ai Musei Capitolini, risulta<br />
di incerta provenienza), area tra la villa dei Quintili e quella<br />
dei Sette Bassi, luogo dove anche il rinvenimento di materiale<br />
scultoreo (una statua colossale di Zeus, due piccole statue<br />
Fig.3
Fig.4<br />
Fig.5<br />
di Zeus in trono, una di bue: figg. 4-6) ha garantito l’esistenza<br />
di un santuario a Zeus Bronton, logicamente correlabile con<br />
l’origine frigia dei Quintili. Di questo dovette conservarsi una<br />
prolungata memoria, se anche più tarde fonti agiografiche (V-<br />
VI/VII secolo), ambientando nell’area della via Appia alcune<br />
vicende connesse al martirio di Cecilia e i compagni e di papa<br />
Urbano, richiamano l’esistenza di un templum Iovis; nella<br />
stessa area una immaginaria domus Marmeniae, luogo della<br />
sepoltura di Urbano, era extra palatium Vespasiani, tradizionalmente<br />
il circo di Massenzio, e prope Columnas, un toponimo<br />
che viene la tentazione di ritenere significativamente<br />
assonante con quello ad columellas utilizzato per indicare il<br />
luogo di elezione di Maioriano.<br />
Abstract<br />
In the Roman Suburbs, some late antique sources attest the existence of places<br />
connected to imperial ceremonials. For example, the Antemius adventus<br />
in Rome, in 467, is introduced by the ceremony of assumption of the power<br />
tertio ab urbe miliario in loco Brontotas; ten years earlier Maioriano levatus<br />
est in miliario VI in campo ad columellas. These places were probably in the<br />
area between the fifth and sixth miles of the Via Appia, in particular in the<br />
site of the villa of the Quintilii. This hypothesis brings out the imperial character<br />
of the road, still accentuated during the late antiquity.<br />
Parole Chiave<br />
Appia; imperatori; adventus; villa dei Quintili<br />
Fig.6<br />
Autore<br />
Lucrezia Spera - lucrezia.spera@uniroma2.it, spera@piac.it<br />
Università di Roma ‘Tor Vergata’ / Pontificio Istituto di Archeologia cristiana<br />
8 ArcheomaticA N°3 settembre <strong>2022</strong>
Tecnologie per i Beni Culturali 9
DOCUMENTAZIONE<br />
Tradizione e Innovazione<br />
nel Restauro Archeologico<br />
L’esempio dei cantieri didattici dell’Istituto<br />
Centrale per il Restauro alla Villa dei Quintili<br />
di Cesare Crova<br />
Nell’ambito dei progetti di conservazione<br />
che hanno interessato la<br />
Villa dei Quintili, un ruolo importante<br />
lo hanno rivestito i cantieri<br />
didattici che nel corso degli ultimi<br />
11 anni hanno visto avvicendarsi,<br />
in un lavoro interdisciplinare tra<br />
la Soprintendenza Archeologica<br />
di Roma e il Parco Archeologico<br />
dell’Appia Antica con la Scuola<br />
di Specializzazione in Beni architettonici<br />
e del paesaggio della<br />
“Sapienza” - Università di Roma<br />
e, soprattutto, l’Istituto Centrale<br />
per il Restauro.<br />
In particolare, l’ICR ha svolto<br />
negli anni un ruolo di consulente<br />
alle attività accademiche e, in seguito,<br />
di attore principale nei cantieri<br />
di conservazione di una porzione<br />
dell’area centrale e della<br />
zona dei carceres, con particolare<br />
riferimento alla conservazione dei<br />
pavimenti in opus sectile che qui<br />
si trovano, punto di partenza per<br />
esperienze che saranno sviluppate<br />
nel prossimo futuro.<br />
Fig. 1 - Villa dei Quintili. Planimetria del complesso dell’area della villa nello stato<br />
attuale (Archivio Parco Archeologico dell’Appia Antica p.g.c.).<br />
PREMESSA<br />
Parlare di innovazione nel restauro<br />
archeologico può, in un primo<br />
momento, apparire stridente, se<br />
collegato alla conservazione di<br />
tipo tradizionale. Invece, come<br />
vedremo, l’innovazione si sposa<br />
anche con la tradizione di cantieri<br />
di questo tipo.<br />
L’innovazione può ben rappresentare<br />
un aiuto e uno stimolo per la<br />
qualificazione e la modernizzazione<br />
sostenibile delle tecniche<br />
riprese dalla tradizione: pensare<br />
di conservare integra sostanzialmente<br />
una forma di tradizione.<br />
La quale rappresenterà la vera<br />
innovazione laddove saprà fare<br />
propria l’idea derivante dall’utilizzo<br />
di un nuovo prodotto con gli<br />
strumenti propri della tradizione,<br />
impiegandolo con profitto e oculatezza<br />
nel restauro di un manufatto<br />
storicizzato.<br />
Si presenta, in questa sede, l’esperienza<br />
condotta nell’ambito<br />
della Scuola di Alta Formazione e<br />
Studio dell’Istituto Centrale per il<br />
Restauro di Roma, presso la Villa<br />
dei Quintili nel complesso del Parco<br />
archeologico dell’Appia Antica,<br />
in un’attività di gruppo di lavoro<br />
multidisciplinare ormai decennale.<br />
L’I.C.R. è nato nel 1939 per volere<br />
dell’allora Ministro dell’Educazio-<br />
10 ArcheomaticA N°3 settembre <strong>2022</strong>
Tecnologie per i Beni Culturali 11<br />
ne Nazionale, Giuseppe Bottai, per<br />
accentrare in un’unica realtà le<br />
diverse professionalità che gravitavano<br />
nell’ambito del restauro, sottraendole<br />
all’empirismo che fino ad<br />
allora lo aveva caratterizzato, definendolo<br />
come un’attività critica<br />
del testo a cui applicare le regole<br />
e il metodo che dall’Ottocento ne<br />
reggevano l’analisi filologica. Già<br />
dalla sua fondazione, l’innovazione<br />
è stato il punto di forza dell’I.C.R.<br />
Nel progetto per l’Istituto, Giulio<br />
Carlo Argan proponeva un modello<br />
di rinnovamento per centralizzare<br />
e indirizzare l’attività di tutela e<br />
conservazione del patrimonio artistico<br />
nazionale (Argan 1938-39),<br />
cercando di porre un freno alla<br />
crescita indiscriminata di scuole di<br />
restauro e centri di diagnosi, di tipo<br />
artigianale e artistico, soggettivo<br />
e arbitrario, creando un istitutoscuola.<br />
Il restauro, infatti, era prevalentemente<br />
artigianale, sia pure<br />
di ottimo artigianato, ma mancava<br />
di una metodologia e soprattutto i<br />
testi: l’unico era il vecchio manuale<br />
di Giovanni Secco Suardo (Secco<br />
Suardo 1866). Il disegno di Giuseppe<br />
Bottai cercava di portare a<br />
compimento un progetto culturale<br />
che aveva da sempre caratterizzato<br />
il suo impegno intellettuale e che<br />
aveva trovato corpo nelle ipotesi<br />
progettuali di Giulio Carlo Argan e<br />
Cesare Brandi, i grandi strateghi<br />
di questo percorso, che fu consacrato<br />
nella legge 22 luglio 1939, n.<br />
1240, “Creazione del Regio Istituto<br />
Centrale del restauro presso il ministero<br />
dell’Educazione Nazionale”<br />
(Crova 2012).<br />
Nasce così una struttura pubblica di<br />
ricerca e di riferimento per l’intera<br />
Nazione, derivata dalla necessità<br />
di ricondurre l’ambito del restauro<br />
su un terreno metodologico multidisciplinare<br />
in cui risultassero fondamentali<br />
le discipline storiche,<br />
ma anche quelle sperimentali. Tra i<br />
tanti esempi di innovazione nel restauro,<br />
l’utilizzo dei raggi X, nel gabinetto<br />
radiografico, per lo studio e<br />
l’indagine diagnostica non invasiva<br />
delle opere d’arte, o le sperimentazioni<br />
fatte in ambito fisico, di cui<br />
è esempio la sala delle esposizioni,<br />
che doveva servire anche per le<br />
esperienze termiche sulle sostanze<br />
dei quadri restaurati. Il locale<br />
era provvisto di finestre rivestite in<br />
vetri termo-lux, un tipo di illuminazione<br />
progettata appositamente<br />
per le opere d’arte, un impianto<br />
di riscaldamento, refrigerazione e<br />
ventilazione, che oltre al funziona-<br />
Fig. 2 - Villa dei Quintili. Particolare dell’area centrale, con l’individuazione delle zone interessate dai<br />
cantieri didattici (Rielaborazione grafica dell’A.).<br />
Fig. 3 - Villa dei Quintili. Ambiente R 2, Xystus (2011). Stato attuale dopo gli interventi di conservazione<br />
(Foto dell’A.).
dove i “nuovi vandali”, come li definiva, stavano tramando<br />
una realizzazione residenziale (Cederna 1953). Inizia così<br />
una campagna di informazione massiccia che produrrà come<br />
effetti la nascita di un grosso fermento del mondo culturale<br />
che porterà, forse colpevolmente essendo trascorsi<br />
trent’anni, alla nascita del Parco Regionale dell’Appia Antica.<br />
Poco, rispetto a un territorio la cui importanza ha un<br />
valore mondiale e che solo nel 2016 ha visto la nascita del<br />
Parco archeologico dell’Appia Antica come istituto autonomo,<br />
dando ora quel rilievo internazionale al giacimento nel<br />
cui perimetro rientra la Villa dei Quintili.<br />
Fig. 4 - Villa dei Quintili. Area delle Piccole Terme (2017), prima<br />
dell’intervento di restauro (Foto dell’A.).<br />
mento normale, permetteva di raggiungere temperature al<br />
disotto e al disopra dei 25° centigradi. Si era compiuta così<br />
una sala unica nel suo genere, mai realizzata al mondo presso<br />
la sede del San Francesco di Paola, progettata da Silvio<br />
Radiconcini (Crova 2012).<br />
IL PARCO ARCHEOLOGICO DELL’APPIA ANTICA<br />
In questo contesto culturale, all’inizio degli anni Cinquanta<br />
dalle pagine de “Il Mondo”, Antonio Cederna iniziava la<br />
sua battaglia contro gli speculatori che volevano lottizzare<br />
e distruggere con piani edilizi molto invasivi quel lembo di<br />
territorio che è oggi il Parco archeologico dell’Appia Antica.<br />
Egli definiva questa porzione di area romana “[…] un<br />
monumento unico da salvare religiosamente intatto, per la<br />
sua storia e per le sue leggende, per le sue rovine e per i<br />
suoi alberi, per la campagna e per il paesaggio, per la vista,<br />
la solitudine, il silenzio, per la sua luce, le sue albe e<br />
i suoi tramonti […]. Andava salvata religiosamente perché<br />
da secoli gli uomini di talento di tutto il mondo l’avevano<br />
amata, descritta, dipinta, cantata, trasformandola in realtà<br />
fantastica, in momento dello spirito, creando un’opera<br />
d’arte di un'opera d’arte: la via Appia era intoccabile, come<br />
l’Acropoli di Atene”, ricordando anche la Villa dei Quintili,<br />
Fig. 5 - Villa dei Quintili. Area R 19 (2021). Stato attuale dopo gli interventi<br />
di conservazione (Foto dell’A.).<br />
LA VILLA DEI QUINTILI<br />
Fu costruita dai fratelli Sesto Quintilio Condiano e Sesto<br />
Quintilio Valerio Massimo, rappresentanti di una delle più<br />
illustri famiglie dell’epoca, gli Antonini, consoli nel 151<br />
d.C., la cui attribuzione deriva da alcune fistule acquarie di<br />
piombo con inciso il loro nome, ritrovate da Antonio Nibby<br />
nel corso degli scavi condotti nel 1828 (Paris, Frontoni, Galli<br />
2019). Divenne in seguito proprietà dell’imperatore Commodo,<br />
che nel 182 d.C. fece uccidere i fratelli Quintili, con<br />
il pretesto di una congiura nei suoi confronti.<br />
L’importanza storica del sito lungo la via Appia, sta nel conservare<br />
ancora uno dei più ricchi patrimoni storico monumentali<br />
del mondo antico, salvatosi miracolosamente, per<br />
l’ambito romano, all’interno della espansione edilizia della<br />
città moderna. La lunga campagna di stampa promossa da<br />
Antonio Cederna (dal 1953 al 1965) e condotta con l’aiuto di<br />
Italia Nostra, contro la speculazione edilizia nella zona archeologica<br />
dell’Appia Antica, porta l’area ad essere inserita<br />
e tutelata nel PRG del 1965 come patrimonio pubblico con<br />
vincolo di inedificabilità. Nel 1979 l’allora sindaco Giulio<br />
Carlo Argan fa propria la proposta di creare un grande Parco<br />
Archeologico nel centro di Roma, che si dovrà collegare<br />
con quello dell’Appia Antica. Cominciano così e si fanno più<br />
incisivi i provvedimenti di tutela e di esproprio, anche se<br />
bisogna aspettare il 1988 perché la Regione Lazio approvi<br />
l’istituzione del Parco Regionale dell’Appia Antica, del quale<br />
Antonio Cederna fu il primo Presidente (Crova 2018).<br />
Il complesso della Villa, ha una tipologia che dipende dallo<br />
spazio dato all’estro dell’architetto e al gusto dei committenti,<br />
mentre la scelta del sito, in un contesto residenziale<br />
come questo, ha certamente condizionato il tipo di pianta<br />
nell’esigenza di armonizzarla con il paesaggio. L’impressione<br />
che si ha della villa, allo stato attuale delle conoscenze,<br />
con i suoi ricchi apparati decorativi e l’abbondanza degli<br />
impianti per ogni genere di conforto, è che si tratti di una<br />
grande residenza di ozio, dove la piacevolezza del luogo<br />
favoriva la distensione e la distrazione dagli impegni di governo.<br />
Nel 1985 lo Stato ha acquisito al patrimonio pubblico 24<br />
ettari di un complesso archeologico molto più ampio con i<br />
fondi della legge speciale su Roma, grazie al Soprintendente<br />
Adriano La Regina (dirigente della Soprintendenza Archeologica<br />
di Roma), esercitando il diritto di prelazione nei confronti<br />
del privato. Da allora i primi interventi con la legge<br />
Roma Capitale, quindi i più importanti lavori con i fondi del<br />
Grande Giubileo 2000 che hanno permesso di aprire definitivamente<br />
al pubblico il sito, attrezzato di tutti i servizi;<br />
altri finanziamenti a seguire e un’opera di manutenzione<br />
programmata costante hanno consentito la crescita della<br />
conoscenza dell’impianto e una buona conservazione.<br />
SCAVI E CANTIERI DIDATTICI<br />
Gli scavi della villa, la più estesa del suburbio romano, hanno<br />
perciò una storia recente, che parte nel 1985, momento<br />
nel quale inizia la fase di definizione progettuale di una<br />
serie di campagne di scavo che interessano il sito con un<br />
12 ArcheomaticA N°3 settembre <strong>2022</strong>
Tecnologie per i Beni Culturali 13<br />
metodico intervento a partire dal 1998, con il grande progetto<br />
per il Giubileo del 2000. A questa prima fase, ne sono<br />
seguite altre tre, 2002-04, 2007-09 e 2017-18, che hanno<br />
permesso di portare alla luce gran parte del complesso della<br />
villa, per un’estensione di circa 22.000 mq, facendo emergere<br />
testimonianze nei settori della residenza, nel settore<br />
termale, nei giardini e presso il grande ninfeo (fig. 1).<br />
All’interno di queste fasi di scavo, l’Istituto Centrale per il<br />
Restauro è stato coinvolto in cinque diverse occasioni (fig.<br />
2), collaborando con la propria attività di consulenza e didattica<br />
alle fasi di restauro di alcune parti del complesso<br />
della Villa, con un’azione sinergica con la Soprintendenza<br />
Archeologica di Roma, coordinata da Rita Paris e Maria Grazia<br />
Filetici con Gisella Capponi, e la Scuola di Specializzazione<br />
in Beni architettonici e del paesaggio della “Sapienza”<br />
Università di Roma diretta da Giovanni Carbonara e in<br />
seguito da Daniela Esposito (Crova 2021).<br />
Tralasciamo le due esperienze presso il complesso di Santa<br />
Maria Nova, tre ettari di campagna romana costellata di ruderi<br />
che ruotano intorno a un antico casale, oggi divenuto<br />
museo multimediale, lasciata in totale abbandono per circa<br />
10 anni e occupata abusivamente da comunità di clandestini,<br />
fino all’acquisto da parte dello Stato avvenuto nel 2006,<br />
per soffermarci sui tre cantieri che, a partire dall’anno<br />
2011, hanno interessato la Villa dei Quintili (Frontoni 2012).<br />
Il primo intervento (2011), in collaborazione con la Scuola di<br />
Specializzazione in beni architettonici e del paesaggio della<br />
“Sapienza”, ha interessato l’area R2 (fig. 3) nel settore<br />
nord-orientale del nucleo centrale della Villa, lo xystus, un<br />
corridoio secondario, anticamente coperto, che collegava<br />
i settori principali della zona residenziale con il giardino<br />
e l’ippodromo. Il complesso di lavori qui condotti è stato<br />
finalizzato a realizzare opere di consolidamento della muratura,<br />
dei rivestimenti di lastre di marmo distaccate (anche<br />
di diversi cm.) lungo la parete orientale del corridoio lungo<br />
circa 15 metri. I problemi di degrado erano dettati da fenomeni<br />
legati principalmente all’azione dell’acqua, in quanto<br />
la caduta della volta di copertura aveva prodotto l’esposizione<br />
delle murature agli agenti atmosferici; in particolare,<br />
la presenza di discontinuità nelle murature favoriva lo<br />
scorrimento delle acque meteoriche. Si è così proceduto a<br />
interventi mirati e calibrati, che hanno permesso di reintegrare<br />
le murature, creando quegli scoli per le acque che ne<br />
favorissero la raccolta in punti preordinati; la riadesione al<br />
supporto degli elementi di rivestimento distaccati, avvalendosi<br />
di argilla espansa, consolidata con iniezioni di malta<br />
per far riaderire le parti riducendo i vuoti presenti nel riempimento<br />
di argilla. Il tutto completato con uno scivolo per<br />
le acque, con funzione protettiva.<br />
Il secondo intervento (2017), anche questo in collaborazione<br />
con la Scuola di Specializzazione in beni architettonici e<br />
del paesaggio della “Sapienza”, ha invece interessato un’area<br />
venuta alla luce nel corso della campagna di scavi della<br />
metà degli anni Ottanta, le Piccole Terme, costituita da una<br />
successione di ambienti, interconnessi da canali di adduzione<br />
ed espulsione delle acque, che erano ad uso e funzione<br />
delle vasche termali (Fig. 4). Il periodo piuttosto lungo<br />
di abbandono dell’area, seguente alla sua scoperta, aveva<br />
prodotto diversi fenomeni patologici di degrado, quali la disgregazione<br />
dei letti di malta, la patina biologica rinvenuta<br />
sia sulla superficie dei blocchi di peperino che sulle cortine,<br />
il deposito superficiale di varia natura, polvere, terra, detriti<br />
e altre forme di materiale organico e inorganico, che<br />
negli anni si era depositato su tutte le superfici, la perdita<br />
di elementi in laterizio e in tufo, la presenza di vegetazione<br />
di varia natura, la frattura del paramento murario dell’emiciclo<br />
con conseguente parziale rotazione di una parte del<br />
paramento stesso.<br />
Fig. 6 - Villa dei Quintili. Area R 20 (2021). Stato attuale dopo gli interventi<br />
di conservazione (Foto dell’A.).<br />
L’intervento, abbastanza complesso rispetto a quello del<br />
2011, ha interessato una serie di operazioni ampie, prevedendo<br />
la disinfestazione e la disinfezione della vegetazione,<br />
procedendo poi con la fase della pulitura effettuata<br />
tramite la rimozione manuale della vegetazione infestante<br />
dalla struttura muraria antica, orizzontale e verticale. Allo<br />
stesso tempo è stata eseguita la rimozione dei depositi incoerenti<br />
dalle creste murarie (terra, detriti, laterizi, tufi o<br />
malte distaccate, polvere). Si è poi proceduto al consolidamento<br />
delle murature, realizzato in modo mirato in funzione<br />
del problema (risarcitura delle fratture, reintegrazioni<br />
murarie, interventi di scuci e cuci, realizzazione di bauletti<br />
sommitali delle creste murarie con fini protettivi).<br />
Fig. 7 - Villa dei Quintili. Area S 14. Vista zenitale (da Frontoni, Galli,<br />
Paris 2020, p. 242 fig. 3).
le pareti tracce di affresco con larghe fasce rosse che delimitano<br />
campi bianchi, intonaco che arriva fino al pavimento<br />
senza zoccolatura, tranne che nell’angolo settentrionale.<br />
L’intervento di restauro ha interessato, infine, l’ambiente<br />
(S14), scavato nel corso nell’ultima campagna (2017-18) che<br />
ha riportato alla luce i carceres (gabbie di partenza per i<br />
cavalli) del circo e una delle due torri che ne erano parte<br />
funzionale (Figg. 7-8). Il complesso oggetto di restauri è<br />
stato costruito sopra i carceres del circo attribuito all’età<br />
di Commodo (161-192 d.C.) e datato all’età dei Gordiani (III<br />
secolo) grazie a un bollo impresso in una malta di alloggiamento<br />
di una fistula aquaria di una delle cannelle; l’area è<br />
stata trovata rasata e obliterata da un impianto per la produzione,<br />
la degustazione e la conservazione del vino (Frontoni,<br />
Galli, Paris, 2020). Si trattava di un ambiente particolarmente<br />
lussuoso, che presentava rivestimenti parietali<br />
e pavimentali in opus sectile; di questi ultimi sono ancora<br />
visibili tracce delle tarsie geometriche in marmi pregiati.<br />
L’ipotesi plausibile per la ripavimentazione dell’ambiente<br />
riferibile alla degustazione e al simposio (S14), con taglio<br />
che risparmia solo il rivestimento marmoreo lungo la parete<br />
occidentale, è ancora in corso di studio (Frontoni, Galli,<br />
Paris, 2020).<br />
Fig. 8 - Villa dei Quintili. Area S 14 (2021). Stato attuale dopo gli interventi<br />
di conservazione (Foto dell’A.).<br />
In ultimo, la pulitura di un canale di scolo ha permesso di<br />
determinare che questo servisse, come ipotizzato, da deflusso,<br />
facendo emergere l’originale pavimentazione in<br />
mattoni bipedali e cocciopesto, permettendo di fare ulteriori<br />
deduzioni sul funzionamento di questo ambiente e di<br />
quelli ad esso connessi.<br />
L’ultimo intervento (2021) fa parte di una convenzione tra<br />
il Parco archeologico dell’Appia Antica, con il Direttore,<br />
Simone Quilici, e la responsabile dell’area, Clara Spallino,<br />
e l’I.C.R., con la Direttrice Alessandra Marino, che ha<br />
interessato la revisione degli interventi già condotti negli<br />
ambienti R19 ed R20 (Figg. 5-6), venuti alla luce nel corso<br />
della campagna di scavi 2002-2004 nella zona residenziale<br />
del complesso della Villa, là dove si trova un’importante<br />
pavimentazione in opus sectile.<br />
Il primo ambiente (R19) è una sala rettangolare di m. 9,50 x<br />
6,00, con mattonelle realizzate in ardesia, palombino giallo<br />
antico, con una zoccolatura in ardesia di cm. 31 di altezza e<br />
listello in palombino di cm. 2 di altezza. Il vano è realizzato<br />
in opera mista (scaglioni di basalto e cinture laterizie) ed è<br />
dotato di intercapedine sotto al pavimento e lungo il lato<br />
breve meridionale per il sistema di riscaldamento azionato<br />
dal piccolo ambiente ipogeo a nord. Un particolare affresco<br />
dal fondo tra il nero e l’azzurro, del quale rimangono sul<br />
posto alcuni lacerti, rappresentava con molta probabilità<br />
scene di giardino, come attestato sui frammenti recuperati<br />
durante gli scavi. Un bollo laterizio ritrovato nei mattoni<br />
del piano superiore dell’ipocausto fissa al 123-125 d.C. il<br />
terminus ad/post quem per la messa in opera del pavimento<br />
(Galli, Frontoni 2015).<br />
Il secondo ambiente (R20), di transito, è caratterizzato da<br />
una pavimentazione in elementi di ardesia (quadrati grandi<br />
cm 29,7 x 29,7 e piccoli cm 7 x 7,5) e bardiglio (cm 29,7<br />
x 15,5). La piccola sala raccorda il settore termale con la<br />
stanza più appartata e riscaldata (R19), forse un oecus-diaeta<br />
invernale. Non è dotata di riscaldamento e reca lungo<br />
CONCLUSIONI. TRA INNOVAZIONE E TRADIZIONE<br />
L’attività condotta presso il complesso della Villa dei Quintili,<br />
fa emergere la complessità di un cantiere di restauro<br />
archeologico, dove diverse figure partecipano all’attività<br />
conservativa, ognuna con compiti precisi, importanti per il<br />
perseguimento dell’obbiettivo finale, il progetto di restauro.<br />
Se da un lato emerge nella fase preventiva l’importanza<br />
di un approccio legato ad una metodologia tradizionale di<br />
intervento, prima fra tutte l’osservazione diretta dei manufatti,<br />
la stesura di eidotipi di studio, l’indagine diretta<br />
con la restituzione digitale del rilievo metrico, cui segue<br />
in quella progettuale e di cantiere con l’impiego di malte<br />
realizzate in opera, o quello di materiale in taluni casi reperito<br />
in situ, il cantiere di restauro non è al tempo stesso<br />
scevro dalla necessità di essere accompagnato da indagini<br />
diagnostiche di laboratorio, dove l’innovazione ha un ruolo<br />
determinante per la possibilità di ottenere risultati prima<br />
solo immaginabili. Così, nei diversi campi d’azione, nelle<br />
analisi di tipo chimico, con l’utilizzo della stratigrafia al microscopio<br />
ottico, i diffrattometri a raggi X di ultima generazione,<br />
l’analisi delle sezioni sottili, sulla scorta di prelievi di<br />
campioni fatti sul posto. A queste si aggiungono le indagini<br />
fisiche, tra le quali per esempio, l’impiego della termografia,<br />
metodologia impiegata presso i laboratori dell’I.C.R. già<br />
a partire dagli anni Settanta del secolo passato, per la felice<br />
intuizione di Giovanni Urbani, che seppe cogliere l’utilità<br />
nel campo del restauro di un tipo di indagine prima ad uso<br />
e consumo del campo bellico, medicale o addirittura criminologico<br />
(Fabretti 2021).<br />
Oggi non possiamo avere la presunzione di replicare materiali<br />
antichi, perché non abbiamo più quegli elementi che<br />
ne permettevano la realizzazione. Piuttosto la ricerca e la<br />
tecnologia, hanno favorito la produzione di materiali che<br />
consentono di crearne altri con caratteristiche spesso migliori,<br />
ma sempre compatibili con quelli antichi, nell’ottica<br />
dell’adagio che il restauro debba essere minimo, reversibile,<br />
distinguibile e compatibile da un punto di vista chimico e<br />
fisico con la materia dell’opera d’arte. Perciò l’innovazione<br />
va intesa quale ricerca di nuove soluzioni, che siano alla<br />
base del lavoro che quotidianamente è sperimentato presso<br />
l’I.C.R.<br />
14 ArcheomaticA N°3 settembre <strong>2022</strong>
Tecnologie per i Beni Culturali 15<br />
Bibliografia<br />
Argan G.C. (1938), Restauro delle opere d’arte.<br />
Progettata istituzione di un Gabinetto Centrale del<br />
restauro, Relazione al Convegno dei Soprintendenti<br />
(Roma, 4-6 luglio 1938), in le Arti, 2, 133-137.<br />
Carpignoli G., Folcini C., Marini F., Nugara C., Sanzaro<br />
D., Ventura G. (2017), Villa dei Quintili, Piccole Terme,<br />
XVI Cantiere didattico, Scuola di Specializzazione in<br />
beni architettonici e del paesaggio, “Sapienza” Università<br />
di Roma, a.a. 2016-17.<br />
Cederna A. (1958), I gangsters dell’Appia, in Il Mondo,<br />
8 settembre, 6-7.<br />
Crova C. (2012), L’I.C.R. e la nascita della Scuola italiana<br />
del Restauro, in Palladio, Rivista di storia dell’architettura<br />
e restauro, (50), 105-130.<br />
Crova C. (2018), Il ruolo di Italia Nostra e delle Associazioni<br />
portatrici di interessi diffusi nella tutela e nella<br />
valorizzazione del patrimonio culturale, in Territori<br />
della Cultura, (32), 74-93.<br />
Crova C. (2021), Il cantiere didattico nella formazione<br />
dello specialista restauratore. Teoria e metodi di un’attività<br />
multidisciplinare, in Realtà dell’architettura fra<br />
materia e immagine. Per Giovanni Carbonara. Studi e<br />
ricerche, a cura di Esposito D., Montanari V., 2 voll.,<br />
l’Erma di Bretschneider: Roma, vol. II, nn. 73-74, 473-<br />
478, (Quaderni dell’Istituto di Storia dell’Architettura,<br />
nn. 73-74).<br />
Fabretti G. (2021), Le potenzialità operative dell’uso,<br />
combinato e coordinato, delle tecniche d’indagine<br />
multispettrale di Controllo non Distruttivo (C.n.D.)<br />
nell’ispezione dei diversi strati costituenti il sistema<br />
di superficie, in La diagnostica artistica e i laboratori<br />
scientifici, Giornata formativa (I.C.R., Roma 22 novembre<br />
2021), s.e.: Roma.<br />
Frontoni R. (2012), S. Maria Nova, in Forma Vrbis, XVII,<br />
(2), 45-48.<br />
Frontoni C., Galli G., Paris R. (2020), Via Appia Antica:<br />
nuove scoperte alla Villa dei Quintili, in AISCOM, Atti<br />
del XXV Colloquio dell’Associazione Italiana per lo Studio<br />
e la Conservazione del Mosaico, (Reggio Calabria,<br />
13-16 marzo 2019), a cura di Cecalupo C., Erba M.E.,<br />
XXV, Quasar: Roma, 235-245.<br />
Galli G., Frontoni R., (2015), Repertorio dei pavimenti<br />
in opus sectile dalla Villa dei Quintili, in AISCOM, Atti<br />
del XX Colloquio dell’Associazione Italiana per lo Studio<br />
e la Conservazione del Mosaico, (Roma, 19-22 marzo),<br />
a cura di Angelelli C., Paribeni A., XX, Scripta Manent<br />
Edizioni: Roma, 149-160.<br />
Labruzzi C. (1784), Via Appia illustrata ab urbe Roma<br />
ad Capuam limite noto Appia longarum teritur regina<br />
viarum, s.l.: s.e.<br />
Paris R. Frontoni R., Galli G., (2019), Via Appia. Villa<br />
dei Quintili, Santa Maria Nova, Roma: Electa.<br />
Secco Suardo G., (1866), Manuale ragionato per la parte<br />
meccanica dell’Arte del Restauratore di dipinti, Tipografia<br />
di Pietro Agnelli: Milano<br />
Sitografia<br />
https://www.facebook.com/parcoappiaantica<br />
Abstract<br />
As part of the conservation projects that have affected the Villa dei Quintili,<br />
an important role has been played by the educational sites which over the<br />
last 11 years have seen alternating, in an interdisciplinary work between the<br />
Archaeological Superintendence of Rome and the Archaeological Park of 'Appia<br />
Antica' with the School of Specialization in Architectural and Landscape Heritage<br />
of the "Sapienza" - University of Rome and, above all, the Central Institute<br />
for Restoration.<br />
In particular, over the years the ICR has played the role of consultant for academic<br />
activities and, subsequently, of main actor in the conservation sites of<br />
a portion of the central area and the area of the Carceres, with particular<br />
reference to the conservation of opus sectile that are found here, the starting<br />
point for experiences that will be developed in the near future.<br />
Parole Chiave<br />
Villa dei Quintili; Piccole Terme, Cantieri didattici; Restauro; Valorizzazione<br />
Autore<br />
Cesare Crova<br />
cesare.crova@beniculturali.it<br />
Dottore di Ricerca in Conservazione dei beni architettonici<br />
Istituto Centrale per il Restauro del MiC
RESTAURO<br />
EDXRF tra analisi e imaging<br />
Nuovi intriganti sviluppi nella<br />
diagnostica dei Beni Culturali<br />
di Giovanni E. Gigante, Sergio A. Barcellos Lins<br />
La fluorescenza dei raggi X (Energy<br />
dispersive), EDXRF, probabilmente la più<br />
utilizzata tecnica analitica per lo studio<br />
dei materiali e delle tecniche nel campo<br />
dei Beni Culturali da più di tre decenni,<br />
sembra non volersi mai fermare riservando<br />
sempre novità di notevole interesse.<br />
Dopo essere stata una tecnica analitica<br />
di laboratorio [1] ed essere successivamente<br />
una delle prime impegnate nelle<br />
analisi non distruttive, anche delle opere<br />
d’arte [2], è divenuta dagli anni Novanta<br />
dello scorso secolo la tecnica di analisi in<br />
situ per eccellenza, grazie allo sviluppo di<br />
sistemi mobili e portatili [3], che hanno<br />
seguito la progressiva miniaturizzazione<br />
dei loro componenti di base ossia: (i) i rivelatori,<br />
(ii) i tubi radiogeni ed infine (iii)<br />
l’elettronica di acquisizione e di elaborazione<br />
dei dati (vedi Figura 1) [4].<br />
Ciò che è accaduto negli ultimi anni è stato uno sviluppo<br />
sorprendente, almeno per i non addetti ai lavori,<br />
che sembra quasi aver cambiato pelle alla fluorescenza<br />
a raggi X, divenendo una tecnica di produzioni di immagini<br />
(mappe elementali – vedi Figura 2) e non più di analisi<br />
degli elementi, anche in alcuni casi quantitativa, come per<br />
i metalli. Questo cambiamento sembra essere accolto con<br />
estremo favore dalla maggioranza degli addetti ai lavori che<br />
preferiscono le immagini ai numeri.<br />
È quasi inutile presentare la Fluorescenza dei Raggi X<br />
(EDXRF) ai lettori di questa rivista che hanno un livello di<br />
conoscenza delle tecniche abbastanza elevato, comunque<br />
possiamo in breve presentarla indicando quali sono i suoi<br />
più comuni impieghi nella diagnostica per i Beni Culturali.<br />
La EDXRF è impiegata soprattutto per la diagnostica su superfici<br />
dipinte, metalli, ceramiche, e vetri; per identificare,<br />
tramite l’analisi degli elementi, i materiali (ad esempio<br />
i pigmenti) utilizzati, i processi di restauro o di degrado,<br />
le tecnologie di produzione adoperate o anche per rivelare<br />
elementi spuri che potrebbero portare a identificare il<br />
manufatto come un falso [5]. Grazie alla disponibilità di<br />
sistemi mobili e/o portatili le indagini vengono in genere<br />
effettuate in situ utilizzando opportuni sistemi di posizionamento.<br />
La EDXRF può essere utilizzata in modalità non<br />
distruttiva, anche se occorre avere qualche cautela nella<br />
16 ArcheomaticA N°3 settembre <strong>2022</strong>
Tecnologie per i Beni Culturali 17<br />
valutazione dei risultati, in quanto la superficie dei manufatti<br />
e’ fortemente disomogenea per presenza di più fasi o<br />
di stratificazione (come per le superfici dipinte).<br />
La radiazione impiegata nell’eccitazione della fluorescenza<br />
e’ a raggi X, che, alle intensità tipiche utilizzate nella<br />
gran parte degli strumenti attualmente in uso, non producono<br />
danni sull’opera (ma anche sugli operatori), se si<br />
adottano le corrette misure di protezione. L’identificazione<br />
degli elementi avviene mediante la rivelazione dei fotoni<br />
(raggi X) che vengono prodotti a seguito dell’eccitazione<br />
dei singoli atomi che emettono, a secondo dell’elemento,<br />
fotoni di una determinata energia. Tali energie, almeno<br />
per le righe caratteristiche K ed L degli elementi normalmente<br />
nel caso di Beni Culturali, non dipendono dal composto<br />
cui l’elemento è legato.<br />
Il processo con il quale avviene l’identificazione e l’eventuale<br />
quantificazione dei vari elementi (componenti), è<br />
eminentemente statistico, per cui, in genere, un po’ come<br />
accade per gli scrutini elettorali, occorre attendere tempo<br />
prima di avere indicazioni valide e un tempo più lungo per<br />
avere risultati certi. Sempre seguendo la precedente analogia<br />
questi tempi sono minori per gli elementi più abbondanti<br />
e decisamente maggiori se l’elemento è minoritario.<br />
Questo fa della EDXRF uno strumento difficile da impiegare<br />
se non si ha una buona conoscenza della tecnica. In particolare,<br />
come accade in diagnostica medica, occorre quasi<br />
sempre un esperto che legga ed interpreti i dati in quanto i<br />
risultati difficilmente si leggono da soli; un esperto scientifico<br />
abituato a leggere i risultati EDXRF su superfici dipinte<br />
vede molte più cose di un non esperto, anche se professionalmente<br />
ben qualificato come può essere un restauratore<br />
o uno storico. In qualche modo si può affermare come sia<br />
l’uso che fa la funzione, evocando così la famosa teoria<br />
evoluzionistica di Lamarck. Questo è quello che sicuramente<br />
è accaduto con la EDXRF, che, essendo stata impiegata<br />
massicciamente per lo studio dei materiali antichi, ha<br />
generato una conoscenza che ha permesso di considerarla<br />
attualmente come una tecnica diagnostica dalla quale non<br />
si possa piu’ prescindere in tali studi.<br />
Quello che bisogna capire è che molto spesso la possibilità<br />
di fare un’analisi quantitativa è fortemente limitata dalla<br />
disomogeneità del campione analizzato, piuttosto che dallo<br />
strumento di misura. Questo ha determinato la spinta a<br />
ideare tecniche di microanalisi in molti casi con la possibilità<br />
di generare immagini microscopiche: emblematico è il<br />
caso della microscopia elettronica a scansione (SEM), che<br />
può essere considerata attualmente la tecnica da cui partire<br />
per studiare materiali disomogenei e compositi anche<br />
su scala nanometrica [6]. Qualcuno sicuramente ricorderà<br />
che nello sviluppo del SEM il punto di partenza è stata la<br />
considerazione che la microscopia classica aveva dei limiti<br />
teorici per la risoluzione laterale; limiti che sarebbe stato<br />
possibile superare solo costruendo microscopi a raggi<br />
X che, avendo una minore lunghezza d’onda, avrebbero<br />
consentito di superarli fino a portarli sotto al micron. Tali<br />
microscopi sono stati costruiti con l’impiego di sorgenti X<br />
molto avanzate come la Luce di Sincrotrone [7], essi non<br />
sono però divenuti strumenti di uso comune almeno nelle<br />
analisi di routine e comunque non per la realizzazione<br />
di strumentazione portatile. Quello che è accaduto per la<br />
EDXRF è naturalmente un’altra storia, che sicuramente si<br />
è sviluppata grazie all’esempio di ciò che è stato fatto con<br />
la SEM. Le mappe elementali, e la loro grande utilità nello<br />
studio di materiali disomogenei [8], sono state create con<br />
le tecniche SEM che permettono di combinare la grande<br />
Fig. 2 - Le mappe elementali sono prodotte utilizzando un singolo picco<br />
di fluorescenza. Quindi su un dipinto che contiene diversi pigmenti ne<br />
vengono prodotte numerose in una singola scansione.<br />
capacità di fare immagini microscopiche con la capacità di<br />
crearne utilizzando la microanalisi a raggi X. Quindi il segreto<br />
è quello di abbinare immagini in alta risoluzione a mappe<br />
elementali. Con la SEM ciò è possibile con un unico strumento,<br />
mentre al momento con la macro XRF (MA-XRF) si può<br />
fare utilizzando, ad esempio, immagini in alta risoluzione o<br />
addirittura prodotte con microscopi. In ogni caso, a scanso<br />
di equivoci, con le attuali tecniche di scansione con XRF si<br />
raggiungono su scale millimetriche (ma con la possibilità di<br />
scansionare aree molto estese, anche di metri quadri).<br />
Lo sviluppo dei sistemi MA-XRF e’ avvenuta, a partire dal<br />
2011, grazie agli avanzamenti tecnologici con l’introduzione<br />
dei rivelatori Silicon Drift (SDD) e la estrema miniaturizzazione<br />
delle sorgenti radiogene [9, 10]. Anche gli sviluppi<br />
della robotica e la miniaturizzazione delle catene di conteggio<br />
hanno facilitato la realizzazione di tali scanner (Figura<br />
3).<br />
I numeri che sono alla base di questo sviluppo tecnologico<br />
sono: (i) milioni di conteggi al secondo che è possibile<br />
acquisire con uno o più rivelatori SDD, (ii) elevati flussi di<br />
Mappe<br />
elementali<br />
Fig. 3 - Miniaturizzazione<br />
di serie dei componenti.
Fig. 4 - Lo scanner è composto da diversi moduli, come mostrato in<br />
figura. Il più ingombrante è il sistema di scansione le cui dimensioni<br />
possono essere ridotte moltissimo, se si fa la scansione di un oggetto<br />
piccolo (vedi il riquadro in alto a sinistra).<br />
raggi X, eventualmente concentrabili su superfici piccole<br />
mediante opportune ottiche, che è possibile ottenere con<br />
sorgenti radiogene di dimensioni molto ridotte e di bassa<br />
potenza, che possono rimanere accese per ore senza deteriorarsi,<br />
(iii) velocità di scansione > 2 mm/s che significa<br />
fare 2 cm2 al minuto (quindi un foglio A4 in poco più di<br />
otto ore e mezzo) grazie alla completa robotizzazione dei<br />
sistemi di scansione. Questi numeri saranno sicuramente<br />
migliorati anche se è difficile pensare si possa scansionare<br />
un foglio A4 in meno di un minuto come attualmente può<br />
fare uno scanner ottico.<br />
Come si arriva a questi numeri? I singoli spettri sono acquisiti<br />
in meno di 300 ms (si può arrivare a tempi di acquisizione<br />
minori utilizzando sorgenti di più elevata intensità)<br />
e ciascuno spettro ha in media 8260 conteggi di cui circa<br />
l’80% può essere utilizzato per informazioni relative ai vari<br />
elementi. Ovviamente, il fattore che limita il sistema è la<br />
brillanza delle sorgenti X convenzionali, che non consentono<br />
di acquisire un milione di conteggi al secondo. È utile<br />
ricordare che quando furono realizzati i primi XRF scanner<br />
utilizzando come sorgente la luce di sincrotrone, venne detto<br />
che le sorgenti convenzionali non avrebbero permesso<br />
di ottenere risultati utili. Questo nodo non si è del tutto<br />
sciolto, però l’utilità delle informazioni ottenute fa sì che<br />
si aspettino ore per avere un risultato, senza spazientirsi<br />
troppo. Queste considerazioni servono solo a mettere in<br />
evidenza che ci sono margini di miglioramento. L’impiego<br />
di più rivelatori va visto come una possibilità di aumentare<br />
l’efficienza geometrica nell’acquisizione dei fotoni emessi,<br />
anche considerando la bassa statistica dei fotoni rivelati e<br />
quindi l’utilità di migliorare la statistica dei conteggi e, infine,<br />
la sensibilità della tecnica.<br />
Legato al problema delle sorgenti è quello della risoluzione.<br />
Attualmente, utilizzando opportune ottiche a raggi X<br />
(che però riducono fortemente le intensità della sorgente)<br />
si arriva a risoluzioni intorno a 35 µm, senza ottiche<br />
si può arrivare a mezzo millimetro. Nel seguito possiamo<br />
comunque prendere un millimetro come valore di riferimento.<br />
Il problema è quello di trovare un compromesso tra le<br />
dimensioni dell’area scansionata e la risoluzione, tenendo<br />
conto dei tempi necessari per l’acquisizione dell’immagine.<br />
Possiamo fotografare un dipinto con un solo scatto perché<br />
usiamo una lente, comunque la risoluzione non è eccellente<br />
se il dipinto è grande. Usando un sistema di scansione la<br />
risoluzione migliora, anche se è difficile, con uno scanner<br />
ottico [11], arrivare alle decine di micron. Prendiamo ad<br />
esempio un’immagine scansionata a 300 ppi - va notato che<br />
nel caso di un’acquisizione è meglio parlare di ppi (point<br />
per inch) piuttosto che di dpi (dot per inch) - la distanza tra<br />
i punti (pixel) è in questo caso di ~ 85 µm. Se si acquisisce<br />
un punto per ogni millimetro, si ottiene una risoluzione di<br />
25.4 ppi, che, nel caso di un foglio A4, significa un 6.237.000<br />
di punti, quindi, di spettri acquisiti. Si tratta di una quantità<br />
di dati molto grande, che non è possibile trattare senza<br />
usare/costruire un sistema di elaborazione appropriato.<br />
Questo è quello che è stato fatto nel programma di sviluppo<br />
di scanner XRF da noi portato avanti negli ultimi tre-quattro<br />
anni. Se si volesse utilizzare una risoluzione maggiore, ad<br />
esempio di 100 µm, il numero di spettri diverrebbe 6.2 107,<br />
comportando cioe’ un tempo di tre giorni e mezzo (85 ore)<br />
per scansionare un semplice foglio A4, il che è attualmente<br />
improponibile, a meno che non si scansioni il dipinto ad una<br />
velocità molto maggiore dell’attuale. Per farlo, l’unica possibilità<br />
è quella di acquisire molti più conteggi per secondo<br />
(cps), utilizzando sorgenti molto più intense delle attuali<br />
(senza però arrivare a sorgenti che non possono essere trasportate<br />
o addirittura portate in laboratorio come quelle<br />
di luce di sincrotrone). In un moderno scanner ottico da<br />
tavolo professionale (che praticamente tutti noi abbiamo in<br />
ufficio) si usano migliaia di rivelatori che scansionano una<br />
riga alla volta ed il carrello avanza con una velocità tale<br />
da digitalizzare un foglio A4 in 10-20 s, cioè scansionando<br />
milioni di pixel al secondo. Va comunque tenuto conto che<br />
uno spettro X è composto in genere di 1024 numeri interi (di<br />
almeno 12 bit) mentre un pixel di un’immagine visibile da’<br />
tre numeri da 8 bit; quindi, un pixel in una immagine XRF ha<br />
un peso notevolmente maggiore e non sarebbe comunque<br />
trasmissibile ad una velocità di milioni di pixel al secondo,<br />
come accade per un’immagine acquisita con uno scanner o<br />
una fotocamera.<br />
Quello che abbiamo realizzato con il nostro progetto è stato<br />
uno sviluppo, che riteniamo assolutamente necessario per<br />
migliorare l’impatto degli scanner nelle indagini sui Beni<br />
Culturali e cioè la completa trasportabilità del sistema. Per<br />
ottenerla, i dispositivi di scansione (Figura 4), che sono la<br />
parte più ingombrante, sono stati ottimizzati e scomposti in<br />
moduli, in modo da rispondere in maniera più efficace alle<br />
necessità di ogni singola applicazione. Per quanto riguarda<br />
la strumentazione si sono fatte scelte conservative, evitando,<br />
ad esempio, di usare ottiche capillari, che richiedano<br />
particolare attenzione nel trasporto. Sono stati così realizzati<br />
diversi moduli di scansione di dimensioni e prestazioni<br />
notevolmente diverse. La riduzione in moduli del sistema è<br />
stata possibile soprattutto con la realizzazione di un software<br />
di acquisizione, che potesse essere facilmente utilizzato<br />
18 ArcheomaticA N°3 settembre <strong>2022</strong>
Tecnologie per i Beni Culturali 19<br />
per i diversi sistemi e consentisse una configurazione flessibile<br />
di tali sistemi (figura 5). Alcuni di tali sistemi sono completamente<br />
mobili, come quello utilizzato presso lo scavo<br />
archeologico di Koumasa nell’Isola di Creta (portato in una<br />
valigia in aereo ed assemblato in situ); altri trasportabili,<br />
come quelli utilizzati per diverse misure presso Musei e Gallerie<br />
come, ad esempio, quello utilizzato a Palazzo Barberini<br />
(Galleria nazionale d’arte antica, Roma) per la scansione<br />
completa della Fornarina di Raffaello [12,] o alla Galleria<br />
Borghese su alcuni dipinti di dimensioni più ridotte (figura<br />
6). La modularità è a nostro avviso la carta vincente.<br />
Come appaiono le mappe? Esse hanno un peso decisamente<br />
inferiore della corrispondente immagine visibile, in quanto<br />
la loro risoluzione è molto minore. Utilizzando opportune<br />
tecniche di elaborazione è possibile fare una sovrapposizione<br />
o presentarle su un video affiancate. Tenendo conto<br />
che la risoluzione normalmente impiegata per un’immagine<br />
video è di 72 dpi, una mappa elementale di 30 x 30 cm2,<br />
acquisita con una risoluzione di 50 dpi, apparirebbe, quindi,<br />
sul video con una risoluzione ottimale in un frame da<br />
10 x 10 cm. Esattamente quello che si sta vedendo con le<br />
mappe acquisite attualmente, che non appaiono sgranate<br />
sul video.<br />
Cosa può rivelare una mappa elementale ad un diagnosta,<br />
ad un restauratore, ma anche ad uno storico? La stretta connessione<br />
che c’è tra elementi chimici e pigmenti è ben nota<br />
a tutti [14]: quindi una mappa di un particolare elemento<br />
mostra la distribuzione nel piano del pigmento ad esso associato<br />
(sempre se l’associazione è univoca), o anche solo<br />
la presenza di un certo pigmento in particolari aree del dipinto.<br />
Per fare degli esempi molto semplici, la presenza di<br />
alcuni elementi caratteristici di pigmenti moderni, come lo<br />
zinco, indicano e visualizzano le eventuali zone di restauro;<br />
la presenza di un elemento-pigmento, che non corrisponde<br />
al colore che è visibile in superficie, indica la presenza di<br />
strati pigmentati nascosti e il riscontro con altre tecniche<br />
può permettere di verificarne l’ipotesi. Questo può portare<br />
a diverse conclusioni come la presenza di un sottostante dipinto,<br />
un pentimento o un restauro. Il rilevamento di forme<br />
nell’area con pigmento anomalo (che può essere fatta con<br />
mappe elementali e non con singole misure XRF) può farci<br />
propendere per un’ipotesi o l’altra.<br />
Veniamo quindi a individuare il principale merito delle mappe<br />
elementali che spostano apparentemente l’indagine diagnostica<br />
dal quantitativo-analitico al qualitativo-segnico.<br />
La stessa cosa, su una superficie dipinta, può essere individuata<br />
in maniere molto diverse, in alcuni casi l’indagine<br />
analitica risulta la modalità più semplice, sempre che<br />
il risultato sia univoco. In altri casi il risultato dell’analisi<br />
è ambiguo, per cui bisogna aiutarsi con l’individuazione di<br />
forme-segni particolari con le mappe, per arrivare ad una<br />
ipotesi più complessa. Questo non significa che la XRF, producendo<br />
immagini, divenga qualitativa, più semplicemente<br />
il procedimento diagnostico, come accade in molti altri<br />
casi, ad esempio nella diagnostica medica, passa attraverso<br />
l’analisi quantitativa dell’immagine con l’individuazione<br />
oggettiva, ed in alcuni casi morfometrica, di segni. Quindi<br />
sempre in una dimensione quantitativa.<br />
Con una singola scansione XRF si producono diverse mappe<br />
elementali (Figura 2), il che è sicuramente un grande vantaggio,<br />
ma anche un grande problema per l’interpretazione<br />
dei dati. Chi è pratico di analisi del colore sa che l’immagine<br />
di un dipinto può essere scomposta in tre immagini che<br />
corrispondono alle tre componenti cromatiche. Manipolando<br />
opportunamente tali immagini, eventualmente facendo<br />
alcune trasformazioni, è possibile fare numerose utili riflessioni<br />
e deduzioni, che possono portare a ipotesi diagnostiche<br />
o critiche molto interessanti. Ovviamente, nel caso<br />
Fig. 5 - L’organizzazione dei dati nel software XISMuS [14], sviluppato<br />
per i sistemi MA XRF, è centrata sul Datacube.<br />
del colore l’esperienza ha portato a sviluppare tecniche di<br />
elaborazione molto sofisticate ed efficaci. Nel caso delle<br />
mappe elementali prodotte con la MA-XRF si sta ancora imparando.<br />
Comunque, alcune idee sono già disponibili, come<br />
quella di effettuare sovrapposizioni di più mappe elementali<br />
tra loro o con l’immagine digitale del dipinto, o quella<br />
di fare correlazioni tra mappe in modo da verificare se due<br />
elementi caratterizzano lo stesso pigmento o due pigmenti<br />
sono impiegati insieme. Per lavorare con le mappe occorre<br />
disporre di un supporto di elaborazione efficiente [14], preferibilmente<br />
integrato con il software di acquisizione e archiviazione<br />
dei dati prodotti con lo scanner. E’ il motivo per<br />
cui molto del nostro lavoro è stato dedicato a questo scopo.<br />
Le mappe sono uno strumento straordinario per la ricostruzione<br />
delle tecniche pittoriche nel caso di superfici dipinte,<br />
ma anche di ceramiche, vetri ed in genere superfici lavorate.<br />
Ovviamente alcuni elementi sono così diffusi e abbon-<br />
Fig. 6 - Lo scanner MA XRF in funzione sulla Fornarina di Raffaello.
danti sulla superficie che è possibile intravedere le forme<br />
presenti nel dipinto. Mancano però le parti che sono state<br />
dipinte con un altro o altri pigmenti. Altre mappe sono utili<br />
perché permettono di individuare le zone in cui è stato utilizzato<br />
un pigmento eterologo o anomalo, ad esempio per<br />
un restauro o per una falsificazione. In genere nel fare le<br />
operazioni come le correlazioni o i confronti è meglio individuare<br />
un’area di interesse in modo da migliorare i risultati<br />
ottenibili e la loro lettura.<br />
Una superficie dipinta è una sovrapposizione di strati, così<br />
come sono stratificate le superfici di moltissime opere con<br />
finalità o cause molto diversificate (estetica, di protezione,<br />
di degrado). La penetrazione dei raggi X nei materiali è in<br />
genere maggiore di quella della radiazione visibile (la luce);<br />
questo è un fatto ben noto a tutti che in genere attribuiscono<br />
questa proprietà ai raggi X fin dalla loro scoperta (basti<br />
pensare alla radiografia). Quello che accade nell’intervallo<br />
di energie, cui appartengono la maggior parte delle righe X<br />
di emissione dei principali elementi, utili alle indagini diagnostiche<br />
non distruttive, è che l’assorbimento varia fortemente<br />
anche per piccole variazioni di energia dei fotoni.<br />
Queste considerazioni portano a diverse conseguenze, tra<br />
cui la prima è che l’immagine della mappa elementale non<br />
è quella del solo strato superficiale, ma ha contributi anche<br />
dagli strati più interni. Occorre notare che ciò accade anche<br />
per le immagini del visibile, anche se con modalità diverse.<br />
Basti pensare al problema dei colori più o meno coprenti ed<br />
alle velature negli affreschi. La seconda è positiva: questo<br />
assorbimento differenziale, anche di fotoni generati dallo<br />
stesso elemento con processi alternativi, ma in rapporto<br />
statistico fisso, può essere utilizzato per misurare lo spessore<br />
di uno strato superficiale [15] o, in alternativa, individuare<br />
in quale strato sta l’elemento osservato. In pratica si<br />
può stabilire se un certo pigmento è presente in uno strato<br />
più interno o in quello superficiale.<br />
Per concludere, le mappe elementali possono essere la<br />
chiave per fare un’operazione, che è stata da sempre pensata,<br />
ma mai possibile: ricostruire un dipinto partendo dai<br />
materiali che lo compongono in maniera scientificamente<br />
più rigorosa. Copiare un dipinto è un’operazione che i pittori<br />
fanno da sempre, spesso con un certo rigore: cioè utilizzando<br />
gli stessi materiali e tecniche che loro pensano abbia<br />
utilizzato l’autore. Spesso i risultati sono molto buoni e suggestivi.<br />
Cosa diversa è individuare puntualmente materiali e<br />
tecniche con la diagnostica e fare una simulazione a partire<br />
dalle forme, che possono essere accuratamente ricostruite<br />
da immagini digitali del dipinto. In questo caso non è una<br />
copia ma una simulazione in quanto le scelte arbitrarie nella<br />
ricostruzione sono ridotte al minimo.<br />
Bibliografia<br />
[1] R. S. Frankel and D. W. Aitken “Energy-Dispersive X-Ray<br />
Emission Spectroscopy”, Appl. Spectrosc. 24(6), (1970), pp.<br />
557-566 DOI:10.1366%252F000370270774372308<br />
[2] R. Cesareo, F. V. Frazzoli, C. Mancini, and S. Sciuti,<br />
M. Marabelli, P. Mora, P. Rotondi, G. Urbani, “Non‐<br />
Destructive Analysis of Chemical Elements in Paintings<br />
and Enamels”, Archaeometry 14(1), 1972, pp. 65-78<br />
DOI:10.1111/j.1475-4754.1972.tb00051.x<br />
[3] R. Cesareo, G. E. Gigante, A. Castellano, S. Ridolfi,<br />
“Portable and handheld systems for energy-dispersive<br />
X-ray fluorescence analysis”, Encyclopaedia of<br />
Analytical Chemistry, John Wiley & Sons Ltd, Chichester<br />
DOI: 10.1002/9780470027318.a6803.pub2<br />
[4] “X-Ray Physics: Interaction with Matter, Production,<br />
Detection” R. Cesareo, Published by La Rivista del Nuovo<br />
Cimento della Società Italiana di Fisica, Bologna, 2000, pp.<br />
231 DOI:10.1007/BF03548887<br />
[5] “Portable X-Ray Fluorescence Spectrometry: Capabilities<br />
for in Situ Analysis” Potts, Philip J. e West, Margaret editori,<br />
pubblicato dalla The Royal Society of Chemistry | 2008 DOI:<br />
10.1039/9781847558640<br />
[6] X. Zhou, G. E. Thompson, “Electron and Photon Based<br />
Spatially Resolved Techniques”, Reference Module in<br />
Materials Science and Materials Engineering, Elsevier, (2017),<br />
ISBN 9780128035818<br />
[7] J. Kirz e C. Jacobsen “The History and Future of X-ray<br />
Microscopy”, Journal of Physics: Conference Series, 186<br />
(2009), DOI: 10.1088/1742-6596/186/1/012001<br />
[8] L. J. Allen, A. J. D’Alfonso, S. D. Findlay, J. M. Le Beau, N.<br />
R. Lugg and S. Stemmer, “Elemental mapping in scanning<br />
transmission electron microscopy”, Journal of Physics:<br />
Conference Series 241 (2010) 012061 DOI:10.1088/1742-<br />
6596/241/1/012061<br />
[9] J. Dik, K. Janssens, G. Van Der Snickt, L. Van Der Loeff,<br />
K. Rickers e M. Cotte, “Visualization of a lost painting by<br />
Vincent Van Gogh using synchrotron radiation-based X-ray<br />
fluorescence elemental mapping”. Analytical Chemistry, 80<br />
(2008), 6436 DOI: 10.1021/ac800965g<br />
[10] M. Alfeld, K. Janssens, J. Dik, W. De Nolf e G. Van Der<br />
Snickt, “Optimization of mobile scanning macro-XRF systems<br />
for the in situ investigation of historical paintings”. Journal of<br />
Analytical Atomic Spectrometry, 26 (2011), 899 DOI: 10.1039/<br />
C0JA00257G<br />
[11] https://en.wikipedia.org/wiki/Image_scanner<br />
[12] A. Cosma, C. Merucci e S. Ridolfi, “Raffaello da vicino:<br />
nuove indagini e nuove scoperte sulla Fornarina.” Officina<br />
Libraria, Milano, Italy (2021). ISBN 88-3367-131-3.<br />
[13] “La fabbrica dei colori: pigmenti e coloranti nella pittura e<br />
nella tintoria a cura di Simona Rinaldi, Il bagatto”, (1986), 572,<br />
ISBN 9788877550507<br />
[14] S. A. Barcellos Lins, B. Bremmers e G. E. Gigante,<br />
“XISMuS – X-ray Fluorescence imaging software for multiple<br />
samples.” SoftwareX, 12 (2020), 100621, DOI: 10.1016/j.<br />
softx.2020.100621<br />
[15] Barcellos Lins, S.A., Gigante, G.E., Cesareo, R., Ridolfi, S.,<br />
Brunetti, A. “Testing the Accuracy of the Calculation of Gold Leaf<br />
Thickness by MC Simulations and MA-XRF Scanning”, Applied<br />
Sciences 10(10), (2020), 3582 DOI: 10.3390/app10103582<br />
Abstract<br />
Aggiungi Abstract: The essay resume the most recent history of EDXRF, a nondestructive<br />
X-Ray fluorescence microanalysis of pigments of paintings used by<br />
the help of elemental colour Map and Portable Instrumentation Package: the<br />
innovative Implementations employed in the past years in the high resolution<br />
of imaging till the perfetto simulation<br />
Parole Chiave<br />
Beni Culturali; Diagnostica; EDXRF; analisi; imaging<br />
Autore<br />
Giovanni E. Gigante<br />
giovanni.gigante@fondazione.uniroma1.it<br />
Sergio A. Barcellos Lins<br />
Sergio.lins@roma3.infn.it<br />
Dipartimento di Scienze di Base e Applicate Sapienza Università di Roma<br />
20 ArcheomaticA N°3 settembre <strong>2022</strong>
Tecnologie per i Beni Culturali 21
RESTAURO<br />
Ricostruzione Digitale 3D dal Medioevo<br />
a Oggi del Palazzo del Vescovado<br />
Oggi Museo Diocesiano di arte sacra a Feltre (BL).<br />
Ricostruzione storico- architettonica<br />
a cura di Tre.Digital<br />
Ricostruzione digitale 3D del<br />
Palazzo del Vescovado di Feltre<br />
secondo una ricostruzione<br />
storica, archeologica e architettonica.<br />
Dalle Torri gemelle<br />
che si ergevano sopra Feltre<br />
alla ricostruzione del Palazzo<br />
del Vescovado sino all’attuale<br />
Museo Diocesano di Arte Sacra.<br />
Fig 1 - Anastilosi delle torri del Vescovado di Feltre.<br />
Lo studio dell’Arch. Gloria Manera si<br />
è occupato dell’analisi storica dei<br />
componenti edilizi del manufatto,<br />
facendo risalire, parete per parete, ogni<br />
elemento alla rispettiva epoca di costruzione,<br />
datandola con accurata precisione.<br />
Queste indicazioni sono state riportate<br />
su alcuni disegni tecnici al CAD ed<br />
è stata proprio la consapevolezza che le<br />
rappresentazioni bidimensionali non fossero<br />
sufficienti a dare consistenza allo<br />
studio stratigrafico a portare alla scelta<br />
di svilupparlo a video, ricostruendo gli<br />
interventi che si erano succeduti sul palazzo.<br />
Con i documenti storici è stato possibile<br />
avanzarne datazione e cronologia e tramite<br />
software di animazione 3D, Tre.digital,<br />
restituire obbiettivamente le varie<br />
conformazioni dell’edificio.<br />
Fig. 2 – Fasi costruttive dell’edificio.<br />
24 ArcheomaticA N°3 settembre <strong>2022</strong>
Tecnologie per i Beni Culturali 25<br />
La prima fase del progetto è stata di ricerca nell’ambito<br />
storico-artistico, da parte di professionisti, per poi<br />
avviare la fase di rilievo dello stato di fatto dell’edificio.<br />
Secondo esperti e ricercatori, prima del palazzo<br />
vescovile, esistevano già due torri o caseforti (fig.1),<br />
che svettavano sopra il massiccio roccioso in scaglia<br />
rossa di Feltre: un luogo ideale e riparato dove insediare<br />
la nuova sede episcopale.<br />
Acquisito il sito, i primi interventi alla struttura, ad<br />
opera del vescovo Villalta, furono di erigere una solida<br />
muratura di contenimento a margine del colle, mentre<br />
a nord vennero collegate le due torri con un alto muro.<br />
Successivamente l’ingresso principale fu protetto con<br />
nuove strutture (fig.2).<br />
Il Vescovado mantiene ancora tutto l’aspetto originario<br />
di un castello (Fig.3 e 4).<br />
Nel 1348 un importante terremoto colpisce Veneto e<br />
Friuli e fa crollare alcune parti dell’episcopio, specialmente<br />
nel lato della torre Ovest (fig.5).<br />
Nel secolo XV il vescovado diventa un palazzo veneziano.<br />
Nel 1510 un incendio devastante colpisce la città di<br />
Feltre, investendo anche il Vescovado. Va a fuoco principalmente<br />
la parte ovest, e nel rogo si perdono anche<br />
i preziosi documenti dell’archivio vescovile (Fig. 9).<br />
LA GRANDE RISTRUTTURAZIONE DI ROVELLIO E<br />
GRADENIGO (FINE XVI SECOLO E INIZI XVII SECOLO)<br />
In questo periodo il palazzo subisce una grande ristrutturazione<br />
ad opera dei vescovi Rovellio e Gradenigo:<br />
l’intento era quello di dare al Vescovado un aspetto<br />
rinascimentale e più omogeneo (Fig.10).<br />
Fig. 3 – Prospetto della sommità del Vescovado di Feltre<br />
RESTAURO<br />
Oggi il palazzo vescovile, a distanza di vent’anni dal primo<br />
progetto, ospita il Nuovo Museo Diocesano di Feltre e Belluno<br />
(Inaugurato l’11 maggio 2018), che in 27 sale contiene<br />
un elevatissimo numero di opere d’arte di enorme importanza<br />
(Fig.11): uno straordinario lavoro di restauro svolto<br />
ad opera di monsignor Giacomo Mazzorana, direttore del<br />
museo, e di Gloria Manera, architetto che ha seguito i lavori<br />
con il supporto tecnico dell’ingegner Siro Andrich e di<br />
Tiziana Conte, conservatrice che ha selezionato le opere da<br />
destinare al Museo e ne ha curato i restauri, affiancata da<br />
numerosi esperti.<br />
Fig. 4 – Planimetria del complesso del Vescovado di Feltre nell’assetto a cavallo tra XIII e XIV secolo.
Fig. 5 – Animazione del crollo dell’edificio durante il terremoto del 1348.<br />
Fig. 6 – Rendering degli ampliamenti del secolo XIV.<br />
26 ArcheomaticA N°3 settembre <strong>2022</strong>
Tecnologie per i Beni Culturali 27<br />
Fig. 7 – A) Profilo del rifacimento in Palazzo Veneziano (facciata).<br />
Fig. 7 - B) Profilo del rifacimento in Palazzo Veneziano (fianco).
Fig. 8 - Modello del rifacimento in palazzo veneziano.<br />
Fig. 9 - Simulazione degli effetti dell’incendio del 1510.<br />
Fig. 10 – Ricostruzione dell’edificio in stile rinascimentale.<br />
28 ArcheomaticA N°3 settembre <strong>2022</strong>
Tecnologie per i Beni Culturali 29<br />
Fig. 11 – Nuovo Museo Diocesano di Feltre e Belluno.<br />
Crediti<br />
Ricostruzione storica: analisi critica dell’edificio e dei<br />
dati documentali<br />
Architetto Gloria Manera<br />
Architetto Pierpaolo Bristot<br />
Dati strutturali e lesioni storiche<br />
Ingegner Siro Andrich<br />
Dati archeologici<br />
Dott. Flavio Cafiero<br />
Dati stratigrafici<br />
Restauratore Federico Pat<br />
Restauratrice Christine Lamoureux<br />
Modellazione 3D e realizzazione video<br />
Architetto Denis Mior - Tre.digital srl<br />
Collaboratore Luca Padovan - Tre.digital srl<br />
Software<br />
3ds Max + Corona Renderer per la parte di modellazione<br />
e rendering fotorealistici di alta qualità.<br />
HitFilm software di editing video<br />
Rayfire modellazione e scomposizione degli oggetti per<br />
l’animazione del crollo nella fase del terremoto sulla<br />
base della tipologia del materiale (es. il muro e il legno,<br />
che per natura hanno diverse animazioni nella fase di<br />
distruzione)<br />
Abstract<br />
3D digital reconstruction of the Palazzo del Vescovado di Feltre according to<br />
a historical, archaeological and architectural reconstruction. From the twin<br />
towers that overlooked Feltre to the reconstruction of the Palazzo del Vescovado<br />
up to the current Diocesan Museum of Sacred Art.<br />
The studio of the Arch. Gloria Manera was involved in the historical analysis<br />
of the building components, tracing each element back to the respective construction<br />
period wall by wall, dating it with accurate precision. These indications<br />
were reported on some CAD technical drawings and it was precisely<br />
the awareness that the two-dimensional representations were not sufficient<br />
to give consistency to the stratigraphic study that led to the choice of developing<br />
it on video, reconstructing the interventions that had taken place on<br />
the building.<br />
With the historical documents it was possible to advance their dating and<br />
chronology and using 3D animation software, Tre.digital objectively returns<br />
the various conformations of the building.<br />
The first phase of the project was research in the historical-artistic field by<br />
professionals, to then begin the phase of surveying the state of the building.<br />
According to experts and researchers, before the bishop's palace, there already<br />
existed two towers or strongholds, which stood out above the rocky massif<br />
of Feltre: an ideal and sheltered place to set up the new episcopal structure.<br />
Once the site was acquired, the first interventions on the structure, by Bishop<br />
Villalta, were to erect a solid retaining wall on the edge of the hill, while to<br />
the north the two towers were connected with a high wall. Subsequently the<br />
main entrance was protected with new structures.<br />
Parole Chiave<br />
Musei; tecnologia; ricostruzione digitale; modellazione 3D;<br />
anastilosi digitale<br />
Autore<br />
a cura di Tre.Digital<br />
contatti@tredigital.it<br />
Integrated Digital Solutions
AZIENDE E PRODOTTI<br />
offrendo prestazioni che non hanno nulla da invidiare<br />
alla serie da cui derivano. Il sistema utilizza un array di<br />
idrofoni che genera immagini ad alta risoluzione della<br />
stratigrafia dei fondali in oceani, laghi, fiumi, porti.<br />
Il modello a bassa frequenza, con doppio trasmettitore<br />
e ampio array di ricezione, è invece ideale per le applicazioni<br />
in acque profonde e per i parchi eolici.<br />
www.codevintec.it<br />
info@codevintec.it<br />
Fonte: Codevintec<br />
SLAM E FOTOGRAMMETRIA: PER UN RILIEVO VELOCE<br />
E DI QUALITÀ<br />
L’utilizzo di più strumentazioni dotate di tecnologie<br />
diverse consente di affrontare i rilievi senza scendere<br />
a compromessi con la produttività, la resa grafica e la<br />
precisione del dato. È il caso del rilievo dimostrativo<br />
effettuato presso Piazzale Porta del Molo di Genova.<br />
In questa occasione Microgeo ha impiegato l’innovativo<br />
Sistema Mobile Mapping ZEB HORIZON della GeoSLAM<br />
con la nuova camera ad alta risoluzione ZEB VISION e il<br />
Sistema fotogrammetrico telescopico 3D EYE.<br />
La praticità dello ZEB HORIZON ha consentito il rilievo<br />
dell’intero piazzale in pochi minuti, mentre con il<br />
Sistema 3D EYE sono state acquisite aree di dettaglio<br />
che si sono concentrate prevalentemente sulla Porta<br />
del Molo.<br />
La durata del rilievo SLAM in campo è stata di soli 10<br />
minuti, mentre la parte di elaborazione compresa di<br />
colorazione della nuvola è durata 40 minuti.<br />
Con il Sistema 3D EYE sono state scattate 84 foto e<br />
sono state allineate ed elaborate nel software di Fotogrammetria<br />
3DF ZEPHYR ottenendo un modello 3D ad<br />
alta definizione (circa 40 minuti di elaborazione automatica).<br />
Successivamente le due nuvole di punti provenienti da<br />
sistemi diversi (SLAM e 3D EYE) sono state unite all’interno<br />
di 3DF Zephyr utilizzando il potente algoritmo<br />
ICP presente all’interno del software, che ha consentito<br />
di scalare la nuvola fotogrammetrica su quella Laser<br />
dello ZEB HORIZON.<br />
Infine è stata generata una mesh fotorealistica della<br />
facciata principale della struttura derivante dall’unione<br />
dei due modelli.<br />
Fonte: Microgeo<br />
https://www.microgeo.it/<br />
info@microgeo.it<br />
SERIE 3400-OTS: I NUOVI SUB BOTTOM PROFILER<br />
DI EDGETECH<br />
Il nuovo 3400-OTS con montaggio su palo su piccole<br />
imbarcazioni ideale per rilievi in acque poco profonde<br />
è un ottimo strumento per indagini archeologiche<br />
o la localizzazione di oggetti sepolti.<br />
Stiamo parlando dei famosi SBP di Edgetech a tecnologia<br />
CHIRP. La nuova serie OTS - compatta, leggera<br />
e ultraleggera - conferma la bontà del progetto 3400<br />
STONEX XVS – SCANNER 3D | FOTOGRAMMETRIA DI<br />
NUOVA GENERAZIONE<br />
XVS è il nuovo scanner 3D vSLAM di Stonex. Grazie al<br />
sistema Visual SLAM (localizzazione e mappatura visiva<br />
simultanea), la traiettoria è mostrata sul tablet. Il sistema<br />
di misura inerziale (IMU) permette all’algoritmo<br />
di generare un blocco continuo di immagini. In ufficio,<br />
la procedura per generare il modello 3D è completamente<br />
automatica, con generazione del miglior risultato.<br />
I dati provenienti da XVS possono essere integrati<br />
con il video di un drone o di qualsiasi telecamera per<br />
una ricostruzione completa dell'area.<br />
La tecnologia Visual SLAM<br />
La tecnologia di localizzazione e mappatura visiva<br />
simultanea determina la posizione e l'orientamento<br />
di una telecamera rispetto all'ambiente circostante,<br />
mappando al contempo l'ambiente stesso. Attraverso<br />
le immagini consecutive, i punti vengono tracciati per<br />
triangolare la loro posizione 3D; queste informazioni<br />
vengono utilizzate contemporaneamente per approssimare<br />
la posizione della telecamera. Il sito del rilievo,<br />
rispetto la fotogrammetria tradizionale, viene acquisito<br />
con la certezza che i fotogrammi hanno la giusta<br />
sovrapposizione per costruire la nuvola di punti.<br />
Mesh colorate e dettagliate<br />
Grazie alla tecnologia impiegata da XVS, i dati raccolti<br />
producono delle mesh dettagliate e con colori fedeli<br />
alla realtà. XVS è il mezzo perfetto per scansionare<br />
aree a valenza archeologica e architettonica sia in interno<br />
che in esterno per poi ottenere una ricostruzione<br />
3D fedele.<br />
30 ArcheomaticA N°3 settembre <strong>2022</strong>
Tecnologie per i Beni Culturali 31<br />
Software dedicato<br />
Il nuovo Stonex 3D scanner XVS è dotato di due software<br />
dedicati:<br />
• XVSapp<br />
XVSapp è un software in dotazione ha un'interfaccia<br />
semplice e aiuta l'utente indicandogli come comportarsi<br />
nei passaggi critici e avvisandolo nel caso in cui l'oggetto<br />
non venga catturato correttamente. I parametri<br />
della telecamera sono completamente personalizzabili,<br />
adattandoli all'ambiente circostante.<br />
Il tablet consigliato è il Microsoft Surface PRO, non incluso<br />
nel pacchetto.<br />
• XVScloud<br />
I dati raccolti sul campo possono essere inviati a un<br />
server per l'elaborazione. Questo servizio restituisce<br />
nuvole di punti o mesh, che possono essere utilizzati<br />
in Cube-3d o in qualsiasi altro software di terze parti.<br />
https://www.stonex.it/it/<br />
info@stonex.it<br />
Fonte: Stonex<br />
SCANSIONE DI SITI STORICI DANNEGGIATI IN UCRAINA.<br />
UNA CASE HISTORY<br />
Teorema Milano, si occupa da 30 anni di distribuire gli<br />
strumenti di misura Leica, specializzandosi negli ultimi<br />
anni nel rilievo 3D tramite scansione laser. La rappresentazione<br />
digitale di modelli in 3D sta acquisendo sempre<br />
più importanza nel documentare i processi di costruzione<br />
di edifici. Ma non solo, con la recente guerra in Ucraina,<br />
la scansione laser permette anche di analizzare i danni a<br />
strutture ed edifici storici, per ottenere una documentazione<br />
ad uso forense e studiare meglio le modalità d’intervento.<br />
Nella primavera del <strong>2022</strong>, l'ingegnere francese e specialista<br />
di dati 3D Emmanuel Durand si trovava tra le macerie<br />
di una biblioteca per bambini ospitata in un edificio<br />
storico a Chernihiv, in Ucraina. Con lo scanner laser per<br />
imaging Leica BLK360 in mano, ha catturato attentamente<br />
la struttura danneggiata dopo che un bombardamento<br />
a marzo l'ha lasciata in rovina. Successivamente, ha elaborato<br />
le scansioni per rappresentare la scena con strati<br />
trasparenti, fornendo una prospettiva unica sull'enorme<br />
danno: le colonne e gli archi sopravvissuti si trovano accanto<br />
a muri demoliti delimitati da un cratere profondo<br />
un metro, una realtà digitale dalle dimensioni sorprendenti.<br />
Durand ha scansionato diversi siti storici danneggiati proprio<br />
come questo durante i suoi 17 giorni di permanenza<br />
in Ucraina. C'è una breve finestra di opportunità, sostiene,<br />
per documentare i danni con vividi dettagli 3D dopo<br />
la fine della distruzione, ma prima che detriti e artefatti<br />
vengano rimossi. In questo momento, non si limita a<br />
scansionare una struttura: cattura un momento significativo<br />
della sua storia.<br />
La scansione laser, ora una tecnologia consolidata per<br />
la conservazione storica, fornisce dati visivamente im-<br />
pattanti e forensi, architettonicamente e storicamente<br />
preziosi per documentare e comunicare l'impatto della<br />
guerra sui siti del patrimonio. Con un invito ufficiale del<br />
Ministero della Cultura ucraino, Durand ha viaggiato attraverso<br />
le regioni colpite dalla guerra dell'Ucraina utilizzando<br />
la scansione per catturare edifici identificati da<br />
esperti culturali, preservandoli in un momento critico nel<br />
tempo.<br />
Inizio del viaggio<br />
Durand, fondatore e proprietario di Amann Engineering<br />
con sede a Ginevra, Svizzera, è specializzato nella scansione<br />
e nell'analisi dell'integrità strutturale di siti industriali<br />
e di grandi dimensioni.<br />
Accompagnato da architetti, ingegneri ed esperti culturali<br />
nelle diverse fasi del suo viaggio, Durand si è recato a<br />
Leopoli, Kiev, Kharkiv e Chernihiv per catturare i siti del<br />
La trasparenza applicata mostra in dettaglio la devastazione di una chiesa<br />
storica a Chernihiv, compreso un cratere lasciato nel terreno.
AZIENDE E PRODOTTI<br />
Scansione laser 3D rendering di un edificio storico in Ucraina. Scansione acquisita con BLK360 G1. Rendering 3D finale di una stazione dei vigili<br />
del fuoco storica a Kharkiv.<br />
patrimonio. A partire da Lviv, è entrato a far parte degli<br />
specialisti locali di scansione 3D di Skeiron, una piccola<br />
impresa impegnata a preservare i siti culturali dell'Ucraina<br />
attraverso la scansione laser e la modellazione 3D. Insieme<br />
esaminarono la grande e ornata cattedrale di San Giorgio,<br />
dentro e fuori.<br />
"Sono intervenuto con il mio BLK360 G1 per mezza giornata<br />
e i loro tecnici hanno scansionato con un Leica ScanStation<br />
C10 e una ScanStation P20. Per me è stata come una sessione<br />
di allenamento in un ambiente abbastanza tranquillo,<br />
piacevole e sicuro”, riflette Durand. “Anche se a Lviv,<br />
ho sentito le sirene per la prima volta, suonando circa due<br />
volte al giorno. Per me è stato spaventoso, ma per la gente<br />
di Lviv questa è la quotidianità".<br />
Frontiere: scansione laser in una zona di guerra<br />
Da Lviv, il viaggio di Durand lo ha portato a Kiev, la capitale<br />
dell'Ucraina dove ha imparato rapidamente ad affrontare<br />
la routine della vita in un paese in guerra.<br />
Accolti a Kiev dagli architetti e dal direttore di un museo,<br />
il team appena formato si è recato in un villaggio a circa 40<br />
chilometri dal confine russo dove hanno dovuto richiedere<br />
un'autorizzazione speciale per entrare.<br />
La biblioteca dei ragazzi è stata la prima sede di scansione,<br />
ospitata all'interno di un edificio storico, adibito a<br />
museo.<br />
“Mi muovevo tra le macerie”, ricorda Durand, “il soffitto<br />
stava crollando, i libri volavano via dagli scaffali. La scansione<br />
si è rivelata molto complicata e per questo lo strumento<br />
da utilizzare era il BLK360. Ho scansionato dentro<br />
e fuori la biblioteca per un totale di un miliardo di punti.<br />
Il secondo giorno, Durand ha scansionato una chiesa a sud<br />
di Chernihiv. Il viaggio verso il sito, distante solo pochi chilometri,<br />
ha richiesto ore di guida poiché il ponte principale<br />
che portava al villaggio era stato distrutto.<br />
“Il sito della chiesa era molto particolare perché si trovava<br />
in un piccolo villaggio quasi deserto. È stato utilizzato<br />
come base dai russi per immagazzinare munizioni ed è ora<br />
circondato da veicoli militari russi distrutti. Nonostante la<br />
pioggia e i camion bruciati che assorbono i laser, i dati sono<br />
ancora molto buoni”.<br />
Soluzioni creative alle sfide di scansione<br />
Avventurandosi ancora di più verso il fronte, Durand e<br />
la squadra si sono recati a Kharkiv, il primo luogo in cui<br />
Durand ha sentito per la prima volta i bombardamenti in<br />
lontananza. Qui hanno scansionato tre siti, tra cui un ospedale,<br />
una stazione dei vigili del fuoco e un'università.<br />
La scansione ad alta risoluzione con diverse configurazioni<br />
in un ambiente fragile significava che ogni sito richiedeva<br />
almeno tre ore per la cattura dei dati. In alcuni casi, il<br />
grado di danno ha richiesto a Durand e al team di adottare<br />
soluzioni creative per superare le diverse difficoltà date<br />
dal muoversi in un’ambiente pericoloso.<br />
“La caserma dei vigili del fuoco era un edificio storico del<br />
1887 costruito in mattoni, in una delle parti più antiche<br />
della zona industriale. Ho utilizzato il BLK360 dalla cima di<br />
una scala idraulica di un camion dei pompieri per ottenere<br />
una sorta di acquisizione LiDAR volante a 30 metri di altezza.<br />
Ciò ha consentito di ottenere dati molto precisi del<br />
tetto, nonostante i piccoli movimenti della scala.”<br />
Durand ha anche scansionato l'edificio della Facoltà di Economia<br />
dell'Università Nazionale di Karazin nel centro della<br />
città, che è stato distrutto da un missile russo a marzo.<br />
32 ArcheomaticA N°3 settembre <strong>2022</strong>
Tecnologie per i Beni Culturali 33<br />
Il danno era così esteso che la possibilità di scansionare<br />
era limitata:<br />
“Mi sono concentrato sul cortile interno e sul tetto. Ho<br />
utilizzato il BLK360 con un'asta di prolunga che mi ha<br />
permesso di superare i tre metri di altezza. Inviando lo<br />
scanner attraverso un buco nel tetto e controllando la<br />
scansione con l'app, sono stato in grado di scansionare<br />
luoghi che altrimenti sarebbero stati troppo pericolosi."<br />
Catturare un punto di riferimento per il futuro<br />
Al suo ritorno a Kiev, Durand voleva scansionare il ponte<br />
Irpin, che era stato distrutto dall'Ucraina per fermare<br />
l'avanzata russa a ovest di Kiev. Sebbene il ponte non<br />
fosse precedentemente considerato storico, Durand ha<br />
convinto il team che si trattava di un sito che, proprio in<br />
quel momento, stava diventando un punto di riferimento<br />
significativo.<br />
"Questo è diventato un luogo molto emblematico", spiega<br />
Durand. “Hanno già deciso di tenere come simbolo<br />
questo ponte distrutto. E un uso importante di queste<br />
scansioni oggi è per la comunicazione. L'Ucraina sta già<br />
utilizzando questi dati per comunicare con il mondo e<br />
dire "guarda, questo è il danno che è stato fatto".<br />
Nuvole di punti: un ingrediente chiave per la comunicazione,<br />
la ricostruzione e la conservazione storica<br />
Sebbene le scansioni di Durand mostrino danni significativi,<br />
alla fine le vede come un ingrediente nel più ampio processo<br />
di ricostruzione e commemorazione culturale in Ucraina.<br />
"La scansione laser porta una luce, un'angolazione e una<br />
prospettiva diverse ad una scena particolare, qualcosa<br />
che prima non esisteva", spiega Durand. “Ad esempio, la<br />
semplice applicazione della trasparenza ad una nuvola<br />
di punti consente alle persone di avere immediatamente<br />
una maggiore percezione del danno, come con il cratere<br />
nella biblioteca dei bambini. E questo non è disponibile<br />
attraverso una sola fotografia.<br />
“Quello che ho fatto in Ucraina è davvero un primo passo.<br />
Produrre nuvole di punti è come fare la farina: è un<br />
ingrediente chiave che altri useranno per cuocere una<br />
varietà di cose. A breve termine, questi possono essere<br />
utilizzati per la comunicazione, per sostenere l'attenzione<br />
sull'Ucraina e collegarli a risorse di istituzioni<br />
internazionali, sovvenzioni per lavori di conservazione e<br />
ricostruzione".<br />
“A lungo termine”, continua Durand, “questi dati possono<br />
essere utilizzati per indagini forensi e gli architetti<br />
possono utilizzarli come base per le ricostruzioni. Anche<br />
queste scansioni diventeranno parte della storia”.<br />
"Quello che stiamo facendo con la scansione dà una profondità<br />
e una dimensione diversa alla rappresentazione<br />
di ciò che è accaduto in Ucraina", riassume Durand. “In<br />
un certo senso fa ben sperare, perché è già un passo<br />
avanti verso la ricostruzione”.<br />
info@geomatica.it - www.geomatica.it<br />
Fonte: Teorema<br />
Time to THE FUSION !<br />
BLK2GO & X-PAD OFFICE FUSION<br />
3D scanning and data processing<br />
are now simpler than ever.<br />
GeoMax provides the solution to increase your efficiency and accuracy.<br />
BLK2GO, a handheld 3D imaging scanner, captures models and point clouds and<br />
X-PAD OFFICE FUSION, GeoMax geodata office software, processes them in a few clicks.<br />
©<strong>2022</strong> Hexagon AB and/or its<br />
subsidiaries and affiliates.<br />
All rights reserved.<br />
Part of Hexagon<br />
Works when you do<br />
GEOJUI22-210x148-BLK-X_Pad.indd 2 07/07/<strong>2022</strong> 17:40
AGORÀ<br />
Gemello digitale 3D: Chiesa di<br />
San Michele Arcangelo – La sperimentazione<br />
presentata costituisce<br />
la prima fase di una ricerca<br />
interdisciplinare finalizzata alla<br />
codificazione di procedure di<br />
controllo e analisi non distruttiva<br />
dello stato di conservazione di<br />
manufatti del patrimonio culturale<br />
per orientare azioni di conservazione<br />
preventiva.<br />
Lo studio è coordinato dal prof.<br />
Massimiliano Campi, dalla prof.<br />
ssa Antonella di Luggo e dall’arch.<br />
Valeria Cera del Dipartimento di<br />
Architettura dell’Università degli<br />
Studi di Napoli Federico II,<br />
nell’ambito dell’Accordo di Collaborazione<br />
Scientifica tra il Centro<br />
Interdipartimentale di Ricerca<br />
Urban\Eco della Federico II e<br />
la Diocesi di Teggiano-Policastro,<br />
nella figura del Vicario Generale,<br />
Don Giuseppe Radesca.<br />
L’indagine è stata condotta sulla<br />
chiesa di San Michele Arcangelo<br />
a Padula interessata da fenomeni<br />
di distacco dell’intonaco di alcuni<br />
affreschi del 1954, localizzati<br />
all’intradosso dei sistemi voltati,<br />
dai quali risultano ora visibili le<br />
tracce di pitture antecedenti.<br />
Il lavoro è stato condotto con il<br />
supporto dell’azienda MicroGeo,<br />
Acquisizione delle immagini termiche e processamento dei dati integrati.<br />
coinvolta allo scopo di relazionare<br />
le componenti morfo-metriche<br />
acquisite con tecniche di rilievo<br />
strumentale ad aspetti cognitivi<br />
e tecnici quali dati microclimatici,<br />
termici, materici e di scostamento<br />
geometrico, al fine di<br />
rendere il modello tridimensionale<br />
del rilievo architettonico un<br />
supporto per la simulazione di<br />
scenari connessi a programmi di<br />
prevenzione conservativa.<br />
Per tale motivo, dopo aver effettuato<br />
un rilievo TLS con un Faro<br />
Focus3D X330 della chiesa, sono<br />
state acquisite informazioni di<br />
dettaglio delle parti ammalorate<br />
degli affreschi attraverso un rilievo<br />
con termocamera.<br />
Impiegando una camera termica<br />
TESTO890, sono state scattate<br />
immagini termiche e, allo stesso<br />
tempo, sono state registrate<br />
anche fotografie nel campo del<br />
visibile con una camera reflex<br />
CanonEos1300D collocata sullo<br />
stesso treppiede in modo da far<br />
coincidere i centri ottici dei due<br />
sensori nella fase di processamento.<br />
All’interno del software<br />
3DF Zephyr, sono stati dapprima<br />
orientati e processati i fotogrammi<br />
reflex. Sfruttando la coincidenza<br />
dei centri ottici, sono<br />
state selezionate poi le immagini<br />
termiche come origine del dato.<br />
A partire dalla nuvola densa precedentemente<br />
ricostruita, le<br />
informazioni sul comportamento<br />
termico delle superfici sono<br />
state proiettate sui singoli punti<br />
della nuvola ottenendo un modello<br />
3D discreto in cui per ogni<br />
punto alla posizione nello spazio<br />
risulta aggregato anche il valore<br />
di temperatura e il dato di colore.<br />
Con riferimento alla cupola di<br />
copertura del transetto, l’analisi<br />
degli stati termici ha evidenziato<br />
la presenza di 4 aree fredde<br />
discendenti dalla lanterna verso<br />
l’imposta, con una temperatura<br />
più bassa (di 0.8 o 1.9 gradi a<br />
seconda della stagione) rispetto<br />
alle zone circostanti.<br />
La lettura incrociata dei dati termici<br />
con quelli geometrici e fotografici<br />
ha restituito l’insistenza<br />
di una condizione patologica<br />
di forte umidità in 4 spicchi che<br />
sono molto più estesi rispetto<br />
alle parti che visivamente risultano<br />
intaccate.<br />
Una ispezione visiva condotta<br />
all’estradosso, ha consentito in<br />
effetti di ricondurre tali porzioni<br />
ai punti liberi della superficie<br />
della cupola, non interessati<br />
dall’intersezione con il sistema<br />
di copertura dell’aula e del<br />
transetto. Qui, in effetti, non<br />
era presente una adeguata coibentazione,<br />
oggi messa in opera.<br />
Grazie quindi ai dati provenienti<br />
dalla termocamera è stata ravvisata<br />
la presenza di umidità<br />
che non è visibile in superficie<br />
e, per questo, da monitorare<br />
per ovviare alla manifestazione<br />
di ulteriori fenomeni di degrado,<br />
comportanti distacchi di intonaco<br />
in aree più grandi.<br />
Chiaramente, le analisi e le relative<br />
valutazioni critiche definiscono<br />
la base di partenza<br />
per indirizzare alcune azioni di<br />
intervento diretto e, al tempo<br />
34 34 ArcheomaticA N°3 settembre <strong>2022</strong>
Tecnologie Tecnologie per per i Beni i Beni Culturali Culturali<br />
35<br />
stesso, orientare le scelte più<br />
opportune per successivi approfondimenti<br />
diagnostici, più ristretti<br />
e mirati, riducendo i danni<br />
al patrimonio storico.<br />
Questa fase di progetto ha visto<br />
il supporto degli arch. Michele<br />
Sanseviero, Alessandro Cancellaro<br />
e Marika Falcone nonché il<br />
contributo degli architetti Giovanni<br />
Angrisani e Lorenzo Bisceglia.<br />
Il lavoro è stato, inoltre, condotto<br />
con la competente collaborazione<br />
di Michele Cirignano e il<br />
sostegno dell’azienda MicroGeo<br />
che si ringraziano per aver messo<br />
a disposizione della ricerca la<br />
termocamera TESTO890 e il software<br />
3DF Zephyr per il processamento<br />
dei dati.<br />
Per ulteriori approfondimenti,<br />
si rimanda alla lettura di alcuni<br />
contributi scientifici:<br />
Cera Valeria (<strong>2022</strong>). Multisensor<br />
Data Fusion for Cultural Heritage<br />
Assets Monitoring and Preventive<br />
Conservation. ISPRS International<br />
Archives of the Photogrammetry,<br />
Remote Sensing and Spatial<br />
Information Sciences, XLVI-2/<br />
W1-<strong>2022</strong>, pp.151-157. https://<br />
doi.org/10.5194/isprs-archives-<br />
Fig. 3 - A partire da sinistra: Manipolazione delle mappe di riflettanza ottenute dal rilievo TLS (a,b).<br />
Variando il range dei valori percentuali (c) è possibile estrarre progressivamente informazioni significative<br />
per le porzioni di affresco danneggiate. Centro: Mappa di riflettanza e classificazione del colore<br />
per le porzioni di affresco danneggiato. Le variazioni evidenziano porzioni con caratteristiche<br />
disomogenee e incoerenti. Destra: Modello del comportamento termico della cupola. I grafici estratti<br />
evidenziano la presenza di 4 aree più fredde e le loro variazioni di temperatura.<br />
XLVI-2-W1-<strong>2022</strong>-151-<strong>2022</strong>, <strong>2022</strong>.<br />
Cera Valeria (2021). La manipolazione<br />
di modelli discreti per<br />
orientare l'indagine diagnostica<br />
per il restauro. In Rosa Anna Genovese<br />
(Ed.), Il patrimonio culturale<br />
tra la transizione digitale, la<br />
sostenibilità ambientale e lo sviluppo<br />
umano. Cultural Heritage<br />
in digital transition, environmental<br />
sustainability and human development,<br />
pp. 167-190. Napoli:<br />
Giannini Editore. ISBN 978-88-<br />
6906-196-7.<br />
Documentazione e Preservazione<br />
del Patrimonio Culturale - SIM-<br />
POSIO CIPA 2023 – Il Patrimonio<br />
culturale nella sua accezione più<br />
estesa è l’espressione più alta della<br />
creatività umana. Gli effetti del<br />
cambiamento climatico, i conflitti<br />
armati, le distruzioni per terrorismo<br />
costituiscono un rischio per<br />
la sua conservazione. Il tema delle<br />
minacce antropiche interseca<br />
quello dei rischi naturali e ambientali.<br />
Passati equilibri si sono rotti,<br />
paesaggi estremi si profilano all’orizzonte<br />
e risposte efficaci tardano<br />
ad arrivare.<br />
La comunità scientifica può e deve<br />
reagire a questo stato di cose.<br />
L’approccio umanistico, inclusivo<br />
di tanti saperi, ci rende capaci di<br />
comprendere, di interpretare e<br />
di preservare il Patrimonio che la<br />
storia ci ha consegnato. Le tecnologie<br />
digitali forniscono contributi<br />
innovativi sia per la conservazione,<br />
il restauro, la riqualificazione,<br />
la fruizione dei siti e sia per il più<br />
ampio spettro dell’economia della<br />
cultura. Il Patrimonio culturale è<br />
dunque materia di nuove narrazioni,<br />
esperienze condivise, luoghi di<br />
incontro e conoscenza del passato,<br />
per interpretare e riflettere sull’evoluzione<br />
della nostra società rispetto<br />
alle sfide globali.<br />
Dal 25 al 30 giugno 2023 a Firenze<br />
avrà luogo il Simposio<br />
Documenting, Understanding, Preserving<br />
Cultural Heritage
AGORÀ<br />
Humanities and digital technologies<br />
for shaping the future<br />
promosso e organizzato da CIPA -<br />
Heritage Documentation.<br />
Il Simposio CIPA 2023 intende unire<br />
competenze scientifiche, tecnologiche<br />
e umanistiche e promuovere<br />
le interazioni con le istituzioni<br />
preposte alla conservazione e al<br />
restauro, con l'obiettivo di definire<br />
sistemi di documentazione che<br />
affrontino l'intero ciclo di vita di<br />
manufatti, siti archeologici, edifici<br />
storici e paesaggi, utilizzando le<br />
nuove tecnologie digitali.<br />
È necessario sviluppare modelli<br />
di riduzione del rischio e di conservazione<br />
preventiva sostenibile<br />
del Patrimonio che supportino la<br />
partecipazione, l'accessibilità e la<br />
valorizzazione delle diversità per<br />
favorire le condizioni per il progresso<br />
sociale, economico e culturale<br />
delle comunità e dei territori<br />
in cui esse vivono.<br />
CIPA - Heritage Documentation è<br />
un’organizzazione internazionale<br />
no-profit che si propone di facilitare<br />
il trasferimento tecnologico<br />
dalle scienze della misura alle discipline<br />
della documentazione del<br />
patrimonio. CIPA - HD è uno dei<br />
primi comitati scientifici internazionali<br />
di ICOMOS (International<br />
Council of Monuments and Sites)<br />
ed è stata fondata nel 1968 congiuntamente<br />
da ICOMOS e ISPRS<br />
(International Society for Photogrammetry<br />
and Remote Sensing).<br />
La comunità tecnico-scientifica<br />
che fa riferimento a CIPA-HD si<br />
riunisce ogni due anni in simposi<br />
che sono occasione di incontro,<br />
confronto, aggiornamento sui temi<br />
della documentazione e conservazione<br />
del patrimonio culturale,<br />
con un’attenzione particolare rivolta<br />
alle nuove tecnologie.<br />
I principali argomenti del CIPA2023<br />
saranno:<br />
• Patrimonio e Conservazione Digitale<br />
• Valutazione del Rischio per il<br />
Patrimonio Culturale<br />
• Documentare i Siti Archeologici<br />
• Documentare l'Architettura Moderna<br />
• Documentare il Patrimonio Subacqueo<br />
• Realtà Virtuale, Aumentata ed<br />
Estesa per i Beni Culturali<br />
• Esperienze di Formazione sulla<br />
Documentazione del Patrimonio<br />
• Tecnologie che cambiano la<br />
Formazione<br />
• Intelligenza Artificiale e Documentazione<br />
dei Beni Culturali<br />
• Monitoraggio del Patrimonio<br />
Costruito<br />
• Nuove Tecnologie per l'Accessibilità<br />
nei Nuovi Musei<br />
• Tecnologie Digitali per contrastare<br />
le Distruzioni Belliche<br />
• Riproduzione 3D dei Beni Culturali:<br />
Tecniche e Metodi<br />
• Tecnologia 3D a supporto<br />
dell'attività di Gestione e Manutenzione<br />
del Patrimonio<br />
• Conservazione Virtuale<br />
• Gemelli Digitali<br />
• Condivisione delle Informazioni<br />
e dei Dati<br />
Sessioni speciali saranno dedicate<br />
a GEORES e ARQUEOLÓGICA 2.0.<br />
Atti del Simposio<br />
I contributi che avranno superato<br />
il processo di peer review saranno<br />
pubblicati in “The International<br />
Archives of the Photogrammetry,<br />
Remote Sensing and Spatial Information<br />
Sciences” e in “ISPRS Annals<br />
of the Photogrammetry, Remote<br />
Sensing and Spatial Information<br />
Sciences”. La piattaforma per<br />
inviare i propri contributi è disponibile<br />
al seguente link: https://<br />
www.conftool.org/cipa2023florence/.<br />
Maggiori informazioni sono<br />
riportate nella pagina del sito web<br />
dell’evento.<br />
Gli autori di lavori selezionati saranno<br />
invitati a presentare una<br />
versione estesa dei loro articoli in<br />
Special Issues di riviste collegate<br />
alla Conferenza (es. Applied Geomatics,<br />
Ananke, Sensors, Virtual<br />
Archaeology Review, etc.).<br />
Registrazioni<br />
La piattaforma per le registrazioni<br />
è disponibile al seguente<br />
link: https://services.aimgroup.<br />
eu/ASPClient/loginindividual.<br />
asp?eventoid=5077 Maggiori informazioni<br />
sulle tariffe disponibili e<br />
sulle scadenze sono riportate nella<br />
pagina dedicata del sito web.<br />
CIPA Spring School<br />
In continuità con la realizzazione<br />
del Simposio, l’ottava edizione<br />
della Spring School del CIPA si svolgerà<br />
a Montecatini Terme, dal 23<br />
al 29 Marzo 2023 dal titolo<br />
3D Surveying and Modeling of Cultural<br />
Heritage<br />
Lezioni teoriche (rilievo 3D, fotogrammetria,<br />
laser scanner, fotografia,<br />
ecc.) si alterneranno ad attività<br />
di acquisizione sul campo e<br />
di elaborazione dei dati in aula. La<br />
Spring School rappresenta un'opportunità<br />
per studenti di corsi di<br />
laurea magistrale, dottorandi di<br />
ricerca, ricercatori e specialisti<br />
nei settori dell’archeologia, architettura,<br />
restauro, conservazione,<br />
geomatica, e in generale nella documentazione<br />
del patrimonio per<br />
approfondire le proprie conoscenze<br />
e competenze con tecniche di<br />
modellazione 3D basate sulla realtà.<br />
Montecatini Terme rappresenta<br />
un caso studio ideale, in quanto<br />
è una delle “Grandi città termali<br />
d’Europa” iscritte nel Patrimonio<br />
mondiale UNESCO.<br />
Maggiori informazioni su: https://<br />
www.cipa2023florence.org/cipaspring-school<br />
36 ArcheomaticA N°3 settembre <strong>2022</strong>
Tecnologie per i Beni Culturali 37<br />
Sede in Italia<br />
Più di 100 distributori nel mondo<br />
Una linea di prodotti Made in Italy<br />
Dove siamo Chiamaci Contattaci<br />
Seguici sui Social<br />
Viale dell’Industria 53<br />
20037, Paderno Dugnano (MI)<br />
Tel. +39 02 78619201<br />
www.stonex.it<br />
info@stonex.it - italia@stonex.it
EVENTI<br />
19 - 21 APRILE 2023<br />
XII Congresso Nazionale AIAr<br />
Messina (Italia)<br />
http://www.associazioneaiar.<br />
com/<br />
20-23 MARZO 2023<br />
3rd International Conference<br />
TMM-CH Transdisciplinary<br />
Multispectral Modelling and<br />
Cooperation for the<br />
Preservation of Cultural<br />
Heritage<br />
Atene (Grecia) – Eugenides<br />
Foundation<br />
https://tmm-ch.com/#about<br />
10 – 11 MAGGIO 2023<br />
Conferenza Esri Italia<br />
Roma<br />
https://www.esriitalia.it/<br />
10 – 12 MAGGIO 2023<br />
Restauro – Salone<br />
Internazionale dei Beni<br />
Culturali e Ambientali<br />
XXVIII edizione<br />
Ferrara Fiere (Italia)<br />
https://www.<br />
salonedelrestauro.com/<br />
24 – 26 MAGGIO 2023<br />
MMT 2023 – 12th International<br />
Symposium on Mobile<br />
Mapping Technology<br />
Padova (Italia)<br />
https://www.cirgeo.unipd.<br />
it/mmt/<br />
25 - 30 GIUGNO 2023<br />
SIFET 2023<br />
Firenze (Italia)<br />
https://www.sifet.org/<br />
25 - 30 GIUGNO 2023<br />
CIPA 2023<br />
Firenze (Italia)<br />
https://www.<br />
cipa2023florence.org/<br />
SETTEMBRE 2023<br />
ArcheoFOSS 2023<br />
Torino (Italia)<br />
https://www.archeofoss.org/<br />
28 – 29 SETTEMBRE 2023<br />
LUBEC 2023<br />
Lucca (Italia)<br />
https://www.lubec.it/<br />
11 - 13 OTTOBRE 2023<br />
INTERGEO<br />
Berlino (Germania)<br />
https://www.intergeo.de/en/<br />
11 - 13 OTTOBRE 2023<br />
DRONITALY<br />
Bologna (Italia)<br />
https://www.dronitaly.it<br />
2 – 5 NOVEMBRE 2023<br />
BMTA PAESTUM 2023<br />
Paestum, SALERNO (Italia)<br />
https://www.<br />
borsaturismoarcheologico.it/<br />
NOVEMBRE 2023<br />
ROMADRONE<br />
Roma (Italia)<br />
https://www.romadrone.it/<br />
10 – 11 maggio<br />
2023<br />
ROMA<br />
38 ArcheomaticA N°3 settembre <strong>2022</strong><br />
www.esriitalia.it
Tecnologie per i Beni Culturali 39<br />
Ogni oggetto, ogni luogo, ogni gesto<br />
racconta l'emozione di una storia<br />
hubstract.org<br />
Hubstract - made for art è uno studio creativo: autori digitali, videomakers, designers e storytellers<br />
realizzano percorsi di visita, allestimenti, eventi e contenuti combinando le nuove tecnologie e i<br />
linguaggi digitali alle esperienze tradizionali.<br />
hubstract.madeforart<br />
hubstract<br />
hubstract