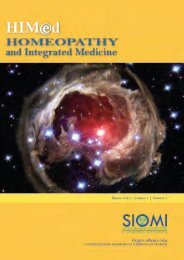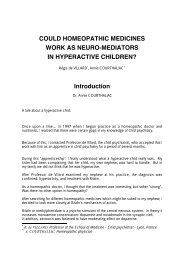HIMed - Anno 3, numero 2 - Novembre 2012 - SIOMI
HIMed - Anno 3, numero 2 - Novembre 2012 - SIOMI
HIMed - Anno 3, numero 2 - Novembre 2012 - SIOMI
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
L’evoluzione dell’idea di tipo in omeopatia<br />
Luigi Turinese<br />
Medico esperto in omeopatia, psicoterapeuta<br />
E-mail: turiness@tin.it<br />
Benché qualcuno creda ancora il contrario, in tutta<br />
la sua attività teorica e clinica Hahnemann non<br />
parve mai interessato a percorrere una via costituzionalistica<br />
o tipologica. Certo, la necessità di studiare<br />
la totalità dei sintomi dei pazienti per meglio stabilire i<br />
criteri di similitudine lo spingeva verso la nozione di globalità,<br />
ma egli non andò mai oltre la segnalazione che<br />
presso certe fisiologie e certi temperamenti fosse più probabile<br />
ritrovare i segni di richiamo di un certo rimedio<br />
piuttosto che di un altro.<br />
L'evoluzione successiva dell'omeopatia, tuttavia, sembra<br />
andare spontaneamente verso l'elaborazione di una medicina<br />
di terreno. Questa tendenza trapela persino nel<br />
linguaggio, se ancora oggi si parla di soggetto psorico, di<br />
paziente sicotico, e così via, quando si dovrebbe più correttamente<br />
affermare che nel tal paziente si manifestano<br />
segni del modello reattivo psorico, del modello reattivo<br />
sicotico, e così via: un modello reattivo, infatti, non è un<br />
tipo, ma uno dei modi - tipologicamente orientati, certo<br />
- di cui ciascun individuo dispone per reagire nelle fasi<br />
di rottura del suo equilibrio fisiologico. Proviamo a ricostruire<br />
le tappe salienti dell'assimilazione del linguaggio<br />
tipologico all'interno del costrutto omeopatico.<br />
Una ventina d'anni dopo la morte di Hahnemann,<br />
Grauvogl descrive tre costituzioni, che sarebbe meglio<br />
definire stati biochimici, in rapporto ai quali classifica i<br />
rimedi omeopatici:<br />
< costituzione idrogenoide, corrispondente ad uno<br />
stato di iperidratazione tissutale;<br />
< costituzione ossigenoide, presso la quale le ossigenazioni<br />
sono in eccesso, per un'esagerazione del catabolismo;<br />
< costituzione carbonitrogena, caratterizzata all'opposto<br />
da insufficiente di ossidazione e da ritenzione azotata.<br />
Influenzato da Grauvogl, all'inizio del '900 il medico<br />
svizzero Antoine Nebel (1870-1954) descrive tre costituzioni<br />
minerali di base correlate ai sali di calcio dello<br />
scheletro.<br />
< Costituzione carbocalcica, normocrinica, capace di<br />
buona resistenza alla tubercolosi. Comprende soggetti<br />
brevilinei, con arcate dentarie regolari, denti quadrati,<br />
articolazioni piuttosto rigide e forti. Il carattere è<br />
calmo ed equilibrato.<br />
< Costituzione fosfocalcica, ipercrinica, poco resistente<br />
alla tubercolosi. Raggruppa soggetti longilinei, dal palato<br />
ogivale, con denti rettangolari presto cariati, dal<br />
torace stretto, predisposti alla cifosi, astenici e nervosi.<br />
CONTRIBUTI ORIGINALI<br />
< Costituzione fluorocalcica, ipocrinica, molto resistente<br />
alla tubercolosi. La morfologia è variabile, ma<br />
è sempre segnata da iperlassità legamentosa: ne conseguono<br />
scoliosi, articolazioni lasse e, a carico degli<br />
organi interni, ptosi viscerali; sono frequenti le varici.<br />
I denti sono piccoli e malocclusi. Il carattere è improntato<br />
a una certa instabilità.<br />
Le caratteristiche delle tre costituzioni minerali di base<br />
sono correlate con le patogenesi dei tre sali di calcio dello<br />
scheletro: Calcarea carbonica, Calcarea phosphorica e<br />
Calcarea fluorica.<br />
Léon Vannier (1880-1963) riprende la classificazione di<br />
Nebel, semplificandone la terminologia (le tre costituzioni<br />
diventano la carbonica, la fosforica e la fluorica) e<br />
precisando che "il fosforico è sempre un eredo-tubercolare,<br />
il fluorico un eredo-sifilitico" (Vannier, 1928: 55-<br />
56). La classificazione di Nebel e Vannier, ancora in auge<br />
in Francia e ripresa anche in opere recenti, ha il difetto<br />
non marginale di trascurare l'antropometria. Difatti ogni<br />
classificazione costituzionale che si rispetti deve postulare<br />
un tipo che rappresenta la norma statistica, rispetto al<br />
quale gli altri soggetti rappresentano appunto deviazioni<br />
dalla norma. Non ha senso parlare di brevilineo e di longilineo<br />
se non in rapporto ad un normolineo. A questo<br />
difetto, tanto grave da porre, secondo me, la classificazione<br />
di Nebel e Vannier al di fuori dell'evoluzione delle<br />
classificazioni costituzionali compiute, pone rimedio<br />
Henry Bernard in lavori scritti a cavallo tra gli anni '40<br />
e gli anni '50 (Bernard, 1951/1985). In questi lavori Bernard<br />
mette al centro della sua classificazione una costituzione<br />
sulfurica, facendone la costituzione più<br />
equilibrata o quanto meno quella in grado di difendersi<br />
meglio, dato che il rimedio di base che la rappresenta,<br />
Sulphur, descrive uno stato di eccellente reattività biologica.<br />
Mostrando un grande acume clinico, Bernard distingue<br />
tre sottotipi sulfurici: un tipo tanto equilibrato<br />
da poter essere considerato un tipo canonico di riferimento<br />
(sulfurico neutro), pressoché impossibile a riscontrarsi<br />
in pratica; e due tipi sulfurici per così dire<br />
"laterali": l'uno le cui caratteristiche lo accostano alla costituzione<br />
carbonica e che Bernard denomina sulfurico<br />
grasso; l'altro che viceversa trae rapporti con la costituzione<br />
fosforica e che per questo viene denominato sulfurico<br />
magro. Si può comprendere come in questo schema<br />
non ci sia posto per una casella fluorica autonoma; difatti<br />
Bernard, pur conservando con molto buon senso un legame<br />
con la tradizione, "declassò" la costituzione fluorica,<br />
che divenne una costituzione mista, apportante una<br />
nota distrofica più o meno accentuata ai tipi costituzionali<br />
di base.<br />
8 HOMEOPATHY AND INTEGRATED MEDICINE | novembre <strong>2012</strong> | vol. 3 | n. 2