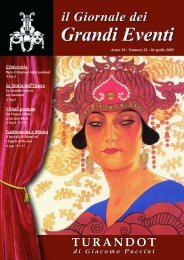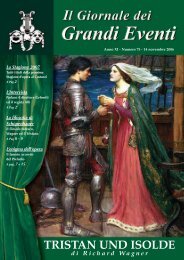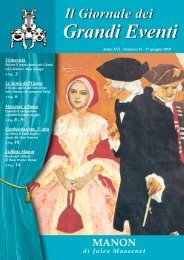Impaginato Pipistrello - Il giornale dei Grandi Eventi
Impaginato Pipistrello - Il giornale dei Grandi Eventi
Impaginato Pipistrello - Il giornale dei Grandi Eventi
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
12 <strong>Il</strong> <strong>Pipistrello</strong> <strong>Il</strong><br />
Das Fledermaus di<br />
Haffner e Genée<br />
è tratto dal vaudeville<br />
Le rèveillon (<strong>Il</strong> veglione)<br />
di Meilhac e<br />
Halévy, rappresentato al<br />
Palais Royal di Parigi il<br />
10 settembre 1872.<br />
Ripercorrendo la genesi<br />
del vaudeville troviamo<br />
che nel XV secolo questo<br />
era un genere di poesia<br />
satirica - diffusa nella<br />
Francia occidentale -<br />
leggera e licenziosa, di<br />
tono sagace, che si scagliava<br />
contro i costumi e<br />
i vizi di ogni rango sociale,<br />
le cui strofe venivano<br />
liberamente intonate<br />
su melodie popolari<br />
preesistenti. Tale forma<br />
si diffuse nel Settecento,<br />
entrando nei teatri<br />
come sezione cantata,<br />
alternata alle parti recitate<br />
del teatro leggero.<br />
Ciò fu permesso dal fatto<br />
che si trattava di canzoni<br />
semplici, eseguibili<br />
anche da attori non musicisti.<br />
Col tempo il vocabolo<br />
finì per indicare<br />
non più le sole canzoni,<br />
ma l’intera rappresentazione.<br />
L’etimologia del termine<br />
risale al XIV secolo. Nella<br />
città di Vire, sulle<br />
sponde dell’omonimo<br />
fiume che scorre tra le<br />
colline della Normandia,<br />
viveva una comunità<br />
di compagnons gallois,<br />
che usavano annotare<br />
le loro melodie, come<br />
le canzoni delle vaux de<br />
Vire cioè delle valli del<br />
Vire. <strong>Il</strong> mutare della forma,<br />
da vaudevire a vaudeville,<br />
dipese sia dall’im-<br />
precisione della trasmissione<br />
orale, che dalla<br />
coincidenza per cui nel<br />
Cinquecento furono pubblicate<br />
raccolte di canzoni<br />
intitolate voix de ville, a<br />
sottolinearne l’origine<br />
popolare piuttosto che<br />
cortigiana.<br />
Arie semplici<br />
ma eleganti<br />
Si trattava di arie molto<br />
semplici, che si potevano<br />
cantare a una voce, prive<br />
di accompagnamento o,<br />
al massimo, con un’armonizzazioneelementare.<br />
Forme musicali quasi<br />
sempre costruite su un<br />
ritmo di danza (minuetto,<br />
gavotta o simili), senza<br />
rispettarne fedelmente<br />
lo schema, ma con cadenza<br />
alla fine di ogni<br />
sezione. La melodia era<br />
costruita su note ribattute<br />
e piccoli salti, priva di<br />
modulazioni (eccetto<br />
passaggi alla dominante<br />
o alla relativa maggiore)<br />
e in assenza di uno sviluppo<br />
agogico. Si trattava<br />
dunque di disegni<br />
melodici orecchiabili e<br />
senza note sostenute, caratterizzati<br />
da un forte<br />
senso ritmico. L’apparente<br />
elementarità rivelava<br />
però toni eleganti,<br />
finemente racchiusi nella<br />
geniale concisione aforistica.<br />
<strong>Il</strong> teatro comico francese<br />
di Sette-Ottocento ricorse<br />
per primo all’uso di<br />
tali canzoni finché, nella<br />
metà del XIX secolo i<br />
canti scomparvero, ma<br />
restò la definizione per<br />
indicare uno spettacolo<br />
teatrale di prosa basato<br />
su una comicità ricca di<br />
equivoci,<br />
scambi, battute<br />
salaci ed<br />
allusive. In<br />
voga nel Settecento,<br />
il genere<br />
dominò<br />
Parigi, ma<br />
approdò<br />
ovunque e<br />
visse una<br />
straordinaria<br />
fortuna fra<br />
Otto e Novecento<br />
grazie<br />
ai suoi massimi<br />
esponenti,<br />
Eugène Labiache<br />
(1815<br />
– 1888) e<br />
Georges Feydeau<br />
(1862<br />
–1921), geniali<br />
per trovate<br />
e situazioni.<br />
Quando<br />
ancora ai<br />
dialoghi si<br />
alternava<br />
la musica,<br />
di tono popolare,<br />
era<br />
uso che gli<br />
attori intonassero<br />
quelle<br />
semplici<br />
strofette<br />
cantate,<br />
quei couplets<br />
che,<br />
conquistato<br />
il campo,daranno<br />
vita all’operetta,<br />
che invece<br />
svilupperà<br />
solo le sezionimusicali<br />
di quel teatro popolare<br />
di prosa.<br />
<strong>Il</strong> vaudeville è una commedia<br />
agile e scanzonata<br />
che, se nelle origini era<br />
ricca di numeri di canto,<br />
eliminate le parti musicali,<br />
si caratterizza per<br />
una spiccata comicità,<br />
dal ritmo veloce e ricco<br />
di colpi di scena: un artificio<br />
teatrale, costruito di<br />
solito a più mani, con<br />
una struttura narrativa<br />
fragile, finanche pretestuosa.<br />
Teatro teatrale,<br />
insomma, che non rispetta<br />
la letteratura o la<br />
Giornale <strong>dei</strong> <strong>Grandi</strong> <strong>Eventi</strong><br />
Generi e forme<br />
<strong>Il</strong> Vaudeville, antenato dell’operetta<br />
Segue intervento da pag. 1<br />
sempre più entrato nel DNA degli austriaci<br />
e <strong>dei</strong> popoli di quello che fu il<br />
grande Impero asburgico, divenendone<br />
un elemento fondamentale della cultura<br />
e dell’identità.<br />
Così se Strauss è sinonimo di valzer, valzer<br />
è sinonimo di Vienna. Ma non solo<br />
di una Vienna Imperiale di 150 anni fa,<br />
ma anche nella Vienna di oggi. Chi non<br />
conosce il concerto di Capodanno dalla<br />
Sala d’Oro del Musikverein che rimane<br />
una delle trasmissioni televisive più seguite<br />
a livello mondiale? Un concerto<br />
inimmaginabile senza i valzer, senza le<br />
melodie degli Strauss.<br />
Les Grands Boulevards et Théâtre du Vaudeville in un quadro di Antoine Blanchard<br />
La musica, il più bello e suadente mezzo<br />
di comunicazione, è di conseguenza<br />
divenuta anche uno straordinario veicolo<br />
per la promozione turistica, un veicolo<br />
universale: senza parole, senza traduzioni<br />
tutti capiscono. Ed una musica<br />
così nota, così tipica come il valzer, è immediatamente<br />
identificabile con l’Austria,<br />
e con la città di Vienna. Un elemento<br />
ormai indispensabile a tutta l’attività<br />
di promozione turistica, la splendida<br />
ed elegantissima cornice di ogni<br />
manifestazione che guarda al mito dell’Austria<br />
Felix.<br />
Radbot d’Asburgo Lorena<br />
Arciduca d’Austria<br />
già Direttore del Turismo Austriaco a Roma<br />
Théâtre du Vaudeville<br />
filosofia, ma mira solo a<br />
costruire complicate e<br />
precise macchine narrative,<br />
quasi congegni ad<br />
orologeria, giochi di<br />
porte che consentono<br />
una giostra di personaggi,<br />
scambi, equivoci<br />
e veloci colpi di scena<br />
per sorprendere e divertire<br />
il pubblico. La<br />
sua assoluta teatralità<br />
fa sì però che i personaggi<br />
non posseggano<br />
profondità psicologica,<br />
sono delle maschere<br />
con ruoli fissi, privi di<br />
evoluzione.<br />
La nascita di questo genere<br />
è quindi da ascriversi<br />
all’esigenza di svago<br />
ed alla volontà di rivincita<br />
del teatro popolare<br />
della Francia rivolu-<br />
zionaria se pensiamo<br />
che, dopo la legge sulla<br />
libertà <strong>dei</strong> teatri, due attori<br />
di vaudeville, Piis e<br />
Barré, aprirono in rue de<br />
Charter una sala deputata<br />
a questo genere, la cui<br />
vivace comicità era capace<br />
di illuminare gli<br />
animi scuriti dalla crisi<br />
<strong>dei</strong> tempi, democratizzando<br />
la tradizione scenica.<br />
Insomma non è un<br />
caso se il Théâtre du Vaudeville<br />
aprì i battenti nella<br />
sanguinosa Parigi del<br />
1792!<br />
Stefania Soldati