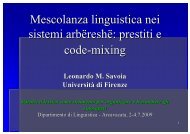germanismi editi e inediti nel codice diplomatico longobardo
germanismi editi e inediti nel codice diplomatico longobardo
germanismi editi e inediti nel codice diplomatico longobardo
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
220<br />
Giovanna Princi Braccini<br />
appartiene poi la glossa guelch che sui margini del manoscritto della British Library,<br />
Harleianus 2719 (sec. IX-X), ha apposto a strabones del I Libro del De compendiosa<br />
doctrina di Marcello Nonio il secondo correttore (H3), forse di provenienza brettone62 .<br />
Per l’italiano si cita come prima emersione alla luce di guercio la sua presenza <strong>nel</strong>la forma<br />
guelcus / guelca <strong>nel</strong> Catholicon di Giovanni da Genova (ante 1286): “Petus i. Guelcus,<br />
strabo aliquantulum, scilicet cujus oculi quadam velocitate cito volvuntur huc illuc: et hæc<br />
peta, i. Guelca, et aliquantulum straba”. Segue di lì a poco la forma corrente (Dante, Francesco<br />
da Barberino e altri). A mezza strada fra il nostro inquircio e il guelcus di Giovanni<br />
da Genova si pone il guercius di Braida Guercii, che è l’odonimo con cui in un documento<br />
del 1099 viene indicata la contrada di Milano corrispondente all’attuale Via Brera63 .<br />
La matrice di guercio è a tutt’oggi controversa, fra origine latina (un latino ricostruito:<br />
*ex-versiare, *euersus ) e germanica. È stato infatti proposto il gotico þwairhs ‘incollerito,<br />
collerico’ (col sostantivo þwairhei ‘ira, contesa’) o la forma corrispondente del <strong>longobardo</strong>.<br />
Dal punto di vista del significato l’etimo germanico non sembra essere obbiettabile:<br />
i corrispondenti antico inglese þweorh, antico altotedesco dwerah, medio altotedesco<br />
twerch e dwerch (tedesco moderno zwerch e quer) presentano i significati di ‘curvo, obliquo,<br />
trasversale’, oltre che il senso figurato ‘cattivo, ostile, irato’, che è l’unico documentato<br />
per il gotico. Non solo, ma <strong>nel</strong> tedesco antico troviamo in dwerh ‘di traverso’ e <strong>nel</strong><br />
medio mit twerhen ougen ansehen e twerhe sehen. Quanto alla fonetica, non disturba la<br />
resa di [r] germanica con [l] del mediolatino (<strong>nel</strong> Catholicon e <strong>nel</strong>le glosse), e la spiegazione<br />
dell’iniziale, di come cioè si sia passati da una sequenza fricativa dentale sorda + [w]<br />
oppure, come qualcuno vuole, da occlusiva dentale sonora + [w] a velare + [w], non può<br />
che riposare su un adattamento romanzo (gallo-romanzo e protoitaliano) della inusitata<br />
combinazione fonematica [t]/[d] + [w] (del resto anche <strong>nel</strong> tedesco moderno a zwerch si<br />
affianca quer). Normale è invece in italiano l’esito di [w] in [g] + [w], la cui generale resa<br />
grafica <strong>nel</strong> mediolatino d’Italia e in italiano è gu-. Né deve fuorviare la grafia -quircio<br />
adottata dal “notarius Laurentius” che scrisse l’atto di Sovana (non nuovo peraltro, anche<br />
lui, a impressionistiche interpretazioni di parole longobarde: ubiscari per *hovescari). Il<br />
digramma qu- era quanto la tradizione grafica latina offriva, al suo tempo (ricordiamoci<br />
che siamo <strong>nel</strong> 752), di disponibile per la resa della detta sequenza [g] + [w] 64 .<br />
*80. saudus (1) ‘non coltivato’.<br />
Si trova <strong>nel</strong>lo stessa ‘charta dotis’ in cui sono brandus, fasso, spita e franciscata (vedi<br />
sopra ai numeri 69, 71, 76 e 72): “... similiter alia petia de oliveto una cum terra sauda vel<br />
pomifera, qui est subtus casa ...” (C.D.L. I: 168.12). Non si tratta di una occorrenza isolata,<br />
ricordare che il materiale lessicografico (per lo più latino con qualche rara presenza germanica)<br />
utilizzato <strong>nel</strong>la fitta glossatura al III Libro, resa necessaria dalla particolarmente complessa<br />
composizione del suo lessico, viene per lo più attinto a glossari precedenti.<br />
62 Lindsay 1903: XXV e 39.<br />
63 Giulini 1854-1857, vol. II: 668. Secondo Olivieri 1961: 275 vi si dovrebbe vedere il nome<br />
personale Werzo per il quale rimanda all’Altdeutsches Namenbuch del Förstemann.<br />
64 Resta aperto comunque il problema se la voce sia entrata indipendentemente <strong>nel</strong> francese e<br />
<strong>nel</strong>l’italiano (<strong>nel</strong>lo spagnolo via Francia meridionale?). Comunemente si pensa che <strong>nel</strong>l’occitanico<br />
(dove la labiovelare germanica esita univocamente in [g]) sia un italianismo, né la grafia della glossa<br />
ad Abbone, al suo alto livello cronologico, ci dà informazioni sulla reale pronunzia locale. Ricordiamo<br />
inoltre la derivazione da più antichi glossari, alcuni dei quali potrebbero essere di provenienza<br />
italiana, delle glosse al III Libro dei Bella.