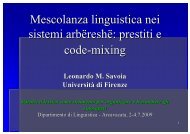germanismi editi e inediti nel codice diplomatico longobardo
germanismi editi e inediti nel codice diplomatico longobardo
germanismi editi e inediti nel codice diplomatico longobardo
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
196<br />
Giovanna Princi Braccini<br />
12. marpahis (8) ‘addetto ai cavalli (in particolare alla bardatura)’<br />
(marepahis [1], marepassi [1], marepassus [1], maripas [2], maripasso [2],<br />
marpas [1]).<br />
Tutte le occorrenze, eccetto una, sono in documenti conservati <strong>nel</strong> Regestum<br />
Farfense, dunque in copia del tardo sec. XI (l’eccezione è ancora più tarda: copia del terzo<br />
decennio del sec. XII). Come il seguente, anche questo termine all’origine indicava persona<br />
connessa con il servizio dei cavalli (*m a r (a) h-) 10 . In effetti <strong>nel</strong>la Historia<br />
Langobardorum di Paolo Diacono per ben due volte compare, <strong>nel</strong>la solita varietà di grafie<br />
della tradizione, come glossa di strator (“strator ... quem lingua propria marpahis<br />
appellant”, II.9; “cum stratore suo, qui lingua propria marpahis dicitur”, VI.6), e il<br />
Lindenbrog <strong>nel</strong>le note della sua edizione del 1595 osserva come la differenza di funzioni<br />
dei due personaggi emerga chiaramente dal Pactus legis Salicae: “marescalcus distinguitur<br />
a stratore ita ut primo cura commissa fuerit, alter sternendis tantum equis [equum sternere<br />
= ‘sellare un cavallo’] et domino adducendis operam dare”. Molto diversa comunque la<br />
fortuna dei due termini, con precoce sparizione dell’uno (che non è accolto ad esempio<br />
<strong>nel</strong>l’Elementarium doctrine rudimentum di Papia: Princi Braccini 1996) e con allocazione<br />
in funzioni e strati sociali diversi, con la complicità della sovrapposizine del consanguineo<br />
proveniente dalla Francia, dell’altro (da maniscalco a maresciallo, voce quest’ultima per la<br />
quale l’influsso d’Oltralpe non può essere negato).<br />
13. marscalc (2) ‘stalliere’ e ‘maniscalco’ (mariscalco [1], marscalc [1]).<br />
Delle due occorrenze è quella in una ‘charta promissionis [di vendita]’ chiusina<br />
dell’aprile 771, giuntaci <strong>nel</strong>l’originale (“Promitto adque spondeo me ego Ansifrid<br />
mariscalco vobis ...”, C.D.L. II: 334.5) ad essere decisamente importante poiché è l’unica<br />
attestazione al momento disponibile in Italia per mariscalc(us) databile con sicurezza in<br />
epoca pre-franca. La seconda occorrenza è infatti in un documento bresciano anch’esso del<br />
771 ma in copia del secolo XII (“+ Ado marscalc ... testes subscripsi ...”, C.D.L. II:<br />
351.24). L’implicazione dell’alta data è che il germanismo italiano (mariscalco,<br />
maniscalco ecc.) potrebbe essere entrato in italiano dal <strong>longobardo</strong> senza pertanto dovere<br />
necessariamente supporre (come vuole l’opinione comune) una ascendenza franca (Princi<br />
Braccini 1991/2: 314-315, nota 60).<br />
*14. mazoscanus (1) ‘economo’, ‘cellarius’(?).<br />
Questa parola compare, annessa a un nome proprio, in una ‘charta testamenti’ del 770<br />
riprodotta <strong>nel</strong> Regestum Farfense di Gregorio da Catino. Zielinski, l’editore di C.D.L. V,<br />
non sembra avere dubbi <strong>nel</strong> leggere mazoscanus, ma, a quanto pare non accettandone la<br />
legittimità lessicale, pensa senz’altro ad un errore per maiescarius o maiorscarius commesso<br />
dallo stesso Gregorio, considerato che <strong>nel</strong>la tradizione del Regestum a noi nota<br />
compare costantemente e chiaramente mazoscanus (C.D.L. V: 197.26, nota). Da parte mia<br />
preferisco accettare la parola <strong>nel</strong>la grafia della tradizione manoscritta e cercare una<br />
soluzione che con tale grafia si accordi. Se <strong>nel</strong> primo membro del composto vedessimo il<br />
germ. *m a t a m / *m a t i z ‘cibo, carne’ ma anche ‘provviste di cibo’ (gotico mats, antico<br />
altotedesco maz, antico inglese mete, antico nordico matr ecc.) e <strong>nel</strong> secondo membro un<br />
10 In una ‘cartula locationis’ riguardante il monastero di S. Salvatore al Monte Amiata del 1153<br />
troviamo ancora un “Robertus mariscalcus (/ marescallus / malescalcus) equorum alborum testis”<br />
(C.D.A. II: 330.34).