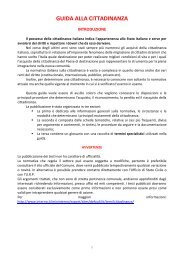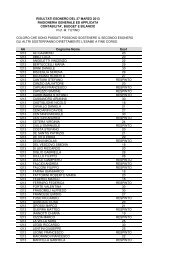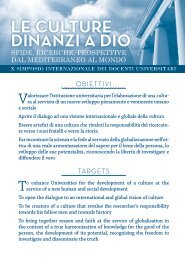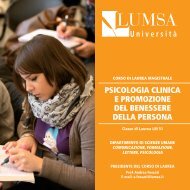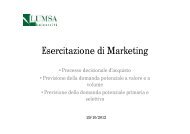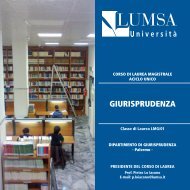linguistica latina I.pdf - Lumsa
linguistica latina I.pdf - Lumsa
linguistica latina I.pdf - Lumsa
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
săcĕr, Arpīnāt(ĭ)s > Arpīnās. Ma non c’è sincope ad es. in uītĭs, hostĭs, uestĭs,<br />
cīuĭs, fortĭs ecc., e comunque questa tendenza alla sincope sembra poi evitata dal<br />
latino standard: cfr. App. Probi, r. 74, p. 59 Asperti orbis non orbs.<br />
Non c’è sincope quando la sillaba precedente è breve (es. cŭtĭs, sĭtĭs, pŏtĭs), ma<br />
c’è sincope nel composto, forse per la maggiore corposità della parola (es.<br />
*compŏt(ĭ)s > compŏs).<br />
Ma in sillaba finale chiusa da consonante diversa da ssss<br />
la vocale vocale lunga lunga si si abbrevia, abbrevia, se non è accentata accentata: accentata<br />
es. ōrātōr > ōrātŏr, ăm-ā-t ><br />
ămăt (ma ămās), cantā-bă-m (ma cantābās), ănĭmăl (vs. genit. ănĭmālĭs);<br />
se la vocale è accentata, non si abbrevia: es. illīc(ĕ), illūc(ĕ);<br />
nei monosillabi la vocale si abbrevia soltanto davanti a m e t: es. flĕt, scĭt,<br />
rĕm, uĭm, dĕt (ancora dēt in Plauto), ma si conserva la lunga in sōl, uēr,<br />
fūr, uīn, ecc.<br />
L’abbreviamento bbreviamento giambico giambico (detto anche correptio iambica o norma della breuis<br />
breuians) è fenomeno del parlato veloce, da noi riscontrabile in metrica: una<br />
sequenza giambica ( ˇ ˉ ) viene infatti utilizzata come pirrichia ( ˇ ˇ ) nella metrica<br />
arcaica (anche in polisillabi); in età classica l’abbreviamento si verificava soltanto<br />
con parole di uso frequente (es. bĕnĕ, mălĕ vs. prŏbē, cĭtŏ vs. rĕtrō, hăuĕ vs. lat.<br />
standard ăuē (cfr. Quint. inst. 1, 6, 21), interiezione pŭtă vs. imper. pŭtā,<br />
avverbio proibitivo căuĕ vs. imper. căuē (così Cicerone attesta (diu. 2, 84) che il<br />
grido di un venditore di fichi (cauneas! = “[vendo fichi] di Cauno!”) fu<br />
interpretato, alla vigilia della spedizione di Crasso contro i Parti, come un<br />
monito a non partire (= căuē nē eas > cău(ĕ) n(ē) eas );<br />
pertanto hĕrī > hĕrĭ (e quindi > hĕrĕ : cfr. Quint. inst. 1,4,8 e 7,22; vedi qui<br />
sopra, p. 4 s.);<br />
*nĕ-hīlŭm [cfr. Enn. ann. 14 terrăque corpus / quae dĕdit ipsă căpit nĕquĕ<br />
dispendī făcĭt hīlŭm = “e la terra, che ha dato il corpo, se lo riprende e non ne<br />
spreca nemmeno un briciolo”] 31 > *nĭhīlŭm (per assimilazione regressiva) ><br />
*nĭhīl (per apocope causata da generalizzazione della forma antevocalica) > nĭhĭl<br />
[cfr. *n(ĕ) oinŏm > *n-oen(ŭm) > nōn].<br />
4.6. 4.6. 4.6. Monottongazione Monottongazione in in sillaba sillaba finale<br />
finale<br />
----oooou̯ u̯ u̯ u̯ > > > > ----ō̩ ō̩ ō̩ ō̩ >>>> -ūūūū: così ad es. *fructou̯-ŏs > *fructū-ŏs > fructŭŭs > fructūs è<br />
genitivo di registro standard, ma Suet. Aug. 87 ci attesta che Augusto nelle<br />
lettere familiari usava il genitivo dŏmōōōōs – forma dialettale, con desinenza in<br />
31 Il termine hīlum indicava “una cosa insignificante”, ad esempio il peduncolo della fava (cfr. Paul.<br />
Fest., p. 90 L. quod grānō făbae ădhaerĕt). Sua forma rinforzata è fīlum (cfr. Varro ling. 5,113 fīlŭm,<br />
quod mĭnĭmŭm est hīlŭm; id ĕnim mĭnĭmŭm est in uestĭmentō).<br />
26