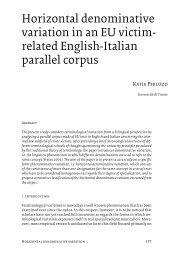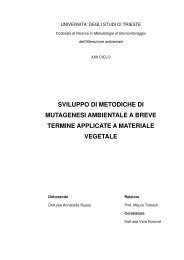1 BREVI CONSIDERAZIONI SULL'ASSUNZIONE DI ... - OpenstarTs
1 BREVI CONSIDERAZIONI SULL'ASSUNZIONE DI ... - OpenstarTs
1 BREVI CONSIDERAZIONI SULL'ASSUNZIONE DI ... - OpenstarTs
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
classica 169 , ampiamente intrecciata con la particolare flessibilità delle volontà pattizie. Tali diverse<br />
posizioni, a nostro parere, non potevano essere state inventate dai compilatori 170 come soluzioni<br />
casistiche e pertanto ci sembrano sotanzialmente genuine 171 . Il pactum in rem era stato segnalato già<br />
a partire dai giuristi del I sec., secondo quanto indicato da Labeone riferito da Paolo a D. 2.14.25<br />
pr.-1; e quanto indicato da Atilicino, Proculo e Labeone riportati da Paolo a D. 2.14.27 pr.-2. Alla<br />
luce della lettura dei vari passi problematici citati il frammento di Ulpiano appare, nella matura<br />
giurisprudenza classica, l’ultimo anello di un insieme di posizioni giurisprudenziali, che erano state<br />
filtrate attraverso le variegate soluzioni casistiche proposte, da cui peraltro si evinceva che neppure i<br />
singoli giuristi erano riusciti a fissare i limiti di trasmissibilità dei pacta in personam. I giuristi<br />
severiani comunque, pur nella diversità delle fattispecie (dal rapporto con l’erede a quello tra<br />
debitore principale e garante o pluralità di garanti) appaiono legati ad un medesimo filo conduttore,<br />
riportato da Ulpiano proprio a D. 2.14.7.8 dove, dopo avere definito in rem i patti che contenevano<br />
un generale pacisci, e in personam i patti che avvantaggiavano una persona singola, aggiunge che il<br />
problema andava risolto comunque ricostruendo la volontà dei paciscenti, asserzione strettamente<br />
collegata alla flessibilità delle negoziazioni pattizie 172 . Crediamo quindi che tale testo rappresenti il<br />
momento finale di soluzioni giurisprudenziali non ricondicibili a rigide regole proprio per la<br />
diversità degli istituti sottoposti ad una varietà di pattuizioni; e pertanto possiamo affermare con<br />
sufficiente certezza che i compilatori possono avere semplificato, ma non certo inventato le varie<br />
elaborazioni: la molteplicità dei patti infatti era tale da non consentire regole uniformi da parte dei<br />
giuristi, e solo a partire dal II sec. si giunse ad affermare il principio sicuro della prevalenza della<br />
volontà e della rilevanza degli interessi delle parti.<br />
estensione delle exceptiones de non petendo. Dalla lettura dei passi comunque notiamo che in questi si evidenziano i<br />
dubbi e i contrasti esistenti a quel tempo.<br />
169<br />
Sulla base di questa riflessione possiamo dire che vi è stata una evoluzione nelle opinioni giurisprudenziali, e<br />
che molto probabilmente all’inizio si riteneva che le eccezioni relative alla posizione personale del debitore principale<br />
(tra cui rientrava l’exceptio pacti) nei confronti del creditore, non erano estensibili al garante.<br />
170<br />
Di contro parte della dottrina romanistica lo afferma: cfr. sul punto G.ROTON<strong>DI</strong>, Di alcune riforme giustinianee<br />
cit., 319, per cui erano stati i giustinianei ad introdurre una divisio dei patti in ossequio ad una tendenza generale in tal<br />
senso F.DE MARTINO, Le garanzie personali cit., 197, adombra qualche sospetto sulla classicità della distinzione tra<br />
pacta in rem e pacta in personam. P.FREZZA, Le garanzie cit., 99 ss., pur dichiarando l’interesse dei postclassici a<br />
disporre categorie interpretative, riconosce il carattere classico dell’autonomia negoziale e della ricerca della volontà<br />
nelle pattuizioni.<br />
171<br />
Cfr. P.VOCI, Diritto ereditario cit., 243 s.; A.WACKE, Zur Lehre von Pactum tacitum cit., 227; M.BRUTTI, La<br />
problematica del dolo processuale cit., 706 s. e 727 s. hanno rivalutato la sostanziale classicità della divisio.<br />
172<br />
G.MELILLO, “Pacta in rem, pacta in personam” cit., 1473, nota che è comunque difficile credere che il patto di<br />
non chiedere, tanto diffuso nella dottrina dei giuristi romani, seguisse motivi di benevolenza e non fosse piuttosto<br />
dettato da motivi di vantaggio già ottenuti o attesi da parte del creditore nei confronti del debitore<br />
38