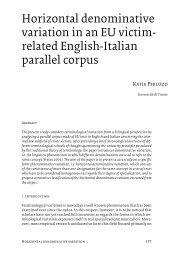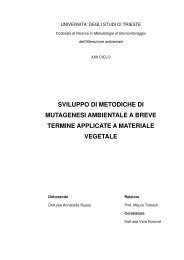1 BREVI CONSIDERAZIONI SULL'ASSUNZIONE DI ... - OpenstarTs
1 BREVI CONSIDERAZIONI SULL'ASSUNZIONE DI ... - OpenstarTs
1 BREVI CONSIDERAZIONI SULL'ASSUNZIONE DI ... - OpenstarTs
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
I negozi di sponsio e di fidepromissio originariamente erano produttivi di obbligazioni<br />
intrasmissibili agli eredi, erano imprescrittibili 17 , e non si dividevano tra cogaranti 18 , assumendo di<br />
conseguenza il carattere di obbligazioni solidali sia nei rapporti tra debitore principale e garante, sia<br />
nei rapporti dei cogaranti tra di loro. Originariamente quindi non era previsto né un regresso tra<br />
garante adempiente e soggetto garantito 19 , né tra cogaranti, e pertanto esse avevano un regime<br />
coincidente con quello delle stipulazioni passive solidali. Con ogni probabilità già in epoca risalente<br />
esisteva la caratteristica dell’affiancarsi della sponsio e della fidepromissio di garanzia ad una<br />
obbligazione principale 20 , che poteva essere solo una obligatio verbis contracta 21 . Già da parte<br />
della giurisprudenza più antica si era forse enucleata in queste figure la caratteristica di stipulazioni<br />
passivamente accessorie, che, pur dando luogo ad una obbligazione solidale, sotto alcuni aspetti<br />
tenevano conto proprio della loro funzione di garanzia; ma in entrambe le figure l’accessorietà 22 era<br />
concepita come concernente gli atti.<br />
c) La fideiussio. Entrambi i due negozi (di cui abbiamo detto) molto simili tra loro, si<br />
differenziavano in più punti dalla fideiussio, che più tardi, forse a partire dal I sec. a.C., verso la fine<br />
dell’età repubblicana 23 comparve nel mondo della prassi giuridica romana 24 . Tale negozio era<br />
17<br />
Ciò vale solo all’origine in quanto, la lex Furia, posteriore al 241 a.C., introdusse per la sponsio la limitazione<br />
dell’obligatio sponsoris al biennio.<br />
18<br />
Da notarsi che un’altra legge, la lex Appuleia approvata nella prima metà del III sec. a.C., riconobbe la<br />
divisibilità dell’obbligazione di garanzia derivante da sponsio e fidepromissio, introducendo il regresso a favore di un<br />
garante contro gli altri cogaranti, i quali dovevano ciascuno la propria parte.<br />
19<br />
Ma già la lex Publilia della prima metà del IV sec. a.C. avrebbe accordato al garante sponsor, che avesse<br />
adempiuto al debito garantito, una azione di regresso (actio depensi) contro il debitore che non avesse fatto fronte ai<br />
suoi debiti.<br />
20<br />
L’idem del formulario paradigmatico della sponsio e della fidepromissio sarebbe dunque stato per parte della<br />
dottrina la misura non tanto dell’identità, quanto dell’accessorietà di una obbligazione rispetto all’altra: cfr. sul punto<br />
F.DE MARTINO, Le garanzie personali cit., 83 ss. e P.FREZZA, Le garanzie cit., 59 ss.<br />
21<br />
A tale proposito cfr. Gai 3.119, dove il giurista sottolinea che sponsio e fidepromissio erano efficaci purchè<br />
accedessero ad un negozio avente struttura di verborum obligatio, ancorchè da questo non sorgesse alcun effetto, come<br />
accadeva quando la stipulatio fosse fatta da un promissor impubere senza l’auctoritas del tutore: in tale caso lo sponsor,<br />
che fosse intervenuto, sarebbe ugualmente risultato obbligato. Tutto ciò anche se il giurista avverte che ancora ai suoi<br />
tempi si discuteva su due eccezioni a questa regola, di cui peraltro non pare qui utile trattare.<br />
22<br />
Possiamo già anticipare che tale caratteristica era quindi ancorata alla struttura della garanzia nella sua<br />
conformazione genetica.<br />
23<br />
E forse probabilmente in età ciceroniana: cfr. per tutti P.FREZZA, Le garanzie cit., 12; M.TALAMANCA,<br />
Fideiussione cit., 329; V.MANNINO, Garanzie delle obbligazioni, in Dig. IV sez. civ., VIII, Torino, 1992, 616 e n. 22.<br />
24<br />
Si sa che la tarda giurisprudenza classica configurava un incarico di garanzia purchè il debitore principale,<br />
presente al negozio di garanzia, non vi si fosse opposto. Inoltre tra garante e debitore principale esisteva un onere di<br />
informazione dell’avvenuto pagamento o dell’eventuale estinzione dell’obbligazione principale, sia ipso iure che ope<br />
exceptionis: se tale onere non fosse stato osservato dal garante egli perdeva il diritto all’esercizio dell’azione di<br />
6