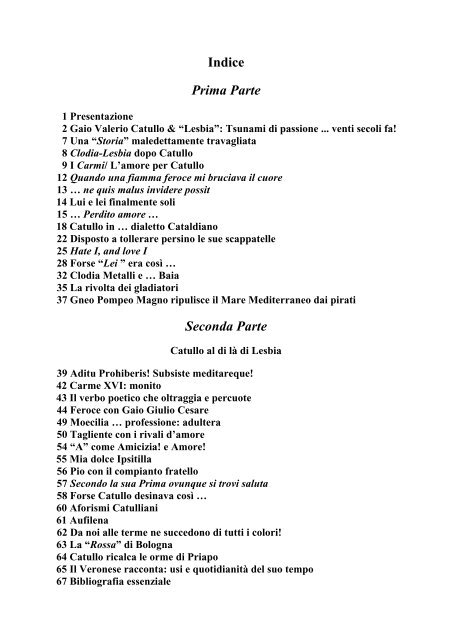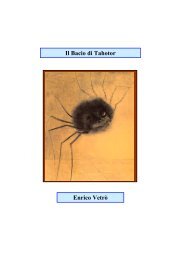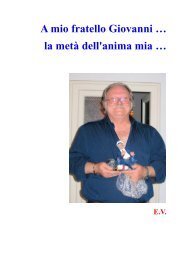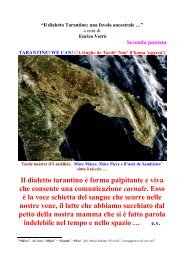Gaio Valerio Catullo &“Lesbia” - Taranto in cartolina
Gaio Valerio Catullo &“Lesbia” - Taranto in cartolina
Gaio Valerio Catullo &“Lesbia” - Taranto in cartolina
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Indice<br />
Prima Parte<br />
1 Presentazione<br />
2 <strong>Gaio</strong> <strong>Valerio</strong> <strong>Catullo</strong> & <strong>“Lesbia”</strong>: Tsunami di passione ... venti secoli fa!<br />
7 Una “Storia” maledettamente travagliata<br />
8 Clodia-Lesbia dopo <strong>Catullo</strong><br />
9 I Carmi/ L’amore per <strong>Catullo</strong><br />
12 Quando una fiamma feroce mi bruciava il cuore<br />
13 … ne quis malus <strong>in</strong>videre possit<br />
14 Lui e lei f<strong>in</strong>almente soli<br />
15 … Perdito amore …<br />
18 <strong>Catullo</strong> <strong>in</strong> … dialetto Cataldiano<br />
22 Disposto a tollerare pers<strong>in</strong>o le sue scappatelle<br />
25 Hate I, and love I<br />
28 Forse “Lei ” era così …<br />
32 Clodia Metalli e … Baia<br />
35 La rivolta dei gladiatori<br />
37 Gneo Pompeo Magno ripulisce il Mare Mediterraneo dai pirati<br />
Seconda Parte<br />
<strong>Catullo</strong> al di là di Lesbia<br />
39 Aditu Prohiberis! Subsiste meditareque!<br />
42 Carme XVI: monito<br />
43 Il verbo poetico che oltraggia e percuote<br />
44 Feroce con <strong>Gaio</strong> Giulio Cesare<br />
49 Moecilia … professione: adultera<br />
50 Tagliente con i rivali d’amore<br />
54 “A” come Amicizia! e Amore!<br />
55 Mia dolce Ipsitilla<br />
56 Pio con il compianto fratello<br />
57 Secondo la sua Prima ovunque si trovi saluta<br />
58 Forse <strong>Catullo</strong> des<strong>in</strong>ava così …<br />
60 Aforismi Catulliani<br />
61 Aufilena<br />
62 Da noi alle terme ne succedono di tutti i colori!<br />
63 La “Rossa” di Bologna<br />
64 <strong>Catullo</strong> ricalca le orme di Priapo<br />
65 Il Veronese racconta: usi e quotidianità del suo tempo<br />
67 Bibliografia essenziale
P r e s e n t a z i o n e<br />
Clodia Metelli e <strong>Gaio</strong> <strong>Valerio</strong> <strong>Catullo</strong> furono <strong>in</strong>negabilmente assertori conv<strong>in</strong>ti della<br />
religione dei sensi e della energia libidica da essi scaturente. Lei, profetessa delle pulsioni<br />
della carne e del sangue, unanimemente riconosciuta tale dai giovanotti bene, dai politici e<br />
dagli <strong>in</strong>tellettuali di Roma del primo secolo avanti Cristo. Lui, apostolo forse più<br />
illum<strong>in</strong>ato, dato che considerò l’altro sesso e gli efebi di cui s’<strong>in</strong>vaghì non solo come punti<br />
di riferimento esistenziali confluenti nella filosofia dei “basia mille” - il contatto fisico - ma<br />
anche e soprattutto come moventi primari dell’ “odi et amo” - i moti dell’anima.<br />
Raccontare di <strong>Valerio</strong> e Clodia, quando di <strong>Valerio</strong> e Clodia è stato detto tutto con gli<br />
imponenti contributi letterari di autorevoli umanisti ed esegeti d’ogni tempo, è impresa<br />
alquanto ardua. Se poi a farlo è un non addetto ai lavori, allora il cimento si rivela<br />
pressoché proibitivo. I rischi, <strong>in</strong>fatti, d’<strong>in</strong>correre nel banale e nel trito e ritrito si fanno<br />
altamente probabili. Il tentativo, <strong>in</strong> ogni caso, è stato effettuato. Complice la passione<br />
congenita e <strong>in</strong>contenibile per la Letteratura Lat<strong>in</strong>a e la Storia di Roma antica, ben<br />
consapevole d’essere un artigiano lontano anni luce dall’<strong>in</strong>tellighenzia specialistica che ha<br />
trattato del poeta veronese e delle sue vicende affettive. In it<strong>in</strong>ere il lettore comune troverà<br />
notizie dal taglio sostanzialmente snello sulla quotidianità del mondo lat<strong>in</strong>o del I sec. a.C. e<br />
del I sec. A.D. (quest’ultimo ancora nitido riflesso dell’era di <strong>Catullo</strong>) che trova agevole<br />
collocazione nel tessuto narrativo dell’irregolare love affair. Un nutrito numero di<br />
immag<strong>in</strong>i artistiche corroborano l’<strong>in</strong>formazione, con l’<strong>in</strong>tento di fornire una concreta<br />
visione d’<strong>in</strong>sieme del contesto sociale, politico, economico e culturale <strong>in</strong> cui <strong>Gaio</strong> <strong>Valerio</strong> si<br />
trovò a vivere e ad operare. Non mancano, tuttavia, stravaganze fatte <strong>in</strong> tutta scienza e<br />
coscienza, come l’avere reso <strong>in</strong> vernacolo tarant<strong>in</strong>o e <strong>in</strong> <strong>in</strong>glese arcaico i celebri carmi V e<br />
LXXXV. Nella seconda parte del lavoro, il cultore della lettura avrà modo <strong>in</strong>vece di<br />
scoprire un <strong>Catullo</strong> di rado trattato nei testi di letteratura. Al di là di Clodia-Lesbia potrà<br />
cogliere, qualora lo desideri, un versificatore che collauda con successo qualcosa mai<br />
prima d’allora sperimentato nella poesia lat<strong>in</strong>a d’alto profilo, per quanto mi risulta. Con<br />
impareggiabile bravura egli riesce ad <strong>in</strong>nestare il sermo lubrico di stampo fescenn<strong>in</strong>o e<br />
della parlata popolare del suo tempo <strong>in</strong> versi colti e raff<strong>in</strong>ati, elevandolo a poetico<br />
turpiloquio, per raccontare <strong>in</strong> tutta libertà e con realistica s<strong>in</strong>golarità l’umanità che gli fu<br />
compagna di percorso esistenziale.<br />
Che cosa mi ha <strong>in</strong>dotto a fare tutto questo?! Di certo il volermi mettere cont<strong>in</strong>uamente <strong>in</strong><br />
discussione, il piacere dell’<strong>in</strong>dag<strong>in</strong>e scrupolosa e della scoperta del dato, la presunzione di<br />
potere essere utile <strong>in</strong> qualche modo al benessere <strong>in</strong>tellettivo del prossimo e dei giovani <strong>in</strong><br />
particolare. Perché la memoria antica della nostra nazione, come la fiamma della madre<br />
patria nel braciere dell’oikistes deve essere mantenuta accesa ad ogni costo, giacché oggi<br />
più che mai, essa può <strong>in</strong>segnare ancora tantissimo. Aggiungerei, <strong>in</strong>f<strong>in</strong>e, il sentito bisogno<br />
di contribuire, sia pure <strong>in</strong> percentuale <strong>in</strong>f<strong>in</strong>itesimale, alla r<strong>in</strong>ascita di una società avvilita<br />
dal genocidio della cultura attuato da un consumismo sempre più arrogante ed ottuso,<br />
dall'<strong>in</strong>sopportabile forza mediatica dello share - micidiale dispensatore di omissioni<br />
culturali e d’ignoranza gratuita - dalle metastasi <strong>in</strong>vasive di una pubblicità<br />
spudoratamente dis<strong>in</strong>ibita e menzognera, che impone sull’essere e sulla dignità<br />
dell’<strong>in</strong>dividuo il primato dell’avere e dell’apparire.<br />
L’autore
2<br />
<strong>Gaio</strong> <strong>Valerio</strong> <strong>Catullo</strong> &<strong>“Lesbia”</strong><br />
Tsunami di passione ... venti secoli fa!<br />
a cura di<br />
Enrico Vetrò<br />
“ …Lesbia! Appena<br />
ti vedo, non mi riesce<br />
più di parlare:<br />
la l<strong>in</strong>gua si fa torpida,<br />
un fuoco sottile mi<br />
corre sotto la pelle,<br />
rimbomba no le orecchie per un suono<br />
<strong>in</strong>terno,<br />
e su entrambi gli occhi si fa buio<br />
…”<br />
Carm<strong>in</strong>a<br />
– LI, 6-12<br />
“ ma <strong>in</strong>nanzi<br />
a tutti lei, che mi è più cara di me<br />
stesso,<br />
lei, la luce mia, f<strong>in</strong>ché ella vive,<br />
il vivere per me è<br />
dolce.” Carm<strong>in</strong>a – LXVIII, 159-160.<br />
"Odi et amo "<br />
clicca e ascolta.<br />
Odi et amo.<br />
Quare id faciam<br />
fortasse requiris.<br />
Nescio, sed<br />
fieri sentio, et<br />
excrucior.<br />
Carm<strong>in</strong>a - LXXXV<br />
“Odio e amo.<br />
Magari vuoi sapere perché faccia così.<br />
Non lo so, ma mi succede, lo sento, e per me è il supplizio della croce.”
3<br />
<strong>Gaio</strong> <strong>Valerio</strong> <strong>Catullo</strong> (Sirmione?/Verona? 87/84 a.C. – Roma?/Sirmione? 57/54 a.C.)<br />
senza f<strong>in</strong>i civili e morali; arte poetica<br />
diretta del duale amare=vivere, alimentata dal puro piacere di<br />
scrivere che si fa scopo di vita.<br />
"Bimillenario della morte di <strong>Gaio</strong> <strong>Valerio</strong> <strong>Catullo</strong>". Francobollo<br />
emesso il 19 Settembre 1949.<br />
Soggetto: sul fondo Ponte Pietra sull'Adige visto da un arco del<br />
teatro romano. Tiratura: 3.131.400 esemplari.<br />
Tutto quello che si sa sulla vita del poeta lat<strong>in</strong>o ci è stato tramandato molti anni dopo la sua morte<br />
e <strong>in</strong> maniera <strong>in</strong>diretta. Ciò vale anche per i suoi 116 Carmi(un corpo lirico di ben 2300 versi),<br />
presumibilmente raccolti dal conterraneo amico e filologo Cornelio Nepote (I sec. a.C). Si dovrà<br />
attendere s<strong>in</strong>o al 1472 per leggere la editio pr<strong>in</strong>ceps stampata (a Venezia) della produzione<br />
poetica di <strong>Catullo</strong> 1 . Le liriche Catulliane si rivelano a tratti veementi, a tratti delicate, sempre<br />
gustose nella loro agile lettura, perché tutte pervase da uno spirito ultramoderno di esprimere i<br />
sentimenti. Il“Nuovo”stile dello scrivere <strong>in</strong> versi divenne corollario di fede abbracciata da anime<br />
sensibili(Neòteroi 2 o Poetae Novi) che – alla pari del nostro rimatore lat<strong>in</strong>o - <strong>in</strong>tesero raccontarsi e<br />
raccontare la vita <strong>in</strong> modo pressoché colloquiale, schietto e contenuto (brevitas), <strong>in</strong> versi, tuttavia,<br />
fortemente evocativi e f<strong>in</strong>emente cesellati(labor limae). Questo tipo di poesia trasse nutrimento dal<br />
groviglio delle esperienze personali quotidiane dei suoi <strong>in</strong>iziatori, sulle quali primeggiò l’eros, <strong>in</strong>teso<br />
come valore essenziale trasgressivo, <strong>in</strong> grado di dare significato alla più che mai fugace esistenza<br />
umana. In contrasto, dunque, con l’<strong>in</strong>transigenza del conservatorismo dei senum severiorum (V,2).<br />
Gli austeri attempati benpensanti, legati a doppio filo alla morale tradizionale lat<strong>in</strong>a, etichettavano<br />
amore e pulsioni come <strong>in</strong>evitabili debolezze dell’età giovanile, tollerandole malapena, a patto che<br />
non si violassero i dettami imposti dal bon ton del vivere sociale di quel tempo. Con <strong>Catullo</strong>, <strong>in</strong><br />
def<strong>in</strong>itiva, si ebbe poesia come libera <strong>in</strong>terpretazione dell’<strong>in</strong>timo sentire, otium <strong>in</strong>dividuale letterario<br />
1 Sulla tradizione manoscritta e le successive edizioni <strong>in</strong> stampa del Liber si consulti: <strong>Catullo</strong>, Le poesie, i grandi libri Garzanti,<br />
<strong>in</strong>troduzione, traduzione e note di Mario Ramous, prefazione di Luca Canali, XIV ed., Apr. 2004, pagg. xiv-xviii.<br />
2 “Quelli alla moda”. Def<strong>in</strong>izione forse polemica di Cicerone, per il loro gusto ellenizzante ed aristocratico.
Nicoletta Tomas Caravia - acrilico - “Los amantes 120” - Madrid, 2000 - Collezione privata<br />
4<br />
Il primo <strong>in</strong>contro avvenne nel 62, forse a Sirmione nella villa di famiglia di <strong>Catullo</strong>. Ospiti Lesbia e il marito.<br />
Sembra più verosimile, tuttavia, che le due vite si fossero <strong>in</strong>crociate a Roma, dove il poeta si trasferì ventenne 3 .<br />
Il vero nome della donna era Claudia (Clodia) Pulchra Tertia (o Secunda? 4 . Nata forse nel 95 a.C.). Lo scrittorefilosofo<br />
lat<strong>in</strong>o Apuleio [125-170 A.D., Apologia (De Magia), cap. X , 9-10] 5 riferisce che a <strong>Gaio</strong> <strong>Valerio</strong> era<br />
piaciuto attribuirle lo pseudonimo Lesbia, "La fanciulla di Lesbo", raffrontandola così a Saffo, una poetessa cara<br />
a molti <strong>in</strong>tellettuali dell’epoca (Cornelio Nepote, Q. Ortensio Ortalo, L. Calvo, E. C<strong>in</strong>na, Partenio di Nicea<br />
Aurelio, Fabullo, Cornelio, Varrone Atac<strong>in</strong>o, M. Furio Bibaculo, Cornifico, Ticida, G. Memmio e Veranio) 6 .<br />
Nata a Lesbo, isoletta del Mare Egeo, <strong>in</strong>torno alla f<strong>in</strong>e del VII sec. a.C., Saffo era divenuta famosa <strong>in</strong> tutta la<br />
Grecia perché celebratrice ed ispiratrice di sentimenti tanto straord<strong>in</strong>ariamente sensuali, quanto<br />
meditativamente delicati e pacati. Il che ha portato ad ipotizzare che il nostro poeta <strong>in</strong>tendesse implicitamente<br />
cantare la figura di una donna colta, raff<strong>in</strong>ata e affasc<strong>in</strong>ante, tutte qualità queste che provocarono nell’uomo<br />
slanci passionali <strong>in</strong>contenibili. Clodia-Lesbia rimane probabilmente identificabile con la figlia del ricco e potente<br />
Appio Claudio Pulcro (Console nel 79) e sorella del Tribuno della Plebe P. Clodio Pulcro 7 , <strong>in</strong>dividuo<br />
spregiudicato ed audace, (chiamato Pulcro per la sua avvenenza) appartenente al partito dei "populares", alleato<br />
di Giulio Cesare (di cui però <strong>in</strong>sidiò la moglie Pompea nel 62). 8 Clodio sarà <strong>in</strong> seguito ucciso da Milone (<strong>in</strong> una ta-<br />
3<br />
“Viviamo a Roma, quella è la mia casa,/ la mia dimora, lì si svolge la mia vita”. (Carm<strong>in</strong>a, LXVIII, v. 34 sg.).<br />
4<br />
Che ella fosse seconda o terza di tre sorelle rimane questione alquanto controversa. Non pochi propendono per la prima ipotesi.<br />
5<br />
“…Eadem igitur opera accusent C. Catullum, quod Lesbiam pro Clodia nom<strong>in</strong>arit …” (“Similmente, dunque, potrebbero accusare<br />
<strong>Catullo</strong>, perché ha chiamato Lesbia, <strong>in</strong>vece di Clodia, la sua donna …” Cfr.: Senecio, a cura di E. Piccolo e L. Lanza, Napoli 2003, <strong>in</strong>:<br />
www.vicoacitillo.it/senecio/sag/amcatullo.pdf).<br />
Nel secolo XVI fu l’umanista Petrus Victorius (o Pietro Vettori, 1499-1585) ad identificare Lesbia come Clodia figlia di Appio Claudio<br />
Pulcro. Cfr.: http://de.wikipedia.org/wiki/Petrus_Victorius.<br />
6<br />
Probabilmente seguì il vezzo letterario del tempo assegnando un criptonimo alla donna amata. (Cfr:<br />
www.vicoacitillo.it/senecio/sag/amcatullo.pdf).<br />
7 Fu il primo membro della gens Claudia a r<strong>in</strong>unciare al suo rango di patrizio [dato che ambiva alla prestigiosa carica di Tribuno della<br />
Plebe! (M. T. Cicero, Epistulae ad Atticum, Liber II,1, 5)]. Infatti modificò il suo nome nella forma plebea di “Clodius”, probabilmente<br />
anche <strong>in</strong> ossequio all’abitud<strong>in</strong>e sempre più diffusa dei plebei di scrivere e pronunciare “o” il gruppo vocalico “au” . Fu ben presto imitato<br />
da sua sorella Lesbia/Clodia.<br />
8<br />
Nella notte fra il 3 e 4 dicembre del 62, durante le sacre cerimonie <strong>in</strong> onore della Bona Dea (per sole donne e verg<strong>in</strong>i vestali, di solito<br />
tenute nell’abitazione di un magistrato) il Pulcro si <strong>in</strong>trodusse <strong>in</strong> casa del Pontefice Massimo Giulio Cesare truccato da suonatrice di cetra,
5<br />
verna a Boville, sulla via Appia, nei pressi di Roma – Cic., Ad Atticum, V,13,1) sostenitore di Pompeo, avversario<br />
politico di Cesare. Si sa per certo che Marco Tullio Cicerone non esitò a diffamare Lesbia pubblicamente e a<br />
def<strong>in</strong>irla con i peggiori epiteti: “non solum meretrix, sed etiam proterva meretrix procaxque”(non semplice<br />
meretrice, ma meretrice sfrenatamente oscena e procace) 9 , e ancora “Clytaemnestra” (“Assass<strong>in</strong>a”, perché era<br />
conv<strong>in</strong>to che costei avesse avvelenato il marito per dare libero sfogo alla sua natura depravata) e “Quadrantaria”<br />
(Prostituta da quattro soldi) 10 . L’astio dell’Arp<strong>in</strong>ate per la matrona fu lampante <strong>in</strong> occasione del v<strong>in</strong>cente<br />
patroc<strong>in</strong>io di un ex amante di costei, un certo Marco Celio Rufo, tra l’altro discepolo dello stesso difensore 11 :<br />
“Ma se una donna, che non abbia marito, apra la casa propria alle brame di tutti, si metta a fare apertamente una<br />
vita da mondana, usi banchettare con uom<strong>in</strong>i a lei assolutamente estranei; se questo ella faccia <strong>in</strong> città, <strong>in</strong> villa, <strong>in</strong><br />
mezzo alla folla di Baia; se si comporti, non solo nel modo di camm<strong>in</strong>are ma anche nel modo di acconciarsi e nella<br />
compagnia, non solo nello sc<strong>in</strong>tillio degli occhi e nella licenziosità dei discorsi, ma anche per quel suo abbracciare e<br />
baciare sulle spiagge, per le gite <strong>in</strong> barca e per i banchetti che frequenta, <strong>in</strong> modo tale da manifestarsi prostituta,<br />
non soltanto, ma prostituta sfrontata e procace: dimmi, Erennio, un giovanotto che per caso le si accompagnasse lo<br />
chiameresti tu adultero, o amante; diresti tu ch'egli voglia attentare al pudore di lei, o soddisfarne la libid<strong>in</strong>e?” 12<br />
“Hai un giard<strong>in</strong>o sul Tevere, e te lo sei adattato apposta <strong>in</strong> quel luogo perché tutta la gioventù di Roma ci venga col<br />
pretesto del nuoto.” 13<br />
“…Se costei, vedova, vivesse <strong>in</strong> piena libertà; sfrontata, senza sfreni; ricca, con ogni sperpero; libid<strong>in</strong>osa, a modo di<br />
meretrice: dovrei io giudicare adultero colui che trattasse questa donna con qualche confidenza di troppo?” 14<br />
Senza contare la voce che fece circolare ad arte durante il processo, secondo la quale Lesbia sarebbe stata<br />
femm<strong>in</strong>a <strong>in</strong>cestuosa, essendosi concessa al fratello Clodio quando ancora era sposata con Lucullo (Plutarco Vite<br />
Parallele, XXIX, 4):<br />
“… Il tuo m<strong>in</strong>or fratello … che ti ama più di ogni altro, e che, non so per quale, credo io, timidezza di vani terrori notturni, ha<br />
sempre usato dormire con te, come un fanciullo con la sorella maggiore.” 15<br />
giacché coltivava una relazione amorosa con la moglie Pompea. (Plutarchus, Vitae Parallelae, Cicero, XXVIII, 2. M. T. Cicero, Ibidem,<br />
Liber I, 12; I, 13; I, 16.). A causa di tale sfrontatezza il Senato lo citò <strong>in</strong> giudizio con l’accusa di sacrilegio. Durante il processo che si<br />
tenne nel 61, il teste a carico Cesare si rifiutò di deporre contro il giovane amico per non ammettere pubblicamente l’adulterio della<br />
consorte. Pompea sarà poi ripudiata dal marito (Cic., ibidem, I,13) “perché una matrona era tenuta ad essere immune da azioni oscene e<br />
da turpi sospetti”. Nemmeno la deposizione demolitoria di Cicerone valse a fare condannare Clodio. Il giorno del misfatto l’imputato non<br />
poteva trovarsi a Terni nell’abitazione di un certo Caus<strong>in</strong>io Schola, come falsamente dichiarato dallo stesso padrone di casa. Appena<br />
qualche ore prima che si consumasse il sacrilegio il “pulchellus puer” [(lo smilzo damer<strong>in</strong>o), Cic., ibidem, I, 16, 9] si era recato presso la<br />
villa dell’Arp<strong>in</strong>ate sul Palat<strong>in</strong>o, per trattenersi con lui <strong>in</strong> piacevole conversazione. 31giudici prezzolati su 56, temendo la violenta reazione<br />
del popolo che parteggiava per l’<strong>in</strong>crim<strong>in</strong>ato, «scrissero sulle tavolette verdetti <strong>in</strong>decifrabili», che furono tutti <strong>in</strong>terpretati come<br />
assoluzione da scrutatori altrettanto corrotti. Il giovane scapestrato fu pertanto clamorosamente assolto. (Plutarchus, ibidem, XXIX, 1, 6, 9.<br />
M. T. Cic., ibidem, I, 16, 4 e5; II, 1, 5).<br />
9<br />
“Pro Caelio Rufo”, XLIX, L - Aprile del 56 a.C. Nella stessa orazione Clodia fu altresì def<strong>in</strong>ita una “Medea Palat<strong>in</strong>a”, ibidem,<br />
XVIII, temibile, cioè, quanto la maga <strong>in</strong>fanticida. “Palat<strong>in</strong>a” perché, come lei, Celio aveva acquistato una casa sul colle Palat<strong>in</strong>o. Lì<br />
aveva preso a frequentare la conturbante donna. L’<strong>in</strong>izio dei suoi guai.<br />
10<br />
“Ibidem”, LXII, Qu<strong>in</strong>til. viii, 6§53. Letteralmente: donna che richiede la modesta somma di un quadrante, un quarto di asse, per le sue<br />
prestazioni sessuali. Plutarco lo conferma usando il term<strong>in</strong>e Κουαδρανταρίαν (Quadrantarìan) perché uno dei suoi amanti le aveva<br />
mandato una borsa colma di quadranti di bronzo, anziché di monete d’argento. (Cfr.: Plutarco, nota 6). Sembra che Clodia volesse sposare<br />
Cicerone (Plutarco,ibidem, XXIX).<br />
11 La trentottenne Clodia aveva trasc<strong>in</strong>ato <strong>in</strong> giudizio il giov<strong>in</strong>astro Rufo con la pesante accusa di veneficio macch<strong>in</strong>ato a suo danno, al<br />
f<strong>in</strong>e di appropriarsi dei suoi gioielli (“aurum et venenum”, Ibidem, XXX). Da quel momento di lei si hanno solo scarse e frammentarie<br />
notizie.<br />
12<br />
Ibidem, XLIX. “Si quae non nupta mulier domum suam patefecerit omnium cupiditati palamque sese <strong>in</strong> meretricia vita collocarit,<br />
virorum alienissimorum conviviis uti <strong>in</strong>stituerit, si hoc <strong>in</strong> urbe, si <strong>in</strong> hortis, si <strong>in</strong> Baiarum illa celebritate faciat, si denique ita sese<br />
gerat non <strong>in</strong>cessu solum, sed ornatu atque comitatu, non flagrantia oculorum, non libertate sermonum, sed etiam complexu,<br />
osculatione, actis, navigatione, conviviis, ut non solum meretrix, sed etiam proterva meretrix procaxque videatur: cum hac si qui<br />
adulescens forte fuerit, utrum hic tibi, L. Herenni, adulter an amator, expugnare pudicitiam an explere libid<strong>in</strong>em voluisse videatur?”<br />
13<br />
Ibidem, XXX. “Habes hortos ad Tiberim ac diligenter eo loco paratos, quo omnis iuventus natandi causa venit.”<br />
14<br />
Ibidem, XXXVIII. “… Ssi vidua libere, proterva petulanter, dives effuse, libid<strong>in</strong>osa meretricio more viveret, adulterum ego putarem,<br />
si quis hanc paulo liberius salutasset?”<br />
15<br />
Ibidem XXXVI. L’<strong>in</strong>s<strong>in</strong>uazione espressa <strong>in</strong> forma di edulcorato sarcasmo qui è più che evidente: “ … m<strong>in</strong>imum fratrem … qui te<br />
amat plurimum, qui propter nescio quam, credo, timiditatem et nocturnos quosdam <strong>in</strong>anes metus tecum semper pusio cum maiore<br />
sorore cubitavit.” Il fratello m<strong>in</strong>ore è ovviamente Publius Clodius Pulcro nato <strong>in</strong>torno al 92. Sì, è vero che fossero entrambi figli di A.<br />
C. Pulcro, ma avevano madri diverse.
6<br />
“Ma se, per contro, liquidata costei, nulla rimanga <strong>in</strong> piedi né dell'accusa, né dei mezzi a cui si appoggia, che altro dovremmo<br />
fare noi, avvocati di Celio, se non resp<strong>in</strong>gere chi ci aggredisce? Ed io lo farei anche con maggior violenza, se non mi<br />
trattenesse la mia <strong>in</strong>imicizia col marito ... volevo dire col fratello: sempre lo stesso errore!” 16<br />
La donna dei sogni di <strong>Catullo</strong> fu moglie del primo cug<strong>in</strong>o Q. C. Metello Celere, (e anche fratellastro di P.Clodio per parte di<br />
madre) proconsole del territorio cisalp<strong>in</strong>o tra il 62 e il 61 e console nel 60. Una “seditiosa” col marito (“Ribelle”. Cic. op. cit.,<br />
II, 1), che morì nel 59. Aveva conosciuto <strong>Catullo</strong> nel 61. Lei trentatreenne, lui di dieci anni più giovane. “Occhi di bue” 17 fu<br />
una matrona dell’alta società, dis<strong>in</strong>ibita e sicura di sé. Si concesse al poeta, ma si può dire che lo tradisse senza soluzione di<br />
cont<strong>in</strong>uità. Uno fra i tanti per lei: Egnazio, Gellio, Marruc<strong>in</strong>o … Eppure il verseggiatore nutrì per lei una passione<br />
assurda, più che mai ardente, totalizzante, cagione della sua morte, dicono, avvenuta quando egli non aveva ancora<br />
trent’anni. 18<br />
Nel 57 l’amore per Lesbia è ormai ridotto <strong>in</strong><br />
Nel colpire l’onorabilità della quasi 40enne Clodia,<br />
durante il processo a carico del 24enne Celio Rufo,<br />
Cicerone volle di fatto sfogare il suo rancore nei<br />
confronti del di lei fratello, Clodio, Tribuno della<br />
Plebe. Costui, <strong>in</strong>fatti, lo aveva fatto esiliare per<br />
avere mandato a morte non pochi cospiratori di<br />
Lucio Sergio Catil<strong>in</strong>a con uno processo sbrigativo.<br />
(Legge Clodia, 58 a.C, conosciuta anche come<br />
“Acquae et <strong>in</strong>gnis <strong>in</strong>terdicio”). Lo stesso Cicerone<br />
tentò <strong>in</strong> seguito di difendere Tito Annio Milone,<br />
Intimidito dalle m<strong>in</strong>acce di morte di G. Pompeo<br />
(sostenitore di Clodio) e più volte <strong>in</strong>terrotto dalla<br />
folla, M. Tullio non riuscì per la tensione a<br />
pronunciare la sua arr<strong>in</strong>ga <strong>in</strong> Senato. Sicché<br />
Milone venne imprigionato e poi costretto all’esilio<br />
a Marsiglia. Sarà elim<strong>in</strong>ato da Clodio il 22<br />
Gennaio del 52 durante una lite montata ad arte.<br />
Affreschi Pompeiani<br />
I sec. A.D.<br />
cenere. Per vari motivi, non ultimo il volere<br />
dimenticare la femme fatale, <strong>Catullo</strong> parte<br />
per la Bit<strong>in</strong>ia (Asia M<strong>in</strong>ore nord occidentale –<br />
cfr. la cart<strong>in</strong>a geografica della regione a pag.<br />
9.) <strong>in</strong> qualità di membro della cohors<br />
amicorum, al seguito dell’amico propretore<br />
<strong>Gaio</strong> Memmio. In tale occasione andrà a<br />
visitare <strong>in</strong> Troade (antica regione dell’Asia<br />
M<strong>in</strong>ore <strong>in</strong> parte prospiciente l’isola di Lesbo) la<br />
tomba del suo carissimo fratello, scomparso<br />
<strong>in</strong>aspettatamente. Ritornato prima a Verona,<br />
e poi nel 56 a Roma, cont<strong>in</strong>uano a giungergli<br />
notizie sulla condotta lasciva dell’ancora<br />
avvenente vedova. Forse lei vuole rimettersi<br />
con lui e manda a dirglielo tramite comuni<br />
amici, Furio e Aurelio (c.11). Non gliene<br />
importa più nulla. È davvero f<strong>in</strong>ita per<br />
sempre.<br />
16 Ibidem, XXXII. “S<strong>in</strong> ista muliere remota nec crimen ullum nec opes ad oppugnandum Caelium illis rel<strong>in</strong>quuntur, quid est<br />
aliud quod nos patroni facere debeamus, nisi ut eos, qui <strong>in</strong>sectantur, repellamus? Quod quidem facerem vehementius, nisi<br />
<strong>in</strong>tercederent mihi <strong>in</strong>imicitiae cum istius mulieris viro-- fratre volui dicere; semper hic erro.” Lo conferma anche nelle Epistulae<br />
ad Atticum. [Noli, <strong>in</strong>quam, de uno pede sororis queri; licet etiam alterum tollas. (Non lamentarti del fatto che tua sorella ti concede<br />
un solo piede; puoi prenderti anche l’altro). Op. cit., 21 (II,1)].<br />
17 Epiteto omerico riservato alla dea Era. Cicerone lo utilizzò <strong>in</strong> senso dispregiativo per denunziare maliziosamente i rapporti <strong>in</strong>cestuosi che si vociferava lei avesse con il<br />
fratello. (Epistulae ad Atticum, op. cit., II, 9). Lo stesso <strong>Catullo</strong> sembra confermarlo nel Carme LXXIX.<br />
18 Si dice che morì consunto dalla tisi o di crepacuore. Ignoro su quale base, dato che le pr<strong>in</strong>cipali fonti storiche non fanno alcuna menzione <strong>in</strong> merito alla cattiva salute<br />
del poeta. Risulta <strong>in</strong>vece più facile ritenere che una condotta di vita piena di stravizi gli avesse causato qualche malore improvviso, portandolo all’immatura scomparsa.
Una “storia” maledettamente travagliata.<br />
Da una attenta lettura dei Carmi si ha la netta sensazione che il cielo relazionale affettivo di <strong>Catullo</strong> spasimante e<br />
amante di Lesbia fu sempre denso di scure nuvolaglie, più che mai foriere di <strong>in</strong>evitabili burrasche. Clodia fu<br />
donna elegante, colta e raff<strong>in</strong>ata, ciò è storicamente appurato, ma allo stesso tempo creatura con la coscienza del<br />
piacere, estremamente libera, spregiudicata e trasgressiva, nell’azione e nei modi di porgersi. Nelle poesie<br />
Catulliane tutto ciò è tangibile e riscontrabile, attraverso gli stati d’animo del poeta, impietosamente condizionati<br />
dalla impossibile e quanto mai volubile creatura - “mea vita”(CIX), ci dice esplicitamente, nel bene e nel male –<br />
causa scatenante di uragani passionali ospitati <strong>in</strong> pionieristici monologhi drammatici.<br />
Il più delle volte gli assòlo poetici magnificano l’amore senza riserve, ma non di rado si traducono <strong>in</strong> filmica di un<br />
uomo leso nella sua dignità, per via dei numerosi tradimenti perpetrati dalla donna ai danni del quanto mai cotto<br />
artista. In altre circostanze prorompe il desiderio del bardo lat<strong>in</strong>o di rimuovere per sempre la causa delle sue<br />
<strong>in</strong>f<strong>in</strong>ite afflizioni dall’io cosciente. Poeta romantico e sempre attuale, dunque, <strong>Gaio</strong> <strong>Valerio</strong>, per l’energia che sa<br />
fare prorompere da versi brevi, dai contorni nitidi e decisivi, più che mai sofferti e sentiti. Parole e ritmi lirici, il<br />
più delle volte sono pervasi da una vena di mal<strong>in</strong>conica rassegnazione, che cattura il lettore sensibile e lo fionda <strong>in</strong><br />
balia di vitali sensazioni <strong>in</strong>neggianti alla religione della carne e del sangue, come, per esempio, <strong>in</strong> “Odi et Amo” 19<br />
e <strong>in</strong> “Vivamus mea Lesbia”. Quando leggi i versi Catulliani non ti stanchi mai, simili come sono ad una ipnotica<br />
tarantata, che ti porta tuo malgrado a ritornarci sopra, a rileggerli e ancora a straleggerli, perché la tua anima<br />
giunge a reclamarne la consangu<strong>in</strong>eità. Drammaticamente, sentimentalmente, <strong>in</strong>somma, maledettamente<br />
co<strong>in</strong>volgenti. Un dono questo riveniente da Lesbia - la “musa ispiratrice” di <strong>Catullo</strong> - elargito senza condizioni agli<br />
estimatori del bardo lat<strong>in</strong>o.<br />
7<br />
<strong>“Lesbia”</strong><br />
Nell’immag<strong>in</strong>ario del pittore <strong>in</strong>glese preraffaellita<br />
John Re<strong>in</strong>hard Weguel<strong>in</strong> ( 1849-1927 )<br />
Dip<strong>in</strong>to del 1878<br />
19<br />
Già Teognide di Megara Isea (Sicilia), vissuto probabilmente nella seconda metà del VI a. C., aveva espresso una immag<strong>in</strong>e<br />
simile (Libro I delle sue Elegie) rivolgendosi a Cirno, il giovane da lui amato “Il mio cuore è <strong>in</strong> difficoltà per il tuo<br />
amore:/<strong>in</strong>fatti non ho la forza di odiare né di amare,/ pur sapendo che è difficile odiare,/quando un uomo ha una persona<br />
cara,/è difficile anche amare chi non vuole essere amato.” Cfr.: “Il miele di Afrodite”, a cura di Mar<strong>in</strong>a Cavalli, Mondatori,<br />
1991, pag.53, vv.1091-1094. Altrettanto aveva fatto Anacreonte (570?-480? a.C.), poeta nato a Teo, <strong>in</strong> Asia m<strong>in</strong>ore: “Amo e<br />
non amo, sono/pazzo e non sono pazzo”. Cfr.: B. Gentili, Anacreon Teius, Roma, 1958, pag. 20, fr. 46. Similmente Sofocle<br />
(497-406 a.C.), aveva scritto: “Ti ho odiato e ti ho amato nello stesso giorno”, Elettra, v. 1363, <strong>in</strong>:<br />
http://www2.classics.unibo.it/Didattica/Programs/20062007/Pasetti/<strong>Catullo</strong>Epigrammi.pdf.
8<br />
Clodia-Lesbia dopo <strong>Catullo</strong><br />
Di Clodia non si sa più nulla dopo il 56. I successivi richiami epistolari del 45 e del 44<br />
ad opera di Cicerone fanno pensare che ella fosse ancora attiva e ricca, ammesso che si<br />
parli di lei e non di una sorella. L’Arp<strong>in</strong>ate, <strong>in</strong>fatti, dopo avere pubblicamente detto di<br />
lei peste e corna, si mostra <strong>in</strong>teressato all’acquisto <strong>in</strong> contanti (“repraesentatione”) di<br />
un suo ameno parco con villa sulla riva destra del Lungotevere, gli “horti Clodiae” (Pro<br />
Cael., 36) 20 . Ma gli affari sono affari: “Scripsisti tamen nescio qui de Clodia. Ubi ergo ea<br />
est aut quando ventura? Placet mihi res sic ut secundum Othonem nihil magis. Sed neque<br />
hanc vendituram puto (delectatur enim et copiosa est), et illud alterum quam sit difficile te<br />
non fugit. Sed, obsecro, enimatur ut aliquid ad id cupio excogitemus.” (M. T. Cicerone<br />
“Epistulae ad Atticum”, xii. 42, 1-2. Cfr. anche xiii, 29, 1-2. ) 21 [Hai scritto non so cosa ne<br />
sia di Clodia. Ma dov’è che si trova dunque, o quando verrà? L’affare con lei mi sembra<br />
conveniente, tanto che subito dopo quello con Otone (il parco di Scapula) nessun altro mi<br />
alletterebbe di più. Ritengo tuttavia che lei non venderà (il luogo la soddisfa sul serio ed è<br />
ricca), e, quanto all’altra operazione, non ti sfugge quante difficoltà presenti. Ma <strong>in</strong> nome<br />
del cielo, sforziamoci di escogitare qualcosa per realizzare ciò che desidero]. “Eo magis<br />
delabor ad Clodiam … Sed quando Clodia Romae futura est et quanti rem<br />
aestimas?”Ibidem, xii, 47. [Propendo sempre più per le trattative con Clodia … Ma<br />
quando si troverà a Roma Clodia e quanto ritieni che ammonti il costo dell’operazione?].<br />
Non è escluso che Clodia mirasse all’acquisto dei bellissimi “horti Scapulani”, parco<br />
con villa annessa, all’altezza dell’odierno Lungotevere della Farnes<strong>in</strong>a, ai quali, come<br />
si è già visto, era <strong>in</strong>teressato lo stesso Cicerone: “Clodia quid egerit scribas ad me velim.”<br />
(Ibidem, xiv. 8, 2). [Ti pregherei di comunicarmi che cosa abbia fatto Clodia]. “Si quaeris<br />
quid optem, primum Scapulae, de<strong>in</strong>de Clodiae.” Ibidem, xii. 41. [Se vuoi sapere cosa<br />
desidero, prima i giard<strong>in</strong>i di Scapula, poi quelli di Clodia]. Risulta evidente che<br />
l’Avvocato stimasse tali “horti” come luoghi ideali per costruire il sacello dest<strong>in</strong>ato ad<br />
eternare la memoria della figlia Tullia scomparsa nel 45. (Ibidem, xii. 29, 2 e xiii, 29).<br />
Ma non ne acquisirà nessuno, verosimilmente per via dell’imm<strong>in</strong>ente entrata <strong>in</strong> vigore<br />
di una legge cara a Giulio Cesare, che prevedeva l’esproprio di terreni <strong>in</strong> ampie zone<br />
del Lungotevere, nell’ambito di un piano edilizio non meglio specificato. (Ibidem, xiii,<br />
33a,1).<br />
In ogni caso si ha la netta sensazione che s<strong>in</strong> dal pr<strong>in</strong>cipio l’Arp<strong>in</strong>ate non nutrisse<br />
molte speranze sul buon esito dell’acquisto della tenuta Scapulana, poiché il prezzo di<br />
vendita imposto sull’<strong>in</strong>tera proprietà dall’avido Otone (ib., xii, 42) - uno degli eredi di<br />
T. Qu<strong>in</strong>ctius Scapula autorizzato a condurre qualunque trattativa di cessione dagli<br />
altri beneficiari Crispo, G. Virgilio e Mustela (ibidem, xii 5a; xii,44; xiii,26) - risultava<br />
proibitivo f<strong>in</strong>anche per le sue notevoli disponibilità f<strong>in</strong>anziarie. Solo se ciascuno dei<br />
successori avesse di persona messo all’asta la parte ereditata, la transazione avrebbe<br />
avuto qualche possibilità di concludersi positivamente (Ibidem, xii, 42,4; xii, 43, 2).<br />
L’assenza di ulteriori riferimenti sulla faccenda nelle lettere ad Attico porta a pensare<br />
che anche Clodia abbandonasse la partita per le stesse ragioni.<br />
20<br />
Marco Tullio Cicerone, In difesa di Marco Celio (Pro Caelio), a cura di A. Cavarzere, Venezia, Marsilio, 1987.<br />
21<br />
T. Pomponio Attico, Roma, 109-32 a.C. Amico d’<strong>in</strong>fanzia dell’Arp<strong>in</strong>ate e primo raccoglitore delle Epistulae, <strong>in</strong><br />
quanto libraio ed editore.
9<br />
I Carmi sono stati raggruppati (s’ignora da chi) per "tipo", senza tenere conto del loro ord<strong>in</strong>e<br />
cronologico:<br />
I carmi 1 - 60, def<strong>in</strong>iti nugae, "coserelle", trattano <strong>in</strong> tono apparentemente giocoso e spensierato vari temi<br />
come l'amore, la politica o le amicizie. Si presentano <strong>in</strong> versi polimetri. In essi traspare la profonda e<br />
quanto mai tormentata personalità del loro autore. Qui si trovano le liriche che più manifestano gli<br />
antitetici sentimenti che <strong>Catullo</strong> provò per Lesbia. Costei, libera dal v<strong>in</strong>colo matrimoniale dopo<br />
l’improvvisa dipartita del marito, amava farsi consolare dai tanti giovani farfalloni della Roma bene, fra cui<br />
il poeta, che <strong>in</strong>vece sognava di essere l'unico. La donna, non gli concederà mai tale gioia.<br />
I carmi 61 - 68, i cosiddetti carm<strong>in</strong>a docta, sono <strong>in</strong> esametri. Essi si mostrano più lunghi e più complessi.<br />
Gli studiosi vi hanno ravvisato un maggiore impegno compositivo da parte di <strong>Catullo</strong>, oltre che la forte<br />
l'<strong>in</strong>fluenza stilistico-letteraria esercitata sul bardo veronese dalla poetessa Saffo di Lesbo, vissuta <strong>in</strong>torno<br />
al VII a.C.<br />
I carmi 69 - 116, gli epigrammata, (epigrammi ed elegie) si presentano <strong>in</strong> distici elegiaci di varia lunghezza<br />
ed argomento. Si può dire che le tematiche trattate siano sostanzialmente quelle del primo gruppo. IL<br />
carme 95 è da molti considerato il Manifesto Neoterico.<br />
L’amore per <strong>Catullo</strong><br />
<strong>Catullo</strong> è l’emblema dell'uomo che consapevolmente si lascia risucchiare dai gorghi passionali di<br />
una relazione amorosa disagiata con una creatura femm<strong>in</strong>ile smodatamente dissoluta. Ci troviamo di<br />
fronte ad una vera e propria attrazione fatale.<br />
C’è da dire, poi, che la concezione Catulliana dell’amore è completamente nuova rispetto alla austera<br />
tradizione romana, che conferiva dignità solo all’unione matrimoniale, considerando fuggevoli<br />
licenze le carnali effusioni extraconiugali (stupri consuetudo). Per il poeta sirmionese il legame con<br />
Lesbia, per quanto vissuto con orgogliosa rivendicazione della sua trasgressività contro la rigidezza<br />
dei moralisti, poggia <strong>in</strong> ogni caso su una <strong>in</strong>tesa che implica fedeltà, lealtà, devozione assoluta,<br />
amicizia, stima, rispetto. Sicché la sua vicenda sentimentale, per quanto drammaticamente fuggevole<br />
possa mostrarsi, possiede per <strong>Catullo</strong> valenza morale non <strong>in</strong>feriore a quella di una unione legittima.<br />
Va da sé, qu<strong>in</strong>di, che il Foedus, 22 il patto d’amore rotto da Lesbia, trasformi ben presto il suo<br />
spasimante <strong>in</strong> un malato angustiato da febbrile delirio passionale (taetrum morbum - LXXVI). Una<br />
patologia a decorso maligno questa, che verosimilmente riuscì a m<strong>in</strong>are e dissipare le sue forze<br />
vitali. Con <strong>Gaio</strong> <strong>Valerio</strong>, <strong>in</strong>somma, si afferma quel modo di sentire e rappresentare l’amore come<br />
passione esclusiva, globale e irrazionale, che è stata all’orig<strong>in</strong>e dell’elegia dei poeti augustei e di<br />
tanta parte della poesia moderna.<br />
La giovane donna, <strong>in</strong> atteggiamento pensoso, regge un<br />
polittico e porta alle labbra uno stilo<br />
Napoli - MN<br />
Dip<strong>in</strong>to r<strong>in</strong>venuto a Pompei (Villa<br />
dei Misteri). Secondo taluni studiosi<br />
l’effigie femm<strong>in</strong>ile raffigurata<br />
rappresenterebbe la poetessa Saffo<br />
di Lesbo. Secondo altri una nobile<br />
fanciulla appartenente ad una gens<br />
locale (gruppo di famiglie che<br />
condividevano lo stesso nomen,<br />
ovvero, l’equivalente del nostro<br />
cognome) .<br />
22 Cfr. Carme 109. Bit<strong>in</strong>ia, con capitale Nicea – Asia M<strong>in</strong>ore.
Pompei – Terme dell’amore<br />
La prima raffigurazione saffica<br />
della storia romana.<br />
10<br />
23<br />
Iscrizione con immag<strong>in</strong>e fallica <strong>in</strong> bassorilievo accanto all’accesso ad un lupanare a Pompei 24<br />
Moneta argentea romana (recto e verso)del I sec. A.D. 25<br />
23<br />
In: http://www.oliari.com/storia/pompei.html.<br />
24<br />
“Lupanare” deriva dalla voce lat<strong>in</strong>a “lupa”, ovvero prostituta. Nell’iscrizione è chiaramente leggibile “HIC<br />
HABITAT FELICITAS” (QUI DIMORA LA FELICITÀ).<br />
25<br />
Alcuni studiosi hanno ipotizzato che monete del genere fossero gettoni d’<strong>in</strong>gresso a bordelli e bagni promiscui di<br />
prima classe. I gestori delle strutture li distribuivano ai loro raff<strong>in</strong>ati clienti <strong>in</strong> cambio di un congruo esborso che<br />
garantiva loro un trattamento di primissimo ord<strong>in</strong>e.
11<br />
“… amorem<br />
hunc nostrum <strong>in</strong>ter nos perpetuumque fore.” 26<br />
Ecco alcuni esempi <strong>in</strong> cui felicità, passione, torturante gelosia, <strong>in</strong>ganni, scappatelle, abbandoni,<br />
riconciliazioni, speranze, delusioni amarissime, <strong>in</strong>vettive, <strong>in</strong>sulti, addii, preghiere disperate turb<strong>in</strong>ano<br />
nell’animo di un uomo senza tempo. Tutto fuoriesce con un lessico poetico ricco e variegato da questo<br />
tzunami emozionale, che uom<strong>in</strong>i d’ogni epoca – sensibili e non – hanno def<strong>in</strong>ito, def<strong>in</strong>iscono e<br />
cont<strong>in</strong>ueranno a def<strong>in</strong>ire “UNA DANNATA FACCENDA DI CUORE!”<br />
V. La morte <strong>in</strong>combe! Non resta che ubriacarsi … di baci!<br />
Viviamo, mia Lesbia, ed amiamo,<br />
i brontolii dei vecchi troppo austeri<br />
facciamo che cont<strong>in</strong>o tutti un soldo!<br />
I soli possono tramontare e ritornare:<br />
per noi, una volta che tramonti la nostra breve luce di vita,<br />
c’è un’unica perpetua notte da dormire.<br />
Dammi mille baci 27 , poi cento,<br />
poi mille altri, poi ancora cento,<br />
poi sempre altri mille, e cento ancora.<br />
E dopo, quando ne avremo accumulati molte migliaia,<br />
li scompiglieremo, per non sapere quanti ce ne siamo dati 28 ,<br />
o perché nessun malvagio ostile possa gettarci il malocchio<br />
sapendo che i baci che ci siamo dati ammontano a tanto. 29 3.300 baci !<br />
Vivamus mea Lesbia, atque amemus,<br />
rumoresque senum seueriorum<br />
omnes unius aestimemus assis!<br />
Soles occidere et redire possunt:<br />
nobis cum semel occidit brevis lux, 5<br />
nox est perpetua una dormienda.<br />
Da mi basia mille, de<strong>in</strong>de centum,<br />
de<strong>in</strong> mille altera, de<strong>in</strong> secunda centum,<br />
de<strong>in</strong>de usque altera mille, de<strong>in</strong>de centum.<br />
De<strong>in</strong>, cum milia multa fecerimus,<br />
conturbabimus illa, ne sciamus,<br />
aut ne quis malus <strong>in</strong>videre possit,<br />
cum tantum sciat esse basiorum.<br />
VII. Ricoprimi di baci <strong>in</strong>f<strong>in</strong>iti come i granelli di sabbia di un deserto o come le stelle <strong>in</strong> cielo …<br />
Chiedi quanti tuoi baci, Lesbia,<br />
mi sian sufficienti e mi avanz<strong>in</strong>o.<br />
Quanto grande è il numero della sabbia libica;<br />
…<br />
o quante numerose stelle, nel silenzio della notte,<br />
contemplano i furtivi amori degli uom<strong>in</strong>i:<br />
se tu mi baci con così tanti baci<br />
basta e avanza a <strong>Catullo</strong> pazzo d’amore …<br />
Quaeris, quot mihi basiationes<br />
tuae, Lesbia, s<strong>in</strong>t satis superque.<br />
quam magnus numerus Libyssae<br />
harenae;<br />
…<br />
aut quam sidera multa, cum tacet nox,<br />
furtivos hom<strong>in</strong>um vident amores:<br />
tam te basia multa basiare<br />
vesano satis et super <strong>Catullo</strong> est …<br />
26 Carm<strong>in</strong>a, CIX. “Questo amore che ci unisce sarà felice e per sempre”.<br />
27 “Basium” è una parola dialettale, presa a prestito dai Celti. Il lat<strong>in</strong>o "puro" avrebbe preferito “osculum”. <strong>Catullo</strong>, come i giovani<br />
d’ogni epoca, predilige un codice l<strong>in</strong>guistico più dis<strong>in</strong>volto e quotidiano, il sermo familiaris.<br />
28 Allora si credeva che la conoscenza precisa di quanto si possedesse fosse di cattivo augurio ed attirasse il malocchio.<br />
29 Cfr.: la versione dialettale tarent<strong>in</strong>a a pag. 12 e quella <strong>in</strong>glese a pag. 19.
12<br />
“Quando una fiamma feroce mi bruciava il cuore”(c. C,7)<br />
“Da mi basia mille…”<br />
Dip<strong>in</strong>to murale con didascalia . Lui dice: “Nolo cum Myrtale/Non voglio farlo con Myrtale” - Pompei – Taverna di Salvius - I sec. A.D.<br />
Napoli – M.N.A.<br />
Il bacio era comunemente <strong>in</strong>dicato con tre vocaboli differenti:<br />
- Osculum/osculari - il bacio di saluto ufficiale fra membri di una famiglia, alle statue raffiguranti<br />
gli dei, alle mulieres <strong>in</strong> pubblico.<br />
- Savium/saviari - il bacio della sfera <strong>in</strong>tima, quello erotico e passionale.<br />
- Basium/basiare - il bacio espressione degli affetti più cari. Secondo gli studiosi il term<strong>in</strong>e non<br />
solo imita il suono naturale che si orig<strong>in</strong>a con il gesto di preparazione delle labbra e l’atto del<br />
baciare vero e proprio, ma sembra anche riprodurre le prime articolazioni verbali dei bamb<strong>in</strong>i<br />
verso madri e nutrici. <strong>Catullo</strong> ha il merito di riutilizzare tale voce, più popolare, ma<br />
probabilmente più congeniale alla sua estetica poetica, <strong>in</strong> direzione di un atto dolce nei confronti<br />
della sua Lesbia-Clodia, per giunta farcito con l’<strong>in</strong>tensa carica passionale ed erotica riscontrabile<br />
nel savium.
13<br />
… ne quis malus <strong>in</strong>videre possit( C.,V,12)<br />
Statuetta lignea del dio Priapo<br />
http://it.geocities.com/artenow/romani.html<br />
Priapo, dio della fertilità, pesa il suo fallo sul piatto di una<br />
bilancia. Il contrappeso è una borsa di monete.<br />
Casa dei Vetti – Pompei<br />
Gettare il Malocchio<br />
Il concetto di “Invidere”, ovvero, di gettare il malocchio, si<br />
rendeva <strong>in</strong> lat<strong>in</strong>o anche con il verbo “fasc<strong>in</strong>are”. Dal<br />
sostantivo “fasc<strong>in</strong>us” o “fasc<strong>in</strong>um”. Quest’ultimo term<strong>in</strong>e<br />
comprendeva anche il significato di membro virile a cui si<br />
attribuiva un efficace potere apotropaico. Tale credenza si<br />
rafforzò maggiormente quando nella penisola italica si diffuse<br />
il culto del dio della fertilità Priapo di Làmpsaco (Ellesponto).<br />
In numerose località prese piede la consuetud<strong>in</strong>e di realizzare<br />
amuleti <strong>in</strong> forma di fallo da appendere ai soffitti delle<br />
abitazioni (t<strong>in</strong>t<strong>in</strong>nabula), o di affrescare le pareti con<br />
l’immag<strong>in</strong>e della div<strong>in</strong>ità ostentante il suo poderoso membro<br />
virile, come simboli di abbondanza e fecondità, e pers<strong>in</strong>o<br />
ciondoli da portare al collo e ai polsi. I cornetti di corallo che<br />
si tengono oggi come portafortuna ne ricordano la forma.<br />
Simulacri del nume si ricavarono, <strong>in</strong>oltre, da blocchi di tufo o<br />
da ceppi di legno stagionati. Essi erano posti a guardia di<br />
vigne, campi coltivati e giard<strong>in</strong>i, <strong>in</strong>sieme con iscrizioni di<br />
monito, miranti a tenere lontani soprattutto i ladri, oltre che il<br />
malocchio e le entità maligne. In genere gli avvertimenti<br />
davano massimo rilievo all’<strong>in</strong>evitabile castigo a cui sarebbero<br />
stati sottoposti coloro che avessero tentato di rubare nelle<br />
proprietà rurali consacrate al nume. Il suo smisurato fallo non<br />
avrebbe esitato a sodomizzarli o a <strong>in</strong>fliggere loro un’altra<br />
punizione sessuale altrettanto umiliante:<br />
“Fem<strong>in</strong>a si furtum facies mihi virve puerve,<br />
haec cunnum, caput hic praebeat, ille nates.”<br />
(“Venga a rubare qui, sotto a chi tocca, una femm<strong>in</strong>a, un uomo, o un ragazzetto:<br />
lei mi darà la fica, lui la bocca ed il terzo il culetto.”) “Carmi priapei”, cura e<br />
traduzione di Cesare Vivaldi, Grandi Tascabili Economici Newton, Roma, 1996,<br />
pp. 58-59. In realtà ai proprietari e gestori di fondi rustici,<br />
boschetti e giard<strong>in</strong>i veniva tacitamente concesso il diritto<br />
di punire sessualmente il ladro colto <strong>in</strong> flagranza. Costui<br />
non aveva scelta: subire o la denuncia e la condanna<br />
esemplare da parte delle autorità.
14<br />
« Lux mea … mea diva … et dom<strong>in</strong>a »<br />
Lui e Lei f<strong>in</strong>almente soli!<br />
Diario di dolci <strong>in</strong>contri furtivi … a casa di un amico …<br />
“… l’aiuto mi venne da Allio.<br />
Egli … a me, alla mia donna diede la sua casa,<br />
perché lì vivessimo il nostro reciproco amore.<br />
E lì entrando con passo leggero la mia dea<br />
si fermò bianca di luce sulla soglia consunta,<br />
puntando il suo piede nel sandalo con un fruscio ...”<br />
. . .<br />
“E affasc<strong>in</strong>ante …<br />
la luce mia <strong>in</strong> un abbraccio si str<strong>in</strong>se al mio grembo …”<br />
… e a casa sua. Donna con collana ed orecch<strong>in</strong>i<br />
. . . Pompei - I sec. A.D.<br />
“… non fu certo la mano del padre che la condusse,<br />
avvolta di profumi orientali, nella mia casa,<br />
ma lei stessa, fuggendo dalle braccia del marito,<br />
a me si donò furtiva <strong>in</strong> una notte di sogno.<br />
E questo mi basta se lei ricorderà felici<br />
quegli istanti che solo a me, a me solo ha donato.” 30<br />
Acconciatura Flaviana<br />
Musei Capitol<strong>in</strong>i<br />
Palazzo Nuovo - Roma<br />
30 La stupenda <strong>in</strong>terpretazione italiana dei vv. 66-72/ vv. 131-132/ vv.143-148 nel carme LXVIII, è tratta dal testo: <strong>Gaio</strong><br />
<strong>Valerio</strong> <strong>Catullo</strong>, Le poesie, i grandi libri Garzanti, <strong>in</strong>troduzione, traduzione e note di Mario Ramous, prefazione di Luca<br />
Canali, XVI edizione, aprile 2004, pp. 187-188 e pag. 191.
15<br />
CII. Chi disprezza apprezza…<br />
Lesbia parla sempre male di me e non la smette mai<br />
di sparlare di me: possa morire, se Lesbia non m'ama.<br />
Quale prova ne ho? Perché sono le mie stesse: la maledico<br />
cont<strong>in</strong>uamente, ma possa morire se non la amo.<br />
CIX. Il patto di amore eterno 31 …<br />
Vita mia adorata, affermi che questo<br />
amore che ci unisce sarà felice e per sempre.<br />
Dei del cielo, fate che possa promettermelo s<strong>in</strong>ceramente,<br />
e che dica queste cose per davvero<br />
e dal profondo del suo cuore,<br />
perché ci sia concesso tener fede, tutta una vita,<br />
a questo patto eterno di sacro amore.<br />
… perdito amore… 32<br />
Lesbia mi dicit semper male nec tacet umquam<br />
de me: Lesbia me dispeream nisi amat.<br />
quo signo? quia sunt totidem mea: deprecor<br />
illam<br />
assidue, verum dispeream nisi amo.<br />
Iucundum, mea vita, mihi proponis amorem<br />
hunc nostrum <strong>in</strong>ter nos perpetuumque fore.<br />
di magni, facite ut vere promittere possit,<br />
atque id s<strong>in</strong>cere dicat et ex animo,<br />
ut liceat nobis tota perducere vita<br />
aeternum hoc sanctae foedus amicitiae.<br />
Amori di Polifemo e Galatea<br />
Casa dei Capitelli colorati<br />
particolare<br />
Pompei 50-79 d.C.<br />
31<br />
Giurare o dare la parola per un romano era cosa sacra. <strong>Catullo</strong> <strong>in</strong> cuor suo sa bene che l’<strong>in</strong>dole di Lesbia è quella di essere bella ma<br />
perfida, nel senso lat<strong>in</strong>o dell’accezione, ossia, sleale, <strong>in</strong>gannatrice. Per questo prega gli dei “ut vere promittere possit”.<br />
32<br />
Carm<strong>in</strong>a, XCI. “Amore perduto, amore disperato”.
16<br />
Stamnos greco<br />
La poetessa Saffo di Skala Eressou (Lesbo) legge seduta una delle sue poesie <strong>in</strong> mezzo a tre leggiadre auditrici.<br />
440-430 a.C circa<br />
Atene – Museo Nazionale Archeologico<br />
<strong>Catullo</strong> non di rado mutuò la struggente forza della passione, la mal<strong>in</strong>conia dell’essere e i delicati moti<br />
dell’animo espressi da Saffo per trasfonderli con stile “nuovo” <strong>in</strong> certe liriche dedicate alla sua Clodia-<br />
Lesbia. Un esempio riviene dal frammento XXXI che al poeta dovette evidentemente ispirare il carme LI ,<br />
divenuto famoso quanto l’orig<strong>in</strong>ale (Cfr. pag. 1):<br />
“… come, anche per poco, ti guardo ecco che non riesco più a parlare, ma la l<strong>in</strong>gua è<br />
spezzata, un fuoco sottile sotto la pelle si è diffuso rapidamente, con gli occhi nulla vedo, le<br />
orecchie ronzano, su me il sudore si spande e un tremito tutta mi cattura, più verde dell' erba<br />
sono, poco lontana dall’essere morta sembro a me stessa ...”<br />
[L’<strong>in</strong>terpretazione è presente nel magnifico e circostanziato saggio di 74 pag<strong>in</strong>e di Gennaro Tedeschi: “Università<br />
degli studi di Trieste – Saffo – Biografia ed Antologia di Versi, a cura di Gennaro Tedeschi – Trieste, 2005”, pagg.<br />
33-34 <strong>in</strong>: http://www.sslmit.univ.trieste.it/crevat<strong>in</strong>/documenti/saffo.pdf.]
17<br />
VIII. Resistere! Resistere! Resistere!<br />
Misero <strong>Catullo</strong>, smetti d’impazzire:<br />
e ciò che vedi esser perso consideralo perduto.<br />
Una fiammata di gioia un tempo i tuoi giorni<br />
quando ti precipitavi dove lei, l'anima tua voleva,<br />
amata come amata non sarà nessuna:<br />
Lì, quando si compivano quei tanti giochi d’amore,<br />
che tu volevi né lei non voleva,<br />
davvero ti rifulsero candidi soli.<br />
Ora lei non vuole piú: e tu pure, coraggio, non volere,<br />
non <strong>in</strong>seguirla, come un miserabile, se fugge,<br />
ma con tutta la tua volontà sopporta, non cedere.<br />
Addio, ragazza. <strong>Catullo</strong> ormai resiste,<br />
non verrà a cercarti, né ti pregherà più se tu rifiuti:<br />
e tu rimpiangerai di non essere più pregata.<br />
Malvagia, guai a te, che vita ti rimane?<br />
Chi ti avvic<strong>in</strong>erà ora? A chi sembrerai car<strong>in</strong>a?<br />
Chi ora amerai? Di chi dirai di essere?<br />
E chi bacerai? A chi le labbra morderai?<br />
Ma tu, <strong>Catullo</strong>, ost<strong>in</strong>ato resisti.<br />
LXXXVII. Nessuna al mondo fu così amata…<br />
… Nessuna donna può dirsi tanto amata<br />
davvero, quanto la mia Lesbia è stata amata da me.<br />
Nessuna lealtà fu mai tanta per alcun patto,<br />
quanta se ne vide <strong>in</strong> me nell’amore che ti portai.<br />
Nulla potest mulier tantum se dicere amatam<br />
vere, quantum a me Lesbia amata mea est.<br />
nulla fides ullo fuit umquam foedere tanta,<br />
quanta <strong>in</strong> amore tuo ex parte reperta mea est.<br />
Miser Catulle, des<strong>in</strong>as <strong>in</strong>eptire,<br />
et quod vides perisse perditum ducas.<br />
fulsere quondam candidi tibi soles,<br />
cum ventitabas quo puella ducebat<br />
amata nobis quantum amabitur nulla.<br />
ibi illa multa cum iocosa fiebant,<br />
quae tu volebas nec puella nolebat,<br />
fulsere vere candidi tibi soles.<br />
nunc iam illa non vult: tu quoque<br />
impotens noli,<br />
nec quae fugit sectare, nec miser vive,<br />
sed obst<strong>in</strong>ata mente perfer, obdura.<br />
vale puella, iam Catullus obdurat,<br />
nec te requiret nec rogabit <strong>in</strong>vitam.<br />
at tu dolebis, cum rogaberis nulla.<br />
scelesta, vae te, quae tibi manet vita?<br />
quis nunc te adibit? cui videberis bella?<br />
quem nunc amabis? cuius esse diceris?<br />
quem basiabis? cui labella mordebis?<br />
at tu, Catulle, dest<strong>in</strong>atus obdura.<br />
LXXVI. Supplica agli dei per la guarigione da una malattia che logora anima e corpo.<br />
È difficile troncare una lunga passione:<br />
è difficile, ma ci devi riuscire <strong>in</strong> qualche modo.<br />
Questa è la sola salvezza, questa la tua vera vittoria;<br />
ma questo fallo, possibile o impossibile che sia.<br />
O dèi, se è vostro compito avere pietà , e se mai offriste<br />
ad alcuno nell’ora della morte un estremo soccorso,<br />
guardate me <strong>in</strong>felice, e se ho vissuto onestamente,<br />
strappatemi a questo male che mi consuma<br />
che <strong>in</strong>s<strong>in</strong>uandosi <strong>in</strong> me come torpore nel fondo delle membra<br />
ha scacciato la gioia dal profondo del mio animo.<br />
Non chiedo già che lei <strong>in</strong>vece ricambi il mio amore,<br />
o, cosa impossibile, che voglia essere onesta;<br />
desidero guarire e liberarmi da questa crudele malattia,<br />
O dèi, accordatemi questo, per la mia devozione.<br />
Difficile est longum subito deponere amorem:<br />
Difficile est, verum hoc qua lubet efficias.<br />
Una salus haec est, hoc est tibi perv<strong>in</strong>cendum:<br />
Hoc facias, sive id non pote sive pote.<br />
O di, si vestrum est misereri, aut si quibus umquam<br />
Exstremo iam ipsa <strong>in</strong> morte tulistis opem,<br />
Me miserum aspicite et, si vitam puriter egi,<br />
Eripite hanc pestem perniciemque mihi,<br />
Quae mihi subrepens imos ut torpor <strong>in</strong> artus<br />
Expulit ex omni pectore laetitias.<br />
Non iam illud quaero, contra ut me diligat illa,<br />
Aut, quod non potis est, esse pudica velit:<br />
Ipse valere opto et taetrum hunc deponere morbum.<br />
O di, reddite mi hoc pro pietate mea.<br />
La musa Calliope suona la lira sulle rocce del monte Elikon (scritta<br />
dietro i talloni). Ai suoi piedi un uccell<strong>in</strong>o ascolta la melodia.<br />
Lekythos – ca. 445 a.C. – Antikensammlungen Monaco - Germania
18<br />
<strong>Catullo</strong> <strong>in</strong> … dialetto cataldiano<br />
Gaie Valerie Catulle, quìnde carme<br />
Ne l’hama gudè’ ’a vite, Lesbia mèje,<br />
e n’hama vambà’ d’amòre, tu e ije.<br />
Nò ù sciame danne adènze 33 o’ tàgghia-tàgghie 34<br />
de le vicchiarrùne arraggiàte,<br />
ca quidde ’nu sorde fàuze 35 nò vvale.<br />
Ce pòtene pònnere le sòle 36<br />
e arréte mèttere le chiaranzàne 37 ,<br />
mò’ ca a nnuje ne ponne<br />
corte a ccome ète<br />
’a luce d’a vita nostre,<br />
’nu sùle ’tèrne scuròrie 38 hama durmè’.<br />
Damme mìle vase, e ppò cciénde,<br />
e ppò mmìle angore, e ppò n’otr’e cciénde,<br />
e rréte a ll’otre une<br />
otr’e mmìle, e arréte ciénde.<br />
Quanne l’hame accucchiàte a mmìle-a-mmìle,<br />
doppe tutte le bagge hama misckà’ 39 ,<br />
pe’ nnò sapè’ cchiù qquande ’nge n’hame date,<br />
e ppiccè nisciùne n’à dda affascenà’ 40<br />
ce se vendelésce 41 ca le bagge<br />
nuestre numùnne honne state. 42<br />
A jièdde à vògghie male e à vògghie ’nnu bbene<br />
pàcce.<br />
Sarà ca tu vuè cu ssè’ a ccome à state.<br />
Nnò mm’ù sàcce spiacà’ mmànghe ije,<br />
ma jè pprobbie accussij’ ’nguèrpe a mmèje,<br />
e mme ssènde fà’ ca stòche ’ngrucefessate. 43<br />
A lei voglio male e voglio bene da morire.<br />
Forse vuoi sapere come sia accaduto.<br />
Non me lo so spiegare nemmeno io,<br />
ma è proprio così dentro di me,<br />
e mi sento come se mi trovassi crocifisso.<br />
33 Dare retta.<br />
34 Critica<br />
35 Un soldo falso.<br />
36 Tramontare.<br />
37 Qui “mèttere” <strong>in</strong> dialetto nostrano significa sorgere , levarsi.<br />
<strong>Gaio</strong> <strong>Valerio</strong> <strong>Catullo</strong>, Carm<strong>in</strong>a, V<br />
Ce la dobbiamo godere, Lesbia mia, la vita,<br />
e dobbiamo ardere d’amore tu ed io.<br />
Non dobbiamo dare retta alle critiche<br />
dei vecchiacci duri e austeri,<br />
ché quelle non valgono un soldo falso.<br />
Se possono tramontare i soli<br />
e un'altra volta sorgere i crepuscoli,<br />
allorché ci tramonterà<br />
effimera com’è<br />
la luce della vita nostra,<br />
un’unica notte perpetua saremo costretti a dormire.<br />
Dammi mille baci, e poi cento,<br />
e poi mille ancora, e poi altri cento,<br />
e senza <strong>in</strong>terruzione<br />
altri mille e nuovamente cento.<br />
Quando ne avremo accumulati molte migliaia<br />
mischieremo poi tutti i baci,<br />
perché più non si sappia quanti ce ne siamo dati,<br />
e perché nessuno possa gettarci il malocchio<br />
se si viene a sapere <strong>in</strong> giro che i baci<br />
nostri sono stati <strong>in</strong> così grande quantità.<br />
Tipologia di antica unità monetaria tarent<strong>in</strong>a:<br />
Didracma d’argento - 430-425 a.C.<br />
Taras, il mitico ecista spartano fondatore di <strong>Taranto</strong>,<br />
cavalca un destriero ed un delf<strong>in</strong>o rispettivamente nel verso<br />
e nel recto della moneta.<br />
38 Una notte senza f<strong>in</strong>e.<br />
39 Mischiare.<br />
40 Gettare il malocchio.<br />
41 Se si porta a conoscenza di tutti.<br />
42 In grande quantità, così tanti.<br />
43 Consulta anche le pagg. 1, 8 e 19. Il Maestro Claudio De Cuia fa notare che nel dialetto tarent<strong>in</strong>o il verbo odiare non<br />
esiste. Rara è pure l’accezione del verbo amare, che si usa esclusivamente per Gesù Cristo, la Madonna e i Santi del<br />
Paradiso. Ecco perché sono stato costretto ad utilizzare <strong>in</strong> loro vece rispettivamente i verbi volere male e volere bene.
19<br />
Tavola Peut<strong>in</strong>geriana (o Tabula Peut<strong>in</strong>geriana). È una copia del XIII secolo di un'antica mappa romana che<br />
mostrava le vie militari dell'Impero. Essa, lunga m. 6.75, si basa sulla carta del mondo, l’Orbis pictus, fatta<br />
disegnare dal generale/ammiraglio Marco Vipsanio Agrippa (64 a.C. – 12 a.C), amico dall’<strong>in</strong>fanzia e genero<br />
dell'imperatore Cesare Augusto (63-14 a.C.), avendone sposato la figlia Giulia. Alla morte di Agrippa la carta<br />
venne scolpita su marmo e collocata nel Porticus Vipsaniae, non distante dall’Ara Pacis. Ciò avveniva<br />
quarant’anni dopo la scomparsa di <strong>Catullo</strong>. Il particolare mostra la Puglia e <strong>Taranto</strong>. In basso a destra asse<br />
coniato dopo il terzo consolato di M. V. Agrippa. Moneta ritrovata <strong>in</strong> una campagna nell’agro di Barletta.
CRONOLOGIA CATULLIANA<br />
87 data di nascita di <strong>Catullo</strong> secondo la testimonianza di Gerolamo.<br />
84 data di nascita di <strong>Catullo</strong> secondo la ricostruzione dei filologi.<br />
57 anno di partenza per la Bit<strong>in</strong>ia, al seguito di <strong>Gaio</strong> Memmio, propretore di quella prov<strong>in</strong>cia<br />
56 anno di ritorno dalla Bit<strong>in</strong>ia (cfr. carm. 10, 28, 46).<br />
58 data di morte di <strong>Catullo</strong> secondo la testimonianza di Gerolamo, a trent’anni di vita.<br />
54 data di morte secondo la ricostruzione dei filologi (<strong>Catullo</strong> conosce il secondo conso-<br />
lato di Pompeo, carm. 113, che è del 55 a.C., e le imprese di Cesare <strong>in</strong> Gallia e Breta-<br />
gna, cfr. carm. 11, 29 e 45, che avvengono negli anni 55-54 a.C.).<br />
QUALCHE CERTEZZA SULLA VITA DI CATULLO<br />
20<br />
il nome, <strong>Gaio</strong> <strong>Valerio</strong>.<br />
l’orig<strong>in</strong>e, cfr. carm. 67.34 (Verona è colonia con pieno diritto di cittad<strong>in</strong>anza dall’89 a.C.)<br />
famiglia agiata (Suet. Iul. 73.4).<br />
una villa a Sirmione (carm. 31).<br />
una casa a Roma (carm.68); una casa fuori Roma sulla strada per Tivoli (carm. 44).<br />
morte di un fratello, <strong>in</strong> Troade (carm. 101). Pompei – Cupido cacciatore<br />
un viaggio <strong>in</strong> Bit<strong>in</strong>ia, nella cohors amicorum del pretore <strong>Gaio</strong> Memmio (57-56 a.C.), let-<br />
terato egli stesso e amico di letterati.<br />
STORIA E CULTURA ROMANA INTORNO A CATULLO<br />
84 C<strong>in</strong>na viene ucciso durante tafferugli <strong>in</strong> piazza<br />
Primi trattati retorici: la Rhetorica ad Herennium e il De <strong>in</strong>ventione di Cicerone<br />
Probabile data di nascita di <strong>Catullo</strong>.<br />
83 Ritorno di Silla dall’Oriente; nuove proscrizioni sillane.<br />
81 Debutto oratorio di Cicerone (Pro Qu<strong>in</strong>ctio); Silla assume la dittatura.<br />
79 Silla depone la dittatura e si ritira a vita privata.<br />
78 Morte di Silla; ribellione di Sertorio, un ex luogotenente di Mario, <strong>in</strong> Spagna.<br />
77-75 Campagna di Pompeo, già luogotenente di Silla, contro Sartorio.<br />
74 Spedizione di Lucullo contro Mitridate, re del Ponto.<br />
73-71Rivolta dei gladiatori di Capua, capeggiati da Spartaco. Alla f<strong>in</strong>e, Pompeo scon-<br />
figge Spartaco, subentrando a Crasso nella direzione della guerra.<br />
70 Consolato di Pompeo e Crasso; nascita di Virgilio.<br />
68 Cesare è questore.<br />
67 Grazie a una legge speciale, Pompeo è <strong>in</strong>caricato della guerra contro i pirati.<br />
66-64 Pompeo subentra a Lucullo nel comando della guerra contro Mitridate.<br />
65 Nascita di Qu<strong>in</strong>to Orazio Flacco. Anno, forse, del trasferimento di <strong>Catullo</strong> a Roma.<br />
63 Cicerone è console. La “congiura” di Catil<strong>in</strong>a. Nascita di Cesare Ottaviano.<br />
62 Ritorno trionfale di Pompeo dall’Oriente; Cesare è pretore.<br />
61 Probabile data dell’<strong>in</strong>contro di <strong>Catullo</strong> con Lesbia.<br />
60 Primo triumvirato fra Pompeo, Cesare e Crasso: i tre uom<strong>in</strong>i più <strong>in</strong> vista di Roma<br />
si spartiscono una serie di cariche <strong>in</strong> un accordo privato.<br />
59 Cesare è console; nascita di Tito Livio.<br />
58 Cesare è proconsole <strong>in</strong> Gallia; <strong>in</strong>izia la conquista della Gallia transalp<strong>in</strong>a. A Roma<br />
spadroneggiano Clodio (spalleggiato da Cesare) e Milone (spalleggiato da Pom-<br />
peo). Cicerone è mandato <strong>in</strong> esilio, <strong>in</strong> virtù di una legge retroattiva che punisce il<br />
mancato appello al popolo dei Catil<strong>in</strong>ari giustiziati nel 63.<br />
57 Ritorno di Cicerone dall’esilio. <strong>Catullo</strong> parte per la Bit<strong>in</strong>ia.<br />
56 A Lucca, i triumviri si ripartiscono le cariche per i prossimi c<strong>in</strong>que anni. Cesare<br />
prolunga il suo comando militare <strong>in</strong> Gallia, onde term<strong>in</strong>arne la conquista.<br />
55 Pompeo e Crasso sono consoli per la seconda volta; probabile data di morte di<br />
Lucrezio, il cui De Rerum Natura viene fatto circolare postumo.<br />
54 Cesare <strong>in</strong> Gran Bretagna; Crasso va <strong>in</strong> Oriente a combattere i Parti: morirà l’anno<br />
dopo nella battaglia di Carre, mettendo così f<strong>in</strong>e al primo triumvirato. A Roma<br />
imperversano le squadre armate di Clodio e quelle di Milone, dando orig<strong>in</strong>e a<br />
tumulti che preludono al più aperto scontro fra Cesare e Pompeo.<br />
Probabile data di morte di <strong>Catullo</strong>, il cui Liber viene presumibilmente assemblato Nobile matrona del I sec. - Pompei<br />
postumo.
21<br />
Erma con l’iscrizione “Saffo (di) Eresia (Eressos)”<br />
Musei Capitol<strong>in</strong>i - Roma
LXVIII. Disposto a tollerare pers<strong>in</strong>o le SUE scappatelle, purché LEI sia di LUI, per sempre…<br />
… E sebbene ella non si accontenti del solo <strong>Catullo</strong>,<br />
sopporterò le rare <strong>in</strong>fedeltà della mia vereconda signora,<br />
per non essere molestamente geloso al modo degli stolti …<br />
…quae tamen etsi uno non est contenta <strong>Catullo</strong>,<br />
rara verecundae furta feremus herae,<br />
ne nimium simus stultorum more molesti …<br />
LXX. Le promesse scritte nel vento o nell’acqua scivolano via … Verso il nulla …<br />
… LA MIA DONNA DICE DI NON VOLER FARE L'AMORE CON ALTRI,<br />
SE NON CON ME, NEPPURE CON GIOVE, SE LA CORTEGGIASSE.<br />
DICE COSì: MA QUEL CHE LA DONNA DICE ALL'AMANTE FOLLE DI PASSIONE<br />
BISOGNA SCRIVERLO SUL VENTO, SULL'ACQUA CHE SCORRE VELOCE …<br />
… NULLI SE DICIT MULIER MEA NUBERE MALLE Casa di Marte e Venere – Affresco - Pompei<br />
QUAM MIHI, NON SI SE IUPPITER IPSE PETAT.<br />
DICIT: SED MULIER CUPIDO QUOD DICIT AMANTI<br />
IN VENTO ET RAPIDA SCRIBERE OPORTET AQUA …<br />
La cittad<strong>in</strong>a di “Eressos” oggi<br />
22<br />
Il v<strong>in</strong>o dei vitigni di Lesbo era<br />
ritenuto medicamentoso ai<br />
tempi di <strong>Catullo</strong><br />
XI. Incommensurabile sconsolata tenerezza…<br />
Lesbo. Vista dal satellite (<strong>in</strong> alto a destra). Posizione geografica dell’isola rispetto alla Grecia (<strong>in</strong> rosso).<br />
La freccia nella cart<strong>in</strong>a pr<strong>in</strong>cipale <strong>in</strong>dica Eressos, la cittad<strong>in</strong>a natale della poetessa Saffo, VII secolo a.C.
XI. CHE SE NE VADA CON CHI VUOLE! CON ME HA CHIUSO!<br />
… Viva e se la spassi con i suoi amichetti,<br />
che <strong>in</strong> trecento tiene contemporaneamente abbracciati,<br />
non amandone nessuno davvero, ma allo stesso modo<br />
rompendo le reni di tutti;<br />
e non aspetti, come prima, il mio amore,<br />
che per colpa sua è caduto come<br />
fiore al marg<strong>in</strong>e di un prato, dopo che<br />
è toccato da un aratro che passa.<br />
… Cum suis vivat vale atque moechis,<br />
quos simul complexa tenet trecentos,<br />
nullum amans vere, sed identidem omnium<br />
ilia rumpens;<br />
nec meum respectet, ut ante, amorem,<br />
qui illius culpa cecidit velut prati<br />
ultimi flos, praetereunte postquam<br />
tactus aratro est.<br />
LVIII. Cruda esplosione di compianto per la lasciva meretrice<br />
Celio 44 , la nostra Lesbia 45 , la bella Lesbia,<br />
Lesbia la bella, che lei sola, <strong>Catullo</strong>,<br />
più che se stesso e tutti i suoi, amò,<br />
ora negli <strong>in</strong>croci e nei vicoli<br />
spreme i nipoti del magnanimo Remo.<br />
23<br />
ad Marcum Caelium Rufum 46<br />
Caeli, Lesbia nostra, Lesbia illa,<br />
illa Lesbia, quam Catullus unam Etère, conviti e gozzovigli - Pompei - Casa dei Casti amanti<br />
plus quam se atque suos amavit omnes,<br />
nunc <strong>in</strong> quadriviis et angiportis<br />
glubit magnanimi Remi nepotes.<br />
LXXXIII. Un chiodo fisso, che perfora il cervello …<br />
Lesbia, davanti al marito parla molto male di me:<br />
e questa per quello sciocco è la massima gioia.<br />
Mulo, non capisci nulla? Se dimentica di me tacesse,<br />
sarebbe guarita: ora, poiché sbraita e mi <strong>in</strong>sulta,<br />
non solo ricorda, ma, cosa ben più grave,<br />
è furente. Cioè, brucia d’amore e parla. 47<br />
Lesbia mi praesente uiro male plurima dicit:<br />
haec illi fatuo maxima laetitia est.<br />
Mule, nihil sentis? si nostri oblita taceret,<br />
sana esset: nunc quod gannit et obloquitur,<br />
non solum mem<strong>in</strong>it, sed, quae multo acrior est res,<br />
irata est. hoc est, uritur et loquitur.<br />
L’<strong>in</strong>fedeltà di una donna ha consumato anime e<br />
corpi d’ogni tempo, e … cont<strong>in</strong>ua a farlo!<br />
Lo so. Non giurare, depravata.<br />
Ti accusano le trecce ancora umide di unguento profumato,<br />
gli occhi ti accusano, pesanti per l’<strong>in</strong>sonnia,<br />
e il nastro della corona <strong>in</strong>torno ai tuoi capelli.<br />
Guarda i ricci disfatti, garbuglio d’<strong>in</strong>decenza,<br />
e come barcolli tutta per il v<strong>in</strong>o.<br />
Va’ via sgualdr<strong>in</strong>a. Ti chiamano l’arpa,<br />
amica delle orge, e i crepitanti colpi delle nacchere.<br />
Meleagro, ” 130 - 60 a.C. “ Antologia Palat<strong>in</strong>a”.<br />
44 Si tratta forse di Celio Rufo, amante di Lesbia dal 59 al 57, portato <strong>in</strong> tribunale da costei (su istigazione del fratello, per colpire<br />
<strong>in</strong>direttamente il suo avversario politico Pompeo, amico dello scapestrato Celio) con l’accusa di veneficio. Sembra che un tempo<br />
<strong>Catullo</strong> gli fosse stato amico. Poi la relazione passionale di Rufo con la sua Lesbia aveva causato la rottura del loro rapporto di<br />
amicizia. Una <strong>in</strong>dicazione <strong>in</strong> tal senso ci viene dal Carme 77: “Rufo, che senza frutto e <strong>in</strong>vano ho creduto un amico/(senza<br />
frutto?Anzi con grave perdita e danno), così ti/ sei <strong>in</strong>s<strong>in</strong>uato <strong>in</strong> me, e bruciando il mio cuore, oh a me/ <strong>in</strong>felice hai sottratto tutto il<br />
mio bene?Lo hai sottratto,/ahimè, crudele veleno della nostra vita, ahimè rov<strong>in</strong>a/della nostra amicizia.” Anche il Carme100<br />
attesterebbe tale sodalizio. Cfr.: http://www2.classics.unibo.it/Didattica/Programs/20062007/Pasetti/<strong>Catullo</strong>Epigrammi.pdf.<br />
45 Lesbia è esplicitamente menzionata da <strong>Catullo</strong> nei carmi 5, 7, 43, 51, 58, 72, 75, 79, 83, 86, 87, 92, 107. Per contro, risulta<br />
<strong>in</strong>direttamente menzionata nei carmi 2, 3, 8, 11, 13, 36, 37, 68, 70, 76, 77, 85, 100, 104, 109.<br />
46 “A Marco Celio Rufo”, coetaneo di <strong>Catullo</strong>. Vedi nota 38.<br />
47 Qui è evidente che la relazione fra i due fosse già <strong>in</strong> fieri quando il marito di Lesbia era ancora <strong>in</strong> vita.
24<br />
<strong>Catullo</strong><br />
Un <strong>in</strong>vitato alla tavola della vita che bene onora chi l’ospita!<br />
48<br />
“Vivamus mea Lesbia, atque amemus …”<br />
48 Ercolano – “Convivium” - Affresco rappresentante una coppia di amanti. Ca. 50 - 79 A.D.
25<br />
“Hate I, and love I. Wherefore so do I haps thou’lt ask me.<br />
Wot I not, yet so I feel, and I am crucified. ”<br />
“La croce! Metafora del tormento d’amore!”<br />
“Let us live, my Lesbia, let us love…”<br />
Satiro e N<strong>in</strong>fa - Casa degli Epigrammi - Pompei<br />
Intonaco dip<strong>in</strong>to - Stabia - ca. 55-79 a.C. - M.A.N. - Napoli<br />
G. V. Catullus, “Lyrical poems”, LXXXV<br />
(cfr.: versioni italiana e lat<strong>in</strong>a <strong>in</strong> prima pag<strong>in</strong>a)<br />
by<br />
Enrico Vetrò<br />
“Let us live, my Lesbia, let us love;<br />
and all the mutter<strong>in</strong>gs of crabbed old<br />
men<br />
let us judge worth be<strong>in</strong>g just one<br />
farth<strong>in</strong>g.<br />
Fall and rise may suns over and over;<br />
to us, whenas our short light hath once<br />
set,<br />
to be slept rema<strong>in</strong>s<br />
of a sole endless night the slumber.<br />
Give me of kisses a thousand, then a<br />
hundred,<br />
another thousand next, a second<br />
hundred that after,<br />
yet more thousand, yet aga<strong>in</strong> a<br />
hundred more.<br />
Then, when we have made up many<br />
thousands,<br />
we will m<strong>in</strong>gle them, that we<br />
may not know the reckon<strong>in</strong>g,<br />
nor anyone malicious blight them with<br />
evil eye,<br />
know<strong>in</strong>g of kisses so a large number<br />
betwixt th<strong>in</strong>e own and m<strong>in</strong>e. ”<br />
G. V. Catullus, “Lyrical poems”, V<br />
by<br />
Enrico Vetrò
26<br />
Mappa di Roma Catulliana<br />
LXXII. Amare di più … volere bene di meno 49 …<br />
Dicevi che conoscevi solo <strong>Catullo</strong>, una volta,<br />
Lesbia, e che a paragone di me non avresti voluto tenere Giove.<br />
Ti volli bene allora non come ne vuole la gente ad<br />
un’amante, ma come il padre ai figli e ai generi.<br />
Ora so chi sei: e anche se più <strong>in</strong>tenso è il desiderio<br />
tuttavia sei diventata sempre più <strong>in</strong>significante e vile.<br />
Come è possibile, tu chiedi? Perché chi ama, un tale tradimento<br />
lo costr<strong>in</strong>ge ad amare di più, ma a voler bene di meno.<br />
Dicebas quondam solum te nosse Catullum,<br />
Lesbia, nec prae me uelle tenere Iouem.<br />
dilexi tum te non tantum ut uolgus amicam,<br />
sed pater ut gnatos diligit et generos.<br />
nunc te cognoui: quare etsi impensius uror, 5<br />
multo mi tamen es uilior et leuior.<br />
qui potis est, <strong>in</strong>quis? quod amantem <strong>in</strong>iuria talis<br />
cogit amare magis, sed bene uelle m<strong>in</strong>us.<br />
LXXV. Anima ridotta a brandelli …<br />
A tal punto [mi] si è ridotta l’anima, o mia Lesbia, per<br />
colpa tua, e così si è perduta per avere compiuto il suo<br />
dovere, che non può più né volerti bene, anche se<br />
diventassi la migliore delle donne, né cessare di amarti,<br />
qualunque cosa tu faccia.<br />
Huc est mens deducta tua mea, Lesbia, culpa<br />
atque ita se officio perdidit ipsa suo,<br />
ut iam nec bene velle queat tibi, si optima fias,<br />
nec desistere amare, omnia si facias.<br />
49 Il dualismo presente nella sottigliezza sentimentale dovrebbe essere così <strong>in</strong>tesa: la passione (amare) non risulta<br />
<strong>in</strong>taccata dai cont<strong>in</strong>ui tradimenti di Lesbia; piuttosto, vengono progressivamente a mancare la stima e l’affetto<br />
(bene velle) che il poeta nutre nei confronti di lei.
27<br />
Le Tre Grazie (Charites) – Affresco proveniente dalla casa di Titus<br />
Dentatus Panthera - Artista ignoto - Pompei - ca.65-79 A.D.<br />
Napoli - Museo Archeologico Nazionale<br />
CVII. A volte, <strong>in</strong>speratamente, LEI ritorna …e il sogno si ammanta di ardente dolcezza<br />
Se mai ti succede ciò che sognavi tanto, qualcosa che ti sei augurato<br />
senza sperarlo, questa è la vera gioia del tuo cuore.<br />
È per questo che anche a me fa piacere ed è più caro dell'oro<br />
che tu ritorni da me, Lesbia, sogno mio.<br />
Ti restituisci ad uno pieno di desiderio - che non sperava più - … di nuovo<br />
a me ti doni. Oh luce dal segno troppo candido! 50<br />
Chi è <strong>in</strong> vita più felice di me? Unico! O chi potrà<br />
dire che c’è da volere di più <strong>in</strong> questa esistenza?<br />
Si quicquam cupido optantique optigit umquam<br />
<strong>in</strong>speranti, hoc est gratum animo proprie.<br />
Quare hoc est gratum nobis quoque carius auro<br />
quod te restituis, Lesbia, mi cupido.<br />
Restituis cupido atque <strong>in</strong>speranti, ipsa refers te<br />
nobis. O lucem candidiore nota!<br />
Quis me uno vivit felicior aut magis hac est<br />
optandus vita dicere quis poterit?<br />
50 Intendi: “Oh, giorno di splendore!” Ovvero giorno da ricordare tra tutti.
28<br />
Forse “Lei” era così …<br />
Fanciulla versante profumo <strong>in</strong> un’ampolla – I sec. A.D. Affresco di villa Farnes<strong>in</strong>a - Roma - Museo Nazionale<br />
XLIII. … occhietti neri, dita affusolate, labbra piccole, piede aggraziato, parlata elegante …<br />
Salve, fanciulla 51 dal naso non m<strong>in</strong>imo<br />
né dal piede grazioso né dai neri occhietti<br />
né dalle dita affusolate né dalla bocca asciutta,<br />
né proprio dalla l<strong>in</strong>gua troppo elegante,<br />
amica del bancarottiere formiano.<br />
La prov<strong>in</strong>cia dice forse che sei graziosa?<br />
A te si paragona la nostra Lesbia?<br />
O secolo ignorante ed <strong>in</strong>sulso!<br />
Salve, nec m<strong>in</strong>imo puella naso<br />
nec bello pede nec nigris ocellis<br />
nec longis digitis nec ore sicco,<br />
nec sane nimis elegante l<strong>in</strong>gua,<br />
decoctoris amica Formiani.<br />
ten prov<strong>in</strong>cia narrat esse bellam?<br />
tecum Lesbia nostra comparatur?<br />
o saeclum <strong>in</strong>sapiens et <strong>in</strong>facetum!<br />
51 Si tratta di Ameana, amica di Mamurra (“il bancarottiere formiano”. Cfr. Carmen LVII, pag. 33). A lei è dedicato<br />
anche il Carme XLIII. Con la tecnica poetica della negazione o del contrasto il poeta sembrerebbe ritrarre Lesbia.
29<br />
o… così…<br />
“Lesbia formosa est, quae cum pulcerrima tota est,<br />
tum omnibus una omnis surripuit Veneres." 52<br />
F<strong>in</strong>e e graziosa, <strong>in</strong>somma!<br />
52 <strong>Catullo</strong>, Carme LXXXVI, vv. 5-6: “È di belle forme Lesbia, lei non solo è bellissima tutta nell’<strong>in</strong>sieme,/ ma anche lei da sola a tutte<br />
le altre ha sottratto le Grazie.” Non si deve escludere che a Cicerone piacessero molto la “flagrantia oculorum” di Clodia (“ gli occhi<br />
sc<strong>in</strong>tillanti/occhi di fuoco”, cfr. pag. 4, nota 11) e non solo quelli. Risulta <strong>in</strong>oltre che fossero vic<strong>in</strong>i di casa sul colle Palat<strong>in</strong>o.<br />
La gelosia di Terenzia, l’arcigna moglie dell’avvocato, giocò un ruolo storico fondamentale. Quasi certamente fu costei ad <strong>in</strong>durlo a<br />
testimoniare contro Clodio nel noto processo a suo carico per oltraggio, per dimostrare con i fatti che il suo Marco Tullio aveva<br />
<strong>in</strong>terrotto ogni tipo di rapporto con l’avvenente sorella.(Cfr. pag. 3, nota 7).
Lesbia <strong>in</strong> lutto<br />
30<br />
Afrodite tra le braccia di Marte, mentre Cupido e Phobos? giocano con le armi del dio.<br />
I sec. A.D. - Museo Archeologico Nazionale - Napoli<br />
Piangete, o Veneri e Cupidi,<br />
e quanto c'è di uom<strong>in</strong>i più belli:<br />
il passero della mia ragazza è morto,<br />
il passero, delizia della mia ragazza,<br />
che lei amava più dei suoi occhi.<br />
Era dolcissimo e la riconosceva proprio<br />
così bene come una ragazza la sua mamma,<br />
e non si muoveva dal suo grembo,<br />
ma saltellando attorno or qua or là<br />
sempre verso la sola padrona pigolava.<br />
Ma lui adesso va per strada tenebrosa<br />
là, dove dicono nessuno ritorni. 53<br />
Ma siate maledette voi, malvagie tenebre<br />
dell'Orco, che divorate tutte le beltà:<br />
Un passero così bello mi toglieste,<br />
o brutta sorte! O passer pover<strong>in</strong>o!<br />
Ora per opera tua alla mia ragazza<br />
piangendo un po' gonfi s'arrossano gli occhietti. C., III<br />
Figura femm<strong>in</strong>ile - affresco<br />
Villa di Arianna – Campo Varano<br />
Antica Stabiae<br />
I sec A.D.<br />
53 “ … illuc, unde negant redire quemquam”. L’ “Amleto” di Shakespeare riporta il motivo nel famoso soliloquio “To be or not to be”: “The undiscovered<br />
country from whose bourn/ no traveller returns…” Atto III, I, 79-80 (“La terra <strong>in</strong>esplorata dalla cui frontiera/ nessun viandante fa ritorno”).
31<br />
Achille (a s<strong>in</strong>istra) e l’amazzone Pentesilea<br />
Achille lotta con l’amazzone Penthesilea<br />
Anfora attica: autore: Exékias – ca. 540-530 a.C.<br />
British Museum – Londra<br />
“… Vi nascerà Achille privo di paura …<br />
Nessun eroe gli si paragonerà <strong>in</strong> guerra …”<br />
<strong>Catullo</strong>, Carm<strong>in</strong>a, LXIV, 338 e 343 54<br />
54 “… Nascetur vobis expers terroris Achilles …/ non illi quisquam bello se conferet heros …”
32<br />
Clodia Metelli e … Baia<br />
“Casta … Laev<strong>in</strong>a … Baianis … coniuge Penelope venit, habit Helene” 55<br />
M.V. Marziale (40-104 ca. A.D.), Epigrammata, Liber I, LXII<br />
Rov<strong>in</strong>e di villa romana su un piccolo promontorio prospiciente il porticciolo di Baia (a sud di Napoli)<br />
Affresco pompeiano di “villa maritima” a terrazza, con portici e un piccolo porto Antica Stabiae - “Villa Maritima” - affresco di Villa S. Marco<br />
L’agiata Lesbia doveva averne una simile a Baia (oggi località del comune di Bacoli , sul golfo di Pozzuoli, Napoli)<br />
Coppia che banchetta<br />
c. 80 a.C. (dettaglio)<br />
Berl<strong>in</strong>o - Pergamon<br />
Museum<br />
Resti di villa romana semisommersa sul mare di Baia, detta Villa Gallo<br />
<strong>Catullo</strong> ne aveva una fra Tivoli e la modesta Sab<strong>in</strong>a (cfr.: C., XLIV) e un’altra<br />
a Sirmione (cfr.: C., XXXI)<br />
55 “La Casta … Lev<strong>in</strong>a (per il poeta Marziale l’equivalente di Lesbia) a Baia … giunse da Penelope, compagna fedele, e se ne ripartì da<br />
Elena (di Troia).” Il nome Baia viene fatto derivare da Baio, il pilota di Ulisse, che qui sarebbe stato sepolto secondo Licofrone,<br />
Alexandra, v. 694. [Licofrone. Tragico greco vissuto ad Alessandria d’Egitto fra il IV e il III sec. a.C. Egli ci fornisce la versione di un<br />
ritorno ad Itaca da parte di Odisseo, che molto differisce dalla versione Omerica. L’eroe si rende conto che la moglie Penelope l’ha<br />
tradito con i Proci <strong>in</strong> sua assenza. Con il concorso di tutti ella ha avuto anche un figlio di nome Pan. (Ciò spiegherebbe l’attribuzione<br />
del nome). Per lo sconforto abbandona l’isola e si eclissa <strong>in</strong> Etruria, rimanendovi s<strong>in</strong>o alla morte. Cfr.: “Odisseo e gli Etruschi: fonti<br />
letterarie e documenti archeologici”, rivista Aufidis, n. 42, Università di Bari, <strong>in</strong>: http://web.tiscal<strong>in</strong>et.it/etruschi_tarqu<strong>in</strong>ia/ulissee.htm].
33<br />
Il riferimento di Marziale la dice lunga su questa amena località alla moda, frequentata ai tempi di<br />
Clodia e durante l’età imperiale da tutta la gente bene di Roma, unitamente ad imperatori, condottieri<br />
e <strong>in</strong>fluenti politici (G. Cesare, Pompeo, Cicerone, Marco Antonio Caligola, Nerone). “La piccola<br />
Roma”non ebbe mai nulla da <strong>in</strong>vidiare alle odierne località vacanziere della Costa azzurra, di Porto<br />
Cervo e di Palm Beach. Aveva acque curative termali 56 all’<strong>in</strong>terno di strutture imponenti, pisc<strong>in</strong>e,<br />
dolci arenili e m<strong>in</strong>uscoli siti naturali dove potersi rilassare e respirare aria estremamente salubre. Ma<br />
con le sue sontuose ville - soprattutto lungo il litorale – Baia fu anche passerella di prime donne e<br />
teatro di <strong>in</strong>trighi, amori e travolgenti passioni. Fu altresì considerata simbolo dei piaceri proibiti, per<br />
donne maritate e non, un luogo di perdizione per ragazze e attempate. Non è dato sapere perché, ma<br />
lì sembra che lascivia e libertà sessuale divenissero il pane quotidiano delle rappresentanti del sesso<br />
femm<strong>in</strong>ile più moralmente <strong>in</strong>tegre. Marziale non fu il solo a pensarla così. Della stessa cosa si<br />
conv<strong>in</strong>se Sesto Aurelio Properzio (49 -16 a.C.):<br />
“ Corrupta … Baias / Ah pereant Baiae crimen amoris aquae ” 57<br />
Sicché Baia e rilassatezza dei costumi si fecero b<strong>in</strong>omio <strong>in</strong>sc<strong>in</strong>dibile nell’età di <strong>Catullo</strong>, divenendo un<br />
saldo punto di riferimento topico degli <strong>in</strong>tellettuali dell’età repubblicana (Cicerone, Att. I, 16, 10; Fam.<br />
IX, 2, 5: Pro Caelio 27; Properzio, I, 11; Ovidio, Ars I, 255; Seneca, Ad Lucilium 51, 1; Marziale,<br />
Epigrammata I, 62; VI, 68; X, 30, ma anche Strabone, V, 243, 5; Dione Cassio, XLVIII, 51-2.)<br />
Alla luce di tutto questo, poteva mai Clodia essere <strong>in</strong>sensibile al fasc<strong>in</strong>o del proibito? Ecco come<br />
Cicerone mette <strong>in</strong> risalto la cosa:<br />
“ Gli accusatori hanno costantemente sulla bocca i piaceri, gli amori, gli adulteri, e Baia e<br />
le spiagge, e i conviti, le gozzoviglie, i canti, i concerti, le gite <strong>in</strong> barca (e non pare che<br />
dicano nulla che sia contro la tua volontà (di Clodia)”. 58<br />
Per Q. F. Orazio ( 65 -8 a.C) Baia, <strong>in</strong>vece, sembra rappresentare la positività, la s<strong>in</strong>tesi dell’<strong>in</strong>no alla<br />
vita, da celebrare con tutta l’<strong>in</strong>teriorità d<strong>in</strong>amica preposta alla nostra sopravvivenza:<br />
"Nullus <strong>in</strong> orbe s<strong>in</strong>us Baiis praelucet amoenis" 59<br />
Villa del Casale – g<strong>in</strong>naste <strong>in</strong> bik<strong>in</strong>i – III sec. A.D.<br />
Piazza Armer<strong>in</strong>i - Enna<br />
56<br />
Un po’ ovunque c’erano sorgenti termali. S<strong>in</strong> dal 178 a.C. si hanno <strong>in</strong>formazioni <strong>in</strong> merito all’uso terapeutico delle<br />
acque termali di Baia. Lo storico Tito Livio (59 a.C. – 17 A.D.), Ab Urbe Condita, XLI,16, riferisce che un console<br />
romano di nome Cornelio riuscì ad alleviare <strong>in</strong> quel luogo i postumi di una caduta da cavallo, grazie alle proprietà<br />
curative delle acque.<br />
Scena Saffica<br />
Pompei<br />
Casa di Cecilio Giocondo<br />
Napoli – M.A.N.<br />
57 l. 1. 11. Eleg. v. 27. Ibidem, v.30. “La Corrotta …Baia”… “ In malora le acque di Baia, vergogna di Amore!”<br />
58 Pro Celio, XXXV. “Accusatores quidem libid<strong>in</strong>es, amores, adulteria, Baias, actas, convivia, comissationes, cantus,<br />
symphonias, navigia iactant, idemque significant nihil se te <strong>in</strong>vita dicere”. Sul comportamento di Clodia a Baia, si<br />
veda anche la pag. 4.<br />
59 “Nulla al mondo splende più dell’ameno golfo di Baia”. (Ep. I,1,84). Sarebbe molto riduttivo, a mio modesto<br />
avviso, ritenere che il godereccio <strong>Catullo</strong> <strong>in</strong>tendesse qui celebrare poeticamente la bontà di un luogo come Baia<br />
unicamente per la sua la ridente posizione geografica.
34<br />
“Ragazze, [aspirate] ai bei doni [delle] Muse dall’odoroso grembo, [e alla chiara],<br />
melodiosa lira”<br />
(Tratto da una lirica di Saffo di dodici versi scoperta nel 2004 su un foglio di papiro <strong>in</strong> cui era avvolta una mummia egiziana. La lirica è<br />
stata pubblicata nel 2005 dal settimanale <strong>in</strong>glese Times Literary supplement . Per chi ne volesse sapere di più cfr.: ed. M. L. West, “A new<br />
Sappho poem”, Times Literary Supplement 5334 [24 June 2005], <strong>in</strong>: http://caelestis.<strong>in</strong>fo/sauvagenoble/2005/06/lsa-pause-sappho-58.html)<br />
“Lesbia e il passerotto”<br />
dip<strong>in</strong>to vittoriano<br />
di<br />
Edward John Poynter (1836 -1919)
35<br />
La rivolta dei gladiatori Vittoria su Spartaco – denario d’argento - 71 a.C.<br />
È legittimo supporre che le agiate famiglie di <strong>Catullo</strong> e Lesbia dovettero vivere con non poca apprensione, del resto<br />
come tutti i ricchi proprietari di schiavi di quel tempo, l’atmosfera di tensione provocata dal susseguirsi di notizie poco<br />
rassicuranti sull’agguerrito esercito di gladiatori <strong>in</strong> rivolta, che m<strong>in</strong>acciarono la sicurezza di Roma nel biennio 73 - 71.<br />
Gladiatore ucciso <strong>in</strong> duello all’ultimo sangue<br />
Particolare di fiasca romana (<strong>in</strong> alto a s<strong>in</strong>istra)<br />
(Römisch-Germanisches Museum, Köln) Gladiatori <strong>in</strong> combattimento – vaso ritrovato a Colchester (UK)<br />
Quando il tracio Spartaco si ribellò a Capua, fuggendo verso il Vesuvio, <strong>Catullo</strong> era appena tredicenne. Lo sparuto<br />
seguito del gladiatore si accrebbe a dismisura <strong>in</strong> poco tempo raggiungendo le 70.000 unità. In un primo momento<br />
Spartaco riuscì a sconfiggere diverse legioni romane <strong>in</strong>viate contro le sue soldatesche. Ma la ribellione venne<br />
def<strong>in</strong>itivamente schiacciata nel 71 a.C., allorché nei pressi del fiume Sele si svolse la battaglia f<strong>in</strong>ale. Vi perirono 60.000<br />
schiavi, tra i quali lo stesso Spartaco, (il corpo del comandante non fu mai trovato). Le perdite dei Romani ammontarono<br />
solo a 1.000 uom<strong>in</strong>i. 6.000 i prigionieri, che Crasso fece crocifiggere nudi lungo la via Appia da Capua a Roma. Circa<br />
diecimila superstiti tentarono la fuga verso nord, ma vennero raggiunti e annientati da Gneo Pompeo Magno.<br />
Mosaico gladiatorio di Tusculum (30 km. a sud di Roma, vic<strong>in</strong>o Frascati) - Galleria Borghese - Roma
GAIO (uno dei massimi giuristi<br />
romani del II sec. A.D. ) <strong>in</strong><br />
"INSTITUTIONUM COMMENTARII<br />
QUATTUOR", II, 12-17, afferma:<br />
"VVii ssoonnoo<br />
ttrree ttiippii ddii uutteennssiillii:: qquueellllii cchhee nnoonn<br />
ssii mmuuoovvoonnoo ee nnoonn ppaarrllaannoo;; qquueellllii<br />
cchhee ssii mmuuoovvoonnoo ee nnoonn ppaarrllaannoo<br />
(animali),, ee qquueellllii cchhee ssii mmuuoovvoonnoo<br />
ee ppaarrllaannoo (schiavi)".<br />
36<br />
6.000 gladiatori di Spartaco furono crocifissi lungo la via Appia<br />
fra Capua e Roma …<br />
“Non amplius, <strong>in</strong>quis, qu<strong>in</strong>quag<strong>in</strong>ta. Cum Spartaco m<strong>in</strong>us multi primo fuerunt” (“Non più di c<strong>in</strong>quanta uom<strong>in</strong>i, dici tu. Al fianco di Spartaco<br />
ce ne furono meno agli <strong>in</strong>izi.” M. T. Cicerone, Epistulae ad Atticum, VI, 2, 8).<br />
Durante la Repubblica e nei primi secoli dell'Impero romano il 15-20% circa della popolazione era<br />
costituito da schiavi (tali anche per debiti <strong>in</strong>soluti, per non essersi presentati alla chiamata di leva obbligatoria o<br />
f<strong>in</strong>anche per <strong>in</strong>capacità di dimostrare la propria identità), ai quali non veniva assicurato alcun diritto<br />
fondamentale, tanto che un proprietario poteva uccidere il suo schiavo nel pieno rispetto della legalità. Nel<br />
I secolo a.C., tuttavia, si <strong>in</strong>iziarono a varare leggi che imponevano il rispetto di regole ben precise sul<br />
mancipio. La legge Cornelia dell'82 a.C., per esempio, vietava l’uccisione di un asservito da parte del suo<br />
padrone; mentre la legge Petronia, del 32 a.C., aboliva l'obbligo da parte di uno schiavizzato di combattere<br />
nel Circo su pretesa del detentore.<br />
Schiavi che pigiano l’uva<br />
Bassorilievo<br />
Schiava che allaccia gioiello alla caviglia della padrona<br />
Particolare di affresco<br />
Gladiatori si affrontano <strong>in</strong> presenza del<br />
Commentarius Magister (Allenatore)<br />
Mosaico pavimentale
37<br />
“Consule Pompeio primum … facto consule nunc iterum”<br />
(C.,CXIII, v.1-2) 60<br />
Gneo Pompeo Magno ripulisce il Mare Mediterraneo dai pirati (67a.C.)<br />
In alto, busto di G. Pompeo Magno<br />
55-50 a.C ca. Copenaghen, e<br />
bassorilievo di battaglia navale I sec.<br />
a.C. (Azio?). M. N. Madrid.<br />
In basso, denario argenteo di 3.80 g.<br />
con profilo del condottiero romano.<br />
La moneta fu coniata per il figlio<br />
Sesto, che volle commemorare suo<br />
padre riportandone l’effigie nel verso.<br />
Nell’autunno del 69 a.C. il porto romano di Ostia viene messo a ferro e fuoco dai pirati Cilici, 61 la flotta da<br />
guerra consolare lì ormeggiata è distrutta, due stimati senatori sono rapiti con le guardie del corpo e il loro<br />
seguito. Le sangu<strong>in</strong>ose scorrerie di questi predoni contro imbarcazioni d’ogni tipo, città costiere, uom<strong>in</strong>i,<br />
donne e bamb<strong>in</strong>i <strong>in</strong>ermi sono sulla bocca di tutti e proseguono da decenni a causa delle <strong>in</strong>adeguate<br />
contromisure prese dalle autorità preposte. <strong>Catullo</strong> non può non sapere. L’atto terroristico di Ostia si<br />
traduce così <strong>in</strong> sfida. La potenza di Roma e i suoi traffici marittimi ora sono apertamente m<strong>in</strong>acciati. Un<br />
trentanovenne uomo d’armi, nonché politico opportunista, il console Gneo Pompeo Magno (29 Sett.106 – 28<br />
Sett. 48 a.C., figlio del generale Gneo Pompeo Strabone), con la decisiva complicità di un suo tenente, il tribuno<br />
della plebe Aulus Gab<strong>in</strong>us (ma anche con gli appoggi politici di G. Cesare 62 e M. T. Cicerone), sfrutta gli echi<br />
del clamoroso accadimento a vantaggio delle sue malcelate ambizioni. Egli riesce a fare varare dal Senato un<br />
provvedimento d’emergenza, la Lex Gab<strong>in</strong>ia (67 a.C., dal nome del proponente tribuno), contro la non più<br />
tollerabile piaga della pirateria. Ecco <strong>in</strong> s<strong>in</strong>tesi quanto si stabilisce: Pompeo muoverà guerra totale ai pirati.<br />
Una flotta di 500 navi, 20 legioni (120.000 fanti e 5000 cavalieri), 24 senatori e 2 questori saranno ai suoi<br />
ord<strong>in</strong>i diretti. Viene pertanto nom<strong>in</strong>ato generale unico con libertà d’azione <strong>in</strong>condizionata sui mari e nell’entroterra<br />
60<br />
Pompeo è eletto console per la prima volta nel 70, <strong>in</strong>sieme con Marco Lic<strong>in</strong>io Crasso. La seconda nel 55 con il medesimo rivale politico e<br />
militare.<br />
61<br />
La Cilicia, terra sulla costa orientale dell’Asia M<strong>in</strong>ore (Turchia) a nord di Cipro.<br />
62<br />
Nel 74 Cesare stesso era stato per trentotto giorni prigioniero dei pirati nell’isola di Farmacussa, nel Dodecanneso , a sud di Mileto. Quando<br />
fu riscattato con la somma di 50 talenti, egli ritornò nell’isola con alcune navi. Catturò i pirati, che successivamente fece prima strangolare e<br />
poi crocifiggere.
38<br />
d’ogni costa, dove potrà sp<strong>in</strong>gersi <strong>in</strong> profondità per 70 km. (imperium <strong>in</strong>f<strong>in</strong>itum). Ha tre anni di tempo per chiudere i<br />
conti con i masnadieri e uno stanziamento di 144 milioni di sesterzi per le spese belliche, quasi l’<strong>in</strong>tero ammontare del<br />
tesoro romano. Il sogno del figlio di Strabone diviene realtà! Plutarco 63 ci fa sapere che l’imperator divide il<br />
Mediterraneo, il Tirreno, i mari della Sardegna, della Sicilia e della Corsica <strong>in</strong> 13 quadranti operativi, ognuno sotto il<br />
monitoraggio sistematico di un legato a cui viene affidato un cont<strong>in</strong>gente di navi, fanti e cavalleria. In tal modo<br />
l’<strong>in</strong>tercettazione di unità ostili è resa altamente probabile. La strategia corale si rivela efficace, tanto che nel volgere di<br />
tre mesi Pompeo debella i predoni e cattura loro 800 navigli. Va a sconfiggerli pers<strong>in</strong>o a casa, <strong>in</strong> Cilicia, presso il<br />
promontorio di Coracesium (oggi Alanya, <strong>in</strong> Turchia), quando con sessanta triremi sorprende le navi superstiti riuniti <strong>in</strong><br />
quel tratto di mare per opporgli l’ultima e disperata resistenza. Alla f<strong>in</strong>e della campagna militare 20.000 prigionieri<br />
sono utilizzati come manodopera per il lavoro delle terre <strong>in</strong>colte di Roma e della penisola Italica sotto il suo dom<strong>in</strong>io<br />
(<strong>Taranto</strong> <strong>in</strong>clusa! Virgilio, Georgiche, IV, vv.116-148). Proprio <strong>in</strong> Cilicia egli fonda una città che porta il suo nome,<br />
Pompeiopolis, a mo’ di sovrano ellenistico (aveva per modello Alessandro Magno!). Dopo la strabiliante impresa il<br />
Senato non richiama Pompeo <strong>in</strong> patria. Gli assegna, <strong>in</strong>vece, un altro delicatissimo compito (Lex Manilia): il comando<br />
della guerra contro Mitridate VI Eupatore (132-66 a.C.), re del Ponto (zona nordorientale dell’Asia M<strong>in</strong>ore). Pompeo,<br />
non solo sconfigge Mitridate, ma assoggetta anche una parte consistente del Medio Oriente. Il 29 settembre del 61,<br />
giorno del suo quarantac<strong>in</strong>quesimo compleanno, e ancora il dì successivo, il generalissimo si gode il trionfo nell’Urbe!<br />
Il massimo onore concessogli per le vittorie riportate contro i nemici esterni di Roma. Le <strong>in</strong>segne poste alla testa<br />
dell’imponente corteo – seguite da schiavi, forzieri zeppi d’oro e tanti altri splendidi bott<strong>in</strong>i di guerra - <strong>in</strong>dicano genti<br />
e paesi sottomessi:<br />
[CN. POMPEIVS CN.F. SEX.N. MAGNVS III] PRO COS.<br />
CUM ORAM MARITIMAM PRAEDONIBVS LIBERASSET<br />
ET IMPERIVM MARIS POPVLO ROMANO RESTITVISSET<br />
EX ASIA PONTO ARMENIA PAPHLAGONIA CAPPADOCIA CILICIA SYRIA<br />
SCYTHIS IVDAEIS ALBANIS HIBERIA INSVLA CRETA BASTERNIS<br />
ET SVPER HAEC DE REGE MITHRIDATE ATQVE TIGRANE TRIVMPHAVIT. 64<br />
"Avendo liberato le coste dai pirati e avendo restituito il dom<strong>in</strong>io del mare al popolo romano, ha<br />
trionfato su Asia, Ponto, Armenia, Paflagonia, Cappadocia, Cilicia, Siria, Sciti, Giudei, Albani,<br />
Iberia, sull’isola di Creta, sui Basterni e, <strong>in</strong>oltre, sul re Mitridate e su Tigrane”<br />
63 (Lucius?) Mestrius Plutarchus ( 46 - 120 A.D.). Vite parallele. Agesilao – Pompeo, Rizzoli - Collana: BUR - Classici<br />
Greci e Lat<strong>in</strong>i, 2000. Le <strong>in</strong>formazioni sono tratte dal V, capp. 24 - 25 i pirati; cap. 25 la Legge Gab<strong>in</strong>ia e l’appoggio di<br />
Cesare; cap. 26 pieni poteri a Pompeo e la vittoria; cap. 28 la vittoria presso il promontorio di Coracesium <strong>in</strong> Cilicia, Il<br />
Mediterraneo è ripulito dai pirati <strong>in</strong> tre mesi.<br />
64 <strong>Gaio</strong> Pl<strong>in</strong>io Secondo (23-79 A.D.), Naturalis Historia, VII, 98, Guard<strong>in</strong>i, Pisa, 1984. L’affresco è di Cesare<br />
Maccari, Roma, Palazzo Madama, sala Maccari. “Cicerone denuncia Catil<strong>in</strong>a <strong>in</strong> Senato”, 1880.
39<br />
Aditu prohiberis !<br />
Subsiste meditareque!65<br />
Oltre questo muro troverai un <strong>Catullo</strong> che non t’aspetti. Non più cantore dell’“odi et amo” e dei “basia<br />
mille”, delle autentiche emozioni passionali, dell’amore struggente, un miraggio, quest’ultimo, r<strong>in</strong>corso<br />
ost<strong>in</strong>atamente s<strong>in</strong>o alla dissoluzione, sotto il sole dei tradimenti perpetrati da una dark lady venerata senza<br />
riserve. Qui, per contro, scoprirai un personaggio che con i suoi “versiculi molliculi” reclama il diritto di<br />
scendere dal piedistallo mielato sul quale addetti ai lavori di tutti i tempi hanno <strong>in</strong>teso porlo. Dando per<br />
scontata la buona fede dell’atteggiamento di pudicizia più o meno conv<strong>in</strong>ta di tantissimi esegeti, della<br />
severità censoria imposta loro da regimi ed <strong>in</strong>tellettuali benpensanti, la comprensibile impossibilità da parte<br />
della editoria scolastica di pubblicare certi contenuti del Liber, è comunque <strong>in</strong>negabile che a generazioni di<br />
lettori comuni e appassionati di letteratura lat<strong>in</strong>a sia stata il più delle volte impedita, o quanto meno poco<br />
propagandata, la scalata di un versante estremamente <strong>in</strong>teressante di quella montagna quale è la variegata e<br />
complessa poetica di <strong>Catullo</strong>. La conseguenza di tutto ciò ha portato ad una visione <strong>in</strong>giustamente mutila<br />
della personalità di chi deve la sua fama al love affair con Lesbia/Clodia. Se per contro si arriva <strong>in</strong> vetta dal<br />
declivio ai più sconosciuto, ci si rende immediatamente conto di come - al di là del fulgido stereotipo amoroso<br />
laccato di mito - <strong>Catullo</strong> sia un lirico di prim’ord<strong>in</strong>e anche quando con il vigore delle sue sferzanti salacità<br />
<strong>in</strong>tende presentarci uno spaccato delle fragilità e manchevolezze di tant’altra parte di umanità del suo<br />
tempo. Di qui il brillante utilizzo di registri comunicativi della l<strong>in</strong>gua parlata, dim<strong>in</strong>utivi <strong>in</strong>clusi, che<br />
pennellano quel vissuto con t<strong>in</strong>te assolutamente realistiche. Allora come non sentirlo uno di noi?! Si ha la<br />
sensazione che a tratti egli si compiaccia della taccia di poeta “parum pudicum” affibbiata da altri sodali<br />
della sua cerchia. Pur stando al gioco, è pronto a dissentire e a chiarire la sua posizione quando qualcuno<br />
glielo ricorda esplicitamente, con energiche arr<strong>in</strong>ghe accusatorie, più che difensive. Il carme XVI risulta<br />
illum<strong>in</strong>ante <strong>in</strong> tal senso. Sì, è vero! L’autore ammette chiaramente che talune composizioni di sua<br />
appartenenza appaiano <strong>in</strong>dubbiamente lascive e spudorate. Ma sono state create a bella posta con tanto “sal<br />
et lepos” per colpire chi merita, e non certo per scandalizzare gli <strong>in</strong>nocenti e puri di cuore, “non dico pueris”.<br />
Non esita a ribellarsi allorquando gli si fa notare di essere un “male marem”, <strong>in</strong>capace, cioè, di mantenere la<br />
65 “Limite <strong>in</strong>valicabile! Fermati e rifletti!”.
40<br />
dignità del vir romano perché autore di versi sdolc<strong>in</strong>ati pieni di “multa milia basiorium”. O allorché gli si dice<br />
che i dardi delle trivialità poetiche lanciati verso tutto e tutti costituiscano la lampante dimostrazione che egli<br />
non abbia a cuore il rispetto per gli dei, le pratiche religiose, la patria, i genitori, i parenti, gli amici e i<br />
conoscenti. In def<strong>in</strong>itiva gli viene mossa l’accusa di essere un “impius” per ciò che scrive, e dunque uomo da<br />
biasimare quanto a condotta. Il poeta ci comunica che così non è, anche <strong>in</strong> altre circostanze (Cfr.: c.<br />
LXXVI/CI). Casomai il contrario. Dalla sua poesia traspare pers<strong>in</strong>o rettitud<strong>in</strong>e e coscienza civile,<br />
<strong>in</strong>sospettabili <strong>in</strong> un giovane all’apparenza spregiudicato. Nel carme LII si avverte chiaramente il suo senso di<br />
profonda amarezza riveniente dalla constatazione di uno Stato governato da <strong>in</strong>dividui la cui immoralità si<br />
legge sui loro corpi deformi. E con parole di fuoco è pronto a ribadire che l’<strong>in</strong>tegrità morale di un artista<br />
presc<strong>in</strong>de dai contenuti dell’opera d’arte! In def<strong>in</strong>itiva sbaglia di grosso chi lo giudica moralmente discutibile<br />
per via di certe sue creazioni poetiche oscene: “Nam castum esse decet pium poetam/ ipsum, versiculos nihil<br />
necesse est”. Un concetto tremendamente evoluto, che ha molto da spartire con l’antivittoriano dogma<br />
estetico di Oscar Wilde nella prefazione del suo celebre romanzo: “There is no such th<strong>in</strong>g as a moral or an<br />
immoral book. Books are well written, or badly written. That is all. … No artist is ever morbid. The artist can<br />
express everyth<strong>in</strong>g. … Vice and virtue are to the artist materials for an art. … Diversity of op<strong>in</strong>ion about a work<br />
of art shows that the work is new, complex, and vital.” 66<br />
Una sanguigna sensibilità congenita porta il bardo lat<strong>in</strong>o a reagire senza esitazione contro quanti m<strong>in</strong>acciano<br />
pr<strong>in</strong>cipi e certezze che gli appartengono, <strong>in</strong> ossequio ad un codice d’onore personale che non ammette mezze<br />
misure. La rappresaglia che ne consegue si concretizza <strong>in</strong>tessuta di sermo lubrico al vetriolo. Spesso il<br />
disprezzo si traduce <strong>in</strong> eros iperaggressivo, come, ad esempio, nel giuramento di rendere taluni 67 di sua<br />
conoscenza allo stato di passive femm<strong>in</strong>elle (“Pedicabo ego vos et irrumabo”, c., XVI), perché ignoranti<br />
<strong>in</strong>capaci di comprendere che il suo prodotto poetico, senza eccezione di sorta, nasce da chi ascolta i “moti del<br />
dentro”. Non è azzardato ritenere che tale violenza verbale dichiaratamente oscena possa anche essere stata<br />
mutuata dalla satira mordace dei Fescenn<strong>in</strong>i e da certi spiritosi ed altrettanto sconci epigrammi priapei 68 . Il<br />
magma di immag<strong>in</strong>i a chiare t<strong>in</strong>te scurrili, il crudo vigore di certi volgarismi, le scariche di collera <strong>in</strong>giuriosa<br />
devastano fondamentalmente 69 due categorie di esseri umani che satellitano la quotidianità Catulliana:<br />
• coloro i quali <strong>in</strong>tendono m<strong>in</strong>are l’amore per Lesbia;<br />
• quanti con i loro comportamenti si prodigano - consciamente o <strong>in</strong>consciamente - per<br />
annichilire la dignità dell’uomo.<br />
Amici di bagordi <strong>in</strong>fedeli, rozzi rivali <strong>in</strong> amore, arroganti prevaricatori, lenoni, stolti, topi di terme, mariuoli<br />
di bassa lega e ladroni alla grande, etère d’alto ed <strong>in</strong>fimo rango, adultere, pedofili, efebi, pederasti, licenziosi<br />
gaudenti, pidocchiosi spilorci, logorroici poetastri da strapazzo, parassiti sociali, potenti arraffoni politici,<br />
sporcaccioni plur<strong>in</strong>cestuosi, rappresentano tutti il vivaio-bersaglio da cui att<strong>in</strong>gere prima e scagliare poi<br />
oltraggiosi e virulenti epiteti. E quando il poeta non passa alle vie di fatto, m<strong>in</strong>accia di farlo! Perché <strong>Catullo</strong><br />
sembra essere fermamente conv<strong>in</strong>to che la m<strong>in</strong>accia possa rivelarsi efficace quanto la stessa esecuzione: “ …<br />
hendecayllabos trecentos/expecta …”(c. XII, vv.10-11); “At non effugies meos iambos”(Fragmenta, 3). “Adeste,<br />
hendecasyllabi, quot estis/omnes undique, quotquot estis omnes ”(c. XLII, vv.1-2) 70 . Gli impasti lessicali da<br />
“salax taberna” 71 , <strong>in</strong>ducono alla schietta risata, non di rado condita di meditata amarezza, e rivelano un<br />
<strong>Catullo</strong> ancora una volta s<strong>in</strong>golare. Scoprirlo senza riserve mentali nel turpiloquio poetico <strong>in</strong>neggiante al<br />
66 “Non esiste un libro morale o immorale. I libri, o sono scritti bene, o sono scritti male. Tutto qui. … L’artista non è mai morboso. Può<br />
esprimere tutto. … Il vizio e la virtù sono per l’artista materiali di un’arte. … La differenza di op<strong>in</strong>ione su un’opera d’arte <strong>in</strong>dica che<br />
l’opera è nuova, complessa, vitale.” Wilde, Oscar. The Picture of Dorian Gray. Ed. Robert Mighall. London: Pengu<strong>in</strong>, 2003.<br />
67 Furio ed Aurelio. Quest’ultimo non doveva essere simpatico a <strong>Catullo</strong>, se il poeta vuole riservargli lo stesso trattamento nel carme 21.<br />
68 Nel primo dei tre Fragmenta <strong>Catullo</strong> consacra un bosco, forse di sua proprietà, al dio ellenistico-asiatico Priapo, il cui culto (importato<br />
dalle città di Làmpsaco e Priapo nella Misia, oggi Turchia nord-occidentale) a Roma va ad amalgamarsi con l’equivalente div<strong>in</strong>ità locale<br />
Mutunus Tutunus (o Mut<strong>in</strong>us Tut<strong>in</strong>us). Non è azzardato pensare che epigrammi Priapei fossero <strong>in</strong> circolazione numerosi già ai tempi di<br />
<strong>Catullo</strong>, oltre che nel I sec. A.D, di cui solo ottanta componimenti del genere ci sono pervenuti <strong>in</strong> forma anonima. Cfr.: Carmi priapei. Le<br />
ottanta poesie anonime, di volta <strong>in</strong> volta attribuite ai grandi poeti lat<strong>in</strong>i, che hanno celebrato la forza procreatrice del dio greco, cura e<br />
traduzione di Cesare Vivaldi, testo lat<strong>in</strong>o a fronte, edizione <strong>in</strong>tegrale, grandi tascabili economici Newton, Milano,1996, pp. 207.<br />
69 Fondamentalmente, perché non mancano aneddoti osceni e contestazioni altrettanto virulente che non rientrano negli ambiti <strong>in</strong>dicati.<br />
70 Aspettati trecento endecasillabi(XII)/Ma non sfuggirai ai miei giambi(F.3)/Avanti, endecasillabi, accorrete tutti, tutti da ogni parte(XLII).<br />
71 Sboccati, facilmente udibili <strong>in</strong> un luoghi moralmente discutibili come una “ignobile osteria”(c. XXXVII), con bordello annesso.
41<br />
goliardico motteggio - prerogativa che contesta con forza la cultura ormai stantia e immobile della vecchia<br />
aristocrazia<br />
( “… his pilosis/ qui duros nequeunt movere lumbos.” - c. XVI, vv.10-11/… rumoresque senum severiorum/omnes<br />
unius aestimemus assis. - c.,V, vv. 2-3 ) – non potrebbe che ampliare lo spazio del campo di osservazione di un<br />
grande della letteratura italica del primo secolo. Alla luce dei predetti riscontri, allora, il lemmario sboccato<br />
sparso nell’opera a macchia di leopardo non può <strong>in</strong>taccare <strong>in</strong> alcun modo il carisma poetico del creatore. Esso,<br />
piuttosto, va considerato come <strong>in</strong>nesto <strong>in</strong> poesia colta, frutto di orig<strong>in</strong>ale sperimentazione fortemente auspicata<br />
e portata a term<strong>in</strong>e con successo <strong>in</strong> un “saeclum <strong>in</strong>sapiens et <strong>in</strong>facetum”(c. XLIII, v.8) a detta dello stesso autore.<br />
La riflessione trova sostegno nella constatazione che il l<strong>in</strong>guaggio poetico osceno è ravvisabile <strong>in</strong> ben 41 dei 116<br />
carmi e 3 frammenti pervenutici, pari al 34,45% del Liber (6, 10, 14, 15, 16, 21, 23, 25, 28b, 29, 32, 33, 36, 37,<br />
39, 41, 42, 53 54, 55,56 57, 59, 67,69,71, 74, 77, 78b, 80, 88, 89, 94, 97, 98, 105, 110, 112, 113, 114, 115) 72 . Una<br />
parte consistente, dunque, che <strong>in</strong> assoluto non può passare sotto silenzio. Di certo a non pochi <strong>in</strong>tellettuali,<br />
anche al di fuori della cerchia del poeta, piacque tutelare “la novità” Catulliana, che un illustre esegeta italiano<br />
ha def<strong>in</strong>ito a buona ragione “goliardia e snobismo pubblicizzati <strong>in</strong> poesia colta dai circoli raff<strong>in</strong>ati<br />
dell’avanguardia … arcadia rovesciata”. 73 Se così non fosse stato, mi domando come sarebbe potuta giungere<br />
s<strong>in</strong>o a noi tanta esibizione di s<strong>in</strong>golari impudiche turbolenze.<br />
Riflessioni di un uomo senza maschera?!<br />
Affresco Pompeiano<br />
Se tutto questo ti risulta difficile da capire, se consideri il turpiloquio<br />
e la scurrilità <strong>in</strong> ogni caso sconvenienti e <strong>in</strong>ammissibili, allora, ti<br />
prego, non valicare questo limite e lasciamoci qui, senza rancore!<br />
72 In rosso i più scurrili, a mio modesto avviso.<br />
73 Luca Canali, <strong>in</strong>: <strong>Gaio</strong> <strong>Valerio</strong> <strong>Catullo</strong>, Le poesie, op. cit., pag. LX.
42<br />
Carme XVI<br />
Monito<br />
Guai a chi mi giudica immorale<br />
solo perché scrivo qualche verso libert<strong>in</strong>o!<br />
Subirebbe lo stesso supplizio che Priapo riserva a<br />
quanti rubano nei campi a lui consacrati!<br />
“Io ve lo ficcherò <strong>in</strong> bocca e <strong>in</strong> culo,<br />
a te Aurelio, checca che non sei altro, e a te <strong>in</strong>vertito d’un Furio,<br />
che dalle mie poesiole mi giudicaste<br />
quasi un depravato perché sono libert<strong>in</strong>e.<br />
Che debba essere casto e pio il poeta, questo è giusto,<br />
ma perché dovrebbero essere così i versi suoi?!<br />
Hanno una loro grazia ed eleganza,<br />
proprio perché un po’ sp<strong>in</strong>ti e senza pudore,<br />
e riescono ad eccitare quello che prude,<br />
non dico nei fanciulli, ma <strong>in</strong> qualche caprone<br />
con le reni <strong>in</strong>chiodate dall’artrite.<br />
E voi, solo perché leggete nei miei versi di baci a migliaia,<br />
pensate che io non sia un maschio a dovere?<br />
Io ve lo ficcherò <strong>in</strong> bocca e <strong>in</strong> culo”.<br />
Pedicabo ego vos et irrumabo,<br />
Aureli pathice et c<strong>in</strong>aede Furi,<br />
qui me ex versiculis meis putastis,<br />
quod sunt molliculi, parum pudicum.<br />
nam castum esse decet pium poetam<br />
ipsum, versiculos nihil necesse est;<br />
qui tum denique habent salem ac leporem,<br />
si sunt molliculi ac parum pudici,<br />
et quod pruriat <strong>in</strong>citare possunt,<br />
non dico pueris, sed his pilosis<br />
qui duros nequeunt movere lumbos.<br />
vos, quod milia multa basiorum<br />
legistis, male me marem putatis?<br />
pedicabo ego vos et irrumabo.<br />
Ritratto di poeta<br />
Pompei
Il verbo poetico<br />
che oltraggia e<br />
percuote<br />
43<br />
29. Culus voracior =culo più vorace<br />
30. Lupanar = troia<br />
31. Lutum=fogna, sporcaccione<br />
32. Magna mentula =cazzone<br />
33. Moecha putida=lurida puttana<br />
34. Moecha turpis = puttana <strong>in</strong>fame<br />
35. Moechare=fare sesso<br />
36. Molesta=impert<strong>in</strong>ente<br />
37. Morbosus=depravato<br />
38. Multus pathicus=gran f<strong>in</strong>occhio<br />
39. Pathicus= checca, bocch<strong>in</strong>aro<br />
40. Pedicare/paedicare=sodomizzare<br />
41. Penis languidus=pene flaccido<br />
42. Perdepsuere uxorem=farsi la (altrui) moglie<br />
43. Pessimae puellae= donne di facili<br />
costumi<br />
1. Aleo=baro<br />
2. Cacatus=schifoso<br />
3. Cacata carta=cartacce di merda<br />
4. Canis ore=muso di cagna<br />
5. Caper =caprone<br />
6. C<strong>in</strong>aedus=checca, <strong>in</strong>vertito<br />
7. Confutuere= fottere<br />
8. Conturbenales=compagni di<br />
bordello<br />
9. Culos l<strong>in</strong>gere=leccare i culi<br />
10. Cunnus=vulva<br />
11. Defututus=fottuto<br />
12. Descendere=Penetrare<br />
13. Diffututa mentula=cazzo<br />
rammollito<br />
14. Febriculosi scorti=puttane<br />
impestate<br />
44. Puella defututa=puttanella fottuta<br />
45. Puellae trusantem=scopatore<br />
Febriculosi scorti=puttane<br />
impestate<br />
pro telo rigida mea=con il coso<br />
duro a mo’ di dardo<br />
46. Pusilli=mezzeseghe, mesch<strong>in</strong>i<br />
15. Fellat=succhiare l’uccello<br />
47. Putide=schifoso<br />
16. Femellas=donnacce<br />
48. Salaputium disertum= cazzetto<br />
17. Fututiones=scopate<br />
sapiente/coglione sapiente<br />
18. Fututus=fottuto<br />
49. Salax=libid<strong>in</strong>oso<br />
19. Grandia tenta vorare=divorare<br />
50. Salse=buffone<br />
peni enormi 51. Sceleste=scellerato<br />
20. Hircus=cornuto/bestia<br />
52. Scortillum=sgualdr<strong>in</strong>ella<br />
puzzolente 53. Scortum=puttana<br />
21. Improbus=sfrontato, <strong>in</strong>fame<br />
54. Scrofola=scrofa, bubbone pestilenziale<br />
22. Impudicus=spudorato/pederastra<br />
55. Semitarii moechi=puttanieri di vicoli<br />
23. Inrumare=penetrare oralmente<br />
56. Sopio=pene/vulva/scemo/cazzone<br />
24. Inrumatione=irrumazione<br />
57. Spurca saliva=sudicio sperma/<br />
25. Inrumator =sporcaccione<br />
sudicia saliva<br />
26. Inrumatus=irrumato<br />
58. Subtile et leve peditum=<br />
27. Insulsa=<strong>in</strong>sulsa<br />
scorreggia timida e soffocata<br />
28. Insulsissimus homo=uomo<br />
stupidissimo<br />
59. Vorax adultera=adultera <strong>in</strong>saziabile<br />
L’Umanità di <strong>Catullo</strong><br />
Acme, Acqu<strong>in</strong>o, Alfeno, Allio, Anzio Arrio, As<strong>in</strong>io,<br />
Aurelio, Ameana, Aufileno, Aufilena, Balbo, Calvo,<br />
Camerio, Catone, Cecilio, Celio, Cesare, Cesio,<br />
Cicerone, C<strong>in</strong>na, Clodia, Clodio, Com<strong>in</strong>io, Cornelio,<br />
Cornificio, Egnazio, Emilio, Erio, Fabullo, Flavio, Furio,<br />
Gallo, Gellio, Geranio, Giovenzio, Ipsitilla, la Rossa di<br />
Bologna, Libone, Lic<strong>in</strong>io, Mamurra, Memmio, Menenio,<br />
Metello, Moecilia, Nasone, Nonio, Nepote, Ortensio,<br />
Ottone, Pisone, Porcio, Pompeo, Postumia, Qu<strong>in</strong>zio,<br />
Qu<strong>in</strong>zia, Ràvido, Rufo, Sestio, Settimio, Silla, Silone,<br />
Socrazio, Suffeno, Sufficio, Tallo, Vat<strong>in</strong>io, Varo,<br />
Veranio, Vezio, Vibennio e figlio, Volusio.
44<br />
<strong>Catullo</strong> … al di là di Lesbia<br />
L’<strong>in</strong>terpretazione obiettiva dei rapporti di <strong>Catullo</strong> con Lesbia rimane sempre cosa ardua, data l’esiguità<br />
delle fonti storiche attendibili a nostra disposizione. La stessa problematica si ripropone con<br />
veemenza anche quando si tenta di ricostruire il relazionarsi quotidiano del poeta con altra gente del<br />
suo tempo, l’Umanità al di là di Lesbia, <strong>in</strong>somma. La Storia desumibile dal Liber, <strong>in</strong> buona sostanza il<br />
pensiero emozionale, sociale, politico ed economico del suo creatore, si presenta sovente come<br />
distillato di mito, per via delle legittime esigenze stilistico-poetiche dell’autore. Sicché è lecito<br />
mantenere una certa dose di prudenza nell’<strong>in</strong>terpretare l’<strong>in</strong>carnato di vita desumibile dai carmi extra<br />
Clodiani, anche quando la realtà <strong>in</strong> essi contenuta sembra offrirsi <strong>in</strong>controvertibile al lettore.<br />
Feroce con … <strong>Gaio</strong> Giulio Cesare<br />
<strong>Catullo</strong> seguì le vicende delle campagne belliche condotte da Cesare <strong>in</strong> Gallia e Britannia. Di lui fu<br />
censore feroce e all’occorrenza non esitò ad attaccarlo apertamente. Pari sorte ebbe Mamurra, uno<br />
stretto collaboratore del condottiero <strong>in</strong>sieme con Nonio, Vat<strong>in</strong>io e Sufficio. Egli usò l’arma astiosa della<br />
satira scurrile nei confronti dell’aspirante tiranno di Roma, def<strong>in</strong>endolo senza mezzi term<strong>in</strong>i con i<br />
peggiori epiteti: 74 “improbus c<strong>in</strong>aedus” (svergognato omosessuale), “morbosus” (depravato),<br />
“eruditulus”(letteratucolo), “vorax adulter”(adultero <strong>in</strong>saziabile), “aleo” (biscazziere), capace soprattutto<br />
di “uncta devorare patrimonia” (divorare consistenti patrimoni):<br />
"Caesaris visens monimenta magni,/ Gallicum Rhenum horribile aequor/ ultimosque Britannos..." (Carme XI,10-<br />
12); " … imperator unice, / fuisti <strong>in</strong> ultima occidentis <strong>in</strong>sula,/ ut ista vestra diffututa mentula/ ducenties comesset<br />
aut trecenties?" (Carme XXIX, 11-14); “… Aut quid hic potest nisi uncta devorare patrimonia?”(Carme XXIX, 21-<br />
22). “irascere iterum meis iambis/ <strong>in</strong>merentibus, unice imperator.” (Carme LIV, vv.6-7) 75<br />
Denario d’argento (3.92 g.) 44 a.C. Recto.<br />
Profilo di G. Cesare laureato con iscrizione da<br />
ds. CAESAR.IM (PERATOR) [Cesare Generale<br />
vittorioso]. A sn. Luna crescente (simbolo di<br />
buon auspicio) fra P(ONTIFEX) e M(AXIMUS)<br />
[Pontefice Massimo - capo del collegio dei<br />
sacerdoti ]. Uno dei primi ritratti di Cesare <strong>in</strong> vita.<br />
Denario d’argento – Verso.<br />
Venere porta lo scettro e impalma la Vittoria<br />
Alata. Da ds. a sn. del campo:<br />
L(UCIUS)AEMILIUS BUCA<br />
[QUATTUORVIR <strong>in</strong> carica. Ovvero uno dei<br />
quattro magistrati autorizzati dal Senato a<br />
sovr<strong>in</strong>tendere congiuntamente la coniatura<br />
ed emissione delle monete nella zecca<br />
mobile al seguito del Generalissimo.]<br />
Busto di G. G. Cesare 13 Qu<strong>in</strong>tile (luglio) 100 - 15 marzo 44 a.C<br />
74 Lo fece anche il suo amico M.F. Bibaculo (n. 103 a.C.?), come ci ricorda il tardo grammatico Diomede (IV sec. A.D.). Cfr.: Grammatici<br />
Lat<strong>in</strong>i ex recensione Henrici Keilii, a cura di He<strong>in</strong>rich Keil/Hermann Hogan, ed. B. G. Teubneri, Lipsia,1857-1880, vol.1,48.<br />
75 “Visitando le opere del grande Cesare,/ il gallico Reno, il mare orrendo/ e gli ultimi Britanni …”. “ … Generale unico/ fosti <strong>in</strong> quell’ultima<br />
isola dell’occidente,/ perché questa vostra fottuta m<strong>in</strong>chia/ mangiasse duecentomila o trecentomila sesterzi?”. [Qui “vostra” si riferisce a<br />
Cesare e Mamurra di Formia. Quest’ultimo, appartenente all’ord<strong>in</strong>e equestre e soprannom<strong>in</strong>ato “mentula”o“magna mentula”(cazzone, ma<br />
ricco, e perciò potenzialmente deleterio a tutto tondo) dal poeta (Carm<strong>in</strong>a, CXIV/CXV). Fu Praefectus Fabrum, cioè capo del genio militare<br />
(Gaius Secundus Pl<strong>in</strong>ius, Naturalis Historia, XXXVI, 48). Il ricchissimo e fidato collaboratore del condottiero stette al suo seguito nelle<br />
campagne di guerra di Gallia e Spagna. Morì nel Dicembre 45 a.C. Cesare accolse impassibile la notizia, mentre era nella sala da bagno della<br />
villa di Cicerone a Pozzuoli. (M. T. Cicero, Epistulae ad Atticum, op. cit., XIII, 52)]“ …O cosa può costui(Cesare)/se non divorare grassi<br />
patrimoni?”. “Arrabbiati ancora per i miei giambi/ <strong>in</strong>nocenti, generalissimo.”
“draco”<br />
45<br />
“ascia”<br />
“tiara”<br />
“culullus"<br />
“aspergillum”<br />
Denario d’argento coniato con il nome “Cesare” senza consenso senatoriale, al ritorno dalla vittoriosa campagna di<br />
Gallia [presumibilmente a Mediolanum (Milano)], prima che G. Giulio varcasse il Rubicone (11 Febbraio del 49, ossia<br />
c<strong>in</strong>que anni dopo la scomparsa di <strong>Catullo</strong>). Una sfida aperta alle istituzioni repubblicane! La zecca mobile al seguito del<br />
condottiero emise monete analoghe nel biennio 49 – 48 a. C. per retribuire lo stipendium ai legionari, e più <strong>in</strong> generale<br />
per far fronte alle spese di guerra.<br />
Nel recto, <strong>in</strong> esergo, si legge CAESAR. Un elefante (<strong>in</strong> l<strong>in</strong>gua punica “caesar”…) si appresta ad attaccare un<br />
drago. Risulta evidente l’impianto allegorico dell’affermazione del bene sul male. Nel verso sono visibili gli<br />
emblemi sacrali del Pontifex Maximus, carica ricoperta da Cesare al momento della coniatura: “culullus”, tazza<br />
per bere; “aspergillum”, l’aspersorio; “ascia”, l’ascia per immolare gli animali sacrificali alle div<strong>in</strong>ità; “tiara”, il<br />
copricapo da portare durante il cerimoniale. Qualche tempo dopo il Senato, mostrando buon viso a cattivo gioco,<br />
accorderà al potente uomo di Roma privilegi alla pari di un monarca. A Cesare fu <strong>in</strong>fatti concesso l’onore perenne<br />
di fregiarsi dei paludamenti del trionfatore: il mantello di porpora e l’alloro. Il qu<strong>in</strong>to mese dell’antico anno prese<br />
il suo nome (Luglio=Giulio) e gli fu eretta una statua nel tempio di Quir<strong>in</strong>o, dio delle armate romane <strong>in</strong> tempo di<br />
pace. Per di più poté sedersi su un trono aureo, e addirittura raffigurarsi sulle unità monetarie alla maniera dei<br />
regnanti ellenistici. In tal modo veniva ad essere clamorosamente cancellata la rigida regola repubblicana di<br />
tenere la moneta al di fuori di ogni <strong>in</strong>fluenza politica. Siffatta pretesa di vanità e totalizzante autosponsorizzazione<br />
diventerà <strong>in</strong> seguito appannaggio di tutti gli imperatori romani, perdurando s<strong>in</strong>o alla est<strong>in</strong>zione dell’Impero. Oltre<br />
al titolo di Pontifex Maximus e di Imperator (“Colui che regna <strong>in</strong> assoluto sull’Impero e Comandante <strong>in</strong> Capo<br />
dell’Esercito di Roma”), costoro pretenderanno l’iscrizione della denom<strong>in</strong>azione “Caesar” su ogni esemplare di<br />
emissione monetale <strong>in</strong>erente al periodo di reggenza, ovverosia “Nobile, di grande dignità e degno di lode”.<br />
Ma quale fu l’atteggiamento di Cesare nei confronti del godereccio scapestrato della Roma abbiente?!<br />
Sembra che <strong>Gaio</strong> Giulio tendesse volutamente ad ignorare le sue maligne frecciat<strong>in</strong>e <strong>in</strong> versi (Qu<strong>in</strong>tiliano, Inst.,<br />
11,1,38) non reputandolo <strong>in</strong> alcun modo <strong>in</strong> grado di ostacolare la sua prestigiosa ascesa politico-sociale con il<br />
solo ausilio della vis poetica. E non esistono elementi probatori per non pensare che egli lo considerasse una<br />
simpatica canaglia dallo stile proclive alla “espressione lirica popolare” poco ossequiosa; una ventata di<br />
dissacrante novità, <strong>in</strong> f<strong>in</strong> dei conti, <strong>in</strong>trodotta dal poeta nuovo 76 nella Urbs dei conservatori dalla rigida morale<br />
comune (… rumoresque senum severiorum - Carm<strong>in</strong>a, V, 2). <strong>Catullo</strong>, <strong>in</strong> buona sostanza, era la prova evidente<br />
dei processi di trasformazione <strong>in</strong> corso nella vecchia repubblica ormai al tramonto. Egli rappresentava l’uomo<br />
nuovo nel campo letterario. Progressista, mordace, spregiudicato e <strong>in</strong>tellettualmente attivo, proprio come<br />
Cesare <strong>in</strong> quello politico. L’alter ego del futuro autocrate, <strong>in</strong>somma. Il tono caustico di altri versi lasciano<br />
76 Un poeta del genere non è impegnato <strong>in</strong> valori civili o politici. Scrive per otium, ovvero per il piacere di svolgere un’attività <strong>in</strong>tellettuale.<br />
La poesia diviene divertimento. I Neoteroi rifiutano i componimenti lunghi e le ampollose composizioni mitologiche, consapevoli della<br />
eleganza di un manufatto poetico breve. Si privilegia così la concisione. I Poetae Novi hanno il culto per la bellezza formale, per la parola<br />
cesellata. Il labor limae è dimostrazione di grande competenza l<strong>in</strong>guistica e mitologica. Il mito rappresentato nella composizione poetica<br />
funge da velo da cui traspaiono i sentimenti del suo creatore.
46<br />
<strong>in</strong>tendere che l’artefice delle imprese di Gallia (58-56 a.C) e Britannia (55-54 a.C.) ritenesse la penna del poeta<br />
giovevole alla sponsorizzazione della sua ambiziosa politica di tornaconto personale, e che plaudisse il modo<br />
di comporre brillante e dis<strong>in</strong>ibito del rimatore per accattivarsene il favore. Si trattava, dopotutto, del giudizio<br />
di un competente <strong>in</strong> ambito culturale. Sappiamo da Plutarco di Cheronea, <strong>in</strong>fatti, che il condottiero fu ottimo<br />
oratore e seppe dist<strong>in</strong>guersi per la <strong>in</strong>cisiva semplicità stilistica dei suoi numerosi scritti; prosa asciutta e<br />
limpida,stile da soldato, 77 apprezzati f<strong>in</strong>anche da Cicerone. <strong>Catullo</strong>, però, non la pensava così: Chi Cesare?!<br />
Un eruditulus da strapazzo. Il veronese, dunque, non aveva mostrato alcun entusiasmo per le sviol<strong>in</strong>ate del<br />
rampollo della Gens Julia e senza tanti complimenti gli aveva risposto di non prenderlo neppure <strong>in</strong><br />
considerazione. Un affronto gravissimo e raff<strong>in</strong>atamente crudele all’<strong>in</strong>dirizzo di un uomo - amico di famiglia,<br />
tra l’altro 78 - che di fatto si era guadagnato il centro dell’attenzione del mondo per le sue straord<strong>in</strong>arie azioni<br />
militari:<br />
“Nil nimium studeo Caesar tibi velle placere./ Nec scire utrum sis albus an ater homo”(C., XCIII, 1-2) 79 .<br />
Non mancarono, tuttavia, i momenti di collera da parte del generalissimo contro la punzecchiante<br />
impert<strong>in</strong>enza del giovane verseggiatore, evidentemente allergico ad ogni forma di dispotica arroganza:<br />
“ …irascere iterum meis iambis/<strong>in</strong>merentibus, unice imperator ”(C., LIV, 6-7) 80 .<br />
È strano come la calvizie di Cesare non sia stata oggetto dei giambi al curaro del poeta! Forse un po’ troppo anche per<br />
un impert<strong>in</strong>ente dis<strong>in</strong>ibito come lui!<br />
Si hanno fondate ragioni per ritenere che molti uom<strong>in</strong>i di cultura della Roma repubblicana considerassero<br />
Cesare soltanto un arrivista senza scrupoli, donnaiolo e licenzioso bisessuale. Lo storico Caio Tranquillo<br />
Svetonio (?70 – 140? A.D.), per esempio, riporta che <strong>Gaio</strong> Giulio fosse convolato a nozze quattro volte e<br />
sempre con donne di condizioni agiate: Cossuzia, Cornelia, Pompea e Calpurnia. Amò <strong>in</strong>oltre numerose nobili<br />
matrone: Postumia, moglie di Servio Sulpicio; Lollia, moglie di Aulo Gab<strong>in</strong>io; Tertulla, moglie di Marco<br />
Crasso; e Mucia, moglie di Gneo Pompeo. Ma più di ogni altra ebbe a cuore Servilia, madre di Marco Bruto:<br />
“Sed ante alias dilexit Marci Bruti matrem Serviliam, cui et primo suo consulatu sexagiens sestertium<br />
margaritam mercatus est.” 81<br />
La più celebre delle amanti di Cesare, a parte la reg<strong>in</strong>a Eunce, moglie di Bogude di Mauritania, fu<br />
Cleopatra, 82 reg<strong>in</strong>a dell’antico Egitto, che egli tenne con sé dal 48 s<strong>in</strong>o al di lui assass<strong>in</strong>io. In concomitanza<br />
delle sue imprese militari e del crescente prestigio politico, divenne di pubblico dom<strong>in</strong>io che G. Giulio non<br />
disdegnasse le relazioni sessuali maschili. E dato che agli occhi dei romani un c<strong>in</strong>edo effem<strong>in</strong>ato suscitava<br />
particolare sdegno, si commentano da soli gli <strong>in</strong>fuocati versi di <strong>Catullo</strong> all’<strong>in</strong>dirizzo di chi sarebbe diventato<br />
l’uomo più potente di Roma:<br />
Pulcre convenit improbis c<strong>in</strong>aedis,<br />
Mamurrae pathicoque Caesarique.<br />
nec mirum: maculae pares utrisque,<br />
C’è accordo tra gli sfrontati f<strong>in</strong>occhi,<br />
Mamurra, che è un pederastra passivo, e Cesare.<br />
Non c’è da stupire: hanno entrambi la medesima macchia,<br />
l’una è di Roma e l’altra viene da Formia,<br />
urbana altera et illa Formiana, entrambe rimangono impresse e non si toglieranno;<br />
impressae resident nec eluentur: depravati alla pari, veri fratelli gemelli,<br />
morbosi pariter, gemelli utrique,<br />
tutti e due letteratucoli, e coricati <strong>in</strong> un solo letto,<br />
uno <strong>in</strong> lecticulo erudituli ambo,<br />
non questo più di quello adultero sfrenato,<br />
non hic quam ille magis vorax adulter,<br />
rivales socii puellularum.<br />
pulcre convenit improbis c<strong>in</strong>aedis. (Carm<strong>in</strong>a, LVII)<br />
rivali compagni di ragazz<strong>in</strong>e.<br />
S’<strong>in</strong>tendono a meraviglia gli svergognati <strong>in</strong>vertiti.<br />
77 Plutarco ( 46? A.D/125?A.D..)., Vita di Cesare, 3, a cura di Bonamente G., collana Filo di perle, Studio Tesi Editore, 1994, pagg. XLVIII-207.<br />
78 Svetonio ci dice che sovente Cesare era gradito ospite dell’agiata e nobile famiglia di <strong>Catullo</strong> quando era governatore della Gallia Cisalp<strong>in</strong>a (Italia<br />
Settentrionale). Riporta <strong>in</strong>oltre che l’Imperator fece altrettanto con <strong>Catullo</strong>, ma dopo che questi andò a porgergli le scuse per avere offeso tanto lui quanto<br />
l’amico Mamurra con la satira velenosa dei suoi versi. Svetonius, De vita Caesarum, Divus Julius, Liber I, LXXIII.<br />
79 “Non me ne importa niente, o Cesare, di volerti piacere./ Né m’<strong>in</strong>teressa sapere se tu sia un uomo bianco o nero.”<br />
80 “E torna pure ad <strong>in</strong>cazzarti/ Generalissimo, contro i miei versi <strong>in</strong>nocenti.”<br />
81 Sv., op. cit., Liber I, L: “Ma più di tutte amò Servilia, la madre di Marco Bruto, per la quale - nel corso del suo primo consolato - acquistò una perla del<br />
valore di sei milioni di sesterzi”. (Equivalenti a circa 11 milioni e mezzo di Euro! Pressappoco 22 miliardi di lire del vecchio conio).<br />
82 Sv., op. cit., LII, ci parla della reg<strong>in</strong>a della Muritania Eunoe. Cleopatra VII Tea Filopatore (Κλεοπάτρα θεά φιλοπάτωρ - Cleopatra Tea Filopatore, 69 –<br />
30 a.C) fu l'ultima reg<strong>in</strong>a dell'antico Egitto e l'ultimo membro della D<strong>in</strong>astia tolemaica. Il nome "Cleopatra" significa "gloria del padre" <strong>in</strong> l<strong>in</strong>gua greca.
47<br />
D'altronde lo stesso Svetonio ce lo conferma più di una volta. Durante la campagna di Britannia, ad<br />
esempio, Cesare acquistava schiavi raff<strong>in</strong>ati di bella presenza, spendendo forti somme di denaro. Per una<br />
sorta di pudore personale ord<strong>in</strong>ava poi di non <strong>in</strong>cludere tali spese nel suo bilancio ufficiale:<br />
“…servitia rectiora politioraque <strong>in</strong>menso pretio, et cuius ipsum etiam puderet, sic ut rationibus vetaret<br />
<strong>in</strong>ferri.”(Svetonius. I, xlvii)<br />
Ci parla poi del love affair con Nicomede IV Filopatore, re di Bit<strong>in</strong>ia. Il romano, allora sedicenne, era<br />
stato <strong>in</strong>viato dal console Marco M<strong>in</strong>ucio Termo <strong>in</strong> quella piccola regione dell’Asia M<strong>in</strong>ore (cfr. cart<strong>in</strong>a<br />
geografica pag.9) al f<strong>in</strong>e di richiedere un supporto navale per la riconquista dell’isola di Lesbo. Fu amore<br />
a prima vista. Il “discendente di venere” tornò ad <strong>in</strong>contrare la sua fiamma qualche tempo dopo,<br />
adducendo la scusa del recupero di un credito presso un liberto. 83<br />
Pers<strong>in</strong>o le legioni di Cesare vittorioso <strong>in</strong> Gallia nei carm<strong>in</strong>a triumphalia 84 pervenutici facevano<br />
riferimento al “vizietto” del loro comandante supremo, che canzonavano sguaiatamente:<br />
“Gallico denique triumpho milites eius <strong>in</strong>ter cetera carm<strong>in</strong>a, qualia currum prosequentes ioculariter canunt,<br />
etiam illud vulgatissimum pronuntiaverunt:<br />
Gallias Caesar subegit, Nicomedes Caesarem: ecce Caesar nunc triumphat qui subegit Gallias,<br />
Nicomedes non triumphat qui subegit Caesarem” 85<br />
Legionari <strong>in</strong> marcia - monete romane risalenti all’epoca di Cesare Ottaviano Augusto<br />
Durante la dittatura di G. Cesare le prov<strong>in</strong>ce romane divennero 18. Dieci <strong>in</strong> occidente (Sicilia, Sardegna, Corsica, Gallia Cisalp<strong>in</strong>a, Illirico, Gallia Narbonese, Gallia Comata,<br />
Spagna Citeriore, Spagna Ulteriore, Africa Vetus, Africa Nova) e 8 <strong>in</strong> oriente (Macedonia, Acaia ed Epiro, Creta, Asia, Bit<strong>in</strong>ia e Ponto, Cilicia e Cipro, Siria, Cirenaica. Tali<br />
territori furono distribuiti ai veterani e <strong>in</strong> essi vennero stabilite numerosissime colonie militari. Cfr.: “Storia d’Italia” di Luisa Gabbiani Flynn, <strong>in</strong>:<br />
http://www.italystl.com/storia.htm.<br />
83 Svetonius, op. cit: II. Lo storico tratta di Cesare anche nei paragrafi XLVII, XLIX, L, LI, LII,LVII.<br />
64 Erano canti che i legionari romani <strong>in</strong> marcia improvvisavano a conclusione di imprese militari vittoriose da parte del loro comandante.<br />
Tali motivetti contenevano <strong>in</strong>sieme espressioni di elogio e di sbeffeggiamento nei confronti del v<strong>in</strong>citore. Pare che la loro funzione fosse<br />
quella di mitigare con il riso l'esaltazione della vittoria, per non <strong>in</strong>durre alla superbia il protagonista della spedizione militare. Cfr.:<br />
http://it.wikipedia.org/wiki/Fescenn<strong>in</strong>i. G.S. Curione Padre (m. 53 a.C.), citato anche da Svetonio, ebbe a dire nei suoi “Discorsi” che<br />
Cesare era “la moglie di tutti i mariti e il marito di tutte le mogli”.<br />
85 Svetonius, op. cit. XLIX. Si allude addirittura all’omosessualità passiva di Cesare: “Inf<strong>in</strong>e nel suo (di Cesare) trionfo <strong>in</strong> Gallia i di lui<br />
soldati - tra le canzonc<strong>in</strong>e sfottenti che di solito venivano cantate da quanti erano al seguito del carro (del vittorioso condottiero) -<br />
stornellavano un motivetto ben noto ancora oggi: Cesare ha sottomesso le Gallie, Nicomede ha sottomesso Cesare: ecco, Cesare che ha<br />
sottomesso le Gallie, ora trionfa, Nicomede che ha sottomesso Cesare non riporta nessun trionfo”. Ma cantavano anche: “Urbani, servate<br />
uxores: moechum calvom adducimus./ Aurum <strong>in</strong> Gallia effutuisti, hic sumpsisti mutuum.” [“Cittad<strong>in</strong>i, sorvegliate le vostre donne: vi<br />
portiamo l’adultero calvo; / In Gallia, o Cesare, hai dissipato con le donne il denaro che qui hai preso <strong>in</strong> prestito.”]. (Svetonius , o.c. I, LI).
48<br />
M. T. Cicerone - Musei Capitol<strong>in</strong>i - Roma<br />
Cleopatra VII Tea Filopatore “Il più eloquente dei nipoti di Romolo”(<strong>Catullo</strong>, C., xlix,1)<br />
86<br />
British Museum – Londra “Le idi di Marzo sono il nostro conforto”<br />
“La fuga della reg<strong>in</strong>a (Cleopatra) non mi dà fastidio” 87<br />
“Aureo” raffigurante Marco Giunio Bruto Cepione (85-42 a.C.), il Cesaricida.<br />
Recto. IMP(ERATOR) BRUT(US) L.(UCIUS ) PLAET.(ORIUS) CEST(IANUS)<br />
Verso. EID(IBUS).MAR(TIIS)<br />
[(R..) Bruto Comandante vittorioso dell’esercito (repubblicano che operò <strong>in</strong> Illiria e Macedonia dal 43 al 42 a.C.).<br />
Lucio Pletorio Cestiano (magistrato coniatore <strong>in</strong> carica della zecca mobile di Bruto). (V.) Idi di Marzo ].<br />
A s<strong>in</strong>istra M. G. Bruto appare raffigurato di profilo con la barba, tratto dist<strong>in</strong>tivo di rispetto e dignità. A destra compaiono due<br />
pugnali, la più che eloquente firma di Bruto e Cassio cesaricidi. Fra le armi si staglia<br />
il pileo frigio, simbolo di libertà. Il berretto era di solito portato dagli schiavi affrancati.<br />
86 “Idus Martiae consolantur”. M. T. Cicerone, “Lettere ad Attico”, XIV, 4, [scritta a Lanuvio il 10 Aprile del 44, anno 358 A.U.C.].<br />
87 “Reg<strong>in</strong>ae fuga mihi non molesta est”. Ibidem XIV,8, 1. [16 aprile del 44 a.C. - 362 ab Urbe Condita]. Cleopatra fu presumibilmente<br />
costretta ad abbandonare Roma <strong>in</strong> tutta fretta, dopo l’assass<strong>in</strong>io di Cesare, temendo per sé e per il figlio Cesarione, frutto della relazione con<br />
il dittatore.
49<br />
M o e c i l i a … 88<br />
professione: adultera<br />
Con un solo colpo ben assestato d’ironia commista a disprezzo <strong>Catullo</strong> centra due bersagli contigui:<br />
l’ambizioso Pompeo - con Cesare padrone di Roma e saccheggiatore del mondo - e Mucia (amica di Clodia-<br />
Lesbia), la di lui ex moglie, che con la sua condotta libert<strong>in</strong>a viola costantemente le leggi del vero amore.<br />
Per il versificatore veronese tutto questo sembra essere <strong>in</strong>tollerabile. Un legame amoroso credibile deve<br />
seguire un pr<strong>in</strong>cipio assoluto affettivo che veda il bene velle, l’aeternum e il sanctae foedus amicitiae (C., CIX,<br />
6) prevalere sul carnale amare (C.,LXXII), pur riconoscendo all’energia libidica che si libera da quest’ultimo<br />
atto il ruolo di farci sentire vivi al mondo. Nel corso del primo consolato di Pompeo (70 a.C.) Mucia aveva<br />
due amanti. Ora che il consorte - dal quale nel frattempo ha divorziato - è console per la seconda volta (55<br />
a.C.), la cifra due è la stessa, ma …con tre zeri <strong>in</strong> più! (Anche Giulio Cesare è da annoverare fra i tanti<br />
libert<strong>in</strong>i accontentati! Cfr. pag. 33).<br />
Consule Pompeio primum duo, C<strong>in</strong>na 89 , solebant<br />
Moeciliam: facto consule nunc iterum<br />
manserunt duo, sed creuerunt milia <strong>in</strong> unum<br />
s<strong>in</strong>gula. fecundum semen adulterio. (C., CXIII)<br />
Scena erotica su coppa romana <strong>in</strong> argento - I sec. A.D.<br />
“The Warren Cup” - British Museum - Londra<br />
Sotto il primo consolato di Pompeo due, C<strong>in</strong>na, avevano<br />
commercio amoroso con Moecilia: adesso, diventato quello<br />
console per la seconda, i due sono rimasti, ma crebbero ognuno<br />
s<strong>in</strong>o a mille per ciascuno. È fecondo il seme dell'adulterio.<br />
Denario d’argento con il busto di Gneo Pompeo<br />
Magno (106-48 a.C.)<br />
Zecca di Cantana - Sicilia<br />
Ai lati oggetti religiosi rituali: urna e lituus<br />
Periodo repubblicano 49-39 a.C.<br />
“MAG(nus)PIVS IMP(erator)ITER”<br />
Museum of f<strong>in</strong>e arts - Boston<br />
« … urbis o putissimei/ socer generque … » (C., XXIX vv. 24-25 ) 90<br />
88<br />
Moecilia, Moecilla o Mucilla sono i dim<strong>in</strong>utivi di Mucia, ex moglie di Pompeo. In alto a ds. fanciulla <strong>in</strong> bik<strong>in</strong>i (particolare). Enna, villa<br />
romana del casale, ca. IV AD.<br />
89<br />
G. Elvio C<strong>in</strong>na, orig<strong>in</strong>ario di Brescia, poeta neoterico del I sec. a.C. <strong>Catullo</strong> lo ammirò per l’epillio Zmyrna. Cfr. anche cc.10 e 113.<br />
90<br />
“… Perle rare di Roma/suocero e genero”(NB che qui putissimei è assonanza di putidissimi = fetentissimi). G. Pompeo Magno sposò<br />
Giulia, figlia di Cesare, nel 59 a.C. Con il suocero e Marco Lic<strong>in</strong>io Crasso - il v<strong>in</strong>citore di Spartaco - fece parte di un accordo segreto def<strong>in</strong>ito
Tagliente con i rivali <strong>in</strong> amore … (“puttanieri di angiporti”)<br />
91<br />
50<br />
Rufo si domanda perché le donne lo resp<strong>in</strong>gano 92<br />
Semplice! Nelle sue ascelle abita un selvaggio caprone!<br />
Noli admirari, quare tibi fem<strong>in</strong>a nulla,<br />
Rufe, uelit tenerum supposuisse<br />
femur,<br />
non si illam rarae labefactes munere<br />
uestis<br />
aut perluciduli deliciis lapidis.<br />
laedit te quaedam mala fabula, qua tibi fertur<br />
ualle<br />
sub alarum trux habitare caper.<br />
hunc metuunt omnes; neque mirum: nam<br />
mala ualde<br />
est<br />
bestia, nec quicum bella puella cubet.<br />
quare aut crudelem nasorum <strong>in</strong>terfice pestem,<br />
aut<br />
admirari des<strong>in</strong>e cur fugiunt. Carm<strong>in</strong>a,LXIX<br />
Non stupirti perché nessuna donna,<br />
o Rufo, voglia stendere sotto di te le sue tenere cosce,<br />
neppure se tentassi di farla vacillare col dono di una<br />
rara veste o con l’attrazione di una pietra di trasparenza<br />
delicata. Ti nuoce una cattiva diceria, secondo cui si<br />
dice che nell’avvallamento delle tue ascelle abita un<br />
selvaggio caprone.<br />
Questo<br />
temono tutte, e non c’è da stupirsi: <strong>in</strong>fatti<br />
è<br />
una gran brutta bestia, con cui nessuna bella ragazza<br />
va a letto.<br />
Per cui o uccidi quella crudele pestilenza per i nasi,<br />
o smetti di stupirti perché le donne ti evitano.<br />
G iochi di Taverna<br />
via di Mercurio<br />
Pompei<br />
Primo Triunvirato (60 a.C.). In pratica la cricca dei tre (Crasso aveva il denaro, Pompeo i veterani, Cesare l’appoggio della plebe) si<br />
garantiva aiuto reciproco contro il Senato, al f<strong>in</strong>e di ottenere vantaggi politici consistenti che avrebbero consentito loro di spartirsi il potere.<br />
A Roma, ovviamente, molti <strong>in</strong>tellettuali come <strong>Catullo</strong> osteggiarono sdegnosi questo <strong>in</strong>trallazzo alla grande, conv<strong>in</strong>ti che le mire politiche<br />
della triade sarebbero state fonte di violenza civile.<br />
91 “Semitarii moechii”, Carm<strong>in</strong>a, 37, v.16.<br />
92 Sembra essere Marco Celio Rufo (82-48 a.C.). Allievo di Cicerone. Lesbia lo preferì a <strong>Catullo</strong> (Cfr.: pag.4, nota 10). Nel carme LXIX,<br />
forse dedicato a Lesbia, ci dice che lo spregevole <strong>in</strong>dividuo è affetto anche da gotta (podagra) In alto a destra mosaico di giovane romano.<br />
Terme di Caracalla. 211-217 A.D.
51<br />
Egnatius “denti bianchi”…<br />
lui, ride … ride sempre!<br />
“Se tu fossi Romano o Sab<strong>in</strong>o o di Tivoli<br />
o grasso Umbro o Etrusco obeso<br />
o Lanuv<strong>in</strong>o nero e tutto denti<br />
uno dell’Oltrepò, per metterci anche i miei,<br />
o chiunque, che si lava i denti con acqua pura,<br />
anche allora vorrei che tu<br />
non ridessi cont<strong>in</strong>uamente d’ogni cosa:<br />
niente è più sciocco di un modo sciocco di ridere.<br />
Per di più sei Celtibero: e <strong>in</strong> terra di Celtiberia<br />
la matt<strong>in</strong>a tutti si strof<strong>in</strong>ano a sangue<br />
gengive e denti con la propria ur<strong>in</strong>a.<br />
Così più bianchi sono questi vostri denti<br />
e più rivelano il piscio che hai bevuto.” (C., XXXIX, vv.15-21) 93<br />
«Si urbanus esses aut Sab<strong>in</strong>us aut Tiburs<br />
aut p<strong>in</strong>guis Vmber aut obesus Etruscus<br />
aut Lanuv<strong>in</strong>us ater atque dentatus<br />
aut Transpadanus, ut meos quoque att<strong>in</strong>gam,<br />
aut quilubet, qui puriter lavit dentes,<br />
tamen renidere usque quaque te nollem:<br />
nam risu <strong>in</strong>epto res <strong>in</strong>eptior nulla est.<br />
nunc Celtiber es: Celtiberia <strong>in</strong> terra,<br />
quod quisque m<strong>in</strong>xit, hoc sibi solet mane<br />
dentem atque russam defricare g<strong>in</strong>givam,<br />
ut quo iste vester expolitior dens est,<br />
hoc te amplius bibisse praedicet loti».<br />
La più antica protesi dentaria scoperta <strong>in</strong> tempi recentissimi<br />
(maggio 2007). Appartenne ad una agiata donna romana del I o II<br />
sec A.D. I denti erano tenuti <strong>in</strong>sieme da un filo d’oro di molti<br />
carati.<br />
Cfr.: http://guide.dada.net/lat<strong>in</strong>o/<strong>in</strong>terventi/2007/05/295340.shtml<br />
A sn.: mosaico pompeiano di figura femm<strong>in</strong>ile<br />
Ora al museo di Capodimonte - Napoli<br />
93 Egnazio è uno spagnolo di orig<strong>in</strong>e italica con nome sannitico, uno dei tanti farfalloni che volano <strong>in</strong>torno a Lesbia e gozzovigliano con lei.<br />
<strong>Catullo</strong>, evidentemente geloso, reagisce con feroce eleganza, scior<strong>in</strong>ando poeticamente le sue peggiori abitud<strong>in</strong>i comportamentali. Il<br />
Celtibero doveva risultare particolarmente antipatico al poeta, giacché lo bersagliò di versi al curaro s<strong>in</strong> dal carme 37, vv.17-20. La tematica<br />
dei denti bianchi compare lì per la prima volta. In più il poeta sfodera il suo migliore sarcasmo nei confronti del giovane rivale. Come può<br />
andare fiero del proprio aspetto uno che è esageratamente capellone, porta la barba <strong>in</strong>colta ed è “ nato fra i conigli della Spagna”?!
52<br />
Pillole …<br />
Ai tempi di <strong>Catullo</strong> si viaggiava così …<br />
“Raeda” - Bassorilievo funerario – Virunum (Zollfeld) – Car<strong>in</strong>zia(Austria)<br />
La raeda, <strong>in</strong>sieme al cisium, all’essedum, al cov<strong>in</strong>us, e al carpentium, divenne la vettura di uso più comune a Roma per il<br />
trasporto di persone e/o bagagli su lunghe distanze. Coperta e abbastanza confortevole per quei tempi, era <strong>in</strong> genere tra<strong>in</strong>ata da<br />
due as<strong>in</strong>i/onagri. I benestanti ambivano ad acquistarne una con due cavalli da tiro per meglio ostentare la loro agiatezza:“Hic<br />
Vedius mihi obviam venit cum duobus essedis et raeda equis iuncta et laectica et familia magna …” [“Questo Vedio (Publio Vedio<br />
Pollione?) mi è venuto <strong>in</strong>contro con due calessi, una carrozza da viaggio tirata da cavalli, una lettiga ed un seguito imponente di schiavi…”<br />
Cic., Aepistulae ad Atticum, VI, 1, 24]. Era noleggiabile, anche con raedarium (vetturale), presso le mansiones, ossia le stazioni postali<br />
situate ad una giornata di viaggio le une dalle altre, dove era possibile effettuare un cambio di pariglia di bestie da tra<strong>in</strong>o ben<br />
riposate ed allogate negli stabula (magazz<strong>in</strong>i e scuderie). Tale operazione era eseguibile anche presso le mutationes (luoghi di tappa<br />
e di rifornimento viveri ogni 5 miglia romane. 1 miglio romano = 1478,5 m.). Il vettur<strong>in</strong>o/passeggero poteva effettuare una sosta di<br />
riposo presso gli hospitia (alberghi) e i deversorioli (alberghetti, locande. Cic., ibidem, XIV, 8 ) dissem<strong>in</strong>ati <strong>in</strong> buon numero lungo i percorsi.<br />
Una raeda tirata da due spediti destrieri era <strong>in</strong> grado di raggiungere l’<strong>in</strong>credibile velocità di sei miglia romane all’ora (circa 9 km.<br />
all’ora). Svetonio ci racconta che <strong>in</strong> Gallia Giulio Cesare era solito noleggiarne una per trasferirsi più celermente - “<strong>in</strong>credibili<br />
celeritate”- da un luogo all’altro del territorio, riuscendo a percorrere “centena passuum milia <strong>in</strong> s<strong>in</strong>gulos dies”[(“100.000 passi al<br />
giorno”, pari a 100 km al giorno, dato che 1 passo romano equivaleva ad 1 metro.) - De vita Caesarum, Divus Julius, Liber I, LVII.].<br />
Cicerone - che da Governatore della Cilicia aveva viaggiato <strong>in</strong> raeda (ad Atticum, V, 16, 1 - 51 a.C.) - <strong>in</strong> un certo senso, avalla quanto<br />
asserisce Svetonio allorché Clodio, lo scapestrato fratello di Lesbia, afferma di aver percorso la distanza Mess<strong>in</strong>a-Roma <strong>in</strong> sette<br />
giorni [691 km., più il tempo della “traiectio” (traghettamento)]. È molto probabile, qu<strong>in</strong>di, che egli si fosse servito dello stesso<br />
mezzo di trasporto:“Ex Sicilia septimo die Romam” [(“Dalla Sicilia a Roma ce l’hai fatta <strong>in</strong> sette giorni”) – Cic., ad Atticum II, 1, 5].<br />
La raeda era orig<strong>in</strong>aria della Gallia e della Britannia, usata anche come carro da guerra. Gli artigiani Romani <strong>in</strong>iziarono a<br />
produrla per il mercato <strong>in</strong>terno dopo che numerosi esemplari erano stati portati nell’Urbe come bott<strong>in</strong>o di guerra.
53<br />
Emilio e Vezio … aliti micidiali!<br />
Affresco I sec a.C. - Ca.mare di Stabia (Na)<br />
“<br />
Non (ita me di ament) quicquam referre putavi,<br />
utrumne os an culum olfacerem Aemilio.<br />
nilo mundius hoc, nihiloque immundius illud,<br />
verum etiam culus mundior et melior:<br />
nam s<strong>in</strong>e dentibus est. hic dentis sesquipedalis,<br />
g<strong>in</strong>givas vero ploxeni habet veteris,<br />
praeterea rictum qualem diffissus <strong>in</strong> aestu<br />
meientis mulae cunnus habere solet.<br />
hic futuit multas et se facit esse venustum,<br />
et non pistr<strong>in</strong>o traditur atque as<strong>in</strong>o?<br />
quem siqua att<strong>in</strong>git, non illam posse putemus<br />
aegroti culum l<strong>in</strong>gere carnificis? Carm<strong>in</strong>a, XCVII<br />
In te, si <strong>in</strong> quemquam, dici pote, putide Victi,<br />
id quod verbosis dicitur et fatuis.<br />
ista cum l<strong>in</strong>gua, si usus veniat tibi, possis<br />
culos et crepidas l<strong>in</strong>gere carpat<strong>in</strong>as.<br />
si nos omn<strong>in</strong>o vis omnes perdere, Victi,<br />
hiscas: omn<strong>in</strong>o quod cupis efficies.<br />
Carm<strong>in</strong>a, XCVIII<br />
Non ho mai creduto (che gli dei non si offendano) che facesse differenza,<br />
annusare la bocca o il culo di Emilio.<br />
L’una non è più pulita o sporca dell’altro,<br />
o meglio, di certo è più pulito e migliore il culo:<br />
<strong>in</strong>fatti è senza denti. Quella <strong>in</strong>vece ha denti enormi,<br />
e gengive simili alle sponde di un carro vecchio,<br />
poi di solito tiene la bocca aperta come<br />
la vulva spaccata di una mula <strong>in</strong> calore mentre piscia.<br />
Costui ne ha fottute molte di femm<strong>in</strong>e e si considera bello,<br />
ma perché non lo mandano a far l’as<strong>in</strong>o nel mul<strong>in</strong>o?<br />
Se una femm<strong>in</strong>a lo palpeggia, non pensiamo forse che quella sarebbe<br />
capace<br />
pers<strong>in</strong>o di leccare il culo di un boia appestato?<br />
A nessuno peggiore di te, Vezio schifoso, si può dire,<br />
ciò che si dice ai ciarlatani ed agli ottusi.<br />
Con quella tua l<strong>in</strong>guaccia, se mai ti capitasse l’occasione, potresti<br />
leccare culi e scarponi di cuoio.<br />
E se <strong>in</strong> un colpo vorrai farci crepare tutti, Vezio,<br />
apri la bocca: otterrai <strong>in</strong> un colpo ciò che desideri.
54<br />
“A”… come Amicizia! e Amore!<br />
Giovenzio … “mi puer/ meos amores”C., xxi<br />
Mellitos oculos tuos, Iuventi 94 ,<br />
si quis me s<strong>in</strong>at usque basiare,<br />
usque ad milia basiem trecenta<br />
nec numquam videar satur futurus,<br />
non si densior aridis aristis<br />
sit nostrae seges osculationis. Carm<strong>in</strong>a, XLVIII<br />
Melliflui gli occhi tuoi, Giovenzio,<br />
se mai mi si permettesse di baciarli sempre,<br />
sempre f<strong>in</strong>o a trecentomila volte li bacerei<br />
e non mi sembra che sarei mai sazio,<br />
nemmeno se la messe del nostro baciarci<br />
fosse più densa delle spighe mature.<br />
Busto di Ant<strong>in</strong>ous Mondragone<br />
(amante dell’Imperatore Adriano)<br />
ca. 130 A.D. - Louvre - Parigi<br />
300.000 baci e …<br />
non sentirsi mai sazio!<br />
Il “Vizio Greco”<br />
La pederastia non era biasimata se praticata<br />
con schiavi e liberti, dato che quest’ultimi<br />
avevano il dovere di accondiscendere sempre<br />
alla volontà del loro padrone. Ad un romano<br />
era consentito <strong>in</strong>trattenersi con uno “scortum”<br />
(prostituto), potendo contare sulla certezza dell’<br />
impunibilità. Ma nel rapporto omoerotico tra<br />
due liberi cittad<strong>in</strong>i, si <strong>in</strong>fliggeva la pena -<br />
un’ammenda - a colui che fosse stato sorpreso<br />
<strong>in</strong> flagrante atteggiamento passivo, “mollis<br />
impudicitia”, (<strong>in</strong> ossequio al concetto romano di<br />
“vir”). La multa era molto salata e ammontava a<br />
10.000 sesterzi, “multa rogata”.<br />
La “Lex Scat<strong>in</strong>ia” (149 a.C.), regolamentò, per<br />
così dire, la pratica omosessuale, apparendo<br />
nel contempo come il primo timido tentativo di<br />
tutelare i fanciulli liberi. Costoro circolavano<br />
portando al collo un legaccio di cuoio o una<br />
catenella con un pendente /amuleto, la “bulla”,<br />
<strong>in</strong>dicante la loro condizione sociale. In caso di<br />
rapporto fra adulti e “pueri” o “praetextati” (da<br />
“praetexta”, la tunica bianca con l’orlo di porpora<br />
che portavano i fanciulli ancora non maturi<br />
sessualmente) veniva punito solo l'adulto,<br />
“stuprum cum puero libero”.<br />
Cfr.: “Vita quotidiana nell’Antica Roma”, <strong>in</strong>:<br />
http://www.archeoempoli.it/anticaroma.htm.<br />
“L’omosessualità a Roma”, <strong>in</strong>:<br />
http://www.luzappy.eu/omosessualita/omosex-pres.doc<br />
94 Anche Giovenzio, (un efebo di Verona?!) lo tortura con “il supplizio della croce” (C. 99). Il poeta lo descrive volubile e scontroso nei suoi riguardi.<br />
L’ambiguità nella vita sessuale di un <strong>in</strong>dividuo <strong>in</strong> genere non destava particolare scalpore <strong>in</strong> quei tempi a Roma. Il giovane si trova al centro dell’attenzione<br />
sentimentale del poeta anche nei Carm<strong>in</strong>a 15, 21, 24, e 81, e molti amici del poeta se lo contendono, Aurelio compreso (C., 21). Da notare come <strong>Catullo</strong> sia<br />
solito dispensare baci a migliaia ai suoi amori: 300.000 a Giovenzio nel carme XLVIII e 3500 a Lesbia nel V. La generosità di tali dimostrazioni di affetto è<br />
criticata dai suoi amici, come si ev<strong>in</strong>ce dal virulentissimo carme XVI. <strong>Catullo</strong> e i suoi contemporanei ritenevano che un vero uomo potesse permettersi di tutto<br />
dal punto di vista sessuale. Si poteva corteggiare ed amare una donna sposata, avere pers<strong>in</strong>o rapporti omosessuali con adulti e ragazzi, conservando<br />
sostanzialmente rispettabilità e dignità agli occhi del mondo (cfr.: Cesare pagg. 31-34). Ciò che non doveva mai venire meno era <strong>in</strong>vece la virilità di un uomo.<br />
Tale tesi è sostenuta con forza da Thomas Nelson W<strong>in</strong>ter <strong>in</strong>: “Catullus Purified” – University of Nebraska-L<strong>in</strong>con, year 1973, pag. 261. L’articolo letterario è<br />
reperibile per <strong>in</strong>tero nel web <strong>in</strong>: http://digitalcommons.unl.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1001&context=classicsfacpub.
“… mi brucia <strong>in</strong> corpo un desiderio senza freni” 95<br />
“… mia dolce Ipsitilla”<br />
Amabo, mea dulcis Ipsitilla,<br />
meae deliciae, mei lepores,<br />
iube ad te veniam meridiatum.<br />
et si iusseris, illud adiuvato,<br />
ne quis lim<strong>in</strong>is obseret tabellam,<br />
neu tibi lubeat foras abire,<br />
sed domi maneas paresque nobis<br />
novem cont<strong>in</strong>uas fututiones.<br />
verum si quid ages, statim iubeto:<br />
nam pransus iaceo et satur sup<strong>in</strong>us<br />
pertundo tunicamque palliumque.<br />
55<br />
Satiro con Menade Pompei - Casa di Cecilio Giocondo - 1-50 d.C. - M.A.N.N<br />
Ti prego, mia dolce Ipsitilla,<br />
mia delizia, mio tesoro,<br />
fammi venire da te nel pomeriggio.<br />
E se lo farai, organizzati sì che<br />
nessuno chiuda il battente dell'<strong>in</strong>gresso,<br />
e non ti salti <strong>in</strong> mente d'andartene fuori,<br />
piuttosto restatene <strong>in</strong> casa e preparami<br />
nove scopate di fila.<br />
Se ne hai voglia, però, <strong>in</strong>vitami immediatamente:<br />
perché dopo mangiato, così disteso, sazio e sup<strong>in</strong>o<br />
io sfondo tunica e mantello. Carmi, XXXII.<br />
95 “… ignis mollibus ardet <strong>in</strong> medullis”. Carmi, XLV, v.16. <strong>Catullo</strong> ripagò con la stessa moneta la condotta libert<strong>in</strong>a di Lesbia: Ipsitilla,<br />
Ameana, Aufilena, Postumia, la Rossa di Bologna, e non pochi giovanetti dagli occhi melliflui, come quelli di Giovenzio.
56<br />
Pio con il compianto fratello<br />
“… <strong>in</strong> perpetuum, frater, ave atque vale.”<br />
Il fratello di <strong>Catullo</strong> morì <strong>in</strong> Bithynia nel 58 a.C. Il poeta ebbe occasione di visitarne la tomba tra il 57 e il 56.<br />
Multas per gentes et multa per aequora<br />
vectus<br />
advenio has miseras, frater, ad <strong>in</strong>ferias,<br />
ut te postremo donarem munere mortis<br />
et mutam nequiquam alloquerer<br />
c<strong>in</strong>erem.<br />
quandoquidem fortuna mihi tete abstulit<br />
ipsum.<br />
heu miser <strong>in</strong>digne frater adempte mihi,<br />
nunc tamen <strong>in</strong>terea haec, prisco quae<br />
more parentum<br />
tradita sunt tristi munere ad <strong>in</strong>ferias,<br />
accipe fraterno multum manantia fletu,<br />
atque <strong>in</strong> perpetuum, frater, ave atque<br />
vale.<br />
NB) La cerimonia funebre, consistente<br />
nell’onorare con offerte rituali (v<strong>in</strong>o, miele,<br />
fiori, cibo, cfr. c. 59) la memoria dei propri cari<br />
sulle tombe, era denom<strong>in</strong>ata “parentatio”<br />
perché <strong>in</strong> tale occasione si gridava “o parens!”,<br />
(o antenato!).<br />
Portato per molte genti e per molti mari<br />
sono giunto, fratello, a queste meste<br />
offerte funebri,<br />
per donarti l'estremo dono di morte<br />
e per parlare <strong>in</strong>vano col tuo cenere muto.<br />
Dal momento che la sorte mi ha strappato<br />
proprio te.<br />
Ohimè <strong>in</strong>felice fratello <strong>in</strong>giustamente<br />
strappatomi,<br />
ora tuttavia <strong>in</strong>tanto accogli queste cose, che<br />
secondo l'antica consuetud<strong>in</strong>e degli antenati<br />
sono a te offerte <strong>in</strong> triste tributo come<br />
sacrificio funebre,<br />
accoglile grondanti assai di pianto fraterno,<br />
e stammi bene, fratello, addio per sempre.<br />
Carm<strong>in</strong>a, CI
57<br />
“Secondo la sua Prima ovunque si trovi saluta. T’imploro d’amarmi, Signora” 96<br />
“Secundus Prim(a)e suae ubique isse(t)[esset] salute. Rogo, dom<strong>in</strong>a, ut me amis [ames].”<br />
Pompei I sec. a.C. (8000 ab. ca.) – iscrizione parietale –<br />
[Corpus Inscriptionum Lat<strong>in</strong>arum – vol. IV - n.1023]<br />
Ercole e Deianira o tenerezze fra<br />
una coppia di amanti.<br />
Affresco parietale - Pompei<br />
“Bulla” d’oro – I sec. a.C.<br />
Ariccia - Roma - Palazzo Massimo alle Terme<br />
Museo Nazionale (cfr.: pag. 54)<br />
96<br />
Irridere sui muri delle abitazioni la irreprensibilità altrui, lodare, esprimere sentimenti di passione e di odio<br />
all’<strong>in</strong>dirizzo di qualcuno/a erano nel mondo lat<strong>in</strong>o pratiche molto comuni. <strong>Catullo</strong>, per esempio, non di rado m<strong>in</strong>accia di bollare<br />
d’<strong>in</strong>famia i suoi rivali d’amore nei modi più disparati a lui congeniali. Uno tra questi è graffire sulla parete esterna della taverna <strong>in</strong> cui<br />
si trovano a gozzovigliare con la sua Lesbia – conv<strong>in</strong>ti di cornificarlo – che essi sono degli emeriti “culattoni” : “ Atqui putate:<br />
namque totius vobis/frontem tabernae sopionibus scribam.” (Perciò credetelo: scriverò su tutto il frontone dell’osteria che avete il<br />
culo rotto). C., xxxvii, vv.9-10.
58<br />
Forse <strong>Catullo</strong> des<strong>in</strong>ava così …<br />
“I Romani mangiavano seduti su uno sgabello, di rado, a tavola, quasi sempre <strong>in</strong> cuc<strong>in</strong>a accanto al fuoco se faceva freddo. Con<br />
il passare del tempo e con il miglioramento delle condizioni economiche, i Romani più abbienti dest<strong>in</strong>arono una stanza al pasto<br />
(tabl<strong>in</strong>um). Soltanto dal II secolo a.C. essi <strong>in</strong>iziarono a mangiare sdraiati sul tricl<strong>in</strong>ium” 97<br />
Di buon’ora, appena sveglio e senza neanche lavarsi le mani, il Romano consuma uno dei due pasti della giornata,<br />
una colazione sostanziosa a base di pane e formaggio, frutta e carne. Si tratta spesso degli avanzi della cena del<br />
giorno prima, che gli <strong>in</strong>vitati ad un banchetto possono portarsi a casa <strong>in</strong> un cest<strong>in</strong>o. Sbrigati i primi affari, si<br />
dedica al prandium, lo spunt<strong>in</strong>o della tarda matt<strong>in</strong>ata, sobrio e veloce. L’evento cul<strong>in</strong>ario della giornata si svolge<br />
<strong>in</strong>vece al pomeriggio, quando il Romano abbiente, dopo il consueto bagno alle terme, e qu<strong>in</strong>di verso le tre o le<br />
quattro del pomeriggio, si siede comodamente a tavola f<strong>in</strong>o al calare del sole. Qui le portate sono numerose, f<strong>in</strong>o<br />
a sei, ognuna con una serie svariata di piatti. Nella cena normale dopo l’antipasto - gustatio - seguono le portate<br />
pr<strong>in</strong>cipali di carne e pesce e si chiude con le secundae mensae, cioè i dessert. La serata cont<strong>in</strong>ua con il simposio,<br />
<strong>in</strong> cui alla mescita di v<strong>in</strong>o - sempre annacquato - si accompagna ancora qualche cibo, come i porri, che stimolano<br />
la voglia di bere. Una serie di norme di buona educazione e di etichetta regola la cena, anche rispetto alla<br />
disposizione dei posti a tavola. Nel tricl<strong>in</strong>io (sala da pranzo), <strong>in</strong>fatti, il padrone di casa fa disporre i letti tricl<strong>in</strong>iari,<br />
su cui i convitati si distendono a due o tre, sostenendosi con il braccio s<strong>in</strong>istro piegato. In tal modo la mano<br />
destra è libera di afferrare i cibi dai bassi tavol<strong>in</strong>i accuratamente imbanditi davanti agli ospiti.<br />
Il posto d’onore, detto “consolare”, è all’estrema destra del letto centrale, ed è così chiamato dal fatto che un<br />
messaggero, entrando dalla porta postagli di fronte, può facilmente trasmettere al convitato ivi disteso una<br />
comunicazione importante e urgente. Il padrone di casa si dispone subito a s<strong>in</strong>istra dell’ospite d’onore.<br />
Nelle case più ricche le sale da pranzo sono più d’una, e vengono occupate secondo la stagione dell’anno e<br />
l’orientamento : i tricl<strong>in</strong>i estivi, spesso sem<strong>in</strong>terrati e contenenti fontanelle e giochi d’acqua, sono orientati a<br />
nord, mentre quelli <strong>in</strong>vernali prospettano a ovest, fatto che permette di cogliere gli ultimi raggi di sole della<br />
giornata. L’alimentazione romana di epoca arcaica e repubblicana è sobria, a base di legumi, cereali, formaggio e<br />
frutta ; con la conquista dell’Oriente, <strong>in</strong>vece, almeno sulle mense ricche, arrivano nuovi <strong>in</strong>gredienti da tutte le<br />
prov<strong>in</strong>ce.Accanto al pane quotidiano, alla puls (sorta di polenta condita), alle grandi quantità di lup<strong>in</strong>i, lenticchie,<br />
ceci e soprattutto fave, oltre a lattughe, cavoli e porri, fichi, mele e pere, <strong>in</strong>com<strong>in</strong>ciano ad essere consumati anche<br />
cibi di lontana provenienza, come le ciliege, importate per la prima volta dall’Oriente da Lucullo.<br />
Il Romano povero, ovviamente, non ha accesso ai cibi importati e costosi e <strong>in</strong> casa non ha neanche il tricl<strong>in</strong>io. Egli<br />
cont<strong>in</strong>ua la tradizione antica di pasti frugali ed economici. Il Romano ricco, <strong>in</strong>vece, come ci tramandano<br />
abbondantemente le fonti, offre frequentemente banchetti, cui partecipano dec<strong>in</strong>e di amici e clienti. Qui i cibi<br />
sono vari, cuc<strong>in</strong>ati con cura ed anche molto elaborati, almeno stando alle ricette del cuoco Apicio, giunte f<strong>in</strong>o a<br />
noi. Sono molto apprezzate le uova di anitra, piccione e pernice e molto consumato è il pesce, fresco o <strong>in</strong><br />
salamoia. Simile ad alcune salse orientali moderne a base di pesce salato e fermentato (come il Nuoc Nam<br />
<strong>in</strong>doc<strong>in</strong>ese), è il garum, una delle salse più note dell’antichità, di cui esistono diverse varietà. Ancora più diffuso,<br />
però, è sicuramente l’olio d’oliva, importato soprattutto dalla Baetica (odierna Andalusia) e dall’Africa<br />
settentrionale, le cui anfore da trasporto hanno formato <strong>in</strong> Roma, <strong>in</strong> circa tre secoli, una vera e propria coll<strong>in</strong>etta<br />
artificiale : il monte Testaccio (detto “Monte dei cocci”). Si mangia raramente carne bov<strong>in</strong>a, più spesso carne<br />
ov<strong>in</strong>a e capr<strong>in</strong>a, e comune è il maiale, del quale si è imparato a sfruttare ogni parte. Il consumo di <strong>in</strong>saccati è<br />
enorme e apprezzata la carne di volatili - da cortile e da voliera - prodotta <strong>in</strong>tensivamente nelle ville rustiche o<br />
cacciata, <strong>in</strong>sieme a selvagg<strong>in</strong>a più grande, come c<strong>in</strong>ghiali, da<strong>in</strong>i, cervi e caprioli. Una delle caratteristiche<br />
fondamentali della cuc<strong>in</strong>a romana è l’accostamento di gusti opposti, del piccante con il dolce, del dolce con<br />
l’aromatico. Oggi non troveremmo poi così gradevoli gran parte delle ricette che ci sono pervenute, ad esempio le<br />
pere lesse con miele, passito, salsa di pesce, olio e uova, e forse neanche le pietanze a base di gru, fenicotteri,<br />
pappagalli e pavoni che ornavano certe tavole molto raff<strong>in</strong>ate.<br />
Fruttiera di vetro e vasi ricolmi di prodotti della terra<br />
Casa di Julia Felix – Pompei – 63/79 A.D.<br />
“ientaculum” (colazione) “prandium”<br />
(pranzo) “coena” (cena) “mappa”<br />
(tovagliolo) “tricl<strong>in</strong>ium” (sala da<br />
pranzo) “lectus tricl<strong>in</strong>aris” (panca coperta da<br />
materasso o cusc<strong>in</strong>i) “gustus” (antipasto) “<br />
primae mensae” “secundae mensae”<br />
(primo e secondo piatto)<br />
97 Da: “Cuc<strong>in</strong>a dell’antica Roma”, <strong>in</strong>: http://cuc<strong>in</strong>astorica.blogspot.com/2007/11/cuc<strong>in</strong>a-dellantica-roma.html. L’articolo a due colonne è di Simona<br />
Moretta, <strong>in</strong>: http://www.activitaly.it/subura/romaoggi/cuc<strong>in</strong>aromana/antichi_romani_cibo.htm.
59<br />
“… bonam atque magnam/cenam, non s<strong>in</strong>e candida puella/ et v<strong>in</strong>o et sale et omnibus cach<strong>in</strong>nis.” 98<br />
Schiavi che servono ad una cena - III sec. a.C. - Cartag<strong>in</strong>e<br />
Banchetto -Pompei Louvre - Parigi<br />
In alto a s<strong>in</strong>istra: fiasche di v<strong>in</strong>o a trottola - 125-90<br />
a.C. Ornavasso – Verbania. A destra: figura<br />
femm<strong>in</strong>ile che serve un vassoio di cibo.<br />
Pompei - Villa dei Misteri - particolare di affresco.<br />
Il sale per i Romani costituiva un vero e<br />
proprio alimento. Rappresentava pers<strong>in</strong>o<br />
un sistema di pagamento, dato che i soldati<br />
lo ricevevano come completamento della<br />
paga (salarium). La fornitura di sale alla<br />
Roma repubblicana era assicurata dalle<br />
sal<strong>in</strong>e create dal re Anco Marzio alla foce<br />
del Tevere. Costava molto e il suo prezzo<br />
aumentava per via delle spese per<br />
trasportarlo <strong>in</strong> località parecchio distanti<br />
dal mare. Molto spesso, però, veniva<br />
distribuito gratuitamente al popolo dagli<br />
uffici annonari. Era anche <strong>in</strong>saporito con<br />
spezie, giacché i Romani lo consideravano<br />
un contorno e sovente lo mangiavano con<br />
il pane. Serviva <strong>in</strong> casa come medic<strong>in</strong>ale di<br />
pronto uso per certi disturbi.<br />
Il v<strong>in</strong>o era raramente limpido e veniva di solito filtrato con un pass<strong>in</strong>o (colum), si beveva quasi sempre allungato con acqua calda o fredda (<strong>in</strong> 11,460<br />
parti. In <strong>in</strong>verno a volte anche con neve) <strong>in</strong> modo da ridurne la gradazione alcolica di solito da 15/16 a 5/6 gradi. I tipi più pregiati erano il Falerno del<br />
Massico (a sud di S<strong>in</strong>uessa/Campania), il Cecubo, il Caleno (Capua), il Volturno, l'Albano e il Sab<strong>in</strong>o (dal Lazio) e il Set<strong>in</strong>o. I più dozz<strong>in</strong>ali erano il<br />
Veietano (come tutti i v<strong>in</strong>i dell'Etruria era considerato di qualità scadente), quello del Vaticano e quello di Marsiglia (i v<strong>in</strong>i della Gallia narbonese<br />
venivano affumicati e spesso contraffatti ). Il Gustaticium era <strong>in</strong>vece un v<strong>in</strong>o aperitivo al quale si aggiungeva miele e si beveva a digiuno prima del<br />
pasto. Il Passim, <strong>in</strong>f<strong>in</strong>e, era un v<strong>in</strong>o fatto con uve secche (passito), serviva per i malati. 99 Cfr.: “Gli utilizzi del sale nel mondo<br />
Romano”, <strong>in</strong>: http://gold.<strong>in</strong>dire.it/datafiles/BDP-<br />
GOLD00000000002039A3/ma...non%20sar%E0%20<strong>in</strong>d<br />
igesto.doc<br />
Alle donne romane, salvo le dovute eccezioni, era vietato bere<br />
v<strong>in</strong>o. Se scoperte venivano punite dai mariti o dai familiari. Cfr.: http://www.tibursuperbum.it/ita/note/romani/V<strong>in</strong>oRomani.htm. V<strong>in</strong>i esteri come quelli<br />
di Taso, di Chio, di Lesbo (ritenuto medicamentoso), di Sicione, di Cipro, di Telmeso, di Tripoli d’Asia, di Beyrut (Libano) e di Sebennys (Egitto)<br />
seppero contendere il primato a non pochi vitigni locali perché venduti a prezzi molto competitivi, determ<strong>in</strong>ando così l’azzeramento produttivo dei<br />
v<strong>in</strong>i meno pregiati. (<strong>in</strong>formazioni <strong>in</strong> parte att<strong>in</strong>te da: “I Romani a Tavola”, <strong>in</strong>: www.bibliolab.it/I%20Romani%20a%20tavola/i%20v<strong>in</strong>i.htm ).<br />
98 “… cena abbondante e succulenta, non senza una bella ragazza e v<strong>in</strong>o e sale ed un mucchio di risate.” Carm<strong>in</strong>a, xiii, vv. 3-5.<br />
99 Da: “Vita quotidiana nell’Antica Roma”, <strong>in</strong>: http://www.archeoempoli.it/anticaroma.htm.
60<br />
Aforismi Catulliani …<br />
Pompei - coppia di benestanti - affresco. Ca. 45 -79 A.D. 100 M. N. Napoli<br />
“Ad ognuno si affibbia un difetto: ma ciò che sta nella bisaccia sulle<br />
nostre spalle noi non lo vediamo” 101<br />
“L’<strong>in</strong>gratitud<strong>in</strong>e è di tutti; e il bene fatto nulla,/anzi fonte di amarezze e di mali peggiori”c.73<br />
“La candida vecchiaia/muovendo la fronte tremula/annuisce tutto a tutti”c.61<br />
100 Si tratta del panettiere Terentius Neo e consorte, come rivela l'iscrizione graffita all'<strong>in</strong>terno della casa. I due si fecero ritrarre <strong>in</strong> posa di<br />
persone colte e facoltose. Per lungo tempo è stato ritenuto a torto che la figura maschile appartenesse ad un <strong>in</strong>fluente personaggio di nome<br />
Paquius Proculus. Cfr.: http://marcheo.sanc.remuna.org/cerca/cerca/Contents/Catalogo/createPage?<strong>in</strong>v=9058.<br />
101 Carm<strong>in</strong>a, xxii, vv. 20-21. “… Suus cuique attributus est error;/ sed non videmus manticae quod <strong>in</strong> tergo est.” Parole che ricordano molto:<br />
“Perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio del tuo fratello, e non t'accorgi della trave che è nel tuo?” Vangelo di Luca: 6,41-42; 6,45.
61<br />
Aufilena<br />
Il poeta deplora la donna, che ha <strong>in</strong>tascato monete sonanti promettendo di darsi a lui. La promessa non<br />
è stata mantenuta. Aufilena è pertanto scesa al livello di una <strong>in</strong>gorda meretrice.<br />
Pompei, Casa dei casti amanti: gallo che becca una melagrana<br />
Pompei, Casa del Centurione - Cubicolo di lupanare 102<br />
Le buone amiche, Aufilena, sono sempre da lodare:<br />
accettano denaro per le cose che si impegnano a fare.<br />
Tu che mi hai promesso sapendo di mentire, non sei un’amica,<br />
e visto che non dai mai e prendi spesso, commetti una malvagità.<br />
Il fare è da nobildonna, il non promettere, Aufilena, sarebbe stato<br />
da virtuosa: ma prendere quanto è stato dato<br />
sottraendosi ai doveri, è peggio dell’agire di una puttana <strong>in</strong>gorda<br />
che si prostituisce con tutto il suo corpo.<br />
Carmen CX.<br />
Aufilena, bonae semper laudantur amicae:<br />
accipiunt pretium quae facere <strong>in</strong>stituunt.<br />
tu, quod promisti, mihi quod mentita, <strong>in</strong>imica es,<br />
quod nec das et fers saepe, facis fac<strong>in</strong>us.<br />
aut facere <strong>in</strong>genuae est, aut non promisse pudicae,<br />
Aufilena, fuit: sed data corripere<br />
fraudando officiis plus quam meretricis avarae est,<br />
quae sese toto corpore prostituit. 103<br />
Pompei – Coppia<br />
Affresco <strong>in</strong> mostra presso il<br />
museo statale dell’Hermitage<br />
San Pietroburgo<br />
Dicembre 2007<br />
102 Il term<strong>in</strong>e lupanare deriva da "lupa", l’appellativo delle meretrici. Come lupi nella notte al chiaro di luna, sembra che esse ululassero per<br />
attirare la clientela. Anche la mitologia romana fa notare che gli stessi fondatori di Roma, Romolo e Remo, erano stati adottati da una "lupa",<br />
un nome alquanto ambiguo. Infatti, Acca Laurentia, la moglie del pastore che li aveva trovati, era una "lupa", cioè una prostituta. Altri nomi<br />
ancora oggi conosciuti, s<strong>in</strong>onimi di lupa sono "puttana", dal lat<strong>in</strong>o putere, puzzare e "troia", altra radice dispregiativa che fa riferimento alle<br />
femm<strong>in</strong>e del maiale, e qu<strong>in</strong>di "troiaio", porcile, ovvero, il luogo sporco e fetido dove <strong>in</strong> genere erano costrette a soggiornare le prostitute.<br />
103 Il poeta ci parla di Aufilena anche nei carmi C e CXI. In quest’ultimo la diffama con la sua consueta feroce ironia, <strong>in</strong>s<strong>in</strong>uando che la<br />
donna non disdegna fornicare con il di lei zio, dal quale è stata addirittura resa gravida … “Accontentarsi di un uomo solo, Aufilena,/ è fra le<br />
lodi la lode d’ogni donna;/ ma meglio è concedersi come e a chi tu vuoi/ che partorire cug<strong>in</strong>i al proprio zio.”
62<br />
Da noi alle terme ne succedono di tutti colori!<br />
Vibennio e suo figlio costituiscono un tandem ben affiatato di ladruncoli di terme. Per un certo periodo di<br />
tempo il latroc<strong>in</strong>io viene perpetrato con successo, grazie ad una tecnica tanto semplice quanto efficace. Mentre<br />
il giovane pederasta si prodiga per rendere, diciamo così, più gradevole la pausa di relax dei frequentatori dei<br />
bagni termali, suo padre ha tutto il tempo per depredarli degli oggetti e capi d’abbigliamento lasciati<br />
<strong>in</strong>custoditi presumibilmente nei locali adibiti a spogliatoio. Ma ora il trucchetto non funziona più. Le vittime<br />
hanno sparso la voce sulle imprese dei due, e al loro <strong>in</strong>gresso i guard<strong>in</strong>ghi bagnanti non si fanno più<br />
<strong>in</strong>f<strong>in</strong>occhiare. Tempi duri, dunque, per il pater familias, e quotazioni del figlio, ahimè, ridotte ormai al<br />
lumic<strong>in</strong>o, gli assicura sardonico il poeta. Spietata e caustica come sempre l’apostrofe contro la disonestà.<br />
Sembra che anche <strong>Catullo</strong> sia stato vittima<br />
egli stesso di un latroc<strong>in</strong>io del genere. Nel<br />
carme XXV, <strong>in</strong>fatti, si scaglia contro con<br />
un certo Thallo, un omosessuale che gli ha<br />
trafugato una fazzoletto prezioso, un<br />
mantello e dei pizzi f<strong>in</strong>emente lavorati<br />
della terra attigua alla Bit<strong>in</strong>ia(Thyni).<br />
O artista dei ladri di terme<br />
Vibennio padre, e tu, il figlio, maestro dei pederasti:<br />
più il genitore è di mano lurida,<br />
più è famelico il culo del suo erede maschio.<br />
Perché non ve ne andate <strong>in</strong> esilio,<br />
<strong>in</strong> terre maledette? Ormai le ruberie di papà<br />
sono sulla bocca di tutti, e le chiappe tue pelose,<br />
figliolo mio, non puoi offrirle che per un soldo. 104 (C., xxxiii)<br />
104 “O furum optime balneariorum/ Vibenni pater et c<strong>in</strong>aede fili/ nam dextra pater <strong>in</strong>qu<strong>in</strong>atiore,/ culo filius est voraciore,/ cur<br />
non exilium malasque <strong>in</strong> oras/ itis? quandoquidem patris rap<strong>in</strong>ae/ notae sunt populo, et natis pilosas,/ fili, non potes asse<br />
venditare.” Le tre immag<strong>in</strong>i riguardano rispettivamente: le terme romane di Bath (Inghilterra), gli spogliatoi delle terme<br />
romane di Stabiae ed il plastico di stabilimento termale nella Roma del I sec. A.D. Cfr.:<br />
http://www.vroma.org/~bmcmanus/baths.html.
63<br />
La “Rossa” di Bologna. Una poco di buono nota a molti, ma anche una povera<br />
disgraziata che per mangiare è costretta a rubare offerte votive lasciate sulle tombe!<br />
La Rossa di Bologna moglie di Menenio<br />
fa pomp<strong>in</strong>i a Rufolo,<br />
quella che spesso hai visto<br />
tra i sepolcreti rubare dallo stesso rogo la cena,<br />
e mentre si getta sul pane che rotola dal fuoco<br />
è frustata da uno che crema cadaveri<br />
rapato a metà per punizione. (c., LIX) 105<br />
Davvero strano l’aneddoto esilarante narrato all’amico:<br />
una scena per la strada, l’impulso improvviso e … il tiro birbone!<br />
Oh, Catone, una cosa da scompisciarsi dal ridere,<br />
ed è giusto che tu lo sappia e ne rida.<br />
Rid<strong>in</strong>e, Catone, se ami un po’ <strong>Catullo</strong>:<br />
credi è uno scherzo troppo divertente.<br />
Ora, sorpresi un bambol<strong>in</strong>o che perforava<br />
una ragazza; io, Diona mia 106 ,<br />
un fulm<strong>in</strong>e, col coso mio duro gli sono sopra e lo impalo. (c., LVI) 107<br />
Satiro e N<strong>in</strong>fa<br />
Mosaico Satiro e N<strong>in</strong>fa<br />
Napoli - M.A.N.<br />
105<br />
Il Rufulum di turno della Bolognese sembra essere ancora Marco Celio Rufo, lo stesso dei carmi 69 e 71. Dato che “ la Rossa” ha<br />
comportamenti da mendicante, disprezzabili perché lesivi della dignità di un Romano, anche l’attività erotica appare qui frutto di necessità. La<br />
degradazione della rossa umilia automaticamente chi lo frequenta, cioè il rivale <strong>in</strong> amore del poeta. Il crematore rapato a metà è con molta<br />
probabilità lo schiavo di un imprenditore di pompe funebri (libit<strong>in</strong>arius) che ha tentato la fuga. Cfr.: <strong>Catullo</strong>, Le poesie, op. cit., pag.308, nota 59.<br />
106<br />
Diona era la madre di Venere, identificata più tardi con la stessa dea della bellezza. L’<strong>in</strong>vocazione serve ad <strong>in</strong>terrompere l’oscenità<br />
della situazione. <strong>Catullo</strong> si compiace di essere parte attiva dell’ammucchiata.<br />
107<br />
Catone. Forse Catone l’Uticense, o Pubblio <strong>Valerio</strong> Catone, poeta e storico del I sec. a.C., nato nella Gallia Cisalp<strong>in</strong>a, o nessuno dei<br />
due.
64<br />
<strong>Catullo</strong> ricalca le orme di Priapo!<br />
La pena che il dio riserva ai ladri di campi<br />
sarà la medesima per chi osasse rubargli il suo Giovenzio<br />
Carme 15<br />
A te come me stesso raccomando il mio amore,<br />
Aurelio. Chiedo un favore riservato,<br />
che, se hai adocchiato qualcosa col tuo cuore,<br />
e la vorresti casta ed <strong>in</strong>tegra,<br />
serbami pulito questo mio ragazzo,<br />
non dico dal popolo - per nulla temo<br />
quelli, che <strong>in</strong> piazza ora qua ora là<br />
passano occupati <strong>in</strong> loro faccende -<br />
ma di te temo e del tuo fallo<br />
nefasto per ragazzi buoni e cattivi.<br />
Tu maneggia chi ti piace, dove ti piace,<br />
quanto vuoi, fuori, quando sarà ritto e pronto:<br />
questo solo ti proibisco, come credo, riservatamente.<br />
Che se una brutta <strong>in</strong>tenzione ed un furore pazzo<br />
ti sp<strong>in</strong>gerà a sì grave colpa, disgraziato,<br />
da aggredire con <strong>in</strong>sidie la stessa mia persona …<br />
oh allora povero te, per la sorte che ti viene!<br />
Divaricate le gambe, per quella porta<br />
ti attraverseranno ravanelli e cefali. 108<br />
Testa maschile<br />
I sec. a. C.<br />
108 Al marito si concedeva tacitamente la facoltà di punire così chi avesse <strong>in</strong>sidiato le propria consorte. Questo<br />
porterebbe alla ipotesi non troppo azzardata che il legame affettivo con Giovenzio aveva per <strong>Catullo</strong> il valore di v<strong>in</strong>colo<br />
matrimoniale. Cfr. <strong>Catullo</strong>, Le poesie, op. cit., pag. 300, nota al carme 15.
65<br />
Il veronese racconta: usi e quotidianità del suo tempo. 109<br />
Figura maschile<br />
II-I sec. a.C.<br />
Museo di Tarqu<strong>in</strong>ia<br />
Il Liber fornisce una grande quantità d’<strong>in</strong>formazioni <strong>in</strong> merito a curiosità, fatti ed usanze di<br />
vita nell’Urbe, nella penisola italica e nelle terre di conquista romane del I sec. a.C. Eccone<br />
alcuni:<br />
Tavoletta romana per<br />
scrivere e due stiletti.<br />
250 a.D.<br />
Dalla parte appuntita<br />
<strong>in</strong>cidevano la tavoletta<br />
di cera, dall’altra<br />
cancellavano.<br />
• Le donne romane usavano profumi assiri per essere più seducenti. (c. 6).<br />
• La Bit<strong>in</strong>ia – Asia M<strong>in</strong>ore – era famosa fra le nobildonne romane per fornire prestanti<br />
portatori di lettighe e pizzi (c.10/25).<br />
• Setabi, città della Spagna, era r<strong>in</strong>omata per la produzione di stoffe di l<strong>in</strong>o f<strong>in</strong>emente<br />
ricamate (c.12/25).<br />
• Sembra che a Roma e <strong>in</strong> certe zone della penisola italica si praticasse una rozza forma<br />
di riciclaggio della carta ai tempi di <strong>Catullo</strong>. Essa era riutilizzata per avvolgere il pesce<br />
acquistato (c.95).<br />
• La Thynia era una regione dell’Asia m<strong>in</strong>ore sulle rive del Mare di Marmora.<br />
Conf<strong>in</strong>ava con la Bit<strong>in</strong>ia dalla quale era divisa dal fiume Psilio (c.25).<br />
• I Saturnali, erano una sorta di Carnevale. Si celebravano il 17 dicembre alla f<strong>in</strong>e delle<br />
sem<strong>in</strong>e di autunno. Erano occasione per fare baldoria, scambiarsi doni e scherzi (c.14).<br />
• La sposa veniva presa <strong>in</strong> braccio da chi l’accompagnava perché non <strong>in</strong>ciampasse sulla<br />
soglia della nuova casa. Inciampare era considerato di cattivo auspicio. Il novello<br />
marito l’accoglieva porgendole acqua e fuoco, simboli della vita futura. Poi andava a<br />
sdraiarsi su un talamo di porpora, dove l’attendeva per consumare la prima notte di<br />
matrimonio ( c.61).<br />
• <strong>Catullo</strong> amava bere il Falerno amaro, cioè, <strong>in</strong>vecchiato e non mescolato con acqua ( c. 27).<br />
• La Fede era una div<strong>in</strong>ità venerata sul Campidoglio (c. 30).<br />
109 La ricerca delle curiosità ritrovate nei versi Catulliani deve tanto a: <strong>Catullo</strong>, Le poesie, op., cit., pagg. 295-326.
66<br />
• Le donne <strong>in</strong> travaglio <strong>in</strong>vocavano la protezione di Giunone Luc<strong>in</strong>a, un altro nome di<br />
Diana (c. 34).<br />
• I Romani veneravano una div<strong>in</strong>ità di orig<strong>in</strong>e greco-egizia di nome Arpocrate. Era il dio<br />
del silenzio! Era rappresentato da un fanciullo che chiedeva di tacere con l’<strong>in</strong>dice della<br />
mano destra sulla bocca ( c. 74).<br />
• Lo starnuto veniva considerato segno di buon augurio e di approvazione da parte delle<br />
div<strong>in</strong>ità(c. 45).<br />
• La prima toga era <strong>in</strong>dossata dai maschi all’età di 17 anni ed era priva di ornamenti e<br />
colori (c. 68).<br />
• La figlia unica avanti negli anni veniva esclusa dall’eredità paterna. Il patrimonio era<br />
dest<strong>in</strong>ato al primo figlio maschio nato da costei. In tal modo altri parenti non<br />
potevano vantare alcun diritto alla eredità (c. 68).<br />
• Sui muri degli edifici si scrivevano giudizi positivi o negativi su conoscenti e persone<br />
<strong>in</strong>contrate occasionalmente, prostitute comprese ( c. 37).<br />
• Alcune popolazioni della Spagna avevano l’abitud<strong>in</strong>e di sbiancarsi i denti con l’ur<strong>in</strong>a.<br />
In Italia, di norma, si usava l’acqua pura (c. 39).<br />
• Il Circo Massimo, fra i colli Palat<strong>in</strong>o e Avent<strong>in</strong>o, era il ritrovo di molte cortigiane<br />
(c.55).<br />
• Il giorno delle nozze di un vir c’era l’usanza di regalare noci ai bamb<strong>in</strong>i, a ricordo del<br />
passaggio della sua sposa dalla pubertà alla vita matrimoniale ( c. 61).<br />
• Era credenza popolare che un collo <strong>in</strong>grossato o gonfio derivasse da un’unione feconda<br />
(c. 64).<br />
• Sembra che i Calibi, un piccolo popolo sul Mar Nero, fossero gli scopritori del ferro (c.<br />
66).<br />
• Le fanciulle verg<strong>in</strong>i non usavano profumo ( c.66).<br />
• I Romani, come i Cretesi, contrassegnavano i giorni lieti con una pietruzza bianca. I<br />
tristi con una nera( c.68).<br />
• La punizione riservata agli adulteri consisteva spesso nella umiliazione sessuale.<br />
L’irrumazione era effettuata con radici e pesci (c.15).<br />
• I Romani adoravano Serapide, una div<strong>in</strong>ità di orig<strong>in</strong>e orientale( cc. 10, 12).<br />
• Gli antichi consideravano il manc<strong>in</strong>o subdolo e pertanto ladro (c.12).<br />
• Si costumava calzare gli animali da tiro con una sorta di sandalo di ferro(c.17).<br />
• I Romani usavano i palimpsestos, pergamene che potevano essere utilizzate per scrivere<br />
più volte, raschiandone la superficie. La carta migliore, la carta regia, era per contro<br />
costituita da papiro egiziano. Su una bacchetta di osso o legno, l’umbilius, si avvolgeva<br />
il rotolo di papiro. Il volumen, squadrato e rasato con pomice, era legato da c<strong>in</strong>ghie di<br />
cuoio t<strong>in</strong>to di rosso. Per conservare i rotoli si usavano gli scr<strong>in</strong>ia, <strong>in</strong>volucri di forma<br />
cil<strong>in</strong>drica. La membrana era l’<strong>in</strong>volucro di pergamena che proteggeva un rotolo di<br />
papiro. I rotolo era legato probabilmente con i lora, c<strong>in</strong>ghiette o nastri rossi. I testi<br />
erano acquistabili presso i chioschi dei librai, scr<strong>in</strong>ia librarium (cc. 1, 14, 22).<br />
• Talasio era la div<strong>in</strong>ità italica del matrimonio e personificazione del grido nuziale<br />
augurale <strong>in</strong>vocato dagli sposi e dai loro parenti (c.61).<br />
Amor<strong>in</strong>o sul dorso di un granchio<br />
Pompei – Casa dei Vetti<br />
A sn. Pompei - Ifigenia particolare di<br />
dip<strong>in</strong>to murale - ca. I sec A.D.
67<br />
Bibliografia essenziale<br />
Enrico Vetrò<br />
Docente di L<strong>in</strong>gua e Letteratura Inglese<br />
Liceo “Aristosseno” - <strong>Taranto</strong><br />
• Aldo Luisi, V<strong>in</strong>o & Poesia d’amore nell’antica Roma, TIEMME Manduria (Ta),<br />
novembre 2003.<br />
• Andrea Freudiani, I grandi generali di Roma antica, Edizione speciale per il Giornale,<br />
Newton & Compton editori s.r.l., Roma, 2003.<br />
• Antonio Sp<strong>in</strong>osa, Cesare, il grande giocatore, Mondadori, Milano, 1995.<br />
• Antonelli Giuseppe, Clodia, Terenzia, Fulvia: la licenziosa Lesbia di <strong>Catullo</strong>, l’astuta<br />
moglie di Cicerone, la crudele consorte di Marco Antonio: tre matrone di età tardorepubblicana,<br />
tre diversi tentativi di emancipazione femm<strong>in</strong>ile, Newton & Compton,<br />
Milano, 1996.<br />
• Aut. vari, “Storia civiltà e vita ai tempi di Roma Antica” vol. 4. - De Agost<strong>in</strong>i editore,<br />
1999.<br />
• Carmi priapei. Le ottanta poesie anonime, di volta <strong>in</strong> volta attribuite ai grandi poeti lat<strong>in</strong>i,<br />
che hanno celebrato la forza procreatrice del dio greco, cura e traduzione di Cesare<br />
Vivaldi, testo lat<strong>in</strong>o a fronte, edizione <strong>in</strong>tegrale, grandi tascabili economici Newton,<br />
Milano,1996.<br />
• <strong>Catullo</strong>, Le poesie, a cura di F. Della Corte, Mondadori, Milano, 1977.<br />
• <strong>Catullo</strong>, Le poesie, i grandi libri Garzanti, <strong>in</strong>troduzione, traduzione e note di Mario<br />
Ramous, prefazione di Luca Canali, XIV edizione: aprile 2004.<br />
• Catullus LXXXXV, read by Matt Dillon, Professor and Chair of Classics and<br />
Archaeology, Loyola Marymount University, Los Angeles, CA.<br />
<strong>in</strong>http://lat<strong>in</strong>um.mypodcast.com/<br />
• Cesare, La guerra gallica, Garzanti, IX edizione, Garzanti, 2005.<br />
• Christian Meier, “Giulio Cesare”, il Giornale, Biblioteca Storica, Garzanti Editore,<br />
2004.<br />
• Cicerone M. T., Epistole ad Attico, a cura di Carlo Di Spigno, testo a fronte, vol.1, Libri<br />
I-VIII, UTET S.p.A., Tor<strong>in</strong>o, Novembre 2005.<br />
• Cicerone M. T., Epistole ad Attico, a cura di Carlo Di Spigno, testo a fronte, vol. 2, Libri<br />
IX-XVI, UTET S.p.A., Tor<strong>in</strong>o, Novembre 2005.<br />
• Cicerone M. T, In difesa di Marco Celio (Pro Caelio), a cura di A. Cavarzere, Venezia,<br />
Marsilio, 1987.<br />
• Claudia (Clodia), <strong>in</strong>: Furio Scampoli, “Le grandi donne di Roma antica”, il Giornale,<br />
Biblioteca Storica, Newton & Compton editori s.r.l., Roma, 2003, pagg.54-63.
68<br />
• Claudiano Claudio, Epitalami e fescenn<strong>in</strong>i, curatore Bianch<strong>in</strong>i E., collana Mnemos<strong>in</strong>e,<br />
Le Càriti Editore, Firenze, 2004<br />
• Di Berard<strong>in</strong>o, L'omosessualità nell'antichità classica, <strong>in</strong> W. Henkel (a cura di),<br />
Ecclesiae Memoria, Misc. J. Metzler, Roma, 1991.<br />
• Div<strong>in</strong>a puella : l’amore e la donna <strong>in</strong> <strong>Catullo</strong>, a cura di Domitilla Leali, C. Signorelli,<br />
Milano, 2001.<br />
• Domenico Ludovico De V<strong>in</strong>centis – Vocabolario del dialetto Tarant<strong>in</strong>o – Arnaldo Forni<br />
Editore, Sala Bolognese, 1977.<br />
• Dupont Florence, La vita quotidiana nella Roma repubblicana, collana economica<br />
Laterza - traduzione di Roberto C<strong>in</strong>cotta (“La vie quotidienne du citoyen roma<strong>in</strong> sous<br />
la République, 509-27 a.C.”) - Gius. Laterza e figli, 2006.<br />
• E. Salza Pr<strong>in</strong>a Ricotti, Dossier: Cibi e banchetti nell'antica Roma, <strong>in</strong>: Archeo, nº 46,<br />
Dicembre 1988, pp. 52-97.<br />
• Eugenio Pucci, “Pompei”, Bonechi, edizioni il “Turismo”, Firenze, 1970.<br />
• Eva Cantarella, “Pompei. I volti dell’amore.” - Arnoldo Mondadori Editore, 1999.<br />
F. Della Corte, <strong>in</strong> CATULLO, Le poesie, a cura di F. Della Corte, Milano, Mondadori,<br />
1977, p.223.<br />
• <strong>Gaio</strong> <strong>Valerio</strong> <strong>Catullo</strong>, Le poesie, a cura di G. Paduano – A. Grilli, Tor<strong>in</strong>o, E<strong>in</strong>audi,<br />
1997 (collana Tascabili).<br />
<strong>Gaio</strong> Pl<strong>in</strong>io Secondo, Naturalis Historia, Guard<strong>in</strong>i, Pisa, 1984.<br />
• Gerhard F<strong>in</strong>k, Ditelo <strong>in</strong> lat<strong>in</strong>o. Insulti, <strong>in</strong>giurie, contumelie dell’Antichità romana <strong>in</strong> un<br />
dilettevole dizionario ragionato ad uso dei moderni, traduzione dall’orig<strong>in</strong>ale tedesco di<br />
Simona Ferrari, Longanesi & C., Milano,1992.<br />
• Giac<strong>in</strong>to Agnello, Arnaldo Orlando, Un poeta e il suo mondo: <strong>Catullo</strong>, G. B. Palumbo,<br />
Palermo, 2003.<br />
• G. Mosconi – F. Polacco, L’onda del passato. Dalle orig<strong>in</strong>i dell’umanità all’apogeo<br />
dell’impero romano, vol. 1, edizioni il capitello, Tor<strong>in</strong>o, 2008.<br />
• Grammatici Lat<strong>in</strong>i ex recensione Henrici Keilii. A cura di He<strong>in</strong>rich Keil/ Hermann<br />
Hogan, ed. B.G. Teubneri, Lipsia 1857-1880.<br />
• T.E. K<strong>in</strong>sey, Catullus 16, “Latomus”, 1966, pp.101-106.<br />
• I canti, <strong>Gaio</strong> <strong>Valerio</strong> <strong>Catullo</strong>; <strong>in</strong>troduzione e note di Alfonso Tra<strong>in</strong>a, traduzione di<br />
Enzo Mandruzzato – Milano, Biblioteca universale Rizzoli, 1986.<br />
• Il miele di Afrodite. Tredici secoli di poesia d’amore <strong>in</strong> Grecia e <strong>in</strong> Roma, Introduzione,<br />
traduzione e note a cura di Mar<strong>in</strong>a Cavalli, Arnoldo Mondatori Editore, Oscar<br />
Mondadori, novembre 1991, I edizione.<br />
• Jerome Carcop<strong>in</strong>o, Giulio Cesare, Rusconi, 1999.<br />
• A. La Penna, Note sul l<strong>in</strong>guaggio erotico dell’elegia lat<strong>in</strong>a, “Maia”, 1951, pp.187-209.<br />
• La festa della frusta, <strong>in</strong>: Focus Storia, n.18 – febbraio/marzo 2008,<br />
Gruner+Jahr/Mondatori S.p.A, Milano, pagg.18-23.<br />
• Luca Canali, Amore e sessualità negli autori lat<strong>in</strong>i, collana saggi, Bompiani, Milano,<br />
2001.<br />
• Luca Canali, Introduzione a <strong>Catullo</strong>, Le poesie, trad. M. Ramous, Garzanti, Milano,<br />
1975<br />
• M. Fabio Qu<strong>in</strong>tiliano - Istituzioni oratorie – curato da Pennac<strong>in</strong>i A., Biblioteca delle<br />
Pléiadi, E<strong>in</strong>audi, 2001.<br />
• Marziale, I cento epigrammi proibiti, a cura di Franco Zagato, tascabili economici<br />
Newton, 1992.<br />
• Menichelli Wanda, <strong>Catullo</strong>: eros e amore, Camunia, Milano, 1995.<br />
• Michael H. Crawford, “Roman Republican Co<strong>in</strong>age” - Cambridge University Press,<br />
1974.
69<br />
• Neil Grant, Everyday Life <strong>in</strong> Ancient Rome, Smart Apple Media (North Mankato, MN),<br />
2003.<br />
• Nemora. Letteratura e antropologia di Roma antica. 1. Dalle orig<strong>in</strong>i all’età di Augusto.<br />
Storia, autori, testi. A cura di Maurizio Bett<strong>in</strong>i. La Nuova Italia, 2008, seconda<br />
ristampa.<br />
• Nicola Gigante - Dizionario della Parlata Tarant<strong>in</strong>a (Storico Critico Etimologico) –<br />
Mandese Editore, <strong>Taranto</strong>, 2002.<br />
• P. Y. Forsyth, The Lady and the Poem: Catullus 35-42 The Classical Journal, Vol. 80,<br />
No. 1 (Oct. - Nov., 1984), pp. 24-26<br />
• Plutarco, Vita di Cesare, a cura di Bonamente G., collana Filo di perle, Studio Tesi<br />
Editore, 1994, pagg. XLVIII-207.<br />
• Plutarco, Vite parallele. Agesilao - Pompeo, Rizzoli - Collana: BUR - Classici Greci e<br />
Lat<strong>in</strong>i, 2000.<br />
• Poeti e prosatori lat<strong>in</strong>i, antologia lat<strong>in</strong>a per il triennio del liceo scientifico: Cesare,<br />
<strong>Catullo</strong>. Poeti elegiaci: Virgilio,Orazio, Sallustio, Livio, Tacito, Seneca, Cicerone,<br />
Lucrezio. Prosatori lat<strong>in</strong>i dell’età Cristiana, a cura di R. Greco [e altri], Napoli, Il<br />
tripode, 1984.<br />
• Remo Cappelli, Manuale di Numismatica, Mursia, Milano, 1995, qu<strong>in</strong>dicesima<br />
edizione.<br />
• Romeo Schieven<strong>in</strong>, Poesia e turpiloquio nel carme 16 di <strong>Catullo</strong>, <strong>in</strong>: materiali e<br />
discussioni per l’analisi dei testi classici, ISSN 0392-6338, Nº 44, 2000, pagg. 195-210.<br />
• Saffo, Frammenti, a cura di Eleonora Cavall<strong>in</strong>i, Ugo Guanda Editore, Parma, 1986.<br />
• Saffo, Poesie. Misteri afrodisiaci tra il sacro e il profano <strong>in</strong> una lirica di spregiudicati<br />
sentimenti, a cura di Ilaria Dagn<strong>in</strong>i, testo greco a fronte, edizione <strong>in</strong>tegrale, Grandi<br />
Tascabili Economici Newton, aprile 1999, terza edizione.<br />
• Salvatore Armando, Studi catulliani, Loffredo, Napoli, 1984.<br />
• Svetonio Caio Tranquillo, Le vite di dodici Cesari. Vol .I. Cesare, Augusto, Tiberio,<br />
Caligola, testo lat<strong>in</strong>o e versione di G.Vitali, Bologna, Zanichelli 1990.<br />
• Svetonio Caio Tranquillo, Vite dei Cesari (Cesare - Augusto - Tiberio - Caligola) -<br />
Bologna : Zanichelli, 1964.<br />
• Svetonio, Le vite dei dodici Cesari, a cura di Guido Vitali, Zanichelli, Bologna,1959.<br />
• Thomas Nelson W<strong>in</strong>ter, Catullus purified: a brief history of carmen16, <strong>in</strong>: Religious<br />
Studies, Faculty Publications, Classics and Religious Studies Department, University of<br />
Nebraska-L<strong>in</strong>coln, year 1973.<br />
• Un amore antico: <strong>Catullo</strong> e Lesbia, antologia Catulliana, a cura di Mario Marzi,<br />
seconda ed., Canova, Treviso, 1995.<br />
• Università degli studi di Trieste – Saffo – Biografia ed Antologia di Versi, a cura di<br />
Gennaro Tedeschi – Trieste, 2005.<br />
• V. Buchheit, “Sal et lepos versiculorum (Catull c. 16)”, Hermes, 104 (1976) 331-347.<br />
• Wilde, Oscar. The Picture of Dorian Gray. Ed. Robert Mighall. London: Pengu<strong>in</strong>, 2003.<br />
• Oscar Wilde, The Picture of Dorian Gray, Edited by Michael Patrick Gillespie, Norton,<br />
W.W. & Company, Inc., Norton critical edition, 2006, second edition.<br />
• NB) A pag. 2: Catullus LXXXXV, letto da Matt Dillon, Professor and Chair of Classics and<br />
Archaeology, Loyola Marymount University, Los Angeles, California. In http://lat<strong>in</strong>um.mypodcast.com/
70<br />
Atlete <strong>in</strong> bik<strong>in</strong>i con manubri e disco - Piazza Armer<strong>in</strong>i - Enna, villa romana del casale, ca. IV AD.<br />
“STATIONIS PRIMAE<br />
F I N I S<br />
SED NON ITINERIS<br />
NEC INVESTIGATIONIS”110<br />
110 “Term<strong>in</strong>e della prima meta, ma non del percorso, né della ricerca”.
71<br />
Enrico Vetrò<br />
Idibus Martiis<br />
Anno Dom<strong>in</strong>i Duo Millesimo Octavo<br />
“Disclaimer”<br />
I CONTENUTI QUI PUBBLICATI appartengono all'autore e non possono<br />
essere replicati neanche parzialmente senza il suo consenso. Il resto<br />
del materiale pubblicato, dove non <strong>in</strong>dicato espressamente, è<br />
copyright dei rispettivi legittimi proprietari, e ha il solo scopo di<br />
recensione/divulgazione. Sono a disposizione per eventuali<br />
<strong>in</strong>volontarie omissioni o <strong>in</strong>esattezze nella citazione delle fonti e delle<br />
illustrazioni. MI SENTIRÒ PIÙ CHE MAI LUSINGATO SE DAGLI SCRITTI<br />
PRODOTTI VERRÁ VOGLIA A CHIUNQUE DI ATTINGERE A SCOPO<br />
UNICAMENTE FORMATIVO-DOCUMENTATIVO. LA CULTURA DEVE<br />
ESSERE APPANNAGGIO DEL MONDO, NE SONO PIÙ CHE MAI<br />
CONVINTO. TUTTAVIA LA CITAZIONE DELLA FONTE È DOVEROSA E<br />
SEMPRE AUSPICABILE. Enrico Vetrò