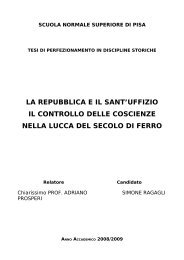- Page 1 and 2: Scuola Normale Superiore di Pisa Un
- Page 3: non ancora sufficientemente discuss
- Page 6 and 7: «Adhaerens Deo, unus spiritus est
- Page 8 and 9: La surimpression de l’organicisme
- Page 10 and 11: I «membres pensants» rispondono a
- Page 12 and 13: portare all’evidenza, o alla chia
- Page 14 and 15: nascosta di quello della carità, i
- Page 16 and 17: Il tema, come recita il titolo del
- Page 18 and 19: Tuttavia quel che qui ci preme, tra
- Page 20 and 21: Ci si concederà perciò di assumer
- Page 22 and 23: tout» si impone dunque come necess
- Page 24: ne emerge nella liasse «APR» e ne
- Page 27 and 28: 1. Dall’Eucaristia alla Chiesa Se
- Page 29 and 30: ora di «ecclesia catholica quae my
- Page 31 and 32: «nel momento stesso in cui diviene
- Page 33 and 34: Christi» (Guglielmo di Auxerre). E
- Page 35 and 36: una sua autonomia. Si cerca una def
- Page 37 and 38: intellettualmente, non un corpo rea
- Page 39 and 40: È dunque nella linea di questa plu
- Page 41 and 42: ecclesiologiche ha fatto sì che fi
- Page 43: Essendo sia il corpo politico che l
- Page 47 and 48: distinzione tra «Ecclesia» e «Co
- Page 49 and 50: visibilmente. Così come l’unità
- Page 51 and 52: grado riguardano gli individui sing
- Page 53 and 54: quelle ricordate prima, Bellarmino
- Page 55 and 56: quasi sensum, sed non motum, ut qui
- Page 57 and 58: merito» lo fa paradossalmente per
- Page 59 and 60: conferma dunque una rinuncia ben pi
- Page 61 and 62: contempo una scissione visibile e s
- Page 63 and 64: Christi Ecclesiam esse unicam tant
- Page 65 and 66: Item qui in republica civili detrec
- Page 68 and 69: APPENDICE: AGOSTINO E L’«UNUS CH
- Page 70 and 71: della nostra indagine. Si tratta di
- Page 72 and 73: la tradizione l’abbia passata piu
- Page 74 and 75: Agostino non manca infatti occasion
- Page 76 and 77: diligit Deum consequens est ut faci
- Page 78 and 79: partiti. Nel commento alla prima le
- Page 80 and 81: tantum, sed super iustos et iniusto
- Page 82 and 83: decidere del suo amore. Ma amando f
- Page 84 and 85: agione di tale reticenza. Innanzitu
- Page 86 and 87: si non diligas, minus habebis. Cum
- Page 88 and 89: A dispetto di quello che potrebbe s
- Page 90 and 91: dicere: Verumtamen non quod ego vol
- Page 93 and 94: CAP. II: BÉRULLE E LA RINASCITA DE
- Page 95 and 96:
seguono proporremo una ricognizione
- Page 97 and 98:
pone via via sempre più al centro
- Page 99 and 100:
Ce Christ donc est un Corps non à
- Page 101 and 102:
difficile conciliazione tra le ista
- Page 103 and 104:
(a) L’immagine della goccia: uno
- Page 105 and 106:
filosofia neoplatonica. Significati
- Page 107 and 108:
aquae et vini miscetur in calice Do
- Page 109 and 110:
nemmeno che i suoi detrattori abbia
- Page 111 and 112:
situazione è ben diversa. La metaf
- Page 113 and 114:
sorelle del libero spirito». Lo si
- Page 115 and 116:
Non bastasse l’autorità di un pr
- Page 117 and 118:
analisi serrata. Ci limiteremo qui
- Page 119 and 120:
doctrine orthodoxe» 247 . Ora, il
- Page 121 and 122:
diventerà sempre più «Almaricus
- Page 123 and 124:
dell’estasi della anime sante com
- Page 125 and 126:
Di fronte a questa accusa al contem
- Page 127 and 128:
Quando dunque Bérulle scrive, allo
- Page 129 and 130:
Così come di contro si attesterà,
- Page 131 and 132:
degli amuaricensi. Tale congiunzion
- Page 133 and 134:
Evidentemente Cornelio a Lapide rie
- Page 135 and 136:
14. & lib. 2. De ornatu spiritalium
- Page 137 and 138:
celebre come di Ruusbroeck. Segno,
- Page 139 and 140:
di Dio, ovvero a Dio stesso. Quest
- Page 141 and 142:
di Canfeld. Tanto più se si tiene
- Page 143 and 144:
un Biel 312 si trovava ridotta a fo
- Page 145 and 146:
negazione del corollario implicito
- Page 147 and 148:
Di fatto l’oratoriano si impegna
- Page 149 and 150:
court, l’être moral c’est la v
- Page 151 and 152:
punto critica. La presa di distanza
- Page 153 and 154:
l’union hypostatique» (Cognet).
- Page 155 and 156:
âme, avec rien qui est Dieu, soit
- Page 157 and 158:
aliquo» 356 . La tradizione agosti
- Page 159 and 160:
est proprie motus naturae, qui semp
- Page 161 and 162:
venuta ad indicare la necessità di
- Page 163 and 164:
ottimistica della natura messa in l
- Page 165 and 166:
e continui a riproporsi. In un opus
- Page 167 and 168:
«notre être est un rapport à Die
- Page 169 and 170:
immagine e somiglianza di Dio, non
- Page 171 and 172:
comme étant en quelque façon les
- Page 173 and 174:
venit, recidet, & evanescet: perind
- Page 175 and 176:
Omnis enim actio seu productio iden
- Page 177 and 178:
che Dio «nos conservat in eodem es
- Page 179 and 180:
comme un néant»). Se le cose hann
- Page 181 and 182:
Le soleil qui nous éclaire pendant
- Page 183 and 184:
partecipazione al corpo mistico, de
- Page 185 and 186:
le altre. Solo pensandolo, il corpo
- Page 187 and 188:
ô Jésus!» Solo la grazia «nous
- Page 189 and 190:
CAP. III: DESCARTES E L’«AMOUR»
- Page 191 and 192:
1. Descartes e la sintesi mancata
- Page 193 and 194:
cartesiana dell’uomo come «res c
- Page 195 and 196:
Il punto di riferimento anche qui,
- Page 197 and 198:
un uso eclettico. Di fatto poi, a p
- Page 199 and 200:
medesime questioni e proporne una n
- Page 201 and 202:
tendenza a ricercare il proprio ben
- Page 203 and 204:
Tommaso ha in vista, proprio come D
- Page 205 and 206:
declinare uno stupore proprio ad og
- Page 207 and 208:
psicologia degli appetiti e delle f
- Page 209 and 210:
nell’affermazione «in ethicis»
- Page 211 and 212:
generi di cose: tant’è che Dio p
- Page 213 and 214:
Descartes ripete precisamente Tomma
- Page 215 and 216:
considerazione che le passioni «no
- Page 217 and 218:
lessico della «praesentia» Tommas
- Page 219 and 220:
comme un tout ... ». E preferisce
- Page 221 and 222:
secondo la quale «ce désir qui na
- Page 223 and 224:
definizione per così dire metonimi
- Page 225 and 226:
Secondo una dinamica della quale le
- Page 227 and 228:
che «Aragon ... ait hanc opinionem
- Page 229 and 230:
assertoria: «il faut toujours pré
- Page 231 and 232:
Così, nella replica del 6 ottobre,
- Page 233 and 234:
«règle». Sennonché niente di ci
- Page 235 and 236:
tutto, Descartes può ora infatti a
- Page 237 and 238:
une autre» Descartes risponde, con
- Page 239 and 240:
238
- Page 241 and 242:
élu, saint et choisi», § 609), a
- Page 243 and 244:
chiara presa di coscienza del valor
- Page 245 and 246:
mundi». E viceversa, i fedeli in C
- Page 247 and 248:
del loro essere situati in un «mon
- Page 249 and 250:
attezzati non c’è luogo pre-ordi
- Page 251 and 252:
da un unico «esprit»: che chi vi
- Page 253 and 254:
anche se solo en passant. Un testo
- Page 255 and 256:
Dove però si vede chiaramente che
- Page 257 and 258:
2. «Unanimité» La seconda figura
- Page 259 and 260:
Mesnard nell’edizione critica del
- Page 261 and 262:
et providence» si manifesta cioè
- Page 263 and 264:
del «grand discours» di Gesù «s
- Page 265 and 266:
Come si vede, Gesù contrappone qui
- Page 267 and 268:
Di questa singolare configurazione
- Page 269 and 270:
filo della riflessione sui miracoli
- Page 271 and 272:
che si vogliono niente più che tes
- Page 273 and 274:
avversari di Montalte inutilmente s
- Page 275 and 276:
essere testimone. La «necessitas»
- Page 277 and 278:
dire tecnica, «les événements».
- Page 279 and 280:
en al di là dei «grands crimes».
- Page 281 and 282:
Dove dunque il giudizio sembrerebbe
- Page 283 and 284:
vanno cioè superate o evitate, ma
- Page 285 and 286:
nel promuovere che nel rendere ardu
- Page 287 and 288:
scritti di Saint-Cyran, redatto pro
- Page 289 and 290:
Descartes, curato da Clerselier. Su
- Page 291 and 292:
sancita in sovrappiù dal ricorso i
- Page 293 and 294:
La lettera ai Périer della primave
- Page 295 and 296:
«politique» hanno snaturato tale
- Page 297 and 298:
Que dans une uniformité d’esprit
- Page 299 and 300:
298
- Page 301 and 302:
della natura umana. Più precisamen
- Page 303 and 304:
(a) «Tant de contradictions se tro
- Page 305 and 306:
eco del «nosce te ipsum». E ad av
- Page 307 and 308:
double» ovvero che con-sistono in
- Page 309 and 310:
C’est une maladie naturelle à l
- Page 311 and 312:
Pascal come fonte e commentario 603
- Page 313 and 314:
dal milieu port-royalista, anche un
- Page 315 and 316:
In essa Pascal avanza un secondo ca
- Page 317 and 318:
Après avoir expliqué l’incompr
- Page 319 and 320:
l’appunto da Montaigne nel saggio
- Page 321 and 322:
proprie capacità i limiti del poss
- Page 323 and 324:
ha giustamente rilevato Martineau 6
- Page 325 and 326:
Cercare, «songer à» si oppone qu
- Page 327 and 328:
Qui di nuovo a tema sono i prodromi
- Page 329 and 330:
contro la presunzione, la possibili
- Page 331 and 332:
dar conto, se non a fronte di una n
- Page 333 and 334:
come un «abandon» dell’orizzont
- Page 335 and 336:
appello alla verità. Come nel ling
- Page 337 and 338:
prova e si mostra nella messa alla
- Page 339 and 340:
interdetto e sospendere perciò il
- Page 341 and 342:
La furbizia della «imagination» s
- Page 343 and 344:
Il lessico della lunga pensée 44 s
- Page 345 and 346:
différentes de moi, puisque peut-
- Page 347 and 348:
sull’incoscienza cedeva alla rico
- Page 349 and 350:
(«cette erreur qui vient par accid
- Page 351 and 352:
diviene necessaria come antidoto ch
- Page 353 and 354:
faut aussi examiner en particulier
- Page 355 and 356:
involontaires». Qui come si vede,
- Page 357 and 358:
quale l’«esprit» non può mai d
- Page 359 and 360:
[qui] s’estime au plus haut point
- Page 361 and 362:
L’articolo 190 delle Passions rin
- Page 363 and 364:
terre, quelque santé et commodité
- Page 365 and 366:
nessuno gli crederà e quindi non r
- Page 367 and 368:
nature de l’homme», proponendola
- Page 369 and 370:
esordisce con un dubbio, che è poi
- Page 371 and 372:
cartesiano. Vediamo in dettaglio. L
- Page 373 and 374:
decidere della conoscenza, e non vi
- Page 375 and 376:
passioni Ŕ e non i giudizi Ŕ dico
- Page 377 and 378:
Il riferimento alla figura del «ro
- Page 379 and 380:
«divertissement» è la maniera in
- Page 381 and 382:
significherà perciò, innanzitutto
- Page 383 and 384:
«divertissement» giunge come la g
- Page 385 and 386:
prova Ŕ dolorosa Ŕ del presente i
- Page 387 and 388:
messianica ebraica perché in essa
- Page 389 and 390:
come l’ipotesi di un «divertisse
- Page 391 and 392:
Pascal si è visto dunque costretto
- Page 393 and 394:
392
- Page 395 and 396:
asterebbero le nostre competenze, p
- Page 397 and 398:
A segnare il campo dei due Ŗstili
- Page 399 and 400:
Duplex est enim omnium appetitionum
- Page 401 and 402:
sé ritenendolo naturale Ŕ ovvero
- Page 403 and 404:
carità: poiché la distanza è que
- Page 405 and 406:
Ils croient que Dieu est seul digne
- Page 407 and 408:
sui» tenendosi fisso («en la vue
- Page 409 and 410:
Ŗgenealogicaŗ sulla quale La Roch
- Page 411 and 412:
quale purtuttavia l’uomo sussiste
- Page 413 and 414:
«amor proprio», di sottrarsi all
- Page 415 and 416:
Il discorso pascaliano sul «moi»
- Page 417 and 418:
la sua infinità, cioè la sua asse
- Page 419 and 420:
«moi» alla ricerca dell’«amour
- Page 421 and 422:
amor di sé e che vanno significati
- Page 423 and 424:
et qu’ainsi je souffre avec vous,
- Page 425 and 426:
jusqu’à la fin du monde. Il ne f
- Page 427 and 428:
«dormir»: «et qu’ainsi j’aie
- Page 429 and 430:
sostituisce il «membre». Essere
- Page 431 and 432:
conoscere nella trasparenza della
- Page 433 and 434:
che devono fare qualcosa d’altro
- Page 435 and 436:
ogni altro amore così come l’«e
- Page 437 and 438:
passée, d’avoir été inutile au
- Page 439 and 440:
Per questo il «vrai chrétien», i
- Page 441 and 442:
Ma il frutto ultimo dei «membres p
- Page 443 and 444:
point d’autorité»: Pascal pensa
- Page 445 and 446:
CONCLUSIONE La nostra lettura della
- Page 447 and 448:
de soi-même que l’amour des autr
- Page 449 and 450:
che può rimanere estraneo o essere
- Page 451 and 452:
itrovato Ŕ speriamo Ŕ il loro con
- Page 453 and 454:
disconoscimento della distinzione t
- Page 455 and 456:
BIBLIOGRAFIA Il classico Essai bibl
- Page 457 and 458:
Antwerp, 1616. LESSIUS Leonardus, D
- Page 459 and 460:
BEAULIEU Armand, Mersenne, le grand
- Page 461 and 462:
CARRAUD Vincent, Qui est le moi?,
- Page 463 and 464:
De LUBAC Henri, Augustinisme et th
- Page 465 and 466:
GOLDMANN Lucien, Le Dieu caché, é
- Page 467 and 468:
KNEBEL Sven K., Casuistry and the E
- Page 469 and 470:
MADEC Goulven, Lectures Augustinien
- Page 471 and 472:
Pascal, Paris, 1996 (2007). MIDALI
- Page 473 and 474:
QUANTIN Jean-Louis, Le rigorisme ch
- Page 475 and 476:
del 33 e congresso annuale della No
- Page 477 and 478:
INDICE Avvertenza 1 INTRODUZIONE 4
- Page 479:
CONCLUSIONE 444 BIBLIOGRAFIA 454 (a