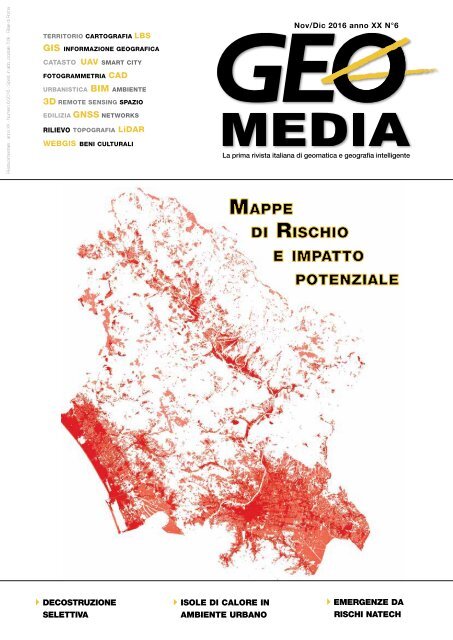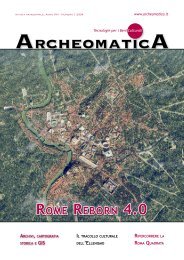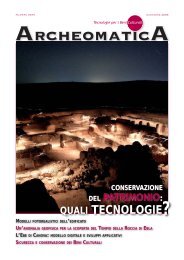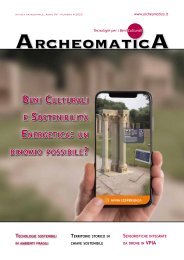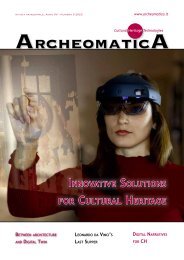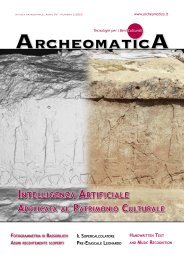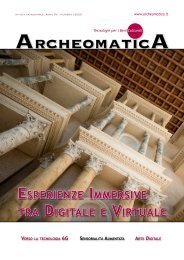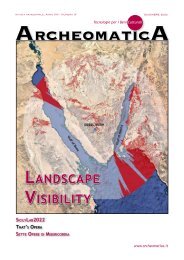You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Rivista bimestrale - anno XX - Numero 6/<strong>2016</strong> - Sped. in abb. postale 70% - Filiale di Roma<br />
TERRITORIO CARTOGRAFIA<br />
GIS<br />
CATASTO<br />
3D<br />
INFORMAZIONE GEOGRAFICA<br />
FOTOGRAMMETRIA<br />
URBANISTICA<br />
GNSS<br />
BIM<br />
RILIEVO TOPOGRAFIA<br />
CAD<br />
REMOTE SENSING SPAZIO<br />
EDILIZIA<br />
WEBGIS<br />
UAV<br />
SMART CITY<br />
AMBIENTE<br />
NETWORKS<br />
LiDAR<br />
BENI CULTURALI<br />
LBS<br />
Nov/Dic <strong>2016</strong> anno XX N°6<br />
La prima rivista italiana di geomatica e geografia intelligente<br />
Mappe<br />
di Rischio<br />
e impatto<br />
potenziale<br />
DECOSTRUZIONE<br />
SELETTIVA<br />
ISOLE DI CALORE IN<br />
AMBIENTE URBANO<br />
EMERGENZE DA<br />
RISCHI NATECH
trimBle SX10<br />
la rivoluzione<br />
è appena cominciata<br />
abbiamo creato uno strumento innovativo, versatile<br />
e integrato. trimble SX10 coniuga la tecnologia di una<br />
Stazione totale robotica di alta precisione con quella di uno<br />
Scanner ad alta velocità e funzionalità imaging reale, senza<br />
alcun compromesso prestazionale.<br />
noleggialo, anche solo per un giorno.<br />
Soluzioni innovative per il rilievo, la misura e la modellazione.<br />
Transforming the way the world works<br />
Spektra Srl, a Trimble Company<br />
039.625051 | info@trimble-italia.it | www.trimble-italia.com
Chi è il garante dell’infrastruttura geografica?<br />
Il potenziamento dell’Infrastruttura di dati territoriali, con il dettaglio e l’accuratezza che serve a fornire<br />
cartografie e mappe del territorio affidabili per gli interventi istituzionali, è una operazione che deve<br />
essere garantita con norme di uniformazione ed omogeneizzazione, nonché di produzione, che siano<br />
rispettate ed applicate in maniera uniforme sul territorio nazionale.<br />
Attualmente il lavoro di produzione di specifiche e norme sui dati territoriali non è tutelato e<br />
garantito ma solamente condiviso ed approvato, in un consesso allargato di tecnici ed esperti del<br />
settore, che hanno prodotto una serie di documenti con prescrizioni e suggerimenti che basterebbe<br />
aggiornare al vaglio delle opportune tecnologie che si sono oggi rese disponibili, per renderli applicabili<br />
universalmente.<br />
Siamo carenti anche di un elemento istituzionale di raccordo dei vari organi, enti e amministrazioni che<br />
operano sulla acquisizione di Dati Territoriali e possa fungere da interfaccia per il raccordo istituzionale<br />
internazionale.<br />
Numerose amministrazioni, ignare o a vario titolo impossibilitate dalla farraginosità di meccanismi<br />
burocratici, non riescono ad avvalersi di quanto già rilevato da altre amministrazioni e viene spesso<br />
duplicata o triplicata la spesa globale in tale settore.<br />
La attuale situazione si origina, come molti di noi sanno bene, da uno stato di confusione generato<br />
dalla mancata riorganizzazione dei servizi cartografici, seguita all'abrogazione di Enti considerati inutili<br />
avvenuta durante il primo passaggio legislativo di competenze dallo Stato alle Regioni negli anni ‘70.<br />
All’epoca gli organi cartografici nazionali erano solo 5 (Istituto Geografico Militare, Istituto Idrografico<br />
della Marina, Servizio geo-topo-cartografico dell’Aeronautica Militare, Servizio Geologico di Stato,<br />
Catasto), oggi incrementati di almeno 20 organi cartografici delle Regioni oltre a vari altri organi di<br />
amministrazioni che operano a vario titolo acquisendo dati territoriali. Abbiamo però finalmente<br />
un organo centrale come catalogo di dati territoriali che sta spingendo fortemente sulla creazione di<br />
metadati che possano riuscire ad aiutare nella ricerca dei dati territoriali già in possesso della PA. Il<br />
Repertorio Nazionale dei Dati Territoriali (RNDT) è l’unica novità di rilievo che possiamo notare nel<br />
settore proponendosi come ente istituzionale e rappresentativo in grado di acquisire informazioni da<br />
tutte le amministrazioni. Ma quello che ci chiediamo è se questa istituzione abbia poi il potere effettivo<br />
di far rispettare a tutti la compilazione e l’uso del sistema centralizzato.<br />
Una carenza che si manifesta, oltre che nelle normali operazioni di pianificazione del territorio, in<br />
occasione delle emergenze per disastri naturali. Valga per tutti considerare la necessaria realizzazione<br />
di modelli idrografici del territorio, per un effettivo piano di prevenzione del rischio idrogeologico,<br />
basato su un quadro di riferimento dato da modelli digitali del terreno che oggi è possibile realizzare con<br />
accuratezza estrema.<br />
La problematica della gestione dell’emergenza in caso di disastri naturali è evidente nel momento in<br />
cui squadre di soccorso ed operatori dell’emergenza non dispongono di dati affidabili, come purtroppo<br />
di nuovo ha dimostrato il recente sisma in Italia Centrale, verificatosi a cavallo di ben 4 Regioni,<br />
non riuscendo nelle poche ore a disposizione per i primi soccorsi, ad interrogare un sistema centrale<br />
affidabile, né ad integrare la realtà di organizzazioni che si prodigano per mappare il territorio con<br />
operazioni di volontariato geografico.<br />
Un garante del coordinamento dell’infrastruttura geografica territoriale nell’emergenza dovrebbe far si<br />
che tutta la documentazione territoriale sia disponibile immediatamente in caso di emergenze e che si<br />
colmino lacune ormai primordiali, come ad esempio la carenza dell’assegnazione di numeri civici e la<br />
loro georeferenziazione.<br />
la prossima volta<br />
#mappiamoprima<br />
http://rivistageomedia.it/cartografia-per-emergenza<br />
Buona lettura,<br />
Renzo Carlucci
In questo<br />
numero...<br />
FOCUS<br />
REPORT<br />
GUEST<br />
LE RUBRICHE<br />
Nuove prospettive<br />
per l’utilizzo del<br />
remote sensing<br />
nella gestione delle<br />
emergenze da rischi<br />
Natech e l’uso della<br />
terminologia specifica<br />
di Sabina Di Franco,<br />
lena Rapisardi,<br />
Rosamaria Salvatori<br />
6<br />
11 TECHNOLOGY for ALL<br />
24 ASSOCIAZIONI<br />
26 IMMAGINE ESA<br />
42 MERCATO<br />
48 SMART CITY<br />
50 AGENDA<br />
Il 20 gennaio 2017, il Moderate<br />
Resolution Imaging Spectroradiometer<br />
(MODIS) a bordo del<br />
satellite Aqua della NASA ha catturato<br />
una immagine true-color<br />
della neve nell'Europa centrale.<br />
Le nuvole sovrastano l'Italia<br />
orientale innevata, mentre le<br />
Alpi sono ricoperte da una fitta<br />
coltre di bianco. La neve si estende,<br />
ad Est, sopra la Slovenia, la<br />
Croatia e la Bosnia Erzegovina.<br />
14 Telerilevamento<br />
e GIS per la<br />
valutazione e il<br />
monitoraggio delle<br />
isole di calore in<br />
ambiente urbano<br />
di Sabrina Adelfio,<br />
Caterina Enea, Giuseppe Bazan,<br />
Pietro Orlando<br />
Crediti immagine: Jeff Schmaltz,<br />
MODIS Land Rapid Response<br />
Team, NASA GSFC<br />
In copertina una<br />
rappresentazione della<br />
mappa del rischio di impatto<br />
potenziale del cinghiale<br />
in formato raster, circa il<br />
comprensorio di Lucca.<br />
20<br />
Soluzioni<br />
informatiche<br />
innovative a supporto<br />
della Decostruzione<br />
Selettiva<br />
di Antonio Bottaro<br />
geomediaonline.it<br />
<strong>GEOmedia</strong>, bimestrale, è la prima rivista italiana di geomatica.<br />
Da 20 anni pubblica argomenti collegati alle tecnologie dei<br />
processi di acquisizione, analisi e interpretazione dei dati,<br />
in particolare strumentali, relativi alla superficie terrestre.<br />
In questo settore <strong>GEOmedia</strong> affronta temi culturali e tecnologici<br />
per l’operatività degli addetti ai settori dei sistemi informativi<br />
geografici e del catasto, della fotogrammetria e cartografia,<br />
della geodesia e topografia, del telerilevamento aereo e<br />
spaziale, con un approccio tecnico-scientifico e divulgativo.
INSERZIONISTI<br />
3D Target 52<br />
28<br />
Analisi GIS<br />
applicate alla<br />
gestione faunistica<br />
Le mappe di rischio<br />
di impatto degli<br />
ungulati<br />
di Alessandro Giugni, Marco<br />
Ferretti, Leonardo Conti<br />
AerRobotix 37<br />
Aeropix 50<br />
Epsilon 42<br />
Esri Italia 41<br />
Flytop 43<br />
GEOCART 48<br />
ME.S.A 40<br />
Planetek Italia 13<br />
Sinergis 51<br />
Sistemi Territoriali 49<br />
Teorema 47<br />
Topcon 23<br />
UNIcuIque<br />
SUUM<br />
di Attilio Selvini<br />
38<br />
Trimble 2<br />
34<br />
A Digital “New World”<br />
The Big Fusion between<br />
Ubiquitous Localization<br />
(GNSS), Sensing (IOT)<br />
and Communications<br />
(5G) by Marco Lisi<br />
una pubblicazione<br />
Science & Technology Communication<br />
Direttore<br />
RENZO CARLUCCI, direttore@rivistageomedia.it<br />
Comitato editoriale<br />
Vyron Antoniou, Fabrizio Bernardini, Mario Caporale,<br />
Luigi Colombo, Mattia Crespi, Luigi Di Prinzio,<br />
Michele Dussi, Michele Fasolo, Marco Lisi, Flavio Lupia,<br />
Beniamino Murgante, Aldo Riggio, Mauro Salvemini,<br />
Domenico Santarsiero, Attilio Selvini, Donato Tufillaro<br />
Direttore Responsabile<br />
FULVIO BERNARDINI, fbernardini@rivistageomedia.it<br />
Redazione<br />
VALERIO CARLUCCI, GIANLUCA PITITTO,<br />
redazione@rivistageomedia.it<br />
Diffusione e Amministrazione<br />
TATIANA IASILLO, diffusione@rivistageomedia.it<br />
Comunicazione e marketing<br />
ALFONSO QUAGLIONE, marketing@rivistageomedia.it<br />
Progetto grafico e impaginazione<br />
DANIELE CARLUCCI, dcarlucci@rivistageomedia.it<br />
MediaGEO soc. coop.<br />
Via Palestro, 95 00185 Roma<br />
Tel. 06.64871209 - Fax. 06.62209510<br />
info@rivistageomedia.it<br />
ISSN 1128-8132<br />
Reg. Trib. di Roma N° 243/2003 del 14.05.03<br />
Stampa: SPADAMEDIA srl<br />
VIA DEL LAVORO 31, 00043 CIAMPINO (ROMA)<br />
Editore: mediaGEO soc. coop.<br />
Condizioni di abbonamento<br />
La quota annuale di abbonamento alla rivista Science è di € & 45,00. Technology Communication<br />
Il prezzo di ciascun fascicolo compreso nell’abbonamento è di € 9,00. Il prezzo di<br />
ciascun fascicolo arretrato è di € 12,00. I prezzi indicati si intendono Iva inclusa.<br />
L’editore, al fine di garantire la continuità del servizio, in mancanza di esplicita<br />
revoca, da comunicarsi in forma scritta entro il trimestre seguente alla scadenza<br />
dell’abbonamento, si riserva di inviare il periodico anche per il periodo successivo.<br />
La disdetta non è comunque valida se l’abbonato non è in regola con i pagamenti.<br />
Il rifiuto o la restituzione dei fascicoli della Rivista non costituiscono disdetta<br />
dell’abbonamento a nessun effetto. I fascicoli non pervenuti possono essere<br />
richiesti dall’abbonato non oltre 20 giorni dopo la ricezione del numero successivo.<br />
Gli articoli firmati impegnano solo la responsabilità dell’autore. È vietata la<br />
riproduzione anche parziale del contenuto di questo numero della Rivista in<br />
qualsiasi forma e con qualsiasi procedimento elettronico o meccanico, ivi inclusi i<br />
sistemi di archiviazione e prelievo dati, senza il consenso scritto dell’editore.<br />
Rivista fondata da Domenico Santarsiero.<br />
Numero chiuso in redazione il 22 gennaio <strong>2016</strong>.
FOCUS<br />
Nuove prospettive per l’utilizzo del remote<br />
sensing nella gestione delle emergenze da<br />
rischi Natech e l’uso della terminologia specifica<br />
di Sabina Di Franco, Elena Rapisardi, Rosamaria Salvatori<br />
Le tecniche di remote sensing hanno assunto un ruolo fondamentale<br />
nella gestione dei rischi, come è dimostrato anche dal programma<br />
Copernicus, fase operativa del GMES (Global Monitoring for<br />
Environment and Security), che offe tra i suoi servizi l’Emergency<br />
Management Service.<br />
Fig. 1 - Ciclo dell’emergenza.<br />
La gestione del rischio è<br />
un’attività complessa che<br />
richiede un approccio<br />
multidisciplinare. Quando avviene<br />
un disastro ogni minuto<br />
è fondamentale per salvare vite<br />
umane, limitare i danni, proteggere<br />
persone, cose e ambiente.<br />
Gli eventi che si susseguono<br />
durante il verificarsi di un<br />
disastro sono, in una certa misura,<br />
ripetitivi e possono essere<br />
schematizzati in un ciclo: il cosiddetto<br />
“ciclo dell’emergenza”<br />
o del disastro. Il ciclo dell’emergenza<br />
può essere suddiviso<br />
in quattro fasi: mitigazione e<br />
prevenzione (prima dell’evento)<br />
e risposta e recupero, ripristino<br />
o superamento (post evento)<br />
(Di Franco, Salvatori, 2015).<br />
La mitigazione consiste in tutte<br />
quelle azioni necessarie per ridurre<br />
l’impatto dei disastri futuri<br />
(Menoni et al., 2012). La fase<br />
di prevenzione comprende le<br />
attività necessarie per ridurre gli<br />
impatti in previsione o nell’imminenza<br />
di eventi disastrosi. La<br />
fase di risposta attiene a tutte<br />
quelle azioni intraprese durante,<br />
o immediatamente dopo l’evento,<br />
con l’intento primario di<br />
salvare e proteggere le vite umane.<br />
Infine il termine recupero<br />
riguarda le attività relative al<br />
processo di ripristino dei servizi,<br />
alla ricostruzione delle opere e<br />
la riparazione dei danni, dopo<br />
l’evento (Alexander, 2002).<br />
Nella letteratura internazionale<br />
vengono definiti rischi Natech<br />
(Natural - Technological) quegli<br />
incidenti tecnologici innescati<br />
da disastri naturali, si tratta di<br />
tutti quegli incidenti che si verificano<br />
in impianti, nella rete<br />
di distribuzione o durante il<br />
trasporto di sostanze pericolose,<br />
a seguito del verificarsi di un<br />
terremoto, un’alluvione, uno<br />
tsunami o altro evento naturale.<br />
(Clerc, Le Claire, 1994; Lindell,<br />
Perry, 1996; Cruz et al., 2004).<br />
Questi rischi sembrano essere<br />
in aumento, non solo per la<br />
crescita delle zone industrializzate,<br />
ma anche in relazione<br />
ai cambiamenti climatici<br />
(Karusman et al., 2011, Salzano<br />
et al., 2013). Le peculiari caratteristiche<br />
degli eventi Natech,<br />
rapidità di svolgimento, possibilità<br />
dell’innesco di catene di<br />
eventi, variabilità dell’estensione<br />
areale, rendono la loro gestione<br />
particolarmente complessa. Il<br />
Joint Research Centre - JRC<br />
della Commissione Europea ha<br />
Fig. 2 - Incendio di un serbatoio di gas naturale a seguito del terremoto del 2011 a Ichihara,<br />
Prefettura di Chiba, Giappone. Foto: Reuters.<br />
6 <strong>GEOmedia</strong> n°6-<strong>2016</strong>
FOCUS<br />
Fig. 3 - Numero di eventi calamitosi per attività industriali. (2002–2012) eMARSJRC –<br />
European Commission, MajorAccidentHazardsBureau.<br />
richiesto nel 2004 alle autorità<br />
nazionali europee, l’identificazione<br />
delle aree potenzialmente<br />
soggette a questi eventi e ha<br />
sviluppato RAPID-N, uno<br />
strumento per mapppare e valutare<br />
rapidamente i danni, che<br />
opera a scala globale (Girgin,<br />
Krausmann, 2013).<br />
Il contributo della comunità<br />
scientifica e l’uso di tecnologie<br />
innovative come quelle connesse<br />
all’osservazione della terra,<br />
sono di importanza strategica<br />
durante tutte le fasi della gestione<br />
dell’emergenza (Joyce et<br />
al., 2009). Gli eventi causati<br />
dai rischi Natech sono caratterizzati<br />
da una rapida dinamica<br />
evolutiva con scenari che si<br />
modificano in un breve arco di<br />
tempo, e in molti casi il lavoro<br />
dei soccorritori è ritardato o<br />
reso particolarmente difficile<br />
dall’impossibilità di raggiungere<br />
le zone colpite e di operare in<br />
sicurezza. Ad esempio, nel caso<br />
di un incidente con rilascio<br />
di sostanze tossiche nell’aria,<br />
le squadre di soccorso devono<br />
evacuare rapidamente i residenti<br />
dell’area a rischio, di cui vanno<br />
definiti dimensioni e contorni.<br />
Per fare ciò è necessario avere<br />
informazioni come il punto<br />
di emissione, la direzione e la<br />
velocità del vento e le condizioni<br />
meteorologiche generali<br />
nel momento del verificarsi<br />
dell’evento. E’ anche necessario<br />
conoscere le caratteristiche geografiche<br />
dell’area, la presenza e<br />
lo stato delle reti stradali e delle<br />
infrastrutture, la cartografia, di<br />
base e tematica è quindi indispensabile.<br />
Inoltre la complessità intrinseca<br />
nei rischi Natech, rende particolarmente<br />
efficace l’uso di<br />
strumenti terminologici dedicati<br />
come glossari e thesauri che<br />
facciano chiarezza sui concetti e<br />
sui termini specifici del dominio,<br />
specialmente nel momento<br />
del verificarsi dell’emergenza.<br />
Le tecnologie<br />
dell’osservazione della<br />
terra e la gestione dei<br />
rischi Natech<br />
I sistemi per l’osservazione della<br />
terra nell’ambito della gestione<br />
delle emergenze rivestono un<br />
ruolo di importanza crescente,<br />
attraverso di essi si possono ricavare<br />
dati tempestivi e accurati<br />
non solo per la valutazione dei<br />
danni durante un evento, ma<br />
anche tutte le informazioni necessarie<br />
per le attività pre e post<br />
emergenziali.<br />
I satelliti orbitanti intorno alla<br />
Terra sono numerosi ed equipaggiati<br />
con sensori attivi e passivi<br />
che operano coprendo tutte<br />
le lunghezze d’onda dall’ultravioletto<br />
alle microonde, si può<br />
supporre quindi che la superficie<br />
della terra sia monitorata<br />
dallo spazio, anche nei momenti<br />
e nei luoghi in cui accadono<br />
le emergenze. Le missioni spaziali<br />
in atto sono versatili e utili<br />
per vari obiettivi, i sensori montati<br />
sui satelliti, possono essere<br />
dedicati a tematiche specifiche<br />
(es. l’osservazione del ghiaccio<br />
polare, la vegetazione, la qualità<br />
dell’acqua, ecc.). I dati attualmente<br />
provenienti dai sensori<br />
sono comparabili con i dati<br />
provenienti dalle prime missioni<br />
spaziali, questo consente di<br />
eseguire analisi multi-temporali<br />
impossibili fino a poco tempo<br />
fa, come la misura dell’urban<br />
sprawl o l’estensione delle calotte<br />
polari.<br />
Le missioni dell’ESA<br />
(European Space Agency),<br />
dell’EUMETSAT (European<br />
Organisation for the<br />
Exploitation of Meteorological<br />
Satellites), della NASA<br />
(National Aeronautics and<br />
Space Administration), del<br />
NOAA (National Oceanic and<br />
Fig. 4 - Numero di eventi per tipo di incidente. (2002–2012) eMARSJRC – European<br />
Commission, MajorAccidentHazardsBureau.<br />
<strong>GEOmedia</strong> n°6-<strong>2016</strong> 7
FOCUS<br />
Atmospheric Administration),<br />
del DLR (Deutschen Zentrum<br />
für Luft- und Raumfahrt),<br />
e dell’ASI (Agenzia Spaziale<br />
Italiana), forniscono un’ampia<br />
varietà di sistemi osservativi che<br />
verrano ulteriormente arricchiti<br />
dalle missioni Sentinel, nell’ambito<br />
del programma europeo<br />
Copernicus. La maggior parte<br />
dei programmi spaziali europei<br />
sono indirizzati verso la gestione<br />
delle emergenze, non solo<br />
da un punto di vista tecnicoscientifico,<br />
ma anche come<br />
impegno economico da parte di<br />
paesi ed imprese. Ad esempio<br />
nel programma GMES (Global<br />
Monitoring for Environment<br />
and Security), ora Copernicus,<br />
la gestione delle emergenze<br />
ha avuto da subito un ruolo<br />
cruciale, è infatti uno dei “Fast<br />
Track Services”, i servizi forniti<br />
e finanziati dal programma. Il<br />
servizio è attualmente operativo<br />
e svolge attività di “rapid<br />
mapping”, a richiesta fornisce<br />
informazioni geospaziali immediatamente<br />
dopo (ore o giorni)<br />
il verificarsi di un evento: dal<br />
2012 il servizio ha fornito<br />
mappe a seguito di circa un<br />
centinaio di richieste, correlate<br />
ad eventi idro-meteorologici e a<br />
incendi (European Commision.<br />
Copernicus Emergency<br />
Management Service - www.<br />
emergency.copernicus.eu). In<br />
quest’ambito la geomatica sta<br />
studiando come migliorare,<br />
semplificare e rendere più rapidi<br />
ed efficienti i flussi per la realizzazione<br />
di mappe tematiche<br />
(Ajmar et al., 2015).<br />
Le immagini satellitari non solo<br />
sono utili nel fornire dati “realtime”,<br />
o “near real-time” per la<br />
gestione dei disastri, ma diventano<br />
fondamentali anche nelle<br />
fasi di prevenzione e mitigazione<br />
(Showalter et al., 1999). Gli<br />
incidenti industriali, sia quelli<br />
causati direttamente dalle attività<br />
umane che quelli innescati<br />
da eventi naturali, ad eccezione<br />
degli sversamenti di petrolio in<br />
mare aperto, sono meno “imprevedibili”<br />
dal punto di vista<br />
della localizzazione spaziale,<br />
poiché avvengono in aree industriali<br />
note e definite (Marzo et<br />
al., 2015).<br />
I fenomeni naturali, anche se<br />
intrinsecamente caratterizzati da<br />
una maggiore “imprevedibilità”<br />
geografica, di solito coinvolgono<br />
porzioni di territorio più<br />
ampie e grazie alla loro scala è<br />
stato possibile utilizzare i satelliti<br />
anche quando le risoluzioni<br />
delle immagini non avevano<br />
il dettaglio e la scala di quelle<br />
odierne. Proprio il progresso<br />
tecnologico su risoluzione e scala,<br />
nonché il maggior numero<br />
Fig. 5 - Campi di applicazione dei dati dell’osservazione della terra. Modificato da Sandau (2010).<br />
di satelliti disponibili, permette<br />
l’uso di questi ultimi anche per<br />
l’analisi e il monitoraggio dei rischi<br />
industriali e, di conseguenza,<br />
dei cosiddetti Natech.<br />
Nell’ambito del progetto<br />
GEOSS i sensori satellitari<br />
attualmente disponibili sono<br />
stati utilizzati sia per attività di<br />
prevenzione, che per il monitoraggio<br />
dei danni provocati<br />
da disastri naturali (terremoti,<br />
piene, incendi boschivi, ecc…).<br />
Gli eventi Natech possono essere<br />
più complessi da analizzare<br />
in remoto, in quanto l’area in<br />
cui avviene l’incidente innescato<br />
dalle cause naturali può essere<br />
piccola. Se però si considera la<br />
durata nel tempo dell’evento e<br />
gli effetti che l’evento produce,<br />
l’area che subisce danni può<br />
essere anche molto estesa. Per<br />
analizzare le zone colpite dagli<br />
eventi calamitosi è necessario<br />
avere cognizione di causa del<br />
tipo di dati da utilizzare in<br />
relazione anche all’estensione<br />
geografica e alla risoluzione<br />
spettrale. Ad esempio immagini<br />
multispettrali ad alta risoluzione<br />
possono essere utilizzate per ottenere<br />
delle mappe dell’uso del<br />
suolo necessarie per derivarne<br />
mappe multi-rischio (Sengupta,<br />
2007).<br />
I grandi incidenti negli impianti<br />
industriali, sia innescati da<br />
eventi naturali che antropici,<br />
provocano spesso la repentina<br />
fuoriuscita di sostanze chimiche<br />
pericolose e possono innescare<br />
degli “effetti domino”, che<br />
causano danni gravi ed estesi<br />
(Antonioni et al., 2009); i dati<br />
del telerilevamento, anche se<br />
difficilmente possono venire<br />
usati per le attività di “previsione”<br />
di questi incidenti, sono<br />
però fondamentali, se raccolti<br />
tempestivamente, nella fase<br />
di intervento per formulare le<br />
strategie di azione e migliorare<br />
le attività di primo soccorso.<br />
Sono inoltre essenziali per la<br />
8 <strong>GEOmedia</strong> n°6-<strong>2016</strong>
FOCUS<br />
valutazione dei danni sia sulle<br />
costruzioni, sia sull’ambiente -<br />
aria, acqua, suolo - (Galderisi et<br />
al., 2008).<br />
Opportunità future: piccoli<br />
satelliti e UAV<br />
Considerando quanto detto nei<br />
paragrafi precedenti, tra i servizi<br />
di EO, in caso di incidenti in<br />
cui è necessaria un’informazione<br />
immediata, possono essere<br />
molto utili i dati forniti dalle<br />
costellazioni di “piccoli” satelliti<br />
(Kucera et al., 2012); i satelliti<br />
tradizionali infatti hanno tempi<br />
di rivisitazione non adatti per<br />
questo tipo di servizio. Le missioni<br />
con i “piccoli” satelliti, di<br />
contro, possono essere appositamente<br />
progettate per un scopo<br />
specifico quale, ad esempio, il<br />
monitoraggio di un’area industriale<br />
(Sandau, 2010) utilizzando<br />
tecnologie già pronte, le<br />
cosiddette (off-the-shelf technologies).<br />
E’ possibile, inoltre,<br />
creare sistemi molto piccoli (bus<br />
and payload) rivedendo l’ingegneria<br />
di sistemi già esistenti e<br />
cercando di miniaturizzarli. In<br />
generale, piccoli satelliti sono<br />
equipaggiati con spettroradiometri<br />
in VIS-nearIR e i dati<br />
sono disponibili in giornata; in<br />
futuro, si prevede di aumentare<br />
la capacità di elaborazione a<br />
bordo e inviare i dati agli utenti<br />
già corretti ed appositamente<br />
elaborati per la specifica applicazione<br />
(Sandau, 2006). Nei<br />
prossimi anni lo sviluppo di<br />
missioni con piccoli satelliti sarà<br />
inoltre favorita dalla comparsa<br />
sul mercato di nuovi sistemi di<br />
lancio dedicati dalla necessità<br />
di “testare” le diverse componenti<br />
prima di una missione<br />
più articolata e costosa, dallo<br />
sviluppo di sistemi interconnessi<br />
di piccole stazioni di ricezione<br />
e, ultimo ma non meno importante,<br />
dalla richiesta di dati<br />
in tempo reale per gli eventi<br />
con rapida evoluzione, come<br />
incidenti industriali o disastri<br />
naturali (Sandau, 2010). Verrà<br />
sicuramente implementata l’interferometria<br />
3D che può essere<br />
estremamente utile nel monitoraggio<br />
dei cambiamenti di uso<br />
del suolo, tra cui lo studio delle<br />
deformazioni in aree urbanoindustriale<br />
e la stima dei danni<br />
derivanti da incidenti industriali<br />
(Sandau e Briess, 2010).<br />
In futuro, aumentando della<br />
risoluzione spaziale delle immagini<br />
aumenterà la domanda di<br />
dati ottici da integrare con i dati<br />
acquisiti dai sensori a microonde<br />
e con i dati rilevati dai sensori<br />
montati su droni ((Lewis,<br />
2011, Sandau, Briess, 2008)<br />
o UAV (Unmanned Aerial<br />
Vehicle). In particolare, i micro-<br />
UAV (peso inferiore a 2 kg) rappresentano<br />
l’ultima frontiera per<br />
l’osservazione della Terra ad alta<br />
risoluzione e bassa quota. Su i<br />
micro-UAV possono essere installati,<br />
infatti, vari sensori che li<br />
rendono utilissimi per le attività<br />
di monitoraggio del territorio<br />
nelle aree urbane e naturali.<br />
Recentemente i micro-UAV<br />
hanno avuto un notevole sviluppo<br />
in seguito alla maggiore<br />
affidabilità e ai costi ridotti per<br />
l’utilizzo di sensori basati sulle<br />
nano-tecnologie (AA. VV.,<br />
2011).<br />
Con UAV, è anche possibile<br />
Fig. 6 - Il termine e le sue relazioni, un diagramma.<br />
osservare la superficie terrestre,<br />
con vista nadirale e prospettica,<br />
ottimi requisiti per valutare i<br />
danni derivanti da incidenti<br />
industriali quali, ad esempio il<br />
crollo degli edifici. I dati prodotti<br />
possono inoltre essere condivisi<br />
come livelli informativi<br />
su piattaforma web (geoSDI) in<br />
pochissimo tempo (dell’ordine<br />
di dieci minuti) fondamentali in<br />
caso di emergenza, poichè hanno<br />
una risoluzione molto alta<br />
ed un corretto posizionamento<br />
geografico (AA. VV., 2011).<br />
I dati acquisiti con gli UAV<br />
saranno sempre più richiesti in<br />
particolare per eventi calamitosi,<br />
sia di origine naturale, antropica<br />
o Natech. Essi, infatti, possono<br />
montare a bordo contemporaneamente<br />
sia fotocamere sia<br />
strumenti dedicati ad acquisire<br />
informazioni specifiche sull’evento<br />
da analizzare. In caso di<br />
incidenti su aree industriali, per<br />
esempio, in cui è possibile la<br />
fuoriuscita di gas tossici e nocivi,<br />
noti in precedenza, i sensori<br />
possono essere progettati ad hoc<br />
per campionare il particolato<br />
atmosferico, rilevare la concentrazione<br />
delle sostanze tossiche e<br />
raccogliere campioni da analizzare<br />
in laboratorio (Wang et al.,<br />
2013). Questi sensori possono<br />
quindi fornire informazione sulle<br />
aree in cui particolato (fumo<br />
<strong>GEOmedia</strong> n°6-<strong>2016</strong> 9
FOCUS<br />
e ceneri) e/o inquinanti possono<br />
ricadere, con evidenti vantaggi<br />
per l’organizzazione delle procedure<br />
di intervento sul territorio.<br />
Inoltre possono monitorare le<br />
zone a rischio più elevato dove è<br />
impossibile l’accesso ai soccorritori.<br />
L’uso di questi mezzi è particolarmente<br />
efficace nel caso di<br />
incidenti in cui si prevede una<br />
reazione a catena (esplosioni,<br />
incendi e crolli) per la formulazione<br />
di un piano di ricerca e<br />
salvataggio e per la prevenzione<br />
dell’effetto domino stesso.<br />
Durante gli incidenti in impianti<br />
che contengono sostanze<br />
chimiche pericolose, possono<br />
essere prodotti gas facilmente<br />
infiammabili, che generano<br />
esplosioni. Queste esplosioni<br />
causano improvvisi movimenti<br />
delle masse d’aria e temperature<br />
molto elevate. Gli UAV, però,<br />
spesso non sono in grado di far<br />
fronte a temperature elevate;<br />
non possono nemmeno mantenere<br />
la stabilità sufficiente per<br />
minimizzare le deformazioni<br />
delle immagini. L’equilibrio, la<br />
stabilità e il controllo del velivolo<br />
durante il volo nonché la durata<br />
delle batterie sono oggetto<br />
di studio per poter minimizzare<br />
questi inconvenienti (AA. VV.,<br />
2011). Di contro, questi velivoli<br />
possono essere di notevole<br />
supporto in quanto, volando<br />
a bassa quota, a differenza dei<br />
satelliti, possono acquisire<br />
immagini sotto la copertura<br />
nuvolosa e sono estremamente<br />
meno costosi di aeromobili con<br />
equipaggio.<br />
Lo sviluppo di sistemi unmanned<br />
non richiede fondi eccessivi<br />
e potrebbe combinare gli<br />
interessi del mondo scientifico<br />
e di quello industriale. Nel<br />
caso di monitoraggio pre- o<br />
post- incidente, infatti, la possibilità<br />
di utilizzare dati acquisiti<br />
da sensori dedicati prevede il<br />
coinvolgimento della piccola e<br />
media industria; la possibilità<br />
di finalizzare le acquisizioni a<br />
specifici utilizzi può diversificare<br />
e aumentare notevolmente i<br />
potenziali utenti.<br />
Fig. 7 - Il Natural Hazards Wikisaurus (NHW), (Wiki + Thesaurus), propone un set di strumenti<br />
terminologici per la conoscenza dei pericoli naturali (http://www.nhwikisaurus.com/).<br />
La terminologia<br />
Le parole assumono significati<br />
diversi a seconda del contesto<br />
nel quale sono utilizzate e molte<br />
ambiguità emergono quando il<br />
dominio di conoscenza al quale<br />
appartengono è complesso o<br />
poco chiaro. Gli strumenti terminologici,<br />
ovvero strumenti<br />
come glossari, lessici e thesauri,<br />
aiutano sia chi produce, organizza<br />
e cataloga l’informazione,<br />
qualunque essa sia, sia quanti<br />
usufruiscano delle informazioni<br />
stesse. In particolare rendono<br />
la ricerca di queste ultime efficace<br />
e rapida, minimizzando<br />
l’effetto del rumore di fondo<br />
e massimizzando la precisione<br />
nel recupero delle informazioni<br />
cercate. Questi concetti, validi<br />
ogni qual volta si utilizzi il linguaggio<br />
per la comunicazione,<br />
divengono ancora più discriminanti<br />
in domini che utilizzano<br />
termini specialistici e tecnici<br />
come quelli legati alle attività<br />
di osservazione della terra e<br />
della gestione delle emergenze.<br />
Inoltre, la necessità di liberare<br />
il campo da ogni “ambiguità<br />
semantica” diventa ancora più<br />
pressante nel momento della<br />
pianificazione del rischio e del<br />
soccorso. La mole di dati attualmente<br />
a disposizione è un vero<br />
e proprio tesoro di informazioni,<br />
ma un tesoro di cui non<br />
possediamo la mappa, un modo<br />
per costruirla è partire dalle<br />
“parole”. Le parole sono quelle<br />
che usiamo quando facciamo<br />
una ricerca e sono i machinereadable<br />
metadata come le key<br />
words associate a i prodotti e<br />
servizi relativi all’earth observation<br />
(EO), che ci permettono<br />
di trovare le informazioni ricercate;<br />
usiamo le parole quando<br />
classifichiamo e organizziamo le<br />
informazioni; usiamo le parole e<br />
le relazioni tra i concetti definiti<br />
da esse quando organizziamo i<br />
contenuti.<br />
Molto si sta facendo nel<br />
campo dell’informatica dove<br />
con le SDI (Spatial Data<br />
Infrastructure) si è raggiunto<br />
un elevato grado di interoperabilità<br />
anche grazie al brokering<br />
approach (Nativi et al., 2013),<br />
per il recupero e la gestione<br />
dei dati. Queste infrastrutture<br />
10 <strong>GEOmedia</strong> n°6-<strong>2016</strong>
FOCUS<br />
permettono, anche attraverso<br />
l’uso di ontologie, la gestione<br />
semantica del sistema, ma alcuni<br />
bisogni rimangono ancora<br />
non soddisfatti soprattutto<br />
quando le query vertono su<br />
qualcosa di molto specifico,<br />
o al contrario quando non si<br />
è esperti nel settore e non si<br />
sa bene cosa cercare. Di fatto<br />
la “componente umana” del<br />
sistema utilizza i termini per<br />
interrogare il sistema stesso e<br />
avere a disposizione un chiara<br />
semantica sui rischi e sui sistemi<br />
di EO, significa innanzitutto<br />
avere dei risultati migliori nel<br />
recupero delle informazioni ed<br />
impegnarsi in una prospettiva<br />
di «conoscenza resiliente», in<br />
grado di usare le conoscenze<br />
scientifiche e degli esperti in<br />
un ottica di «spiegazione» e<br />
«comprensione», elementi chiave<br />
per prendere la decisione<br />
migliore di fronte a un disastro.<br />
Se in qualche modo tecniche e<br />
conoscenze scientifiche hanno<br />
una sorta di “interoperabilitàcontestuale”,<br />
le gestione del rischio<br />
e le attività operative sono<br />
strettamente legate ai domini<br />
semantici determinati anche da<br />
differenze politiche e culturali;<br />
ciò significa che vi è la necessità<br />
di rendere esplicite le relazioni<br />
esatte e precise tra concetti (e<br />
termini) appartenenti ad una<br />
ampia gamma di discipline e<br />
anche a lingue diverse.<br />
Si propongono qui due strumenti<br />
utili per affrontare le<br />
criticità connesse al corretto<br />
utilizzo di linguaggi specifici:<br />
l’NHWikisaurus (http://www.<br />
nhwikisaurus.com/) e Earth<br />
Observation Systems Thesaurus<br />
- EOSterm (http://thesaurusonline.iia.cnr.it/vocabs/eosterm/en/index.php).<br />
Il NHWikisaurus, nasce dalla<br />
collaborazione tra la facoltà<br />
di Scienze della Terra dell’<br />
Università di Torino e del’IIA<br />
- CNR (Rapisardi et al., 2014)<br />
e propone un prototipo collaborativo<br />
di produzione dei<br />
contenuti nella parte wiki e per<br />
gli articoli di approfondimento,<br />
mentre nel contempo offre strumenti<br />
teminologici “classici”<br />
(thesaurus, glossario e ontologia),<br />
per una corretta comprensione<br />
dei concetti e delle parole<br />
legate ai rischi naturali. In una<br />
tematica complessa come quella<br />
della gestione dei pericoli e dei<br />
rischi, lo sforzo di costruire una<br />
mappa tra i concetti aiuta molto<br />
a ridurre ed organizzare la complessità<br />
di tutto il sistema, nelle<br />
sue diverse fasi dalla prevenzione,<br />
alla gestione dell’emergenza,<br />
dal superamento delle crisi<br />
all’analisi migliorativa del processo.<br />
Sono stati identificati i<br />
fenomeni, i processi, gli attori e<br />
le azioni e sono state costruite le<br />
relazioni tra questi “entità”.<br />
EOSterm - Earth Observation<br />
Systems Thesaurus, nasce da un<br />
progetto del CNR IIA (Plini<br />
et al., 2007, 2014), volto alla<br />
costruzione di un sistema terminologico<br />
per telerilevamento<br />
e GIS. I termini selezionati<br />
ed organizzati con relazioni<br />
gerarchiche, di equivalenza e<br />
associative, contiene circa 3.000<br />
termini in italiano ed inglese.<br />
Le principali fonti dalle quali<br />
è stata ricavata la terminologia<br />
sono le seguenti: AGI, CCRS<br />
Remote Sensing Glossary of<br />
Canada Centre, ATIS Telecom<br />
glossary 2000, Glossary of<br />
Cartographic Terms” of Texas<br />
University, Dictionary of<br />
Abbreviations and Acronyms<br />
in GIS, Cartography and<br />
Remote Sensing of the<br />
University of California,<br />
Glossary of Oceanography,<br />
Climatology and the Related<br />
Geosciences, GIS Glossary”<br />
of Environmental Systems<br />
Research Institute Inc. (ESRI),<br />
Glossary of GIS and Metadata<br />
terms of Environmental On-<br />
Line Services (ERIN).<br />
Conclusioni<br />
Negli ultimi anni si è dimostrato<br />
come l’integrazione ed il confronto<br />
delle immagini raccolte<br />
attraverso diverse piattaforme,<br />
satelliti, aeroplani, elicotteri,<br />
UAV, possa fornire informazioni<br />
utili ai soccorritori e a chi<br />
gestisce l’emergenza. Inoltre l’e-<br />
Fig. 8 - EOSterm - Thesaurus su i sistemi di osservazione della terra (http://thesaurusonline.iia.cnr.<br />
it/vocabs/eosterm/it/index.php).<br />
<strong>GEOmedia</strong> n°6-<strong>2016</strong> 11
FOCUS<br />
laborazione dei dati provenienti<br />
dall’EO costituisce una base<br />
conoscitiva per creare scenari<br />
incidentali, individuare le zone<br />
a rischio Natech e di conseguenza<br />
creare piani per la pianificazione<br />
dell’emergenza, dalla<br />
prevenzione alla ricostruzione,<br />
così come fornisce dati utili per<br />
le analisi post evento. La visone<br />
di insieme mostra chiaramente<br />
come i dati del remote sensing<br />
siano una fonte di informazioni<br />
sempre più importante, sia per i<br />
rischi Natech che per tutte le altre<br />
tipologie di rischio, in tutte<br />
le fasi del ciclo dell’emergenza,<br />
dalla fase di prevenzione a quella<br />
della gestione dell’emergenza,<br />
alla ricostruzione, per poi tornare<br />
di nuovo alla prevenzione<br />
secondo un ciclo di miglioramento<br />
continuo.<br />
Una delle sfide cruciali dei prossimi<br />
anni sarà quella di pianificare<br />
accuratamente le missioni<br />
dei micro-satelliti al fine di<br />
massimizzarne l’uso per l’osservazione<br />
delle aree potenzialmente<br />
a rischio per migliorarne<br />
la valutazione e la gestione e per<br />
studiare i fattori di causalità e le<br />
connessioni tra rischi antropici<br />
e rischi naturali.<br />
Inoltre gli UAV sembrano essere<br />
particolarmente adatti nelle<br />
operazioni di soccorso, anche in<br />
quelle situazioni o luoghi dove<br />
per le squadre di soccorso non<br />
è sicuro intervenire (ad esempio<br />
per la presenza di crolli o sostanze<br />
nocive).<br />
Inoltre la gran mole di dati a<br />
disposizione rende utile l’uso<br />
di strumenti terminologici che,<br />
attraverso i concetti e i termini<br />
in essi contenuti, ne facilitino<br />
la catalogazione, la gestione e il<br />
recupero, in modo da rendere le<br />
informazioni fruibili in tempi<br />
rapidi. Sarebbe utile disporre di<br />
glossari e thesauri relativi specificamente<br />
ai rischi Natech e alla<br />
tecnologia necessaria per la loro<br />
gestione.<br />
BIBLIOGRAFIA<br />
AA. VV. (2011), “Dipartimento IUAV per la Ricerca. Unità di Ricerca: Nuove tecnologie per la conoscenza del territorio e<br />
dell’ambiente. “City Sensing” e “Near Mapping” microdrone i-uav piattaforma aerea leggera a bassa quota per il monitoraggio citta’<br />
ambiente e territorio, rilievi di parchi, infrastrutture, aree industriali, edifici, aree in dissesto idrogeologico, applicazioni tematiche<br />
di protezione civile”, Rapporto Conclusivo, http://www.ricercasit.it/smartcities/ricerca/Pervasive%20Real%20Time%20Sensing/<br />
MicrodroneUAV/Progetto%20I-UAV.pdf<br />
Alexander D. (2002), “From civil defence to civil protection and back again”, Disaster Prevention and Management, 11, (3): 209-213<br />
Ajmar A, Boccardo P, Disabato F, Giulio Tonolo F. (2015), “Rapid Mapping: geomatics role and research opportunities”, Geodesy<br />
And Geomatics To The Edge. Rendiconti Lincei, 26, 1: 63-73 DOI: 10.1007/s12210-015-0410-9<br />
Antonioni G, Bonvicini S, Spadoni G, Cozzani V. (2009), “Development of a framework for the risk assessment of Na-Tech accidental<br />
events”, Reliability Engineering & System Safety, 94, 9: 1442-1450<br />
Clerc A, Le Claire G. (1994), “The environmental impacts of natural and technological (Na-tech) disasters”, Background discussion<br />
paper for The World Conference on Natural Disaster Reduction, Yokohama, Japan, 23–27 May 1994<br />
Cruz AM, Steinberg LJ, Vetere Arellano L, Nordvik JP, Pisano F. (2004), “State of the Art in Natech Risk Management (NATECH:<br />
Natural Hazard Triggering a Technological Disaster)”, EUR 21292 EN, © European Communities<br />
Di Franco S, Salvatori R. (2015), “Current situation and needs in man-made and Natech risks management using Earth<br />
Observation techniques”, Remote Sensing Applications: Society and Environment, 1: 72–84. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.rsase.2015.06.004<br />
European Commision. Copernicus Emergency Management Service, http://emergency.copernicus.eu/mapping/#zoom=2&lat=20.<br />
25728&lon=17.0555&layers=0B000000T<br />
Galderisi A, Ceudech A, Pistucci M. (2008), “A method for Na-tech risk assessment as supporting tool for land use planning mitigation<br />
strategies”, Nat Hazards, DOI 10.1007/s11069-008-9224-8<br />
Girgin S, Krausmann E. (2013), “RAPID-N: Rapid Natech risk assessment and mapping framework”, Journal of Loss Prevention in<br />
the Process Industries, 26: 949 - 960, DOI:10.1016/j.jlp.2013.10.004<br />
Joyce KE, Wright KC, Samsonov SV, Ambrosia VG. (2009), Remote sensing and the disaster management cycle. Advances in Geoscience<br />
and Remote Sensing, Gary Jedlovec (Ed.), ISBN: 978-953-307-005-6, InTech, DOI: 10.5772/8341<br />
Krausmann E, Cozzani V, Salzano E, Renni E. (2011), “Industrial accidents triggered by natural hazards: an emerging risk issue”,<br />
Nat. Hazards Earth Syst. Sci., 11: 921–929, DOI:10.5194/nhess-11-921-2011<br />
Kucera J, Lemoine G, Kemper T. (2012), “Post-Disaster Needs Assessment: the role of remote sensing and geospatial information”,<br />
IPSC - Institute for the Protection and Security of the Citizen. JRC- European Commission. Vienna, PDNA training, https://www.gfdrr.<br />
org/sites/gfdrr.org/files/3_JRC-Remote_Sensing.pdf<br />
Lewis PE. (2011), “The Evolution of Airborne Chemical and Radiological Remote Sensing For Emergency and Natural<br />
Disaster Response”, National Geospatial-Intelligence Agency (NGA) - USA. SPIE 2011 Remote Sensing PlenaryTalk, http://spie.org/<br />
Documents/AboutSPIE/PDF/ERS11-plenary-Lewis.pdf<br />
Lindell MK, Perry RW. (1996), “Identifying and managing conjoint threats: earthquake-induced hazardous materials releases”. The<br />
US. J Hazard Mater 50: 31–46<br />
Marzo E, Busini V, Rota R. (2015)), “Definition of a short-cut methodology for assessing the vulnerability of a territory in naturaltechnological<br />
risk estimation”, Reliability Engineering and System Safety, 134: 92–97<br />
Menoni S, Molinari D, Parker D, Ballio F, Tapsell S. (2012), “Assessing multifaceted vulnerability and resilience in order to design<br />
risk-mitigation strategies”, Nat Hazards, 64: 2057–2082, DOI 10.1007/s11069-012-0134-4<br />
Nativi S, Craglia M, Pearlman J. (2013), “Earth Science Infrastructures Interoperability: The Brokering Approach”, IEEE Journal of<br />
selected topics in applied earth observations and remote sensing, 6, 3, DOI: 10.1109/JSTARS.2013.2243113<br />
Plini P, Di Franco S, De Santis V, Salvatori R. (2015), “EOSterm - Earth Observation Systems Thesaurus”, http://thesaurusonline.<br />
iia.cnr.it/vocabs/eosterm/en/index.php<br />
Plini P, Salvatori R, Di Franco S, De Santis V. (2007), “L’organizzazione di metadati e dati relativi a piattaforme aeree e satellitari per<br />
il telerilevamento”, 11ª Conferenza Nazionale ASITA, Torino<br />
Rapisardi E, Di Franco S, Giardino M. (2014), “Web Participatory Framework for Disaster Resilience: Coping with Information<br />
Deluge”, Conference: IAEG 2014, Engineering Geology for Society and Territory, 7<br />
Salzano E, Basco A, Busini V, Cozzani V, Marzo E, Rota R, Spadoni G. (2013), “Public awareness promoting new or emerging<br />
risks: Industrial accidents triggered by natural hazards (Natech)”, Journal of Risk Research, 16, 3-4: 469-485, DOI:<br />
10.1080/13669877.2012.729529<br />
Sandau R. (2006), International Study on Cost-Effective Earth Observation Missions, Balkema A.A. Publishers, Taylor & Francis<br />
Group, Leiden, The Netherlands, 160. ISBN10:0-415-39136-9, ISBN13:9-78-0-415-39136-8<br />
Sandau R, Briess K. (2008), “Potential for advancements in remote sensing using small satellites”, The International Archives of the<br />
Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences. XXXVII, B1, Beijing<br />
Sandau R, Briess K. (2010). “The role of small satellite mission in global change studies- Advances”, Chuvieco, E., Li, J., Yang, X.<br />
(Eds). Earth Observation of Global Change. Springer Science & Business Media, 298<br />
Sandau R. (2010), “Status and trends of small satellite missions for Earth observation”, Acta Astronautica, 66: 1 - 12<br />
Sengupta A. (2007), “Industrial hazard, vulnerability and Risk Assessment for land use Planning: A case study old Haldia, west<br />
Bengal, India”, International Institute for Geo-information Science and Earth Observation (ITC), http://www.itc.nl/library/papers_2007/msc/iirs/sengupta.pdf<br />
Showalter PS, Ramspott M. (1999), “The use of remote sensing in detecting and analyzing natural hazards and disaster, 1972-<br />
1998. A partially annotated Bibliography”. J.M. Lovell Center for Environmental Geography and Hazards Research, Southwest Texas<br />
State University., 1<br />
Wang L, Zhou W, Zhao S.(2013), “Application of Mini-UAV in Emergency Rescue of Major Accidents of Hazardous Chemicals”,<br />
International Conference on Remote Sensing, Environment and Transportation Engineering (RSETE 2013)<br />
ABSTRACT<br />
The Earth Observation (EO) techniques are becoming increasingly important in risk management activities not only for natural hazards<br />
and natural disaster monitoring but also to ride out industrial and Natech accidents. The latest development in the aerospace industry such<br />
as sensors miniaturization and high spatial and temporal resolution missions devoted to monitoring areas of specific interest, have made the<br />
use of EO techniques more efficient and ready to use in near real time conditions. This paper summarize the current state of knowledge on<br />
how EO data can be useful in manage all the phases of the Natech disaster, from the environmental conditions before the accident strikes to<br />
the post accident relief, from the scenario setting and planning stage to damage assessment. Moreover some terminological tools are proposed<br />
NHWikisaurus and EOSterm thesaurus, that could be useful for semantic knowledge spreading in EO and risk managment.<br />
PAROLE CHIAVE<br />
Gestione del rischio; Natech; remote sensing; telerilevamento; Copernicus; GMES; emergenza<br />
AUTORE<br />
Sabina Di Franco<br />
difranco@iia.cnr.it<br />
Rosamaria Salvatori<br />
Istituto sull'InquinamentoAtmosferico – CNR<br />
via salaria Km 29,300<br />
Elena Rapisardi<br />
NatRisk, Università di Torino<br />
NOTA REDAZIONE<br />
Il tema di questo articolo è stato presentato per la prima volta nella XIX Conferenza ASITA.<br />
12 <strong>GEOmedia</strong> n°6-<strong>2016</strong>
FOCUS<br />
<strong>GEOmedia</strong> n°6-<strong>2016</strong> 13
REPORT<br />
Telerilevamento e GIS per la<br />
valutazione e il monitoraggio delle<br />
isole di calore in ambiente urbano<br />
di Sabrina Adelfio, Caterina Enea, Giuseppe Bazan, Pietro Orlando<br />
Fig. 1 – Strisciata immagine MIVIS 2002.<br />
Le tecniche di analisi spaziale e di telerilevamento costituiscono uno strumento molto utile per la conoscenza e lo<br />
studio del fenomeno dell’isola di calore urbano (indicata anche come UHI, dall’acronimo inglese Urban Heat Island).<br />
Nel presente studio, tra le molteplici cause che portano alla generazione di questo fenomeno, sono state approfondite<br />
quelle relative alle caratteristiche fisiche delle superfici e alla presenza delle diverse coperture di uso del suolo.<br />
Negli ultimi secoli l’aumento<br />
demografico<br />
mondiale e la crescita<br />
incontrollata delle città hanno<br />
causato significativi cambiamenti<br />
del territorio da parte dell’uomo.<br />
Una delle conseguenze provocate<br />
da questa trasformazione è la<br />
formazione dell’UHI. Questa si<br />
presenta come un evento microclimatico<br />
che si verifica nelle aree<br />
urbanizzate e consiste in un notevole<br />
aumento della temperatura<br />
nell’ambito urbano rispetto alla<br />
periferia della città e, in particolare,<br />
alle aree rurali circostanti<br />
(Oke, 1973). Nonostante il fenomeno<br />
sia noto almeno dal XIX<br />
secolo, solamente negli ultimi<br />
decenni ha suscitato l’interesse<br />
del mondo scientifico, divenendo<br />
una problematica su cui i pianificatori<br />
urbani stanno ponendo<br />
una grande attenzione. Gli studi<br />
finora effettuati ne distinguono<br />
tre tipologie:<br />
4Isola di calore atmosferica<br />
(Atmospheric UHI - AUHI),<br />
che si distingue ulteriormente<br />
in:<br />
o Isola di calore dello strato<br />
limite urbano, situato al<br />
di sopra dell’altezza media<br />
degli edifici (Urban<br />
Boundary Layer – UBL);<br />
o Isola di calore dello strato<br />
della copertura urbana,<br />
ubicato sotto l’altezza<br />
media degli edifici (Urban<br />
Canopy Layer - UCL);<br />
4Isola di calore di superficie<br />
o epidermica (Surface UHI –<br />
SUHI);<br />
4Isola di calore del sottosuolo<br />
(Subsurface UHI).<br />
Questi diversi tipi di isola di<br />
calore sono certamente correlati,<br />
infatti l’interazione tra il<br />
Boundary Layer, il Canopy Layer e<br />
il Surface Layer genera o meno la<br />
presenza sopra la città di un’isola<br />
di colore. Tuttavia è importante<br />
distinguerli, poiché differiscono<br />
per cause, strumenti di misurazione<br />
e dinamiche temporali.<br />
Le isole di calore atmosferiche<br />
si manifestano in prevalenza di<br />
notte e possono essere negative<br />
di giorno, viceversa quelle di superficie<br />
raggiungono la massima<br />
intensità durante le ore diurne.<br />
Per dedurre con sufficiente precisione<br />
la temperatura superficiale<br />
delle coperture al suolo è stato<br />
utilizzato il Telerilevamento<br />
Termico (Thermal Remote Sensing<br />
- TRS), effettuato con sensori che<br />
acquisiscono informazioni nella<br />
sottobanda dell’infrarosso termico.<br />
Il TRS permette, dunque, di<br />
misurare la quantità di radiazione<br />
elettromagnetica emessa dalla superficie<br />
terrestre nelle lunghezze<br />
d’onda che appartengono alla<br />
regione dell’infrarosso termico.<br />
In seguito, attraverso l’utilizzo<br />
integrato delle tecnologie di telerilevamento<br />
implementate in<br />
ambiente GIS, è stato possibile<br />
analizzare le caratteristiche della<br />
struttura urbana e, in particolare,<br />
comprendere come variano le<br />
temperature all’aumentare della<br />
distanza dalle aree verdi.<br />
14 <strong>GEOmedia</strong> n°6-<strong>2016</strong>
REPORT<br />
Area di studio<br />
La città di Palermo si trova ad<br />
una latitudine di 38°06’56”N<br />
e longitudine di 13°21’41”E,<br />
con un’altitudine di 14 m s.l.m.<br />
Il Comune si estende per una<br />
superficie pari a 160,59 Km 2<br />
con una popolazione di 678 492<br />
abitanti. La città è caratterizzata<br />
da un clima temperato delle medie<br />
latitudini con estati asciutte e<br />
calde e inverni freschi e piovosi.<br />
Nell’analisi condotta è stata presa<br />
in considerazione una strisciata<br />
corrispondente alla zona Ovest di<br />
Palermo delimitata a nord dalla<br />
borgata marinara di Mondello e a<br />
sud dalla valle del fiume Oreto.<br />
La scelta dell’area è stata orientata<br />
dalla presenza di differenti tipologie<br />
di tessuto urbano, al fine<br />
di verificare il comportamento<br />
delle temperature al variare delle<br />
differenti coperture di uso del<br />
suolo. Sono, infatti, presenti aree<br />
consolidate ad alta densità, con<br />
tessuto diffuso a media e bassa<br />
densità e aree verdi di notevole<br />
estensione. Tra le infrastrutture<br />
presenti, Viale della Regione<br />
Siciliana è quella che segna<br />
maggiormente il territorio,<br />
attraversandolo da nord a sud.<br />
Questa, se da un lato rappresenta<br />
un fondamentale elemento di<br />
decongestionamento del traffico<br />
urbano, dall’altro provoca un inquinamento<br />
acustico e atmosferico<br />
tale da ridurre la qualità della<br />
vita e della salute dei cittadini.<br />
Tale impatto viene testimoniato<br />
da dati relativi alle emissioni di<br />
CO (g/Km) ricavate con l’applicazione<br />
del metodo COPERT<br />
II (COmputer Programme to<br />
calculate Emission from Road<br />
Traffic) nell’ambito delle attività<br />
del progetto CORINAIR<br />
(COoRdination Information<br />
AIR) (Corriere, 2011). Da qui la<br />
necessità di eseguire analisi più<br />
approfondite con l’obiettivo di<br />
quantificare le variazioni di temperatura<br />
dovute all’aumento delle<br />
distanze dalla vegetazione.<br />
Materiali e metodologia<br />
L’immagine è stata acquisita dal<br />
sensore MIVIS (Multispectral<br />
Infrared and Visible Immaging<br />
Spectrometer) che opera con<br />
un’elevata risoluzione spettrale<br />
e spaziale. I dati sono stati rilevati<br />
con un volo effettuato sulla<br />
città di Palermo nel luglio del<br />
2002, intorno alle ore 12, ora<br />
che ha permesso di ridurre le<br />
zone d’ombra data la posizione<br />
zenitale del sole. L’immagine è<br />
stata calibrata radiometricamente<br />
e corretta geometricamente al<br />
fine di eliminare le distorsioni<br />
geometriche e radiometriche<br />
dovute al sistema di acquisizione,<br />
al mezzo di propagazione del<br />
segnale, all’angolo di ripresa e<br />
all’effetto della curvatura terrestre.<br />
Successivamente l’immagine<br />
MIVIS è stata georeferenziata<br />
nel sistema cartografico di riferimento<br />
WGS84 UTM33.<br />
Per elaborare l’immagine in<br />
esame si è fatto uso del software<br />
ENVI (Environment for<br />
Visualizing Images), realizzato<br />
dalla Research Systems Inc., nella<br />
versione 4.3. Questa è stata<br />
sottoposta inizialmente ad una<br />
fase di calibrazione mediante<br />
l’utilizzo del metodo empirico<br />
lineare che rimuove approssimativamente<br />
l’irradianza solare,<br />
l’assorbimento atmosferico, gli<br />
effetti di scattering e permette di<br />
passare da valori di radianza a valori<br />
di riflettenza. A tal proposito<br />
si è fatto riferimento ad alcune<br />
misurazioni condotte su alcune<br />
porzioni di asfalto, messo in opera<br />
da poco, e su della ghiaia.<br />
Sono state compiute molteplici<br />
elaborazioni con le tecniche di<br />
classificazione pixel-based, utilizzando<br />
i differenti algoritmi implementati<br />
nel software ENVI, al<br />
fine di valutare e confrontare le<br />
mappe tematiche risultanti dalle<br />
differenti metodologie di classificazione.<br />
Si è potuto constatare<br />
che il risultato qualitativamente<br />
migliore e più rappresentativo<br />
per il territorio osservato è stato<br />
ottenuto con l’algoritmo SAM.<br />
Questo richiede come input un<br />
numero di aree di prova (training<br />
areas) o spettri di riferimento,<br />
derivanti da specifiche ROI<br />
(Region of Interest). Nel presente<br />
studio gli spettri input<br />
sono stati ricavati da ROI<br />
individuate nella scena, dove la<br />
metodologia seguita si è avvalsa<br />
di un’analisi visiva di sintesi<br />
additive in RGB. Ogni ROI è<br />
costituita da raggruppamenti di<br />
pixel il più possibile omogenei<br />
e rappresentativi, che serviranno<br />
ad addestrare l’algoritmo di<br />
classificazione affinché associ<br />
ogni pixel dell’immagine ad<br />
una data categoria. Le ROI<br />
utilizzate per la classificazione<br />
fanno riferimento a 5 classi<br />
di copertura del suolo (Asfalto,<br />
Vegetazione, Edifici con Tetto<br />
bianco, Edifici con Tetto rosso)<br />
più la classe Ombra. La distinzione<br />
tra Tetti rossi e Tetti<br />
bianchi è servita non solo ad individuare<br />
la tipologia di uso del<br />
suolo, ma anche ad analizzare<br />
le caratteristiche termiche dei<br />
ROI NAME COLOR PIXELS POLYGONOS FILL ORIEN ORIENT<br />
Ombra Sea Green 38 3/38 Solid 45 0.10<br />
Asfalto Magenta 186 4/186 Solid 45 0.10<br />
Vegetazione Green 472 12/147 Solid 45 0.10<br />
Edifici con Cyan 60 5/60 Solid 45 0.10<br />
tetto bianco<br />
Edifici con Red 30 3/30 Solid 45 0.10<br />
tetto rosso<br />
Suolo nudo Yellow 34 2/34 Solid 45 0.10<br />
Fig. 2 – ROI strisciata immagine MIVIS 2002<br />
<strong>GEOmedia</strong> n°6-<strong>2016</strong> 15
REPORT<br />
materiali utilizzati. Anche la<br />
classe Ombra, fornisce più che<br />
informazioni relative all’uso del<br />
suolo, informazioni termiche,<br />
in quanto temperature inferiori<br />
nella classe dell’asfalto o dell’urbanizzato<br />
non sarebbe state<br />
altrimenti spiegate.<br />
Nel processo decisionale di<br />
classificazione sono state utilizzate<br />
le bande da 1 a 32 e da 93<br />
a 102. Le bande centrali sono<br />
state escluse al fine di evitare sovrapposizioni<br />
tra le firme spettrali,<br />
con conseguenti errori di classificazione<br />
dei pixel. Attraverso<br />
il processo di classificazione si<br />
passa da un’immagine composta<br />
da Digital Number ad un’immagine<br />
di classi corrispondenti<br />
alle categorie di usi del suolo.<br />
Nonostante la classificazione<br />
ottenuta mediante l’utilizzo<br />
dell’algoritmo SAM sia stata la<br />
migliore, si è potuto riscontrare<br />
come una medesima classe tematica<br />
fosse al suo interno molto<br />
variegata e risultasse costituita da<br />
classi spettrali differenti fra loro.<br />
L’errore che può essere commesso<br />
durante il processo di classificazione<br />
è quello di assegnare un<br />
pixel ad una categoria o classe<br />
diversa da quella a cui appartiene.<br />
Per avere contezza dell’errore<br />
commesso, si ricorre alla “verifica<br />
di accuratezza” che prevede la<br />
realizzazione di una matrice di<br />
confusione, ovvero una matrice<br />
quadrata in cui vengono riportati<br />
i risultati dal confronto tra<br />
la mappa tematica prodotta in<br />
seguito alla classificazione e la<br />
verità di riferimento. La matrice<br />
ha dimensione q×q, dove q è il<br />
numero delle classi o categorie<br />
nella mappa; le colonne rappresentano<br />
i dati di riferimento<br />
(verità), mentre le righe rappresentano<br />
i dati della classificazione.<br />
Il software ENVI può calcolare<br />
una matrice di confusione<br />
utilizzando la ground true image<br />
oppure le ground true ROIs. Nel<br />
presente lavoro è stato utilizzato<br />
CLASS TETTI SUOLO ASFALTO OMBRA TETTI VEGETAZIONE TOTALE<br />
ROSSI NUDO<br />
BIANCHI<br />
Unclassified 0 0 0 0 69 0 69<br />
Tetti rossi 127 0 0 0 0 0 127<br />
Suolo nudo 40 111 0 0 0 0 151<br />
Asfalto 0 54 46 0 0 0 100<br />
Ombra 0 35 55 108 0 0 198<br />
Tetti bianchi 0 0 0 0 50 0 50<br />
Vegetazione 0 0 0 0 0 175 175<br />
Totale 167 200 101 108 119 175 870<br />
Fig. 3 – Ground Truth (pixels).<br />
il secondo metodo che prevede la<br />
realizzazione di ulteriori ROI di<br />
verità a terra, che saranno confrontate<br />
con le ROI utilizzate per<br />
la classificazione delle immagini.<br />
Il prodotto dell’analisi comprende<br />
una valutazione di accuratezza<br />
totale in percentuale (Overall<br />
Accuracy), data dal rapporto tra<br />
i pixel classificati correttamente<br />
e i pixel totali; il coefficiente<br />
kappa; la matrice di confusione,<br />
nella cui diagonale vengono<br />
rappresentati i pixel classificati<br />
correttamente; gli errori di commissione<br />
(percentuale di pixel<br />
in più nella classe); gli errori di<br />
omissione (percentuale di pixel<br />
lasciati fuori dalla classe di appartenenza);<br />
le precisioni producer<br />
and user (utente e produttore)<br />
per ogni classe. La precisione<br />
producer è la probabilità che un<br />
pixel nell’immagine classificata<br />
venga assegnato alla classe x<br />
dato che la classe di verità a<br />
terra è x. La precisione user è la<br />
probabilità che la classe di verità<br />
a terra sia x dato che il pixel è<br />
CLASS<br />
COMMISSION<br />
stato assegnato alla classe x nella<br />
classificazione.<br />
Di seguito si riportano la verifica<br />
di accuratezza dell’intera strisciata<br />
presa in esame.<br />
Overall Accuracy: (617/870)<br />
70,9195%; Coefficiente Kappa:<br />
0,6547<br />
Si è cercato a questo punto di<br />
migliorare i risultati fin qui ottenuti<br />
eseguendo un’operazione<br />
di filtraggio che consiste nell’eliminare<br />
i pixel che in realtà non<br />
appartengono alla classe corretta.<br />
Tale operazione sfrutta, per determinare<br />
il valore del pixel di<br />
destinazione, il valore di alcuni<br />
pixel ad esso più vicini. Nel caso<br />
specifico si è scelto un quadrato<br />
di 3x3 pixel in cui quello in esame<br />
si trova in posizione centrale.<br />
In questo modo è stato possibile<br />
risolvere le problematiche connesse<br />
alla presenza di pixel isolati<br />
presenti in altre classi.<br />
Successivamente l’immagine<br />
classificata è stata importata in<br />
ambiente GIS come shapefile,<br />
elaborata con il software ArcGis<br />
OMISSION<br />
COMMISSION<br />
OMISSION<br />
%<br />
%<br />
(pixels)<br />
(pixels)<br />
Tetti rossi 0 23,95 0/127 40/167<br />
Suolo nudo 26,49 44,50 40/151 89/200<br />
Asfalto 54,00 54,46 54/100 55/101<br />
Ombra 45,45 0 90/198 0/108<br />
Tetti bianchi 0 57,98 0/50 69/119<br />
Vegetazione 0 0 0/175 0/175<br />
Fig. 4 – Errori di commissione e omissione.<br />
16 <strong>GEOmedia</strong> n°6-<strong>2016</strong>
REPORT<br />
10.0 e ulteriormente corretta,<br />
in quanto sono state riscontrate<br />
anomalie nella classificazione del<br />
suolo nudo, erroneamente individuato<br />
come Edifici con tetto<br />
rosso. È stata quindi fatta una<br />
query selezionando tutti i poligoni<br />
classificati come Tetti rossi<br />
che presentavano una superficie<br />
maggiore di 5000 mq, per verificare<br />
di volta in volta la reale<br />
classe di appartenenza. Si sono<br />
riscontrati, inoltre, degli errori<br />
relativi alla classe dell’Asfalto che<br />
spesso presentava al suo interno<br />
porzioni rocciose di Suolo nudo;<br />
anche queste sono state di volta<br />
in volta verificate e corrette.<br />
Non avendo, inoltre, inserito<br />
all’interno delle ROI la classe<br />
Acqua il mare viene classificato<br />
come Ombra. In questa fase di<br />
correzione, pertanto, il mare è<br />
stato ritagliato dall’immagine<br />
in modo da non tenerne conto<br />
nelle successive elaborazioni. Pur<br />
non essendo l’Ombra, una tipologia<br />
di copertura di uso del suolo,<br />
è stato necessario mantenerla<br />
come classe a sé, in quanto le<br />
zone d’ombra creavano dei problemi<br />
nella classificazione. Sono<br />
state così ottenute le immagini<br />
finali, sulle quali sono state calcolate<br />
le percentuali di coperture<br />
di uso del suolo. Nella strisciata<br />
si ha il 27,80% di Suolo nudo,<br />
il 22,53% di Vegetazione, il<br />
19,52% di Ombra, il 13,03% di<br />
Asfalto, il 9,52% di Edifici con<br />
tetto rosso e il 7,60% di Edifici<br />
con tetto bianco.<br />
Dall’immagine MIVIS è stata<br />
poi realizzata una termografia<br />
prendendo in considerazione le<br />
bande dell’infrarosso termico<br />
CLASS PROD. ACC.<br />
%<br />
USER. ACC.<br />
%<br />
PROD. ACC. USER. ACC.<br />
(pixels<br />
(pixels)<br />
Tetti rossi 76,05 100,00 127/167 127/127<br />
Suolo nudo 55,50 73,51 111/200 111/151<br />
Asfalto 45,54 46,00 46/101 46/100<br />
Ombra 100,00 54,55 108/108 108/198<br />
Tetti bianchi 42,02 100,00 50/119 50/50<br />
Vegetazione 100,00 100,00 175/175 175/175<br />
Fig. 5 – Precisioni utente e produttore.<br />
(dalla 93 alla 102 corrispondenti<br />
alle lunghezze d’onda comprese<br />
tra 8,2 e 12,7 μm). In particolare<br />
estraendo la banda 93 (con<br />
lunghezza d’onda compresa tra<br />
8,20 e 8,60 μm) è stato possibile<br />
ricavare valori di emissività delle<br />
superfici, ossia valori di temperatura.<br />
Le informazioni ottenute<br />
con la realizzazione dell’immagine<br />
termica sono servite a comprendere<br />
come le componenti<br />
del paesaggio urbano influenzino<br />
le dinamiche della radiazione<br />
termica e come vi sia dunque<br />
una forte correlazione tra caratteristiche<br />
delle superfici urbane<br />
e temperatura. Per rappresentare<br />
le variazioni di temperatura è<br />
stata utilizzata una graduazione<br />
di colori che va dal verde delle<br />
zone più fredde al rosso delle<br />
zone più calde. Importando le<br />
immagini in ambiente GIS è<br />
stato possibile calcolare le temperature<br />
medie di ogni classe<br />
di uso del suolo. Nell’intera<br />
strisciata la temperatura media<br />
più elevata si ha per il Suolo<br />
nudo con 36,99°, seguono gli<br />
Edifici con tetto rosso e l’Asfalto<br />
con 36,02°, gli Edifici<br />
con tetto bianco con 34,47°,<br />
la Vegetazione con 30,81° e per<br />
ultima l’Ombra con 28,99°.<br />
Nonostante il Suolo nudo sia<br />
caratterizzato da una superficie<br />
permeabile in cui si ha il processo<br />
di evapotraspirazione, l’assenza<br />
totale di vegetazione e di zone<br />
d’ombra lo rende la superficie<br />
più calda. Gli Edifici con tetto<br />
rosso hanno una temperatura<br />
più elevata rispetto a quelli con<br />
Tetto bianco, in quanto superfici<br />
con vernici o materiali chiari<br />
riflettono gran parte della radiazione<br />
proveniente dal sole,<br />
assorbendone quantità irrisorie.<br />
Inoltre, un tessuto a bassa densità<br />
intervallato da vegetazione<br />
può contribuire all’abbassamento<br />
delle temperature; tuttavia<br />
anche il tessuto consolidato<br />
presenta temperature inferiori a<br />
causa della formazione di zone<br />
d’ombra tra gli edifici. L’asfalto<br />
delle strade e dei grandi parcheggi<br />
crea delle vaste superfici<br />
impermealizzate e assorbe una<br />
quantità notevole di radiazione,<br />
a causa del colore scuro dei manti<br />
bituminosi. Al contrario i tetti<br />
bianchi, per le loro proprietà<br />
riflettenti, e la vegetazione presentano<br />
temperature inferiori.<br />
Quest’ultima, infatti, caratterizza<br />
i suoli permeabili favorendo<br />
Fig. 6 – Classificazione finale – Strisciata immagine MIVIS 2002.<br />
<strong>GEOmedia</strong> n°6-<strong>2016</strong> 17
REPORT<br />
Fig. 7 – Termografia – Strisciata immagine MIVIS 2002.<br />
il processo di evapotraspirazione<br />
e garantisce la presenza di zone<br />
d’ombra. Le informazioni ottenute<br />
dall’analisi termica hanno<br />
confermato la presenza di elevate<br />
temperature in corrispondenza<br />
di forti emissioni di CO, nello<br />
specifico l’attenzione è stata<br />
rivolta su due tratti stradali di<br />
Viale della Regione Siciliana,<br />
quantificando le variazioni di<br />
temperatura dovute all’aumento<br />
delle distanze dalla vegetazione.<br />
Al fine di verificare il comportamento<br />
delle temperature in aree<br />
con tipologie di tessuto urbano a<br />
bassa densità edilizia e in assenza<br />
di forti emissioni di CO, sono<br />
state prese in considerazione due<br />
porzioni di territorio caratterizzate<br />
dalla presenza di aree verdi.<br />
L’analisi prevede innanzitutto<br />
di estrapolare la vegetazione<br />
dalla classificazione effettuata<br />
precedentemente e importarla in<br />
ambiente GIS, dove saranno costruiti<br />
cinque buffer con larghezza<br />
di 3 m attorno alle aree verdi,<br />
aumentando progressivamente la<br />
distanza da queste. Il primo parte<br />
direttamente dal limite esterno<br />
della vegetazione (si indicherà<br />
in seguito a una distanza di 0<br />
m), il secondo da una distanza<br />
di 3 m, il terzo di 6 m, il quarto<br />
di 12 m e infine l’ultimo di 18.<br />
Successivamente i buffer così costruiti<br />
vengono intersecati con la<br />
classificazione, al fine di calcolare<br />
le temperature medie di ogni<br />
classe all’interno di ogni buffer,<br />
per comprenderne il comportamento<br />
all’aumentare delle distanze<br />
dalla vegetazione. Sotto si<br />
riportano le variazioni di temperatura<br />
in C° (asse Y) rapportate<br />
all’aumento delle distanze in m<br />
dalla vegetazione (asse X).<br />
Nelle immagini si può notare<br />
come le classi di uso del suolo<br />
presentino un cambiamento<br />
repentino delle temperature alle<br />
distanze di 0, 3 e 6 m dalla vegetazione,<br />
mentre le variazioni<br />
diventano meno evidenti dai 6<br />
ai 18 m, ad eccezione della classe<br />
Ombra. In particolare le temperature<br />
di tutte le classi tendono<br />
ad innalzarsi all’aumentare della<br />
distanza dalla vegetazione, ad<br />
esclusione delle classi Asfalto e<br />
Ombra. Nello specifico si può<br />
notare come tutte le classi, ad<br />
esclusione dell’Ombra, presenti-<br />
Fig. 8 – Variazioni di temperatura a diverse distanze dalla vegetazione per classi di copertura di uso del suolo.<br />
Fig. 9 - Variazioni di temperatura a diverse distanze dalla vegetazione per classi di copertura di uso del suolo.<br />
Fig. 10 - Variazioni di temperatura a diverse distanze dalla vegetazione per classi di copertura di uso del suolo.<br />
Fig. 11 - Variazioni di temperatura a diverse distanze dalla vegetazione per classi di copertura di uso del suolo.<br />
18 <strong>GEOmedia</strong> n°6-<strong>2016</strong>
no un andamento logaritmico<br />
con coefficiente di determinazione<br />
(più comunemente<br />
R 2) che varia da un minimo di<br />
circa 0,70 per l’Asfalto ad un<br />
massimo di 0,98 per il Suolo<br />
nudo. Si può scrivere, quindi,<br />
la seguente equazione:<br />
∆T= k (lnxi-lnxi-1)<br />
Dove ∆T rappresenta la differenza<br />
di temperatura tra il<br />
buffer nella distanza xi e il precedente<br />
xi-1; k è una costante.<br />
Pertanto è possibile determinare<br />
la differenza di temperatura<br />
in funzione della distanza<br />
dalla vegetazione, in quanto a<br />
valori bassi di ∆T corrispondono<br />
distanze ridotte tra le<br />
diverse piantumazioni di verde;<br />
viceversa fissato ∆T è possibile<br />
quantificare le distanze<br />
tra le diverse piantumazioni.<br />
Tuttavia la temperatura media<br />
dell’intero buffer non dipende<br />
più soltanto dalla distanza dalla<br />
vegetazione ma anche dalle<br />
percentuali di copertura di<br />
ogni classe presente.<br />
Inoltre, come si evince dalle<br />
ultime due immagini e grafici,<br />
una distribuzione diffusa nel<br />
territorio di aree verdi (Fig.<br />
11) favorisce un significativo<br />
abbassamento delle temperature<br />
di circa 2 gradi, rispetto<br />
alla presenza della stessa quantità<br />
di verde (circa il 50% per<br />
entrambe le figure). concentrato<br />
in determinate aree (Fig.<br />
10).<br />
Conclusioni<br />
Le aree urbane rappresentano<br />
gli ambiti più a rischio per<br />
i cambiamenti climatici, in<br />
quanto laddove è più alta la<br />
densità abitativa maggiori<br />
sono i rischi ambientali e<br />
sociali. Le città dovranno contribuire<br />
ad adattarsi al cambiamento<br />
climatico e allo stesso<br />
tempo mitigarlo, adottando<br />
politiche che affrontino le due<br />
problematiche in maniera integrata.<br />
Mentre l’adattamento<br />
richiede strategie,<br />
politiche e azioni specifiche a<br />
livello locale per aumentarne<br />
la resilienza al cambiamento,<br />
la mitigazione è un’azione<br />
globale che richiede sostanziali<br />
cambiamenti del comportamento<br />
individuale ed importanti<br />
innovazioni tecnologiche.<br />
Pertanto se gli interventi<br />
vengono applicati sul singolo<br />
edificio si ha come conseguenza<br />
una riduzione della temperatura<br />
delle superfici delle<br />
singole abitazioni, consentendo<br />
di ridurre il consumo<br />
di energia elettrica. Ma se le<br />
azioni di mitigazione vengono<br />
effettuate da molte strutture,<br />
le numerose riduzioni di temperatura<br />
locale e di emissioni<br />
di calore antropogenico provocano<br />
una diminuzione della<br />
temperatura di tutta la città,<br />
apportando un vantaggio per<br />
l’intera collettività e di conseguenza<br />
una migliore qualità<br />
dell’aria. Fondamentale risulta<br />
quindi contribuire alla conoscenza<br />
dei fenomeni in atto ed<br />
alle possibilità di adattamento<br />
che i centri urbani possono<br />
attuare. Nel presente studio<br />
il telerilevamento si è rivelato<br />
una tecnica eccellente per la<br />
rilevazione delle temperature,<br />
confermando che la presenza<br />
di superfici asfaltate, la<br />
continua cementificazione e<br />
l’inquinamento atmosferico<br />
sono le principali cause della<br />
generazione di calore urbano.<br />
Da qui la necessità di attuare<br />
interventi di greening urbano<br />
con un’ottica multiobiettivo<br />
che affianchi alle funzioni termoregolative,<br />
anche quelle di<br />
ottimizzare la risposta idrologica,<br />
apportando conseguenze<br />
positive sotto il profilo ambientale,<br />
ecologico ma anche<br />
estetico, sociale e culturale.<br />
REPORT<br />
BIBLIOGRAFIA<br />
Arnfield A. J. (2003), Two decades of urban climate research: a<br />
review of turbulence, exchanges of energy and water, and the urban heat<br />
island, in “International journal of climatology” 23<br />
Brivio P. A., Lechi G., Zilioli E. (2006), Principi e metodi di Telerilevamento,<br />
Città Studi Edizioni<br />
Corriere F. (2011), Impianti ettometrici e infrastrutture puntuali per i<br />
trasporti, FrancoAngeli<br />
Department of Environmental Science and Engineering, Fudan University<br />
(2009), Remote sensing evaluation of urban heat island and its<br />
spatial pattern of the Shanghai metropolitan area, China, in “Ecological<br />
Complexity” 6<br />
Department of Physics, Faculty of Science, Mahasarakham University<br />
and Department of Geoinformatics, Faculty of Informatics,<br />
Mahasarakham University (2012), Urban heat island monitoring<br />
and analysis by using integration of satellite data and knowledge based<br />
method, in “International Journal of Development and Sustainability,<br />
Vol. 1 Number 2<br />
Institute of Space and Earth Information Science, Yuen Yuen<br />
Research Centre for Satellite Remote Sensing, The Chinese<br />
University of Hong Kong (2011), Urban Heat Island Analysis Using<br />
the Landsat TM Data and ASTER Data: A Case Study in Hong Kong,<br />
in “Remote Sensing” 3<br />
Key Laboratory of Soil & Water Conservation and Desert Prevention,<br />
Ministry of Education, Beijing Forest University (2008), Study<br />
on the distribution changes of urban heat island based on heat-grenness<br />
feature space, in “The International Archives of the Photogrammetry,<br />
Remote Sensing and Spatial Information Sciences” Vol. XXXVII.<br />
Part B7<br />
Oke T. R. (1973), City size and the urban heat island, Atmospheric<br />
Environment, 7.<br />
Oke T. R. (1995), The heat island characteristics of the urban boundary<br />
layer: Characteristics, causes and effects, in “Wind Climate in Cities”<br />
Oke T.R. (1997), Urban Climates and Global Environmental Change,<br />
in “Thompson, R.D. and A. Perry (eds.) Applied Climatology: Principles<br />
& Practices”, New York<br />
Rizwan, Ahmed Memon, Leung Dennis Y.C. e Chunho Liu (2008),<br />
A review on the generation, determination and mitigation of Urban<br />
Heat Island, in “Journal of Environmental Sciences” 20<br />
Stanganelli M., Soravia M. (2012), Consumo energetico e caratteristiche<br />
della morfologia urbana, in “Planum. The Journal of Urbanism”, n.<br />
25, vol 2<br />
State Key Laboratory of Information Engineering in Surveying,<br />
Mapping and Remote Sensing (LIESMARS) and Marine Science<br />
and Environmental Studies, University of San Diego (2006).<br />
PAROLE CHIAVE<br />
Telerilevamento; analisi spaziale; isole di calore urbano; territorio<br />
ABSTRACT<br />
The techniques of spatial analysis and Remote Sensing represent an useful tool for<br />
the knowledge and the study of the Urban Heat Island phenomenon (English acronym<br />
UHI). In this study, among the different causes that lead to the generation<br />
of the event, those regarding physical features of the surface and the presence of<br />
different land use/cover such as: the high cover of urban areas and the lack of green<br />
areas have been examined. The Remote Sensing techniques allow to create maps<br />
of the land use/cover, then, in order to estimate the different in temperature due<br />
to the distance to the vegetation, the temperature of the bodies already tested have<br />
been compared with a thermal map. In detail the aim of the research is to examine<br />
the presence of the phenomenon in Palermo, through the analysis of portion of soil<br />
with different morphological features.<br />
AUTORE<br />
Sabrina Adelfio,<br />
sabrina.adelfio@gmail.com<br />
Caterina Enea<br />
eneakatia@libero.it<br />
Università di Palermo, Scuola Politecnica, Dipartimento<br />
di Architettura, Viale delle Scienze, Edificio 14, Palermo.<br />
Giuseppe Bazan<br />
Giuseppe.bazan@unipa.it<br />
Pietro Orlando<br />
pietro.orlando@unipa.it<br />
Università di Palermo, Scuola Politecnica, Viale delle<br />
Scienze, Edificio 14, Palermo.<br />
NOTA DELLA REDAZIONE<br />
Il tema di questo articolo è stato presentato per la prima volta<br />
nella XIX Conferenza ASITA. <strong>GEOmedia</strong> n°6-<strong>2016</strong> 19
REPORT<br />
Soluzioni informatiche innovative a<br />
supporto della Decostruzione Selettiva<br />
di Antonio Bottaro<br />
Soluzioni informatiche<br />
innovative per ridurre<br />
l'impatto del processo edilizio<br />
sull'ambiente e sul riuso<br />
dei materiali da costruzione<br />
intesi come risorse da reimpiegare<br />
nell’intervento<br />
edilizio stesso. È necessario<br />
volgere verso un modello<br />
a “zero energia” e a “zero<br />
rifiuti”.<br />
Dobbiamo sentirci tutti<br />
coinvolti nel portare<br />
un contributo all’elaborazione<br />
di una risposta<br />
collettiva di contrasto rispetto<br />
ai cambiamenti climatici che<br />
affliggono i nostri tempi.<br />
Un contributo in tal senso può<br />
venire dall’adeguamento del<br />
ciclo di vita del ‘Fabbricato’ che,<br />
considerato alla stregua di un<br />
’organismo edilizio’, può essere<br />
riportato in linea con la natura<br />
ciclica di fenomeni naturali (paradigma<br />
ecologico).<br />
Questo vuol dire orientare le<br />
attività di ricerca all’individuazione<br />
di soluzioni atte alla<br />
‘chiusura del cerchio’ inerente<br />
il ciclo di vita del fabbricato in<br />
modo che venga modificata la<br />
tradizionale risposta ‘lineare’<br />
(Cradle to Grave: dalla culla alla<br />
tomba), grandemente energivora,<br />
verso la realizzazione di<br />
diversi cicli di decostruzione/ricostruzione<br />
che consentano, l’adozione<br />
di un sempre maggior<br />
contenuto di ‘riuso’ dei materiali<br />
(Cradle to Cradle: dalla culla<br />
alla culla).<br />
Le ristrutturazioni cicliche infatti<br />
ben si adattano al naturale<br />
processo di efficientamento del<br />
Fabbricato che si adegua, nel<br />
tempo, all’evoluzione delle tecnologie<br />
e dei materiali connessi<br />
ai diversi aspetti che lo riguardano:<br />
energetico, di sicurezza,<br />
sismico, etc.<br />
Al fine di ridurre effettivamente,<br />
ed in modo complessivo gli<br />
impatti ambientali dovuti agli<br />
interventi edilizi, appare necessario<br />
ed imprescindibile, che il<br />
progetto si faccia carico del tema<br />
dei materiali in modo complessivo.<br />
Il processo edilizio ed il<br />
progetto tecnologico devono essere<br />
rinnovati per far sì che possano<br />
accogliere le istanze ambientali<br />
in modo completo. In<br />
questo senso, al modello a ‘zero<br />
energia’ (ciascun fabbricato deve<br />
produrre almeno l’energia che<br />
consuma) si deve integrare l’aspetto<br />
della costruzione a ‘zero<br />
rifiuti’. Con questa espressione<br />
si intende richiamare il nuovo<br />
paradigma progettuale nel quale<br />
i materiali di scarto, derivanti<br />
dalle demolizioni, siano intesi<br />
come risorse da re-impiegare<br />
nell’intervento edilizio stesso.<br />
Riuscire a tenere conto dei<br />
materiali in sede di progetto<br />
è un tema importante anche<br />
nella governance delle politiche<br />
di incentivazione al riuso. Le<br />
amministrazioni necessitano di<br />
strumenti idonei al computo ed<br />
anche al controllo delle quantità<br />
oggetto di riuso o di avvenuto<br />
‘smaltimento’ nelle corrette filiere<br />
di recupero.<br />
Servono quindi nuovi strumenti<br />
per tenere in debito conto, nel<br />
ciclo di vita di un manufatto,<br />
20 <strong>GEOmedia</strong> n°6-<strong>2016</strong>
REPORT<br />
il trattamento digitale dei ‘materiali’<br />
nel tempo, supportando<br />
nuove esigenze di progetto quali:<br />
il Design for Deconstruction,<br />
il Design for Recycling ed il<br />
Design for Waste.<br />
Andranno prodotte scene di<br />
realtà aumentata, georiferite al<br />
territorio, innestate su modellazioni<br />
3D veloci, facilmente<br />
navigabili e misurabili. I materiali<br />
dovranno essere ’battezzati’<br />
secondo codifiche internazionalmente<br />
riconosciute.<br />
Tutti i cicli di ristrutturazione<br />
prevedono atti preliminari di<br />
decostruzione e di successiva<br />
ri-costruzione mirati alla<br />
sostituzione di ‘materiali’ per<br />
il raggiungimento di stati di<br />
maggiore efficientamento.<br />
Contemplare i materiali in questo<br />
nuovo contesto comporta<br />
il loro riporto, nei Data Base<br />
associati, attraverso codifiche<br />
idonee sia al loro smaltimento<br />
(in Europa sono le codifiche<br />
CER – Codifica Europea dei<br />
Rifiuti) che, ad esempio, per la<br />
fase di progettazione del ‘nuovo’,<br />
dall’utilizzo di codifiche<br />
conformi a quanto richiesto<br />
dal BIM (Building Information<br />
Modeling).<br />
La tendenza a non antropizzare<br />
più nuovo terreno ma a meglio<br />
riutilizzare quanto ‘costruito’ ed<br />
in disuso, o non efficientatile, è<br />
una necessità che sta diventando<br />
sempre più cogente nelle<br />
società avanzate. A tale proposito<br />
si rileva che si possiede<br />
una ottima conoscenza dei costi<br />
di costruzione (ex-novo) ma si<br />
conosce poco dei prezzi di sostituzione<br />
(completa demolizione<br />
selettiva). Una moderna demolizione<br />
selettiva richiede l’intervento<br />
umano che comporta costi<br />
assicurativi elevati in ragione<br />
della ovvia pericolosità di detta<br />
classe di interventi. Questo<br />
aspetto apre quindi il tema della<br />
‘guida’ automatica di automi<br />
in grado di sostituire l’uomo.<br />
E’ necessaria quindi una modellazione<br />
3D, aumentata dal<br />
punto di vista metrico mediante<br />
contributi fotogrammetrici per<br />
una definizione utile di tipo<br />
centimetrico. In tale contesto<br />
dovrà essere possibile guidare<br />
automi senza la presenza umana<br />
(Droni) che saranno in grado di<br />
operare in un contesto, anche<br />
semanticamente conosciuto, restituendo,<br />
in tempo quasi reale,<br />
gli aggiornamenti sulla realtà<br />
che contestualmente contribuiscono<br />
a ‘modificare’.<br />
La demolizione selettiva è però<br />
un processo che si ‘innesta’ su<br />
un ‘quadro’ di espletamenti<br />
burocratici che attualmente<br />
affiancano il processo con un<br />
notevole ‘peso’. I processi di<br />
informatizzazione della componente<br />
‘burocratica’ nascono,<br />
comunemente, come mera<br />
trasposizione, in formati digitalmente<br />
memorizzabili, di quanto<br />
precedentemente richiesto sotto<br />
forma ‘cartacea’. L’effettuazione<br />
di questo passo consente di<br />
certo il superamento della carta<br />
e, nella migliore delle ipotesi,<br />
con la standardizzazione dei<br />
formati e dei processi, si può<br />
raggiungere un più elevato livello<br />
di automazione attraverso<br />
il trattamento digitale dei dati<br />
ottenibile mediante elaborazione<br />
informatica. Sono risultati<br />
importanti ma che non colgono<br />
a pieno le positività insite in<br />
un vero processo di digitalizzazione.<br />
Anche il documento<br />
noto come ‘Piano di gestione<br />
dei rifiuti’, in tal senso, non<br />
costituisce un’eccezione. Tutte<br />
le informazioni codificate al suo<br />
interno sono infatti 'digitalizzate'<br />
solo ai sensi di una dematerializzazione<br />
del documento e<br />
non per un possibile loro riutilizzo<br />
in un processo digitale.<br />
Un’informatizzazione di solo<br />
primo livello può fornire la<br />
possibilità di riporto dei dati<br />
previsti per detto documento,<br />
ospitabili in un opportuno<br />
‘cartiglio’, redatto a partire da<br />
‘dati’ che il professionista compila<br />
e correda attraverso il loro<br />
reperimento con un processo<br />
di acquisizione, per ispezione<br />
diretta sul posto, eventualmente<br />
arricchito da elementi della propria<br />
conoscenza professionale<br />
supportata da archivi (codici,<br />
foto, manuali, abachi…) che<br />
consente, ovviamente, la formalizzazione<br />
di un lavoro serio di<br />
perizia, ma non è in grado di<br />
ottimizzare a pieno il portato<br />
di un processo che, ove svolto<br />
in una filiera ad elevato livello<br />
di contenuto di servizi digitali,<br />
vedrebbe il tutto dipanarsi ad<br />
un più elevato livello di risoluzione<br />
automatica delle complessità<br />
sottese.<br />
Provare a pensare l’intero processo<br />
trasposto in un’ottica<br />
digitale significa affrontarlo in<br />
un contesto di trasposizione<br />
della realtà in realtà aumentata<br />
che coinvolge una modellazione<br />
3D, opportunamente ‘aumentata’<br />
nel senso della ‘vestizione’<br />
<strong>GEOmedia</strong> n°6-<strong>2016</strong> 21
REPORT<br />
degli spazi con le informazioni<br />
provenienti dai consueti processi<br />
di 3D‘data capture’. In<br />
tale processo va logicamente<br />
separato quanto utile alla ‘navigazione’<br />
da quanto necessario<br />
al processo di misura. Per avere<br />
rappresentazioni fedeli a livelli<br />
di precisione elevata servono<br />
grandissime moli di dati, mentre,<br />
per una corretta navigazione<br />
in una realtà virtuale, molto<br />
simile alla vera, è sufficiente<br />
solo un piccolo sottoinsieme di<br />
punti.<br />
Ai professionisti andranno forniti<br />
servizi e processi digitali<br />
in grado di operare su scenari<br />
di realtà virtuale/aumentata<br />
che consentano di ‘entrare’ in<br />
un modello evoluto di ‘modellazione<br />
3D’ (quest’ultima<br />
sviluppata da RomaTre nell’ambito<br />
del Computational Visual<br />
Design (CVD-Lab) e denominata<br />
LAR -Linear Algebraic<br />
Representation) sulla quale è<br />
‘strutturalmente’ possibile operare<br />
anche con i consueti operatori<br />
matematici differenziali.<br />
Questa realtà virtuale dovrà<br />
essere servita della possibilità di<br />
georiferire le informazioni proprie<br />
alle diverse specializzazioni<br />
professionali che operano sullo<br />
steso contesto (e sulla medesima<br />
rappresentazione) consentendo<br />
la disamina delle diverse ‘viste’<br />
secondo gli specifici argomenti<br />
che si desidera affrontare:<br />
Design for Deconstruction,<br />
il Design for Recycling ed il<br />
Design for Waste.<br />
L’avere il tutto contestualizzato<br />
secondo i codici CER consente<br />
di avere in automatico sia la<br />
valutazione del costo finale di<br />
smaltimento dei diversi cicli<br />
di ristrutturazione che i dati<br />
connessi al ‘riuso’ con l’annessa<br />
produzione automatica del carico<br />
‘burocratico’ (es. Piano di<br />
smaltimento dei rifiuti, Registro<br />
di carico e scarico, FIR, componente<br />
MUD). Nel caso ‘terminale’<br />
della Sostituzione Edilizia<br />
viene prodotto un GANTT<br />
relativo alle ‘fasi’ della decostruzione<br />
selettiva con stima dei<br />
tempi e computo della gestione<br />
ottimizata delle aree di buffer<br />
(scarrabili).<br />
BIBLIOGRAFIA<br />
Altamura, P. (2012). Gestione eco-efficace dei<br />
materiali da costruzione nel ciclo di vita del fabbricato.<br />
Tesi di Dottorato, Sapienza Università<br />
di Roma.<br />
DiCarlo, A., Paoluzzi, A., and Shapiro, V.<br />
(2014). Linear algebraic representation for<br />
topological structures. Comput. Aided Des.,<br />
46:269–274.<br />
Paoluzzi, A., Pascucci, V., Vicentino, M., Baldazzi,<br />
C., and Portuesi, S. (2001). Geometric<br />
Programming for Computer Aided Design.<br />
John Wiley & Sons, Inc., New York, NY, USA.<br />
815 pages.<br />
PAROLE CHIAVE<br />
Soluzioni informatiche; decostruzione;<br />
riuso; rifiuti; modellazione<br />
3D; droni; servizi digitali; realtà<br />
aumentata; PA<br />
ABSTRACT<br />
Building processes and designs have to be renewed<br />
to take account of environmental concerns.<br />
To reduce the impact of construction<br />
projects on the environment, the design needs<br />
to take the issue of building materials into consideration.<br />
Public administrations need suitable<br />
tools for the calculation and the control of reused<br />
or disposed materials. Innovative IT tools<br />
should handle the digital processing of materials<br />
throughout the project, supporting new project<br />
requirements such as: Design for Deconstruction,<br />
Design for Recycling and Design for<br />
Waste.<br />
AUTORE<br />
Antonio Bottaro<br />
abottaro@geoweb.it<br />
GEOWEB S.p.A.<br />
Viale Luca Gaurico 9/11 00143-Roma<br />
http://www.geoweb.it<br />
22 <strong>GEOmedia</strong> n°6-<strong>2016</strong>
REPORT<br />
SOLUZIONI DI GEOPOSIZIONAMENTO<br />
topconpositioning.com/hiper-hr<br />
PRESENTA HIPER HR<br />
CONNETTIVITÀ AVANZATA<br />
FORMA<br />
E FUNZIONE<br />
ALTAMENTE<br />
CONFIGURABILE<br />
PRESTAZIONI<br />
SUPERIORI<br />
A PROVA<br />
DI FUTURO<br />
MODERNA TECNOLOGIA DI POSIZIONAMENTO IBRIDO<br />
Traccia tutti i segnali satellitari con la versatilità di gestire qualsiasi progetto. La tecnologia all’avanguardia,<br />
brevettata di HiPer HR, offre elevata ripetibilità di posizionamento in un design compatto.<br />
© <strong>2016</strong> Topcon Positioning Group<br />
<strong>GEOmedia</strong> n°6-<strong>2016</strong> 23
REPORT<br />
Forum TECHNOLOGY for ALL<br />
Pubblicate le date 2017 - online gli atti dell'edizione <strong>2016</strong><br />
Si svolgerà dal 17 al 19 ottobre<br />
2017 la quarta edizione<br />
del Forum TECHNOLOGY<br />
for ALL, evento dedicato alle<br />
soluzioni tecnologiche d’avanguardia<br />
per i settori del territorio,<br />
dei beni culturali e delle<br />
smartcity storiche. Giunto alla<br />
sua quarta edizione, il Forum<br />
TECHNOLOGY for ALL si<br />
propone in maniera sempre più<br />
innovativa, con workshop in<br />
campo, formazione e conferenze<br />
per comprendere e diffondere<br />
le applicazioni delle nuove<br />
tecnologie. Come nelle precedenti<br />
edizioni le tre giornate saranno<br />
dedicate a test in campo,<br />
alla formazione e allo scambio<br />
di esperienze in quanto il Forum<br />
è un momento informativo, ma<br />
anche formativo, che segue<br />
l’intero processo di applicazione<br />
delle tecnologie innovative,<br />
dall’acquisizione dei dati all’elaborazione,<br />
dalla strutturazione<br />
all’organizzazione per la diffusione<br />
agli utenti finali. Tra le<br />
novità di quest’anno uno sguardo<br />
alla crescita dell’arte mediatica<br />
nella misura e documentazione<br />
di precisione, vista nella<br />
diffusione anche ai non esperti<br />
degli applicativi per usare semplicemente<br />
tecniche complesse.<br />
Uno sguardo al ruolo dell’Italia<br />
nello sviluppo e conservazione<br />
del patrimonio dell’Umanità e,<br />
a fronte delle recenti emergenze<br />
affrontate, una analisi degli<br />
strumenti per mitigare gli eventi<br />
potenzialmente disastrosi.<br />
Proseguirà il dibattito aperto<br />
sull’apporto ponderato delle<br />
tecnologie che, superato l’entusiasmo<br />
del primo impatto innovativo,<br />
possano effettivamente<br />
essere ammesse a un ciclo di<br />
produzione normato con standard<br />
condivisi per uno sviluppo<br />
socio-economico sostenibile<br />
in cui l’innovazione intelligente<br />
giochi un ruolo chiave<br />
per il Territorio, il Patrimonio<br />
Culturale e le Smart City.<br />
Stiamo progettando anche un<br />
percorso itinerante e distribuito<br />
nel tempo per presentare test sul<br />
campo eseguiti preventivamente<br />
in accordo con le istituzioni<br />
e i siti che parteciperanno all’evento.<br />
La precedente edizione<br />
<strong>2016</strong> con oltre mille visitatori,<br />
80 relatori, 28 sponsor e 19 patrocini,<br />
iniziata nella splendida<br />
cornice dell’Area di Massenzio<br />
sulla Via Appia Antica a Roma,<br />
si è conclusa negli spazi articolati<br />
dell’Auditorium della<br />
Biblioteca Nazionale Centrale<br />
di Roma. Nello stile anche fieristico<br />
ed istituzionale il Forum<br />
allargato alla cittadinanza e dedicato<br />
all’innovazione, ha promosso<br />
con sessioni, dibattiti,<br />
incontri e discussioni aperte,<br />
un’interattività tra produttori,<br />
esperti, studiosi, ricercatori,<br />
studenti, utenti ed operatori, disposti<br />
al confronto negli organismi<br />
conferenzieri ed espositivi<br />
che hanno ad3erito all’iniziativa,<br />
strumentale ad un vero<br />
e proprio campus di formazione<br />
con decine di ‘workshops’.<br />
Per consultare gli<br />
Atti del Forum vai su:<br />
http://www.technologyforall.it/<br />
24 <strong>GEOmedia</strong> n°6-<strong>2016</strong>
ASSOCIAZIONI<br />
XXXII Congresso<br />
dei Geografi Italiani<br />
Convegno FOSS4G-IT 2017<br />
Il XXXII Congresso geografico italiano, promosso dall’Associazione<br />
dei geografi italiani, si svolgerà a Roma dal 7 al 10 Giugno<br />
2017. Nell’anno in cui ricorrono il centenario della Rivoluzione<br />
d’Ottobre, e il cinquecentenario della Riforma luterana, il tema<br />
del Congresso saranno appunto le rivoluzioni e le riforme. Si<br />
tratta di un tema con il quale la geografia si è confrontata più<br />
volte. In questi ultimi anni si sono poi modificati profondamente<br />
sia i contenuti sia le pratiche della ricerca. Interventi legislativi<br />
e tagli hanno comportato una progressiva precarizzazione e una<br />
sostanziale diaspora dei geografi italiani. Se, da una parte, sono<br />
scomparsi insegnamenti, corsi di laurea e di dottorato, linee di<br />
indagine, dall’altra la ricerca, così come la formazione geografica,<br />
si confronta oggi più che mai con un contesto transdisciplinare e<br />
transnazionale. Il riferimento a paradigmi scientifici unificanti e<br />
a tradizioni consolidate si è indebolito. I linguaggi, gli interessi e<br />
i metodi si sono frammentati anche per via di fenomeni più generali<br />
quali la globalizzazione della ricerca, l’inevitabile ricambio<br />
generazionale, le difficoltà che il mondo contemporaneo pone<br />
in termini di comprensione, rappresentazione, progettualità. Il<br />
Congresso vuole valorizzare questo mosaico di diversità, ma al<br />
tempo stesso ricostruire il senso di un’appartenenza attraverso un<br />
confronto aperto sia all’interno sia e soprattutto verso l’esterno.<br />
Si adottano per questo modalità organizzative inedite rispetto<br />
alle edizioni precedenti: qualsiasi studioso o studiosa potrà proporre<br />
e gestire specifiche sessioni tematiche in autonomia, e la<br />
gran parte del programma congressuale sarà strutturato in sessioni<br />
parallele. L’idea è che il Congresso non debba essere un palcoscenico<br />
per pochi, ma un luogo che si nutre di varietà, confronti<br />
e relazioni orizzontali, aperto al contributo di tutti. L’ambizione<br />
è mostrare come la geografia, una delle forme più antiche di conoscenza<br />
del mondo, sia più che mai viva e vitale: una chiave<br />
di lettura cruciale per comprendere l’attualità e per progettare<br />
alternative, tra nuove riforme e rivoluzioni.<br />
La deadline per la sottomissione degli abstract è il 15 febbraio 2017.<br />
Per maggiori informazioni:<br />
http://www.congressogeografico.it<br />
Per il primo anno tale convegno raccoglie insieme il “XVIII<br />
Meeting degli utenti italiani di GRASS GIS e GFOSS” e il “X<br />
GFOSS DAY” e dedicherà la giornata di sabato a OpenStreetMap.<br />
Date dell’evento<br />
6-11 febbraio 2017 GRASS Community Sprint<br />
8 febbraio 2017 Giornata dedicata ai Workshop<br />
9-10 febbraio 2017 Convegno<br />
11 febbraio 2017 Giornata dedicata a Open<br />
Quanto ne sa la Pubblica Amministrazione di Open Source?<br />
Una recente indagine dell'ISTAT su ICT e Pubblica Amministrazione<br />
ha fatto un quadro non lusinghiero della situazione<br />
Italiana per le PA locali.<br />
In questo senso i software open source possono dare un grande<br />
supporto. Per monitorare questa situazione un gruppo di lavoro<br />
che ha racchiuso personalità universitarie appartenenti al gruppo<br />
degli utenti italiani di GRASS e membri dell'associazione<br />
GFOSS.it ha predisposto un semplice e veloce questionario<br />
(http://goo.gl/forms/tAAXJsIlPZ) utile per raccogliere alcune<br />
indicazioni circa l'utilizzo del software free e open source in<br />
ambito geografico (Geographical Free and Open Sorce Software<br />
- GFOSS) da parte della Pubblica Amministrazione.<br />
Il questionario potrà mettere in luce timori e limiti del software<br />
GFOSS, ma anche evidenziare buone pratiche ed esempi di<br />
amministrazioni virtuose, con l'obiettivo di redigerne un cosiddetto<br />
libro bianco e di presentarne i primi risultati nel corso del<br />
prossimo XVIII meeting che si terrà a Genova il 9 - 10 febbraio<br />
2017.<br />
E' disponibile il programma dettagliato dell'evento,<br />
vedi news qui:<br />
http://www.geoforall.it/kwpy3<br />
grass.gfoss.genova@gmail.com<br />
Convegno AIC 2017<br />
Il convegno annuale dell’AIC del 2017 si terrà a Genova presso il Museo<br />
del Mare dal 10 al 12 maggio del 2017. Organizzato in collaborazione con<br />
l’Istituto Idrografico della Marina, con il Museo del Mare e con l’Università<br />
di Genova, tratterà di Cartografia e crescita blu: conoscenza, politiche,<br />
gestione e rappresentazione di una tematica sensibile. E’ disponibile la<br />
prima circolare con la tempistica per la sottomissione degli articoli e le condizioni<br />
di partecipazione, mentre a breve saranno attivati i link per la diffusione della call e per la trasmissione diretta<br />
di abstract e articoli.<br />
Per maggiori informazioni vedi: http://www.aic-cartografia.it/news/convegno-aic-2017cartografia-e-crescita-blu/<br />
<strong>GEOmedia</strong> n°6-<strong>2016</strong> 25
I Monti Virunga<br />
L’immagine satellitare è di tipo radar-composito<br />
ed è stata ottenuta da Sentinel-1:<br />
mostra il sistema dei monti Virunga in Africa<br />
orientale, una catena di vulcani che si estende attraverso<br />
il confine settentrionale del Ruanda con l’Uganda e verso est<br />
all’interno della Repubblica Democratica del Congo.<br />
Mentre la maggioranza di questi otto vulcani è dormiente, due<br />
di essi sono ancora attivi, con le eruzioni più recenti che risalgono<br />
al 2006 ed al 2010. Queste montagne sorgono sull’Alberine Rift,<br />
dove la Placca Somala si allontana dal resto del continente africano.<br />
Quest’area è una delle regioni africane a più alta diversità biologica,<br />
ma l’elevata densità di popolazione umana, la povertà ed i conflitti<br />
costituiscono una sfida alla conservazione. In ogni caso, all’interno<br />
dell’area montuosa è stata realizzata una serie di parchi<br />
nazionali allo scopo di proteggere la<br />
Credits: ESA.<br />
Traduzione: Gianluca Pititto
REPORT<br />
Analisi GIS applicate alla gestione faunistica<br />
Le mappe di rischio di impatto degli ungulati<br />
Fig. 1 - Mappa di impatto in formato<br />
raster. Esempio per il cinghiale comprensorio<br />
di Lucca.<br />
di Alessandro Giugni,<br />
Marco Ferretti,<br />
Leonardo Conti<br />
Gli ungulati selvatici sono<br />
ormai diffusi nella quasi<br />
totalità della penisola italiana.<br />
La loro presenza crea criticità<br />
sia alle colture agricole che<br />
alle strutture e alle attività<br />
antropiche. Una corretta<br />
pianificazione territoriale può<br />
attenuare le problematiche ad<br />
oggi presenti. Gli strumenti<br />
GIS possono aiutare in questa<br />
elaborazione, partendo da<br />
open data disponibili sul web.<br />
La fauna selvatica, ed<br />
in particolar modo gli<br />
ungulati, hanno subito<br />
un incremento demografico e<br />
geografico significativo negli<br />
ultimi decenni, soprattutto in<br />
regioni come la Toscana dove<br />
l’habitat ed il clima sono ideali<br />
per la loro proliferazione. Gli<br />
Ungulati presenti in Toscana<br />
sono i seguenti: Cinghiale<br />
(Sus scrofa L.), Cervo (Cervus<br />
elaphus L.) , Capriolo (Capreolus<br />
capreolus L.), Daino (Dama<br />
dama L.), Muflone (Ovis<br />
musimon P.) (Regione Toscana<br />
2012). Le cause principali<br />
dell’aumento di ungulati sono<br />
l’abbandono delle coltivazioni<br />
in ambiente montano, la<br />
diminuzione della pressione<br />
venatoria, l’aumento delle<br />
aree protette e l’immissione<br />
incontrollata di specie come il<br />
cinghiale (Riga et al. 2011). La<br />
maggiore presenza sul territorio<br />
delle popolazioni di ungulati<br />
selvatici ha portato ad un aumento<br />
di vantaggi e di benefici<br />
sociali ed economici, come il<br />
possibile utilizzo per attività<br />
turistico-venatorie, ma ha<br />
causato anche un aumento di<br />
problematiche relative alla loro<br />
convivenza con l’uomo e alla<br />
loro presenza in zone antropizzate<br />
(Riga et al. 2011, Banti et<br />
al. 2009). Attraverso l’utilizzo<br />
di programmi GIS è però possibile<br />
pianificare strategie gestionali<br />
che possono diminuire<br />
l’impatto di queste specie sul<br />
territorio e favorire un equilibrio<br />
di essi con l’ambiente e le<br />
attività umane.<br />
28 <strong>GEOmedia</strong> n°6-<strong>2016</strong>
REPORT<br />
Obiettivo dello studio<br />
Nel corso del 2013 sono state<br />
pubblicate dall’ISPRA (Istituto<br />
per la Protezione e la Ricerca<br />
Ambientale) le Linee Guida per<br />
la Gestione degli Ungulati (Raganella<br />
Pelliccioni et al. 2013).<br />
Una parte di queste riguarda<br />
l’importanza di una corretta<br />
pianificazione territoriale per<br />
la gestione delle criticità legate<br />
agli ungulati, in particolare<br />
nel testo si sottolinea come sia<br />
importante individuare aree<br />
problematiche (dette anche in<br />
un’accezione gestionale non<br />
vocate ad una determinata specie),<br />
dove programmare una<br />
gestione di tipo non conservativo.<br />
Queste aree devono essere<br />
scelte tramite parametri oggettivi,<br />
attraverso strumenti informatici<br />
(GIS) e con tecniche<br />
ripetibili e controllabili. L’obiettivo<br />
di questo studio è stato<br />
quello di creare una mappa di<br />
impatto potenziale degli ungulati<br />
a livello regionale toscano,<br />
secondo le modalità dettate da<br />
ISPRA. Partendo da questa,<br />
si sono poi individuate aree<br />
dove poter svolgere interventi<br />
di controllo faunistico ai sensi<br />
dell’art. 19 L.N. 157/92, per il<br />
contenimento delle specie nei<br />
confronti delle colture agricole<br />
e delle aree antropizzate.<br />
n. Ucs2013 Descrizione Cinghiale Capriolo Cervo Daino Muflone<br />
1 111 Zone residenziali a tessuto continuo 5 5 5 5 5<br />
2 112 Zone residenziali a tessuto discontinuo 5 5 5 5 5<br />
3 1121 Pertinenza abitativa, edificato sparso 5 5 5 5 5<br />
4 121 Aree industriali, commerciali e dei servizi pub. 5 5 5 5 5<br />
5 1211 Depuratori 5 5 5 5 5<br />
6 1212 Impianto fotovoltaico 5 5 5 5 5<br />
7 122 Reti stradali, ferroviarie e infrastrutture tecnici 5 5 5 5 5<br />
8 1221 Strade in aree boscate 5 5 5 5 5<br />
9 123 Aree portuali 5 5 5 5 5<br />
10 124 Aeroporti 5 5 5 5 5<br />
11 131 Aree estrattive 5 5 5 5 5<br />
12 132 Discariche, depositi di rottami 5 5 5 5 5<br />
13 133 Cantieri, edifici in costruzione 5 5 5 5 5<br />
14 141 Aree verdi urbane 5 5 5 5 5<br />
15 1411 Cimitero 5 5 5 5 5<br />
16 142 Aree ricreative e sportive 5 5 5 5 5<br />
17 210 Seminativi irrigui e non irrigui 3 2 2 2 2<br />
18 2101 Serre stabili 5 5 5 5 5<br />
19 2102 Vivai 4 4 4 4 4<br />
20 213 Risaie 4 4 4 4 4<br />
21 221 Vigneti 4 4 4 4 4<br />
22 222 Frutteti 4 4 4 4 4<br />
23 223 Oliveti 2 3 3 3 3<br />
24 2221 Arboricoltura 2 2 2 2 2<br />
25 231 Prati stabili 2 1 1 1 1<br />
26 241 Colture temporanee associate a colture perm. 2 1 1 1 1<br />
27 242 Sistemi colturali e particellari complessi 4 1 1 1 1<br />
28 243 Colture agrarie con presenza di spazi naturali 2 1 1 1 1<br />
29 244 Aree agroforestali 1 1 1 1 1<br />
30 311 Boschi di latifoglie 0 0 0 0 0<br />
31 312 Boschi di conifere 0 0 0 0 0<br />
32 313 Boschi misti di conifere e latifoglie 0 0 0 0 0<br />
33 321 Pascolo naturale e praterie 2 1 1 1 1<br />
34 322 Brughiere e cespuglieti 0 0 0 0 0<br />
35 323 Vegetazione sclerofilla 0 0 0 0 0<br />
36 324 Vegetazione boschiva ed arbustiva in evol. 0 0 0 0 0<br />
37 331 Spiagge, dune e sabbie 3 3 3 3 3<br />
38 332 Rocce nude, falesie, rupi affioramenti 0 0 0 0 0<br />
39 333 Aree con vegetazione rada 0 0 0 0 0<br />
40 3331 Cesse parafuoco 0 0 0 0 0<br />
41 334 Aree percorse da incendio 0 0 0 0 0<br />
42 411 Paludi interne 3 3 3 3 3<br />
43 421 Paludi salmastre 3 3 3 3 3<br />
44 422 Saline 5 5 5 5 5<br />
45 423 Zone intertidali 3 3 3 3 3<br />
46 511 Corsi d'acqua, canali e idrovie 0 0 0 0 0<br />
47 512 Specchi d'acqua 0 0 0 0 0<br />
48 5124 Acquacoltura 0 0 0 0 0<br />
49 521 Lagune 0 0 0 0 0<br />
50 523 Mare 0 0 0 0 0<br />
Tab.1 - Categoria uso del suolo con valori di impatto.<br />
Area di studio e software<br />
utilizzato<br />
L’ area di studio è la Regione<br />
Toscana. Il territorio toscano<br />
è per la maggior parte collinare<br />
66,5%, comprende anche<br />
zone di pianura (circa l’8,4%)<br />
e importanti massicci montuosi<br />
(25,1%) (Regione Toscana<br />
2012).<br />
Per la produzione della cartografia<br />
oggetto dello studio<br />
è stato utilizzato un software<br />
GIS, nello specifico ArcGIS<br />
10.2 di ESRI. Il GIS comprende<br />
una serie di strumenti<br />
software per acquisire, memorizzare,<br />
estrarre, trasformare<br />
e visualizzare dati spaziali dal<br />
mondo reale (Burrough 1986).<br />
Si basa su un DBMS (Data<br />
Base Management System)<br />
spaziale che è capace di gestire<br />
le posizioni degli elementi sul<br />
territorio poiché sono associate<br />
all’informazione geografica oltre<br />
che all’informazione testuale<br />
e numerica.<br />
Produzione della mappa di<br />
impatto potenziale<br />
Dal portale cartografico della<br />
Regione Toscana Geoscopio<br />
(www.regione.toscana.it/<br />
geoscopio) è stato scaricato<br />
l’open data geografico vettoriale<br />
“ucs2013”, che contiene<br />
l’uso e la copertura del suolo<br />
realizzato analizzando le foto<br />
aeree raccolte nel 2013. Tale<br />
file risulta il più aggiornato, in<br />
quanto prodotto dalla Regione<br />
Toscana nel 2015, ed è in formato<br />
vettoriale poligonale, versione<br />
shape file. Il file vettoriale<br />
contiene diversi campi (fields),<br />
il campo che descrive i valori<br />
delle 50 categorie dell’uso del<br />
suolo è ucs2013. Le categorie<br />
sono basate sui tre livelli del<br />
Corine Land Cover (European<br />
Environment Agency 2000),<br />
per alcune di esse la Regione<br />
Toscana ha prodotto un quarto<br />
livello. Sempre dal portale<br />
Geoscopio è stato scaricato il<br />
file poligonale vettoriale con<br />
i confini amministrativi delle<br />
province toscane, è stato quindi<br />
creato un nuovo file nel<br />
quale sono state unite quelle<br />
di Firenze e Prato, essendo da<br />
un punto di vista gestionale un<br />
unico comprensorio omogeneo.<br />
Con la funzione GIS clip l’uso<br />
del suolo regionale è stato suddiviso<br />
nei 9 comprensori del<br />
<strong>GEOmedia</strong> n°6-<strong>2016</strong> 29
REPORT<br />
Livello di impatto Categorie Superficie (ha)<br />
0 Nullo 118.154<br />
1 Irrilevante 2.507<br />
2 Aree coltivate, impatto scarso 14.937<br />
3 Aree coltivate aperte, impatto probabile 16.661<br />
4 Aree coltivate di pregio, impatto molto probabile 4.329<br />
5 Aree urbane e similari, impatto certo 20.774<br />
Tab.2 - Tabella categoria uso del suolo con valori di impatto.<br />
territorio regionale: Firenze e<br />
Prato, Arezzo, Grosseto, Livorno,<br />
Lucca, Massa Carrara, Pisa,<br />
Pistoia, Siena.<br />
È stata poi creata una tabella,<br />
denominata Tabella di Impatto<br />
(Tab. 1), con cinque colonne,<br />
una per ogni specie di ungulati<br />
presente in Toscana, e 50 righe,<br />
una per ogni categoria dell’uso<br />
del suolo. Per ogni categoria di<br />
uso del suolo sono stati assegnati<br />
nella tabella suddetta dei<br />
valori che vanno da 0 (impatto<br />
nullo) a 5 (impatto certo), differenziato<br />
a seconda della specie<br />
ungulata. In sintesi i valori<br />
degli impatti sono stati suddivisi<br />
nelle seguenti categorie:<br />
• 5: aree urbane e similari<br />
(impatto certo)<br />
• 4: aree coltivate di pregio<br />
(impatto molto probabile)<br />
• 3: aree coltivate (aperte)<br />
Fig. 2 - Mappa di impatto in formato raster. Esempio per il capriolo nel comprensorio di Lucca<br />
dove l’impatto è possibile<br />
• 2: aree coltivate dove<br />
l’impatto è scarso<br />
• 1: impatto non rilevante<br />
• 0: impatto da considerarsi<br />
nullo<br />
Le prime elaborazioni per arrivare<br />
a definire delle mappe<br />
di impatto potenziale hanno<br />
riguardato operazioni di geoprocessing,<br />
in particolare con la<br />
funzione join field è stata agganciata<br />
la Tabella di Impatto<br />
contenente i valori di impatto<br />
potenziale, ad ogni file vettoriale<br />
poligonale di uso del suolo,<br />
a livello di comprensorio.<br />
Come risultato è stato prodotto<br />
un file poligonale vettoriale<br />
per ogni comprensorio similare<br />
a ucs2013, con la presenza dei<br />
5 campi in più derivanti dalla<br />
tabella (5 impatto certo, 0<br />
impatto nullo), uno per ogni<br />
specie ungulata. Il primo file<br />
creato (vettoriale poligonale,<br />
per ogni comprensorio) è stato<br />
nominato ucs_nomecomprensorio.<br />
Agendo sulla simbologia<br />
è possibile, utilizzando la<br />
classificazione di impatto nei<br />
campi di ogni specie ungulata,<br />
visualizzare facilmente l’impatto<br />
potenziale di ciascuna<br />
specie a livello di comprensorio.<br />
Successivamente sono stati<br />
creati dei file in formato raster,<br />
mediante la funzione convert<br />
polygon to raster, che facilitasse<br />
l’analisi e la lettura (Fig. 1).<br />
Questi file raster hanno celle di<br />
dimensioni 10 m x 10 m, contenenti<br />
i valori di impatto potenziale<br />
per ogni specie ungulata<br />
del file poligonale vettoriale<br />
riferita ad ogni singola cella. Il<br />
30 <strong>GEOmedia</strong> n°6-<strong>2016</strong>
REPORT<br />
Sup. Tot. (ha) Sup. Agro-forestale Sup. Intervento Liv. impatto Sup. % Sup. ha<br />
177.363 152.815 86.136 0 14 12.059<br />
1 3 2.584<br />
2 8 6.891<br />
3 35 30.148<br />
4 11 9.475<br />
5 29 24.979<br />
Tab.3 - Tabella superfici per il controllo del cinghiale per ogni livello di impatto.<br />
seguito quanto prodotto per la<br />
specie cinghiale e capriolo.<br />
Selezionando da ucs_nomecomprensorio<br />
i poligoni aventi impatto<br />
più elevato per il cinghiale<br />
(cioè 3-4-5 rispettivamente<br />
seminativi in aree aperte, aree<br />
con colture pregiate, aree urbane)<br />
è stato elaborato un ultefile<br />
è stato prodotto per ogni<br />
specie e per ogni comprensorio,<br />
ed è stato nominato usosuolospecie_comprensorio.<br />
Analizzando la mappa del comprensorio<br />
di Lucca presa come<br />
esempio del lavoro svolto a<br />
scala regionale, è evidente l’impatto<br />
potenziale del cinghiale<br />
maggiormente significativo<br />
nelle aree urbane (ad est Lucca<br />
ed a ovest la Versilia) e nelle<br />
aree agricole di pianura e della<br />
Valle del Serchio. Nella Tabella<br />
2 si riporta l’esempio del<br />
Comprensorio di Lucca. Dalla<br />
tabella si evincono i dati relativi<br />
alle superfici (ha) in relazione<br />
ai diversi livelli di impatto e<br />
alle diverse categorie.<br />
Medesima operazione è stata<br />
svolta per le altre quattro<br />
specie di ungulati per i nove<br />
compresori gestionali. A titolo<br />
di esempio si riporta la<br />
mappa di impatto potenziale<br />
del capriolo nel comprensorio<br />
lucchese. Queste mappe sono<br />
di fondamentale importanza<br />
per la definizione delle aree<br />
problematiche (dette anche<br />
non vocate) agli ungulati, così<br />
come previste da ISPRA.<br />
riore file vettoriale poligonale.<br />
Questo ha consentito di individuare<br />
esclusivamente le zone<br />
dove il cinghiale ha un impatto<br />
significativo. Sono stati eliminati<br />
i poligoni con codice strade<br />
e strade in ambiente boscato<br />
(codici 122 e 1221) e quelli<br />
aventi superficie inferiore ad<br />
Produzione delle mappe<br />
per il controllo art. 19<br />
L.N. 157/92<br />
Successivamente è stato creato<br />
un file per rappresentare le aree<br />
dove è più importante svolgere<br />
il controllo delle specie ai<br />
sensi dell’art. 19 L.N.157/92,<br />
per contenerne il numero. Di<br />
Fig. 3 - Aree da sottoporre al controllo ai sensi dell’art. 19 L.N. 157/92. Esempio per il cinghiale<br />
comprensorio di Lucca.<br />
<strong>GEOmedia</strong> n°6-<strong>2016</strong> 31
REPORT<br />
Sup. Tot. (ha) Sup. Agro-forestale Sup. Intervento Liv. impatto Sup. % Sup. ha<br />
177.363 152.815 63.964 0 12 7.676<br />
1 4 2.529<br />
2 7 4.477<br />
3 15 9.595<br />
4 24 15.351<br />
5 38 24.306<br />
Tab. 4 - Tabella superfici per il controllo del capriolo per ogni livello di impatto.<br />
un ettaro. A questo punto, per<br />
i restanti poligoni è stata utilizzata<br />
la funzione buffer, che ha<br />
permesso di creare un contorno<br />
(buffer zone) di 300 metri dagli<br />
stessi. Infine con la funzione<br />
dissolve sono stati uniti i precedenti<br />
buffer in un unico file.<br />
Il file prodotto per ogni comprensorio<br />
è stato denominato<br />
comprensorio_ctrcinghiale.<br />
Da qui si nota che le aree di<br />
Fig. 4 - Aree da sottoporre al controllo ai<br />
sensi dell’art. 19 L.N. 157/92. Esempio per il<br />
capriolo comprensorio di Lucca.<br />
intervento per il controllo del<br />
cinghiale si sovrappongono alle<br />
zone dove il rischio di impatto<br />
è maggiore. Nella Tabella 3<br />
le superfici di riferimento per<br />
ogni livello di impatto.<br />
Per il capriolo, Selezionando<br />
dal file dell’uso del suolo<br />
ucs_nomecomprensorio i poligoni<br />
aventi impatto 4-5 per la<br />
specie (in sintesi aree urbane,<br />
aree con colture pregiate come<br />
vivai o vigneti) è stato elaborato<br />
un ulteriore file vettoriale<br />
poligonale, con ben individuate<br />
le aree a maggiore impatto. Da<br />
questo file sono stati poi eliminati<br />
i poligoni con codice strade<br />
e strade in ambiente boscato<br />
(122 e 1221) e quelli aventi superficie<br />
inferiore ad un ettaro.<br />
Per i restanti è stata utilizzata la<br />
funzione buffer, che ha permesso<br />
di creare un contorno di 300<br />
metri dai poligoni. Infine con<br />
la funzione dissolve sono stati<br />
uniti i precedenti buffer in un<br />
unico file. Il risultato è un file<br />
comprensorio_ctrcapriolo dove è<br />
possibile visualizzare l’area sovrapposta<br />
alla mappa di impatto<br />
potenziale del capriolo.<br />
E’ possibile verificare che l’area<br />
è diversa e inferiore rispetto a<br />
quella del cinghiale (Tabella<br />
4) che si concentra nelle aree<br />
urbane e nelle colture di pregio<br />
e non considera i seminativi.<br />
In tutti e due i casi è evidente,<br />
confrontando gli ettaraggi, che<br />
le aree da sottoporre agli interventi<br />
di controllo sono solo<br />
una parte di tutta la superficie<br />
del comprensorio.<br />
La verifica delle mappe:<br />
danni della specie georiferiti<br />
sovrapposti alla mappa<br />
di impatto<br />
Una volta prodotte le mappe<br />
di impatto, vi era la necessità<br />
di una verifica delle stesse. Per<br />
questo sono stati raccolti e georiferiti<br />
i dati sui danni periziati<br />
degli ungulati all’agricoltura in<br />
possesso di Province e Ambiti<br />
32 <strong>GEOmedia</strong> n°6-<strong>2016</strong>
REPORT<br />
Fig.5 - Danni accertati georiferiti e mappe di<br />
impatto. Esempio per il cinghiale comprensorio<br />
di Lucca dal 2011 al 2015.<br />
BIBLIOGRAFIA<br />
Banti, P., Nuti, S., Ponzetta, M.P. & Sorbetti<br />
Guerri, F. (2009), Gli incidenti stradali causati<br />
dalla fauna selvatica nella Regione Toscana. Analisi<br />
del fenomeno nel periodo 2001-2008. Ed. Centro<br />
stampa Giunta Regionale Toscana.<br />
Burrough, P. A. (1986), Principles of Geographic<br />
Information Systems for Land Resource Assessment.<br />
Monographs on Soil and Resources Survey No.<br />
12, Oxford Science Publications, New York.<br />
European Environment Agency (2000),<br />
CORINE Land Cover, Technical Guidelines.<br />
Technical Addendum 2000<br />
Raganella Pelliccioni, E., Riga, F. & Toso, S.<br />
(2013), Linee guida per la gestione degli Ungulati.<br />
Manuali e Linee Guida ISPRA 91/2013<br />
(Retrieved: 01.09.<strong>2016</strong>)<br />
http://www.isprambiente.gov.it/files/<br />
pubblicazioni/manuali-lineeguida/<br />
MLG_91_2013.pdf<br />
(Retrieved: 01.09.<strong>2016</strong>)<br />
Regione Toscana (2012), Piano Regionale Agricolo<br />
Forestale 2012-2015. Regione Toscana<br />
http://www.regione.toscana.it/cittadini/<br />
alimentazione<br />
(Retrieved: 01.09.<strong>2016</strong>)<br />
Riga, F., Genghini, M., Cascone, C. & Di<br />
Luzio, P. (2011), Impatto degli Ungulati sulle<br />
colture agricole e forestali: proposta per linee<br />
guida nazionali. Manuali e Linee guida ISPRA<br />
68/2011.<br />
http://www.isprambiente.gov.it/files/<br />
pubblicazioni/manuali-lineeguida/10673_<br />
MLG_68_2011.pdf<br />
(Retrieved: 01.09.<strong>2016</strong>)<br />
Territoriali di Caccia (ATC).<br />
I danni accertati non sono stati<br />
inseriti come parametro diretto<br />
per la realizzazione delle mappe<br />
di rischio di impatto, poiché<br />
il dato non copre del tutto il<br />
territorio regionale ma solo<br />
una porzione di esso: i danni<br />
infatti non sono accertati nelle<br />
aree protette (20-30% del<br />
territorio) e negli istituti faunistici<br />
privati (massimo 15% del<br />
territorio) e i danni accertati<br />
non sono tutti i danni effettivi<br />
(possono essere richiesti solo<br />
dalle Aziende Agricole munite<br />
di Partita IVA). Sono stati<br />
sovrapposti i danni georeferenziati<br />
con la mappa di rischio di<br />
impatto per ciascuna specie: si<br />
ottiene una mappa che dimostra<br />
come la quasi totalità dei<br />
danni si concentrino nelle aree<br />
a massimo rischio di impatto.<br />
Il risultato, per il comprensorio<br />
di Lucca riferito ai danni del<br />
cinghiale, è visibile nella Figura 5.<br />
Le mappe di impatto degli<br />
ungulati sono degli strumenti<br />
fondamentali per definire le<br />
aree non vocate/problematiche,<br />
dove seguire una gestione<br />
non conservativa delle specie<br />
ungulate. E’ possibile inoltre<br />
raffinare questa analisi individuando<br />
le porzioni di territorio<br />
dove effettuare le operazioni di<br />
controllo ai sensi dell’art. 19<br />
L.N. 157/92.<br />
PAROLE CHIAVE<br />
GIS; gestione del rischio; pianificazione<br />
faunistica; area non vocata; interventi di<br />
controllo<br />
ABSTRACT<br />
Wild ungulates are widespread in almost all of the<br />
Italian peninsula. Their presence creates critical<br />
both to agricultural crops than to human structures.<br />
Proper wildlife territory planning can mitigate<br />
the problems present today. GIS tools can help<br />
in this process. It is possible through repeatable and<br />
objective measurable data to produce maps of potential<br />
impact of wild ungulates and guide management<br />
decisions through them. The study has<br />
produced maps of potential impact in the Tuscany<br />
territory for species: wild boar, roe deer, red deer,<br />
fallow deer and mouflon. The study also identified<br />
areas where operate through containment strategies<br />
provided by national legislation.<br />
AUTORE<br />
Dott. Alessandro Giugni<br />
giugni.alessandro7@gmail.com<br />
Dott. Marco Ferretti<br />
marco.ferretti@regione.toscana.it<br />
Regione Toscana<br />
Dott. Leonardo Conti<br />
leonardo.conti@unifi.it<br />
GESAAF Università degli Studi di Firenze<br />
<strong>GEOmedia</strong> n°6-<strong>2016</strong> 33
GUEST PAPER<br />
A Digital “New World”<br />
The Big Fusion between Ubiquitous Localization<br />
(GNSS), Sensing (IOT) and Communications (5G)<br />
by Marco Lisi<br />
La grande fusione fra<br />
servizi di localizzazione<br />
(GNSS), monitoraggio<br />
remoto (IoT) e<br />
comunicazione (5G).<br />
Fig. 1 - GNSS Multi-Constellation Scenario.<br />
We are at the dawn of<br />
the discovery of a<br />
“New World”: not<br />
a virtual one, but the digital<br />
representation, in all its minute<br />
details, of our physical world, of<br />
planet Earth.<br />
This epochal transition in the<br />
history of mankind is being<br />
triggered by three main technological<br />
trends:<br />
4Ubiquitous Localization and<br />
Timing: Global Navigation<br />
Satellite Systems and other<br />
similar Positioning, Navigation<br />
and Timing (PNT)<br />
infrastructures make possible<br />
a very accurate localization in<br />
space and time of both people<br />
and things;<br />
4Ubiquitous Sensing: from 1<br />
to 10 trillion sensors will be<br />
connected to Internet in the<br />
next decade (a minimum of<br />
140 sensors for every human<br />
being on the planet);<br />
4Ubiquitous Connectivity:<br />
2.3 billion mobile broadband<br />
devices and 7 billion mobile<br />
cellular device in 2014. In the<br />
next years 5G will dramatically<br />
increase both connectivity<br />
and data rates.<br />
Enormous amounts of data are<br />
being collected daily and at an<br />
exponentially increasing rate.<br />
99% of them is digitized and<br />
50% has an associated IP address.<br />
Fig. 2 - the global PNT<br />
infrastructure.<br />
We are practically going for a<br />
detailed digital mapping of the<br />
world around us. It is an entirely<br />
New World we are facing,<br />
but we have not learnt yet how<br />
to navigate and explore it.<br />
Ubiquitous Localization<br />
and Timing<br />
Global Navigation Satellite<br />
Systems, such as GPS, GLO-<br />
NASS, Galileo and Beidou,<br />
constitute together a potentially<br />
34 <strong>GEOmedia</strong> n°6-2015
GUEST PAPER<br />
Fig. 3 - IoT impacts on business and society.<br />
Data deriving from different<br />
systems and platforms will<br />
be seamlessly “fused” at user<br />
receiver level, guaranteeing a<br />
high degree of availability and<br />
continuity.<br />
interoperable and coordinated<br />
infrastructure, supporting in a<br />
vital way most industrial and<br />
economic aspects of our society<br />
(fig. 1).<br />
Fig. 4 - 5G infrastructure architecture.<br />
GPS in particular is nowadays<br />
considered a worldwide utility,<br />
tightly interconnected with all<br />
other critical infrastructures,<br />
from electric power distribution<br />
systems to air traffic management<br />
systems, from railways to<br />
water and oil piping networks.<br />
In the mind of the average user<br />
(but also in that of many engineers)<br />
the main contribution<br />
of GNSS’s, their true “raison<br />
d’être”, is in providing one’s accurate<br />
position and in allowing<br />
a reliable navigation, be it by<br />
car, by airplane, by train or by<br />
boat.<br />
Precise timing is understood,<br />
at least by engineers, as an enabling<br />
feature of GNSS’s and a<br />
very useful by-product, after<br />
positioning and navigation.<br />
The reality, as shown by studies<br />
performed e.g. by the US Department<br />
of Homeland Security<br />
(DHS), is that in fact timing<br />
is the most strategic and essential<br />
of the services offered by<br />
GNSS’s, and the one most affecting<br />
all critical infrastructures<br />
of our society.<br />
Non-GNSS PNT systems and<br />
technologies are also being developed<br />
worldwide.<br />
In the not so far future, a PNT<br />
system of systems, including<br />
GNSS and non-GNSS infrastructures,<br />
is likely to take place,<br />
while, at user receiver level, a<br />
fusion of data from GNSS and<br />
other sensors (such as inertial<br />
platforms, Wi-Fi, GSM, signals<br />
of opportunity, etc.) will become<br />
normal practice (fig. 2).<br />
Ubiquitous Sensing<br />
(Internet of Things)<br />
The Internet of Things (IoT)<br />
envisions many billions of<br />
Internet-connected objects<br />
(ICOs) or “things” that can<br />
sense, communicate, compute,<br />
and potentially actuate, as well<br />
as have intelligence, multimodal<br />
interfaces, physical/virtual identities,<br />
and attributes.<br />
The IoT is likely to revolutionize<br />
all aspects of our society and<br />
daily life (fig. 3).<br />
Its exponential growth will actually<br />
imply the practical feasibility<br />
of an Ubiquitous Sensing:<br />
from 1 to 10 trillion sensors will<br />
be connected to Internet in the<br />
next decade (a minimum of 140<br />
sensors for every human being<br />
on the planet).<br />
Ubiquitous sensing, or ubiquitous<br />
“geo”-sensing to emphasize<br />
the spatial dimension, as deriving<br />
from IoT and from mobile<br />
broadband communications,<br />
will mean that we will be able<br />
to probe, even in real time,<br />
the phenomena around us, the<br />
surrounding reality, with capabilities<br />
far beyond those made<br />
so far available by our senses.<br />
Enormous amounts of data will<br />
be available for our analyses, all<br />
of them referenced in space and<br />
time.<br />
Ubiquitous<br />
Connectivity (5G)<br />
5G, the forth coming wave in<br />
mobile communications, will<br />
realize a quantum leap towards<br />
the goal of ubiquitous connectivity<br />
(fig. 4).<br />
As a matter of fact, 5G will not<br />
simply extend in a linear way<br />
the capabilities of the previous<br />
<strong>GEOmedia</strong> n°6-2015 35
GUEST PAPER<br />
Fig. 5 - 5G and the Internet of Things.<br />
Fig. 6 - 16th century plan of the City of London<br />
four generations of mobile<br />
networks. Its dramatically enhanced<br />
performance in terms<br />
of flexibility and throughput<br />
will make fully feasible those<br />
“smart” applications and infrastructures<br />
that require networking,<br />
high data rates, real time<br />
processing.<br />
It is evident how 5G will become<br />
the natural complement of<br />
the IoT, its technological enabler<br />
(fig. 5).<br />
A new perception<br />
of the world<br />
An example will make clear the<br />
potentialities deriving from the<br />
fusion of ubiquitous localization<br />
and timing, sensing and<br />
connectivity.<br />
Fig. 7 - City of London aerial view.<br />
Figure 6 shows a plan of the<br />
City of London in the time of<br />
Queen Elizabeth (16th century).<br />
Public (e.g. the London<br />
Tower) and private buildings<br />
are clearly identifiable, as well as<br />
London Bridge and the banks<br />
of the Thames river. Fairly detailed<br />
and useful for its time.<br />
Figure 7 offers a far more detailed<br />
view of approximately the<br />
same area, as made available<br />
by Google Earth. The picture<br />
is fairly detailed and can enriched<br />
with street names, labels,<br />
photos, etc. Let us now imagine<br />
to be able to link and merge<br />
almost in real time all the information<br />
coming from thousands<br />
(if not millions) of sensors spread<br />
over the area (fig. 8).<br />
What we will get is a sort of<br />
“Augmented Reality” representation<br />
of the same geographical<br />
site, through which we might<br />
be able this time to exercise<br />
most of our senses: smell the<br />
clean waters of the river Thames,<br />
feel the slightly chilly wind<br />
along the banks, hear the sounds<br />
and calls of the six (or nine?)<br />
legendary ravens living at the<br />
Tower of London.<br />
The role of satellites in the<br />
“Digital New World”<br />
Satellites are going to play an<br />
important (in some cases primary)<br />
role in this new scenario.<br />
In terms of localization and<br />
timing, GNSSs presently (and<br />
most likely also in the years to<br />
come) are the backbone of a<br />
worldwide PNT infrastructure,<br />
also including alternative<br />
ground-based systems (such as<br />
eLoran) as well as stand-alone<br />
technologies (miniaturized<br />
inertial platforms and atomic<br />
clocks). As far as sensing is<br />
concerned, despite the enormous<br />
amount of sensors being<br />
integrated in smartphones and<br />
other portable devices, Earth<br />
observation will keep depending<br />
heavily on satellites of various<br />
complexity (down to nano<br />
and pico satellites) and with<br />
a variety of embarked sensors<br />
(multi spectral optical, radiometers,<br />
altimeters, SARs).<br />
36 <strong>GEOmedia</strong> n°6-2015
REPORT<br />
moving towards an integration<br />
of PNT, Remote Sensing and<br />
Telecommunications systems leading<br />
to a worldwide, system of<br />
systems infrastructure (fig. 9).<br />
Fig. 8 - An “Augmented Reality” evolution through data fusion<br />
In the area of telecommunications,<br />
notwithstanding the<br />
exponential development of<br />
mobile cellular networks, both<br />
in terms of data rates and coverage,<br />
satellites remain the<br />
primary solution to guarantee<br />
services over the oceans and to<br />
provide an affordable last-mile<br />
connections to users in scarcely<br />
populated areas.<br />
Moreover, satellite networks,<br />
both for trunk and mobile<br />
communications, are the natural<br />
back-up for terrestrial<br />
networks, improving the overall<br />
resilience, security and availability<br />
of the world telecommunications<br />
infrastructure.<br />
Satellite and terrestrial system<br />
integration, already being experimented<br />
with 4G mobile cellular<br />
communications systems,<br />
is high priority in the agenda of<br />
the coming 5G network, with<br />
the clear purpose of achieving<br />
a truly ubiquitous coverage.<br />
This integration will require the<br />
development of interoperability<br />
standards to make the two sectors<br />
interconnect efficiently and<br />
reliably, both at network and at<br />
IP levels.<br />
In conclusion, we are rapidly<br />
Conclusion<br />
Ubiquitous Localization and<br />
Timing, Ubiquitous Sensing,<br />
Ubiquitous Connectivity: these<br />
three main technological trends<br />
are triggering an epochal transition<br />
in the history of mankind.<br />
We are practically going for a<br />
detailed digital mapping of the<br />
world around us, for an evolution<br />
of reality as we can sense<br />
it today towards an enriched,<br />
augmented reality.<br />
It is an entirely New World<br />
we are facing, but we have not<br />
learnt yet how to navigate and<br />
explore it.<br />
The future asks for an ever<br />
closer integration and fusion of<br />
Telecommunications, Sensing<br />
and Positioning, Navigation<br />
and Timing applications.<br />
KEYWORDS<br />
GNSS; PNT; IoT; communication; infrastructure;<br />
networks; precise timing<br />
ABSTRACT<br />
La grande fusione fra servizi di localizzazione (GNSS), monitoraggio<br />
remoto (IoT) e comunicazione (5G). Un “Nuovo<br />
Mondo” digitale si profila all’orizzonte: le tecnologie sono<br />
sempre più onnipresenti nella nostra vita quotidiana e termini<br />
come geolocalizzazione, Internet of Things (IoT), connettività,<br />
sensori, GPS, GNSS o rappresentazione digitale sono ormai<br />
conosciuti anche ai non addetti ai lavori. Il mondo dell’industria<br />
è sempre più basato è devoto ai sistemi di posizionamento satellitare<br />
e sulla misura del tempo. I principali trend tecnologici del<br />
momento come il GNSS e altre infrastrutture PNT, l’Internet<br />
delle Cose e la connettività (5G) cambieranno drasticamente<br />
la nostra vita quotidiana; l’integrazione fra queste infrastrutture<br />
(GNSS, IoT e connettività) giocherà un ruolo fondamentale per<br />
la realizzazione del “Nuovo Mondo” digitale.<br />
AUTHOR<br />
Marco Lisi<br />
marco.lisi@esa.int<br />
Responsabile dei Servizi GNSS<br />
(Agenzia Spaziale Europea)<br />
Fig. 9 - Worldwide systems of systems infrastructure.<br />
<strong>GEOmedia</strong> n°6-<strong>2016</strong> 37
REPORT<br />
UNICUIQUE SUUM<br />
di Attilio Selvini<br />
Fig. 1 - A sinistra, DGK 5N; a destra DGK 5G.<br />
In un momento in cui i GIS e i servizi basati sui dati geospaziali<br />
sono sempre più richiesti, l'autore riflette sull'effettiva validità<br />
dell'informatica applicata alla cartografia e sulla massa di dati<br />
prodotti dagli uffici regionali che, talvolta, vengono utilizzati solo<br />
in minima parte.<br />
Ancora una volta debbo<br />
scomodare Cicerone. Il<br />
titolo di questa breve<br />
nota riprende un aforisma<br />
romano che si rifà al grande<br />
senatore: («Iustitia ... suum<br />
cuique distribuit», De nat. deor.<br />
III, 15) ma che qui assume ben<br />
altro significato.<br />
Mi riferisco ancora all’intervista<br />
che il Direttore di<br />
<strong>GEOmedia</strong> ha fatto all’amico e<br />
collega Mattia Crespi, ordinario<br />
alla Sapienza (1) nella quale<br />
si fa notare come in Italia,<br />
esempio unico in Europa, vi<br />
siano non solo cinque organi<br />
cartografici dello Stato, bensì<br />
una ulteriore miriade di organi<br />
e organucci locali che<br />
decidono come e qualmente<br />
procurarsi cartografia (scusate:<br />
“database” topocartografici),<br />
salvo poi, come dice ancora il<br />
Direttore in uno degli ultimi<br />
“GeoForUs” (2), non essere<br />
nemmeno in grado di farne<br />
trovare traccia.<br />
A quanto pare, in tema cartografico,<br />
il detto ciceroniano<br />
“a ciascuno il suo” va inteso<br />
come segue: ogni ente, dal<br />
piccolo comune alla grande<br />
regione, faccia quello che<br />
vuole; a scapito dell’economia<br />
ma prima di tutto della razionalità:<br />
tanto, paga Pantalone.<br />
Al solito debbo ricordare la<br />
carta fondamentale tedesca, la<br />
“DGK 5”, per la quale vi sono<br />
norme severe e uniche per tutti<br />
i “Länder”, con l’eccezione dei<br />
territori ex-DDR nei quali la<br />
scala nominale, per motivi di<br />
tempestività, venne ridotta all’<br />
1: 10000. Il sistema di riferimento<br />
è unico: ATKIS, ovvero<br />
Amtliches Topographisch-<br />
Kartographisches<br />
InformationsSysteme, in<br />
italiano Sistema informativo<br />
topocartografico<br />
ufficiale. Le versioni<br />
della carta sono quattro:<br />
la prima è quella<br />
ordinaria (DGK<br />
5N); la seconda è<br />
la rappresentazione<br />
tridimensionale del<br />
suolo ma senza curve<br />
di livello (DGK<br />
5G). La terza è la<br />
nota rappresentazione<br />
ortofotografica<br />
(DGK 5 L) e infine<br />
l’ultima è la carta d’uso<br />
del suolo (DGK 5 Bo).<br />
Se ne vedono, in ordine,<br />
le relative immagini qui a<br />
fianco.<br />
Ancora negli anni novanta del<br />
secolo ventesimo, da noi si<br />
produceva cartografia tecnica<br />
per restituzione analitica; qualcuno<br />
usava anche strumenti<br />
analogici provvisti di motori<br />
“passo-passo”, mentre si affacciava<br />
sul mercato la restituzione<br />
digitale. E di cartografia numerica<br />
se ne produsse tanta nel<br />
decennio di fine del Duemila,<br />
così come ancora in quello<br />
successivo. Basti pensare a titolo<br />
esemplificativo alla grande<br />
carta numerica di Milano alla<br />
scala nominale di 1:1000, fra<br />
i cui collaudatori vi è anche<br />
chi scrive. Tutta questa cartografia<br />
aveva rappresentazione<br />
su diversi “livelli”, per cui era<br />
immediato separare (e se del<br />
caso proiettare su carta) il reticolo<br />
stradale, oppure le acque<br />
superficiali, o ancora la sola<br />
vegetazione, la sola altimetria a<br />
curve di livello, i soli edifici e<br />
così via, a seconda delle necessità<br />
dell’ente utilizzatore della<br />
cartografia stessa.<br />
Ma nel frattempo si diffonde-<br />
38 <strong>GEOmedia</strong> n°6-<strong>2016</strong>
REPORT<br />
va il concetto di “database”:<br />
DB in sigla, ovviamente e<br />
secondo la mania imperante<br />
di sottomettersi all’inglese,<br />
dimenticando l’espressione<br />
più corretta nella nostra lingua<br />
madre, che parla di “banca dei<br />
dati”. Proprio nell’ultimo decennio<br />
appena sopra ricordato,<br />
chi scrive fu relatore di una<br />
tesi di laurea in architettura,<br />
che aveva appunto per tema la<br />
proposta di un “database” per il<br />
comune milanese. In un articolo<br />
di alcuni anni fa (3), avevo<br />
messo in guardia sulla ormai<br />
certa prevalenza (o prevaricazione)<br />
dell’informatica sulla topografia;<br />
ciò si è puntualmente<br />
verificato. Scrivevo allora:<br />
“l’informatica ha inizialmente<br />
tarpato le ali a molti topografi<br />
tradizionali, ed ha per contro<br />
promosso topografi e cartografi<br />
molte persone provenienti da altri<br />
tipi di studi, che lentamente<br />
ma inesorabilmente stanno trasformando<br />
la cartografia in una<br />
valanga di dati informatici di<br />
assai dubbio valore.<br />
Se si leggono le voluminose<br />
prescrizioni sui DB topografici<br />
di alcune regioni italiane, ci<br />
si stupisce per la massa di dati<br />
richiesti, per la minuzia con cui<br />
si chiede di estrarne le cose più<br />
o meno minime e utili, per la<br />
possibilità richiesta di ricavarne<br />
estratti alle scale più varie.<br />
Scrivevo ancora, nella “lettera<br />
aperta” citata: “So di molte e<br />
serie aziende di cartografia, che<br />
vacillano sotto il peso di imposizioni<br />
informatiche con altrettanti<br />
programmi elaborativi, di cui<br />
in buona parte si potrebbe fare<br />
a meno. Purtroppo ciò a scapito<br />
della leggibilità delle carte e<br />
soprattutto della loro bo-ntà (dovrei<br />
dire correttamente “incertezza”)<br />
metrica, sulla quale spesso<br />
enti committenti e collaudatori<br />
sorvolano facilmente.” Come<br />
non ripetermi ora?<br />
Ho chiesto, alla maggiore<br />
Fig. 2 - A sinistra, DGK 5L, a destra DGK 5Bo.<br />
azienda italiana di rilevamento<br />
e rappresentazione, la CGR<br />
di Parma, e a un paio di altre<br />
imprese di media grandezza e<br />
di ottime capacità, di espormi<br />
quanto fanno in tema di cartografia<br />
tecnica. Le risposte<br />
concordi mi dicono che ormai<br />
quasi nessuna richiesta di cartografia<br />
numerica perviene<br />
loro dagli enti territoriali: solo<br />
DB topografici e naturalmente<br />
multiscala. La restituzione<br />
analitica è scomparsa: si fa<br />
solo restituzione digitale, con<br />
prevalenza di ortofoto. Sempre<br />
più richiesta la presa appoggiata<br />
a GPS e INS. I prezzi sono<br />
inadeguati, i tempi di collaudo<br />
addirittura improponibili! Le<br />
poche aziende sopravvissute ai<br />
bei tempi dell’ultimo scorcio<br />
di secolo tirano avanti con<br />
difficoltà, in mezzo alla selva<br />
di capitolati e bandi in genere<br />
diversi fra di loro.<br />
Ma a che cosa in realtà servono<br />
questi DB? Nella “lettera” rammentata,<br />
e mi spiace citarmi<br />
ma vi sono costretto, osservavo<br />
quanto segue: “Le carte comunali,<br />
insomma i “database”<br />
odierni, servono soprattutto alla<br />
redazione di quelli che erano<br />
sino a ieri i piani regolatori<br />
generali e che oggi si chiamano<br />
“piani di governo del territorio”.<br />
Oppure per progettare nuovi<br />
quartieri e nuove strade, sempre<br />
nell’ambito limitato dei comuni<br />
o delle comunità più o meno<br />
montane.<br />
Tertium non datur: le grandi<br />
strade ordinarie e ferrate, gli<br />
elettrodotti ed i gasdotti richiedono<br />
cartografia specifica, con<br />
rappresentazioni sia sul piano<br />
cartografico UTM o GB che sia<br />
(oggi meglio, su ETRF2000), sia<br />
sul piano medio locale (le cosiddette<br />
carte in “coordinate rettilinee<br />
locali” dei costruttori). Che<br />
poi gli attuali “database” permettano<br />
di trovare, sempre con le<br />
incertezze della scala nominale,<br />
la posizione dei chiusini, delle<br />
condutture di smaltimento o di<br />
adduzione; che permettano di<br />
individuare linee di marciapiede<br />
od isole pedonali; che possano<br />
dire al fisco locale chi abita in<br />
un certo edificio, è più materia<br />
di sistema informativo che di<br />
database.” E mi pare che non<br />
vi sia altro da aggiungere. Solo<br />
una riflessione: quante battaglie<br />
sono state condotte dal<br />
sessanta al settanta, per invitare<br />
i Comuni e poi le Regioni a<br />
provvedersi di cartografia tecnica!<br />
Vi erano allora enti che per<br />
procurarsi carte urbane non<br />
si peritavano di usare quelle<br />
catastali, sovrapponendovi alla<br />
bell’e meglio l’altimetria ricavata<br />
dalle “tavolette” IGM al<br />
venticinquemila! Quando arrivarono<br />
le prime carte comunali<br />
<strong>GEOmedia</strong> n°6-<strong>2016</strong> 39
REPORT<br />
aerofotogrammetriche, redatte<br />
per restituzione dagli strumenti<br />
analogici (quelli digitali si diffusero<br />
fra il settanta e l’ottanta)<br />
molti uffici tecnici gridarono<br />
alla meraviglia. Ero allora assessore<br />
all’urbanistica del mio<br />
comune di nascita e di residenza,<br />
ed ero stato io a presentare<br />
in consiglio la richiesta di un’asta<br />
pubblica per provvedere alla<br />
carta al 2000 dell’intero territorio,<br />
che comprendeva anche<br />
buona parte dell’aeroporto<br />
(non ancora intercontinentale)<br />
di Malpensa. La carta, redatta<br />
dalla IRTA milanese, una<br />
delle quattro aziende storiche<br />
italiane, e magistralmente collaudata<br />
da Mariano Cunietti,<br />
ordinario nel Politecnico di<br />
Milano e più oltre presidente<br />
della SIFET, venne immediatamente<br />
utilizzata con successo<br />
per la redazione del PRG.<br />
E altrettanto fecero molti<br />
comuni e consorzi sparsi per<br />
l’Italia. Le carte di quei tempi<br />
erano rigorosamente collaudate<br />
(4) non solo per il contenuto<br />
semantico, bensì anche per<br />
l’incertezza metrica in posizione<br />
e quota. E assolvevano<br />
egregiamente le necessità urbanistiche<br />
e progettuali locali.<br />
Trent’anni dopo, ogni ente ha<br />
dimenticato quei tempi felici,<br />
e smania per avere “database”<br />
talvolta illeggibili dagli stessi<br />
tecnici preposti al loro impiego.<br />
Valanghe di dati, al limite<br />
della comprensibilità, dei quali<br />
sono una minima parte viene<br />
di fatto utilizzata. Ma l’informatica<br />
deve prevalere!<br />
BIBLIOGRAFIA<br />
1) Carlucci, R. (2015), Un incontro con Mattia<br />
Crespi, docente di Geomatica alla Sapienza di<br />
Roma, in <strong>GEOmedia</strong>, n° 1, Roma.<br />
2) Carlucci, R. (2015), Mamma ho perso il<br />
DBGT della Calabria, in <strong>GEOmedia</strong>, n° 6<br />
Roma.<br />
3) Selvini, A. (2012) Lettera aperta ai topografi,<br />
in Il Seprio, n° 4, Varese.<br />
4) Cunietti, M. & Selvini, A. (1965) Il collaudo<br />
dei rilievi fotogrammetrici, in Boll. SIFET, n°<br />
3, Milano.<br />
PAROLE CHIAVE<br />
Cartografia; informatica; database; dati<br />
ABSTRACT<br />
The article is a reflection on the actual value<br />
of information technology applied to cartography.<br />
In particular, the author wonders<br />
how thousands of data can be really useful in<br />
as many databases which are difficult to understand<br />
to the same technicians who should<br />
have use them.<br />
AUTORE<br />
Attilio Selvini<br />
Attilio.selvini@gmail.com<br />
Politecnico di Milano<br />
40 <strong>GEOmedia</strong> n°6-<strong>2016</strong>
REPORT<br />
ArcGIS<br />
il WebGIS accessibile<br />
ovunque<br />
in ogni momento<br />
da ogni dispositivo<br />
www.esriitalia.it<br />
<strong>GEOmedia</strong> n°6-<strong>2016</strong> 41
MERCATO<br />
Tecnologie per la localizzazione indoor/<br />
outdoor sviluppate dal progetto Europeo<br />
i-locate<br />
Nel corso del triennio del progetto i-locate è stata<br />
sviluppata una tecnologia per la localizzazione indoor/<br />
outdoor mediante l’utilizzo di dispositivi Bluetooth,<br />
WiFi, GPS.<br />
ll progetto i-locate, giunto al termine del terzo anno,<br />
ha inoltre sviluppato un portale per la condivisione<br />
dei dati geografici aperti relativi a spazi indoor, quali,<br />
ad esempio, ospedali, centri commerciali, musei.<br />
Le tecnologie realizzate sono state applicate a diversi<br />
casi d’uso, tra i quali:<br />
4Sanitario, per guidare i pazienti sino alla struttura<br />
ospedaliera e all’interno dell’edificio stesso;<br />
4Servizi al cittadino, per guidare i cittadini verso gli<br />
uffici pubblici di interesse e all’interno dell’edificio<br />
stesso;<br />
4Gestione delle apparecchiature, per supportare<br />
i tecnici e gli operatori nell’individuazione delle<br />
apparecchiature all’interno di edifici.<br />
I siti pilota in Europa in cui sono state validate tali<br />
tecnologie, mediante il coinvolgimento degli utenti<br />
finali sono situati in: Rovereto (IT), Malta, Atene<br />
(GR), Alba Iulia (RO), Eindhoven (NL), Baia Sprie<br />
(RO), Dresden (DE), Rijeka (HR), Brasov (RO),<br />
Genova (IT), Lussemburgo, Sibiu (RO), Velletri (IT),<br />
Tremosine (IT).<br />
I risultati del progetto e in particolare di ciascun sito<br />
pilota sono stati presentati durante l’ultimo meeting<br />
di progetto che si è tenuto a Velletri (Italia) presso la<br />
Casa delle Culture e della Musica (ex Convento del<br />
Carmine) dal 2 al 4 Novembre <strong>2016</strong>.<br />
Durante l’evento si è inoltre tenuto un Exploitation<br />
Booster Workshop presieduto da Giovanni Zazzerini,<br />
esperto nominato dalla Commissione Europea, con lo<br />
scopo di aiutare il consorzio a sfruttare i risultati del<br />
progetto nel migliore dei modi.<br />
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito web di<br />
progetto: http://www.i-locate.eu<br />
http://www.epsilon-italia.it<br />
42 <strong>GEOmedia</strong> n°6-<strong>2016</strong>
MERCATO<br />
CUBE T: il nuovo software<br />
STONEX per rilievi a 360°<br />
Grazie alla partnership con Leonardo<br />
Software House, STONEX amplia<br />
la sua gamma di soluzioni per rilievi<br />
a 360 gradi dando vita a CUBE T, il<br />
nuovo e potente software per il rilievo<br />
integrato per Tablet Windows 8/10 con<br />
piena compatibilità con Leonardo XE.<br />
STONEX CUBE T unisce i vantaggi<br />
di un potente software per il rilievo ed<br />
i tracciamenti con GPS con un CAD<br />
Topografico.<br />
Rilievi GPS e software office in un<br />
un unica soluzione<br />
STONEX CUBE T, il nuovo software<br />
per Windowsrc PC, rappresenta l’unione<br />
tra un potente software CAD<br />
per il Mapping e la Topografia e un<br />
software per i rilievi ed i tracciamenti<br />
GPS/RTK.<br />
CUBE T consente di importare anche<br />
i dati provenienti dalle Stazioni Totali<br />
per la creazione di file di lavoro integrati.<br />
Per lo più dedicato agli Utenti di<br />
Ricevitori GNSS STONEX, CUBE<br />
T consente la gestione dei vari formati<br />
dei dati provenienti delle stazioni totali<br />
e dal protocollo universale NMEA, per<br />
consentire anche agli utenti di GPS<br />
non Stonex di beneficiare delle funzionalità<br />
di CUBE T.<br />
CUBE T fornisce un set completo<br />
di funzioni per la raccolta dei dati in<br />
diverse modalità: Base + Rover, Rover<br />
da rete GPS, sia in modo RTK che<br />
Statico o Statico Rapido: il controllo<br />
totale del ricevitore garantisce un lavoro<br />
sensza soluzione di continuità e<br />
dalla elevata affidabilità.<br />
File GeoTiff o qualsiasi tipo di file immagine<br />
possono essere importati, georeferenziati<br />
ed usati come immagini di<br />
sfondo durante il rilievo.<br />
La vasta gamma di formati di<br />
Importazione/Esportazione come<br />
DXF, DXB, DWG, SHP, XML, fanno<br />
di CUBE T uno dei sistemi per il<br />
mapping più aperti in commercio.<br />
Caratteristiche Principali<br />
• Software per il rilievo e la restituzione<br />
in un’unica soluzione<br />
• Gestione completa dei Ricevitori<br />
GNSS Stonex<br />
• Funzioni Grafiche – colori, dimensioni,<br />
layer, simboli (punti, linee, testo…)<br />
totalmente gestite dall’Utente<br />
• Lavori indipendenti possono essere<br />
memorizzati in un unico file di lavoro,<br />
garantendo una gestione efficace<br />
dei diversi cantieri<br />
• Il libretto di campagna del rilievo<br />
con stazione totale può essere integrato<br />
coi dati GPS<br />
• Gestione delle immagini raster di<br />
sfondo<br />
• Set completo di funzioni COGO e<br />
per il disegno cartografico<br />
• Funzioni topografiche incluse: poligonale,<br />
celerimensura, intersezione<br />
• Possibilità di scegliere tra sistemi<br />
di riferimento standard e personalizzati<br />
• Calcolo dei 7 parametri di rototraslazione<br />
dal sistema WGS84/ECEF<br />
al sistema di coordinate locali<br />
• La vasta scelta di formati di importazione/esportazione<br />
permette<br />
all’Utente lo scambio dati con qualsiasi<br />
software esterno (DXF, DXB,<br />
DWG, SHP, Land XML, ASCII<br />
personalizzato, Excel®…)<br />
• RTK NTRIP, Statico, Sistema<br />
Base + Rover sono pienamente supportati<br />
• Connessione WiFi con i ricevitori<br />
GPS più avanzati<br />
• Gestione E-Bubble & Tilt sensor<br />
• STONEX CUBE Tablet è adatto e<br />
Tablet Windows 10 o notebook.<br />
http://www.stonexpositioning.com/<br />
index.php/it/<br />
<strong>GEOmedia</strong> n°6-<strong>2016</strong> 43
MERCATO<br />
App MAGNET<br />
Construct 2.0<br />
di Topcon<br />
T o p c o n<br />
Positioning<br />
Group lancia<br />
MAGNET<br />
Construct 2.0,<br />
la app di nuova<br />
generazione realizzata<br />
per gestire<br />
una vasta gamma<br />
di stazioni<br />
totali Topcon da<br />
uno smartphone<br />
o da un tablet.<br />
La prima versione<br />
della app invece, era stata<br />
realizzata appositamente<br />
per gestire unicamente il<br />
sistema LN-100 Layout<br />
Navigator system. “Questa<br />
produttività ‘pronta all’uso’<br />
è ora disponibile per<br />
gran parte degli strumenti<br />
Topcon,” ha affermato<br />
David Ahl, direttore della<br />
gestione prodotti software.<br />
“Che si preferisca avvalersi<br />
di dispositivi Android<br />
o dell’ultimo hardware<br />
Apple iPhone, iPad, o iPod<br />
Touch, la app MAGNET<br />
Construct 2.0 offre opzioni<br />
intuitive per connettersi<br />
in modalità wireless e gestire<br />
una stazione totale per<br />
misurazioni rapide, oltre<br />
a un orientamento grafico<br />
dei vostri dati.”<br />
“Si tratta di un esempio di<br />
ciò su cui ci stiamo concentrando<br />
per offrire più<br />
opzioni che siano di utilità<br />
per gli utenti finali,” ha<br />
affermato Ahl. “Questa<br />
compatibilità multipiattaforma<br />
offerta dalla app<br />
MAGNET Construct 2.0,<br />
rende ancora più accessibili<br />
le soluzioni di misurazione<br />
per diverse applicazioni.”<br />
MAGNET Construct<br />
offre anche una connettività<br />
sicura ai servizi<br />
web di MAGNET<br />
Enterprise per un interscambio<br />
dati in tempo reale<br />
tra il cantiere o la campagna,<br />
e l›ufficio.<br />
La app è disponibile sia<br />
sull’Apple App Store che<br />
su Google Play.<br />
Per maggiori informazioni,<br />
visitare il sito topconpositioning.com.<br />
http://topconpositioning.com<br />
Formazione<br />
TerreLogiche 2017<br />
E’ online il calendario<br />
2017 della Formazione<br />
Terrelogiche con una proposta<br />
formativa molto<br />
ricca e tante novità. Tra i<br />
corsi del nuovo anno due<br />
new entry: “Statistica con<br />
R (base)” e “Geodatabase<br />
(PostGIS)”.<br />
Nel primo semestre verranno<br />
proposti due nuovi<br />
corsi:<br />
• “Statistica con R (base)”<br />
che affronta i principali<br />
aspetti riguardanti la<br />
gestione statistica dei<br />
dati e la loro rappresentazione<br />
grafica tramite<br />
l’utilizzo del software<br />
Open Source R.<br />
• “Geodatabase<br />
(PostGIS)” che introduce<br />
all’utilizzo di<br />
PostGIS per l’immagazzinamento,<br />
l’interrogazione<br />
e la manipolazione<br />
di dati territoriali georiferiti<br />
in modo rapido<br />
ed efficiente.<br />
Per maggiori informazioni<br />
sui corsi: http://<br />
www.terrelogiche.com/<br />
calendario-e-costi.html<br />
Tra le novità anche la<br />
possibilità di acquisto dei<br />
“Pacchetti Formativi”,<br />
percorsi tematici creati<br />
da un team di docenti<br />
che permettono di seguire<br />
più sessioni formative<br />
con riduzioni sul costo<br />
di listino e possibilità di<br />
dilazionare il pagamento.<br />
E per tutti coloro che<br />
vogliono tenere costantemente<br />
aggiornato il proprio<br />
team, Terrelogiche<br />
propone i corsi in house<br />
con personalizzazione<br />
dei contenuti didattici e<br />
delle tematiche affrontate<br />
in base alle specifiche esigenze<br />
degli uffici.<br />
Le iscrizioni ai corsi<br />
2017 sono aperte!<br />
http://www.terrelogiche.com<br />
• Rilievi batimetrici automatizzati<br />
• Fotogrammetria delle sponde<br />
• Acquisizione dati e immagini<br />
• Mappatura parametri ambientali<br />
• Attività di ricerca<br />
Vendita – Noleggio - Servizi chiavi in mano, anche con strumentazione cliente<br />
44 <strong>GEOmedia</strong> n°6-<strong>2016</strong>
MERCATO<br />
Teorema presenta<br />
le ultime novità dei<br />
Laser Scanner HDS<br />
Teorema, Distributore per<br />
Lombardia e Piacenza degli<br />
Strumenti Topografici<br />
Leica presenta le ultime<br />
novità dei Laser Scanner<br />
HDS.<br />
L’elevata qualità, le prestazioni<br />
e la massima robustezza,<br />
rendono Leica<br />
ScanStation P16 lo strumento<br />
ideale nel mondo<br />
della scansione laser 3D.<br />
Il suo interessante rapporto<br />
prezzo-prestazioni e<br />
l›interfaccia semplice, garantiscono<br />
una soluzione<br />
interessante per tutte le applicazioni<br />
con una portata<br />
fino a 40 metri.<br />
Leica ScanStation P16<br />
Leica ScanStation P16<br />
dispone di un’interfaccia<br />
touchscreen pratica<br />
ed intuitiva. Il pulsante<br />
di scansione «one-touch»<br />
e il software in modalità<br />
procedura guidata garantiscono<br />
un flusso di lavoro<br />
semplice ed un controllo<br />
rapido dei dati sul campo.<br />
Combinato al comando a<br />
distanza WLAN, il sistema<br />
Leica ScanStation P16 può<br />
essere utilizzato da qualsiasi<br />
dispositivo palmare.<br />
Leica ScanStation<br />
P30 e P40<br />
Leica ScanStation P30 è<br />
uno scanner ad alta versatilità<br />
adatto per una vasta<br />
gamma di tipiche soluzioni<br />
di scansione. Con il suo<br />
mix ottimale di velocità,<br />
autonomia e precisione ed<br />
una robustezza senza pari,<br />
è la soluzione all-in-one<br />
per una ampia gamma<br />
completa di applicazioni.<br />
Leica ScanStation P40 offre<br />
massima versatilità,<br />
ottima portata, elevata<br />
velocità di scansione ed<br />
eccellente qualità dei dati<br />
quando e dove necessario.<br />
E’ la soluzione perfetta<br />
per qualsiasi attività<br />
di scansione laser 3D.<br />
La scelta giusta<br />
Sia che ti occorra una rappresentazione<br />
dettagliata<br />
di una facciata costruita,<br />
una planimetria in 2D o<br />
dati 3D per l’integrazione<br />
nella modellazione BIM<br />
(Building Information<br />
Modeling), ricostruire una<br />
scena del crimine, acquisire<br />
la geometria 3D di strade,<br />
gallerie e ponti, sai che per i<br />
tuoi progetti, avrai bisogno<br />
di un strumento di scansione<br />
preciso. I nuovi laser<br />
scanner ScanStation P30 e<br />
P40 sono la scelta giusta,<br />
perché i dettagli sono importanti.<br />
Teorema srl<br />
Via Romilli 20/8 20139<br />
Milano<br />
Tel 02/5398739<br />
http://www.geomatica.it/<br />
<strong>GEOmedia</strong> n°6-<strong>2016</strong> 45
MERCATO<br />
Cosa riserva il sistema Galileo all’Italia nel<br />
prossimo futuro? Sono quasi 20 anni che si parla del<br />
sistema Galileo con investimenti che dall’anno 2000 al 2020<br />
arriveranno ad oltre 10 miliardi di euro. Ovviamente ogni paese<br />
della Comunità ha dato il suo contributo in quota parte,<br />
ricevendo poi benefici più o meno proporzionali all’investimento.<br />
Oggi a distanza di quasi venti anni ci chiediamo quale<br />
sia la ricaduta di tale investimento per l’Italia.<br />
Di certo l’Italia ha il ruolo di fanalino di coda nel settore pur<br />
avendo know-how specifico e strutture di ricerca di tutto rispetto,<br />
anche in rapporto a quel mondo che travalicando i<br />
confini d’Europa offre competenza e professionalità di alto<br />
livello. Galileo si dirige essenzialmente a servizi basati sulla localizzazione<br />
(LBS), che dipendono fortemente dall’affidabilità<br />
e dalla disponibilità del posizionamento la cui realizzazione, lo<br />
ricordiamo, ancora oggi, nelle nostre zone, è affidata al sistema<br />
GPS statunitense, e al sistema GLONASS russo.<br />
Il ruolo dell’Italia nel sistema di posizionamento Galileo, dal<br />
punto di vista dei servizi indotti, è abbastanza marginale e<br />
quanto dei previsti benefici saranno disponibili alle piccole e<br />
medie imprese italiane che potrebbero usufruire degli “Initial<br />
Services” avviati a fine <strong>2016</strong> e promossi dalla GSA, l’Agenzia<br />
del GNNS europeo?<br />
I professionisti del settore topografico non sembrano interessati<br />
dal nuovo sistema in quanto gli altri sono disponibili e altamente<br />
precisi. Una piccola indagine nel settore ci conferma<br />
che da tempo i produttori hanno abilitato la ricezione delle<br />
frequenze riservate al sistema Galileo, ma nessuno ancora parla<br />
di evidenti vantaggi nell’esecuzione delle misurazioni. Nel<br />
settore degli smartphone attualmente risulta un solo produttore,<br />
BQ, che con il suo smartphone Aquarius riceve i satelliti<br />
Galileo, ma non spiega quale siano i vantaggi, neanche durante<br />
un Hackaton promosso recentemente dalla GSA a Praga.<br />
Servizi di interesse prioritario sono nel supporto al soccorso<br />
per le emergenze ed anche nella grande accuratezza dell’orologio<br />
atomico che porterà all’aumento della precisione sulla<br />
localizzazione da singolo, ma avrà molte applicazioni secondarie.<br />
“La geolocalizzazione è al centro dell’attuale rivoluzione digitale,<br />
con nuovi servizi che trasformano la nostra vita quotidiana<br />
– ha affermato il vicepresidente della Commissione<br />
Europea Maroš Šefčovič in occasione della dichiarazione degli<br />
Initial services –. Galileo sarà alla base della prossima generazione<br />
di tecnologie basate sulla localizzazione, come le automobili<br />
autonome, i dispositivi connessi o i servizi urbani<br />
intelligenti. Oggi mi rivolgo agli imprenditori europei con<br />
questo invito: immaginate cosa potete fare con Galileo. Non<br />
aspettate, innovate!”.<br />
Ma in pratica quanto conoscono gli utenti italiani di questa<br />
innovazione Europea?<br />
Cercheremo di appurarlo nel corso di questo anno e il primo<br />
appuntamento è al numero 1 2017 di <strong>GEOmedia</strong> dedicato<br />
interamente a questo tema con approfondimenti su:<br />
4 Gli Initial Services Galileo<br />
4 I primi gestori del servizio<br />
4 L’impatto nel settore del survey<br />
4 Quali giovamenti per i Location Based Services?<br />
4 GPS e Galileo, lotta ad armi pari?<br />
4 I nuovi servizi per il soccorso<br />
4 Smartphone Galileo ready, esistono?<br />
Renzo Carlucci<br />
Conferenza Esri Italia<br />
2017<br />
Cogli l’occasione e partecipa<br />
al Call for Paper<br />
della manifestazione più<br />
articolata e completa a livello<br />
nazionale nel settore<br />
delle tecnologie geospaziali<br />
e dei Sistemi Informativi<br />
Geografici: la Conferenza<br />
Esri Italia, che si terrà a<br />
Roma il 10 e 11 maggio<br />
2017.<br />
Condividi i risultati dei<br />
tuoi progetti, la tua storia<br />
di successo e racconta a<br />
un pubblico di esperti del<br />
settore come la tecnologia<br />
Esri ha permesso di migliorare<br />
il tuo lavoro.<br />
Diventa protagonista di<br />
un momento di arricchimento<br />
che coinvolge<br />
migliaia di professionisti<br />
da molti anni.<br />
http://www.esri.com<br />
In promozione lo scanner<br />
ZEB1 la soluzione<br />
portatile per il rilievo 3D<br />
Lo scanner ZEB1, sviluppato<br />
da GeoSLAM,<br />
è la soluzione di rilievo<br />
vincente per la misura e<br />
la mappatura di ambienti<br />
tridimensionali su più livelli.<br />
ZEB1 rileva oltre 40.000<br />
punti di misura al secondo<br />
e li trasforma in una nuvola<br />
di punti interamente<br />
registrata. Estremamente<br />
portatile e leggero, viene<br />
utilizzato in movimento<br />
ed è l’ideale per il rilievo<br />
di spazi interni complessi<br />
e sotterranei.<br />
Promozione da prendere<br />
al volo!<br />
19.990,00<br />
Inclusi 10.000 data processing<br />
credits per il processamento<br />
della nuvola<br />
di punti<br />
Vai ai prodotti:<br />
https://goo.gl/uNpzOC<br />
http://www.mesa-laserscanner3d.com<br />
46 <strong>GEOmedia</strong> n°6-<strong>2016</strong>
MERCATO<br />
Mesh il piccolo drone professionale<br />
che supporta Galileo<br />
Mesh sarà il primo drone professionale inoffensivo al mondo<br />
a supportare Galileo, il nuovo sistema di navigazione satellitare<br />
sviluppato dall’Agenzia Spaziale Europea (ESA) per<br />
l’Unione Europea.<br />
La sua entrata in funzione è stata prevista per giovedì 15<br />
dicembre. E permetterà di sganciare il Vecchio Continente<br />
dallo statunitense GPS e dal russo GLONASS.<br />
Dopo 17 anni di sviluppo, Galileo è ora pronto per entrare<br />
in funzione, permettendo all’Europa di rendersi<br />
indipendente anche sul fronte dei sistemi di posizionamento<br />
satellitare. Il supporto a Galileo, in questa prima<br />
fase iniziale, sarà garantito solo su alcuni dispositivi<br />
che comunque potrebbero aver necessità, in ogni<br />
caso, di ricevere un piccolo aggiornamento software.<br />
Cosa cambierà nel mondo dei droni professionali dopo<br />
l’entrata in funzione di Galileo?<br />
Maggiore precisione, disponibilità, copertura. La precisione<br />
dei GNSS (sistema satellitare globale di navigazione) sarà<br />
migliorata grazie alla possibilità di utilizzare una costellazione<br />
combinata GPS-Galileo. In questo modo, il numero<br />
di satelliti costantemente disponibili sarà quasi il doppio,<br />
permettendo misure più precise. Per lo stesso motivo, il<br />
numero maggiore di satelliti che diffondono un segnale di<br />
geo-localizzazione, permetterà di avere un servizio con maggiore<br />
disponibilità, anche in ambienti a visibilità limitate.<br />
Infine, la copertura offerta da Galileo in alcune aree geografiche<br />
sarà migliore del GPS, per come è stata progettata<br />
la posizione dei satelliti. Anche a livello di servizio, Galileo<br />
sarà migliorativo rispetto al GPS, offrendo alcune caratteristiche<br />
ora assenti nei GNSS, come i servizi di integrità<br />
garantita del segnale, e in generale l’affidabilità del sistema,<br />
oppure la possibilità di accedere ai dati grezzi non elaborati.<br />
Le applicazioni che nascono ogni giorno sono moltissime e<br />
questo enorme mercato è destinato a raggiungere 3 miliardi<br />
di utenti entro il 2020, la sua crescita sarà progressiva e promette<br />
prestazioni di altissimo livello.<br />
http://www.italdron.com/it<br />
TEOREMA sRl MIlANO:<br />
sOlUZIONI INNOVATIVE PER lA TOPOGRAFIA<br />
E lA TERMOGRAFIA “IR”<br />
Dal 1986 Teorema srl lavora a fianco del professionista<br />
fornendo la tecnologia più avanzata, la migliore formazione tecnica<br />
ed una accurata assistenza post-vendita<br />
per rendere affidabile e produttivo il vostro lavoro.<br />
Leica HDS P30 / P40<br />
Leica Nova MS60<br />
Leica Serie Captivate<br />
Leica CS35<br />
Rugged Tablet<br />
Ricevitore<br />
GNSS GS14<br />
Leica 3D Disto<br />
Leica<br />
Disto S910<br />
Termocamera<br />
Flir T420<br />
www.geomatica.it • www.disto.it • www.termocamere.com<br />
Via A. Romilli, 20/8 20139 Milano • Tel. 02 5398739 • teorema@geomatica.it <strong>GEOmedia</strong> n°6-<strong>2016</strong> 47
SMART CITIES<br />
Smart cities<br />
or dumb cities?<br />
Servizi geospaziali e<br />
città<br />
di Beniamino Murgante<br />
e Giuseppe Borruso<br />
La discussione più recente<br />
sulla città si sofferma<br />
sempre più sulla<br />
sua ‘intelligenza’, richiamando<br />
il concetto<br />
di Smart Cities, più<br />
volte affrontato su queste<br />
colonne. Tale intelligenza<br />
si concretizza,<br />
nella maggior parte dei<br />
casi, nell’introduzione<br />
di uno ‘strato tecnologico’<br />
sulla città,<br />
spesso caratterizzato<br />
dall’installazione di alcuni<br />
dispositivi quali<br />
lampioni in grado di<br />
accendersi e spegnersi<br />
da soli in base alle condizioni<br />
di luce, o un<br />
set di telecamere per il<br />
controllo del traffico, o<br />
l’implementazione di<br />
una rete wi-fi pubblica<br />
al servizio di cittadini,<br />
o, più propriamente,<br />
city users. Tali elementi<br />
sono senz’altro necessari<br />
ma, più volte, si è ribadito<br />
come questi, da<br />
soli, non siano in grado<br />
di rendere intelligente<br />
una città, senza una<br />
vera e propria rete, in<br />
grado di coniugare regole<br />
condivise, aspetti<br />
tecnologici, dati e cittadini.<br />
Una città smart,<br />
infatti, è una città che<br />
prima di tutto viene incontro<br />
ai propri cittadini<br />
o utenti, fornendo<br />
loro dei servizi, e in cui<br />
il lato tecnologico rappresenta<br />
l’elemento per<br />
raggiungere un’elevata<br />
efficienza, per ottimizzare<br />
tali elementi e, auspicabilmente,<br />
risultare<br />
quasi invisibile.<br />
Il legame tra città<br />
‘smart’ e le tecnologie<br />
e i servizi geospaziali è<br />
necessariamente molto<br />
forte, quasi scontato,<br />
apparentemente. Le<br />
città sono localizzate<br />
nello spazio. Le strade,<br />
gli edifici, gli elementi<br />
naturali e artificiali, i<br />
servizi, hanno una posizione,<br />
e così gli utilizzatori<br />
della città, anche<br />
se questi si muovono<br />
nello spazio. Realtà statiche<br />
e dinamiche allo<br />
stesso tempo. Nodi,<br />
relazioni, reti, flussi,<br />
sono tutti elementi che<br />
caratterizzano la città,<br />
secondo la tradizione<br />
degli studi urbanistici<br />
e della geografia urbana.<br />
Se fino a ieri questi<br />
potevano essere rappresentati<br />
in modo statico,<br />
oggi la dinamica<br />
di questi elementi può<br />
essere raccolta, analizzata,<br />
elaborata, visualizzata.<br />
Le tecnologie geoinformatiche<br />
sono oggi alla<br />
base di tutta una serie<br />
di servizi geolocalizzati,<br />
quelli che di fatto contribuiscono<br />
o possono<br />
contribuire a rendere le<br />
città più o meno smart.<br />
Videocamere e sensori<br />
smart possono monitorare<br />
il traffico urbano<br />
– e questi oggetti sono<br />
dotati di una posizione<br />
nello spazio, geolocalizzabile<br />
– così come<br />
dispositivi mobili,<br />
come gli smartphones,<br />
raccogliendo dati aiutano<br />
a produrre le mappe<br />
di, appunto, traffico<br />
urbano di Google. Gli<br />
smartphones nelle nostre<br />
tasche sono oggi<br />
dei concentrati di tecnologia<br />
che l’ampiezza<br />
di banda della rete cellulare<br />
e la liberalizzazione<br />
civile del segnale<br />
GPS, per citare solo<br />
due rivoluzioni degli<br />
ultimi lustri, hanno<br />
reso senza precedenti la<br />
possibilità di scambiarsi<br />
dati e informazioni,<br />
consentendo elevati livelli<br />
di interazione tra<br />
soggetti e con lo spazio<br />
circostante, e di raccogliere<br />
queste ultime, a<br />
scopo ludico, ma anche<br />
utilizzabili per attività<br />
di pianificazione commerciale<br />
(da parte di<br />
chi questi dati li raccoglie)<br />
e urbana.<br />
Sempre più la posizione,<br />
diventa elemento<br />
importante e alla base<br />
di quanto ruota attorno<br />
al servizio di smartness:<br />
i cittadini, i sensori e i<br />
dispositivi, i dati (siano<br />
essi open, siano essi<br />
big), le infrastrutture, e<br />
tutti i servizi che possono<br />
derivare da queste<br />
interazioni. E ciò, anche<br />
se apparentemente<br />
ormai consolidato, non<br />
rappresenta ancora un<br />
elemento facilmente<br />
gestibile, soprattutto<br />
in termini di precisione.<br />
Da un lato, infatti,<br />
tutte le componenti<br />
‘fisse’ possiedono una<br />
posizione: gli hot spot<br />
wi-fi, le centraline, tutti<br />
i dispositivi e sensoristica;<br />
dall’altro lato<br />
i dispositivi mobili o,<br />
in accezione più umanizzata,<br />
i cittadini o gli<br />
utenti della città, cambiano<br />
la loro posizione<br />
nello spazio e questa<br />
può avere diversi livelli<br />
di precisione e affidabilità.<br />
Ed è qui che si giocheranno<br />
le sfide dei<br />
prossimi anni. Il posizionamento<br />
outdoor e<br />
quello indoor sono infatti<br />
il terreno di gioco<br />
dove si svilupperanno<br />
servizi, sempre più precisi,<br />
basati sulla geolocalizzazione.<br />
Gli attuali<br />
dispositivi mobili, dotati<br />
di ricevitore GNSS<br />
adattato soprattutto<br />
per ricevere il segnale<br />
della costellazione statunitense<br />
GPS, si attestano<br />
infatti su livelli<br />
di precisione dell’ordine<br />
dei 5 – 10 metri,<br />
con peggioramenti dovuto<br />
all’effetto ‘canyon’<br />
riscontrabile in molte<br />
realtà urbane. Tale<br />
dato è destinato a migliorare,<br />
con la capacità,<br />
già esistente e ulteriormente<br />
implementabile<br />
nel futuro più<br />
prossimo, dei ricevitori<br />
(multicostellazione) di<br />
captare i segnali da altre<br />
costellazioni, quali<br />
la russa GLONASS,<br />
quella cinese Beidou e,<br />
da quest’anno, l’europea<br />
GALILEO. L’altra<br />
grande frontiera è rappresentata<br />
dal posizionamento<br />
interno, dove<br />
i sistemi satellitari perdono<br />
la loro efficacia.<br />
Gli utenti della città<br />
si muovono all’interno<br />
di edifici, quali abitazioni,<br />
punti vendita,<br />
luoghi pubblici. Qui<br />
la localizzazione non<br />
può più essere garantita,<br />
ad esempio, dalla<br />
posizione del dispositivo<br />
all’interno della<br />
cella di telefonia mo-<br />
48 <strong>GEOmedia</strong> n°6-2015
SMART CITIES<br />
bile per fornire servizi<br />
e informazioni ad hoc e<br />
precisamente indirizzate.<br />
Sistemi che garantiscano<br />
la localizzazione a<br />
ogni singolo piano di un<br />
edificio e con precisioni<br />
senz’altro sub-metriche<br />
sono pertanto necessari,<br />
e le ricerche sono in atto,<br />
sia con riferimento all’utilizzo<br />
dei sensori montati<br />
all’interno dei dispositivi,<br />
sia relativi a sistemi<br />
esterni (es. hot spot<br />
wi-fi, ibeacons, ecc.). Al<br />
di là delle applicazioni<br />
meramente commerciali,<br />
ovviamente tra le prime<br />
a essere sviluppabili anche<br />
tenendo conto di<br />
un ritorno economico,<br />
le applicazioni in ambito<br />
smart sono molto<br />
ampie. Dal monitoraggio<br />
dei flussi di persone<br />
all’interno degli edifici a<br />
scopi di pianificazione,<br />
a sistemi di guida e di<br />
somministrazione di informazioni<br />
per persone<br />
disabili, a servizi di assistenza<br />
remota, per esempio<br />
per persone anziane.<br />
Geolocalizzazione e<br />
smartness sono pertanto<br />
ancora agli inizi della<br />
loro coesistenza, pur<br />
trattandosi di concetti e<br />
di tecnologie ormai ampiamente<br />
testate e rese<br />
disponibili negli ultimi<br />
decenni, e con ampie e<br />
promettenti evoluzioni.<br />
RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI<br />
Batty M., Urban studies: Diverse cities, successful cities, Nature<br />
Human Behaviour, Volume 1, article 0022, pp. 1 – 2. http://www.<br />
nature.com/articles/s41562-016-0022<br />
Batty M., Building a Science of Cities, Cities, Volume 29,<br />
Supplement 1, March 2012, Pp. S9 – S16, http://www.complexcity.<br />
info/files/2011/12/BATTY-CITIES-2011.pdf<br />
Batty M., The New Science of Cities, The MIT Press, 2013.<br />
Bezerra J. et al., The Mobile Revolution: How Mobile Technologies<br />
Drive a Trillion-Dollar Impact, bcg perspectives, visitato il 20 gennaio<br />
<strong>2016</strong> https://www.bcgperspectives.com/content/articles/<br />
telecommunications_technology_business_transformation_mobile_revolution/<br />
Murgante B., Borruso G., Smart Cities or Dumb Cities? Città e<br />
Applicazioni per Smartphones, <strong>GEOmedia</strong> Vol 17, N° 5, 2013.<br />
Murgante B., Borruso G., Smart cities: un’analisi critica delle opportunità<br />
e dei rischi, <strong>GEOmedia</strong> Vol 17, N° 3, 2013.<br />
Tweddle JC, Robinson LD, Pocock MJ, Roy HE. Guide to citizen<br />
science: developing, implementing and evaluating citizen science<br />
to study biodiversity and the environment in the UK. Natural<br />
History Museum and NERC Centre for Ecology and Hydrology for<br />
UK-EOF 2012. www.ukeof.org.uk<br />
Warf B. e Sui D. (2010), From GIS to neogeography: ontological implications<br />
and theories of truth, “Annals of GIS”, 16 (4), pp. 197-209.
AGENDA<br />
07 - 09 febbraio 2017<br />
Berna (Svizzera)<br />
8th Workshop on Remote<br />
Sensing of Land Ice and Snow<br />
of the European Association of<br />
Remote Sensing Laboratories<br />
(EARSeL)<br />
www.geoforall.it/kwpaw<br />
8-11 febbraio<br />
Genova<br />
FOSS4G-IT 2017<br />
www.geoforall.it/kwppx<br />
21 - 24 febbraio 2017<br />
Firenze<br />
10th Coastal Altimetry<br />
Workshop<br />
www.geoforall.it/kwp8a<br />
1-3 marzo 2017<br />
Nafplio (Grecia)<br />
International Workshop ISPRS/<br />
CIPA 3D-ARCH<br />
www.geoforall.it/k9yx4<br />
05-07 marzo 2017<br />
Dubai (UAE)<br />
JURSE 2017 URBAN 2017<br />
URS 2017<br />
www.geoforall.it/k9cwu<br />
14-16 marzo 2017<br />
Munich (Germania)<br />
Munich Satellite Navigation<br />
Summit 2017<br />
www.geoforall.it/k9cu4<br />
29 marzo 2017<br />
Roma<br />
UAV & SAR: i droni nelle<br />
operazioni di salvataggio<br />
www.geoforall.it/k9cy3<br />
10-12 Aprile 2017<br />
Roma<br />
AIIT International Congress<br />
TIS Rome 2017<br />
www.geoforall.it/k9c46<br />
18-20 aprile 2017<br />
Sharjah (UAE)<br />
ASCMCES-17<br />
www.geoforall.it/k9cw6<br />
23–28 aprile 2017<br />
Vienna (Austria)<br />
European Geosciences Union<br />
(EGU) Special session on RPAS<br />
in monitoring applications and<br />
management of natural hazards<br />
www.geoforall.it/kwp6c<br />
24–26 aprile 2017<br />
Vienna (Austria)<br />
Geosciences Information For<br />
Teachers (GIFT) workshop by<br />
EGU<br />
www.geoforall.it/k9crp<br />
27-28 aprile 2017<br />
Porto (Portugal)<br />
GISTAM 2017 3rd<br />
International Conference on<br />
Geographical Information<br />
Systems Theory, Applications<br />
and Management<br />
www.geoforall.it/kx9wx<br />
06-08 maggio 2017<br />
Cairo (Egypt)<br />
10th International Symposium<br />
On Mobile Mapping<br />
Technology and Summer<br />
School on mobile Mapping<br />
www.geoforall.it/k9cw8<br />
10-11 maggio 2017<br />
Roma<br />
Conferenza Esri Italia 2017<br />
www.geoforall.it/k9cyk<br />
15-17 maggio 2017<br />
Mosca (Russia)<br />
ISPRS International Workshop<br />
Photogrammetric and<br />
computer vision techniques for<br />
video Surveillance, Biometrics<br />
and Biomedicine - PSBB17<br />
www.geoforall.it/kwp9r<br />
23-24 maggio 2017<br />
London (UK)<br />
GEO Business 2017<br />
www.geoforall.it/k9cwd<br />
29 maggio - 2 giugno 2017<br />
Salzburg (Austria)<br />
GNC 2017 10th ESA GNC<br />
Conference<br />
www.geoforall.it/k9chh<br />
06-09 giugno 2017<br />
Hannover (GERMANY)<br />
ISPRS WG Hannover<br />
Workshop HRIGI 17 – CMRT<br />
17 – EuroCOW 17 Joint<br />
Meeting<br />
www.geoforall.it/k9cw4<br />
7-10 giugno 2017<br />
Roma<br />
XXXII Congresso dei Geografi<br />
Italiani<br />
www.geoforall.it/kwphk<br />
25 giugno-1 luglio 2017<br />
Zagreb (Croatia)<br />
XXX International Geodetic<br />
Student Meeting<br />
www.geoforall.it/kxpff<br />
26-29 giugno 2017<br />
Munich (Germany)<br />
SPIE Optical Metrology<br />
Videometrics, Range Imaging<br />
and Applications XIV<br />
www.geoforall.it/kwp9f<br />
4 - 7 luglio 2017<br />
Salzburg (Austria)<br />
GI_Forum 2017<br />
www.geoforall.it/k9cup<br />
16-22 luglio 2017<br />
Obergurgl (AUSTRIA)<br />
Innsbruck Summer School of<br />
Alpine Research 2017 Close<br />
Range Sensing Techniques in<br />
Alpine Terrain Venue<br />
www.geoforall.it/k9cwh
FIBER MANAGER ®<br />
TUTTA LA TUA RETE A PORTATA DI MANO<br />
GESTISCI L’INFRASTRUTTURA CON UN SOLO GEODATABASE INTEGRATO<br />
Con FiberManager® puoi gestire le reti di telecomunicazione con un unico geodatabase che consente la<br />
visione globale ed integrata dell’intera infrastruttura di rete. In questo modo hai a disposizione uno strumento<br />
di business intelligence geografica centralizzato, da cui puoi estrarre tutti i report, gli schemi e i documenti<br />
necessari a progettare, costruire, sviluppare e gestire la tua rete nel modo più efficace possibile.<br />
FiberManager® mette a fattor comune la piattaforma GIS leader nel mondo con il modello dati e le funzionalità<br />
smart implementate da una community network di aziende di telecomunicazioni operanti in vari paesi nel<br />
mondo.<br />
FiberManager® è una verticalizzazione della suite ArcFM® di Schneider Electric, di cui Sinergis è rivenditore<br />
esclusivo in Italia.<br />
www.sinergis.it