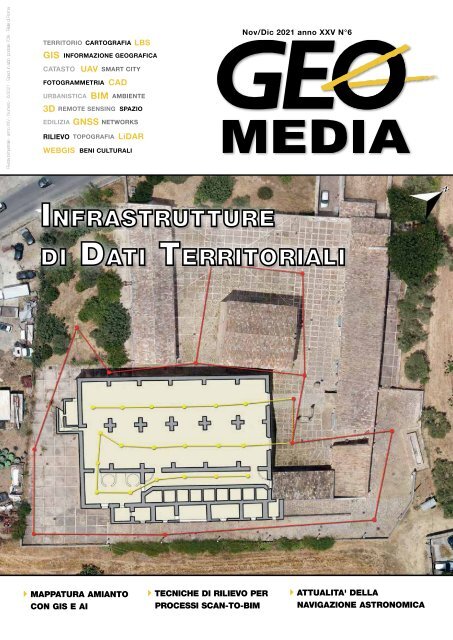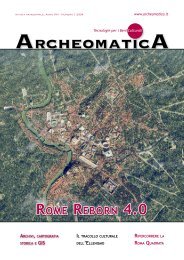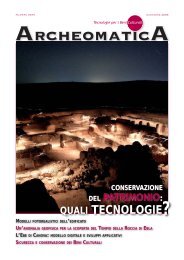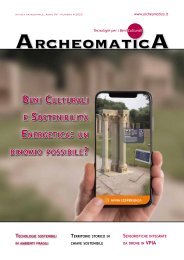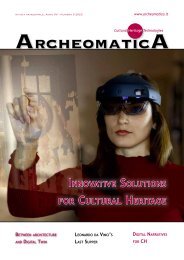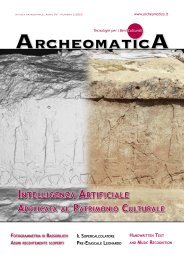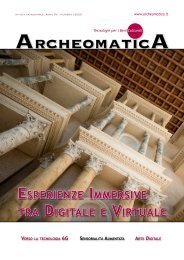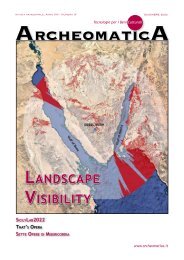GEOmedia_6_2021
Rivista Italiana di Geomatica
Rivista Italiana di Geomatica
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Rivista bimestrale - anno XXV - Numero - 6/<strong>2021</strong> - Sped. in abb. postale 70% - Filiale di Roma<br />
TERRITORIO CARTOGRAFIA<br />
GIS<br />
CATASTO<br />
3D<br />
INFORMAZIONE GEOGRAFICA<br />
FOTOGRAMMETRIA<br />
URBANISTICA<br />
EDILIZIA<br />
GNSS<br />
BIM<br />
RILIEVO TOPOGRAFIA<br />
CAD<br />
REMOTE SENSING SPAZIO<br />
WEBGIS<br />
UAV<br />
SMART CITY<br />
AMBIENTE<br />
NETWORKS<br />
LiDAR<br />
BENI CULTURALI<br />
LBS<br />
Nov/Dic <strong>2021</strong> anno XXV N°6<br />
Infrastrutture<br />
di Dati Territoriali<br />
MAPPATURA AMIANTO<br />
CON GIS E AI<br />
TECNICHE DI RILIEVO PER<br />
PROCESSI SCAN-TO-BIM<br />
ATTUALITA' DELLA<br />
NAVIGAZIONE ASTRONOMICA
Il futuro delle IDT<br />
Se pensiamo al grande lavoro intrapreso negli ultimi 50 anni per la realizzazione dei<br />
Geodatabase topografici che costituiscono l’ossatura portante delle Infrastrutture dei Dati<br />
Territoriali, non possiamo tralasciare un aggiornamento programmatico. Aggiungendo la<br />
necessità di corredare i Geodatabase delle informazioni territoriali connesse si costruisce<br />
un assioma che dovrebbero costituire il fondamento degli obiettivi delle amministrazioni<br />
responsabili ai vari livelli, dallo Stato al singolo Comune.<br />
Sappiamo bene che dopo una lunga fase di incertezza istituzionale, compensata in parte dalle<br />
azioni condotte nei Gruppi di Lavoro promossi da AGID e attivati nel maggio del 2014, nel<br />
corso del 2018 si avviarono i lavori della Consulta Nazionale per l’Informazione Territoriale ed<br />
Ambientale (CNITA) in attuazione della Direttiva INSPIRE.<br />
Le attività dell’organismo presieduto dal Ministero dell’Ambiente si esplicano attraverso<br />
6 sezioni tecniche. La prima è presieduta dall’ISPRA, che opera per il raccordo tra il<br />
livello nazionale e il livello territoriale per la realizzazione dell’infrastruttura nazionale per<br />
l’informazione territoriale e del monitoraggio ambientale. Segue l’AGID per la raccolta delle<br />
istanze italiane sui metadati da trasmettere in sede europea attraverso il Repertorio Nazionale<br />
dei Dati Territoriali preparando il rapporto annuale INSPIRE. Viene quindi l’IGM che propone<br />
l’attribuzione univoca della responsabilità di produzione e mantenimento dei dati di interesse<br />
generale, predisponendo un sistema di monitoraggio per la verifica dell’aggiornamento dei<br />
dati territoriali esistenti e dei dati territoriali raccolti ex novo in conformità alle disposizioni di<br />
esecuzione europee con raccordo e reportistica per la preparazione dell’annuale report INSPIRE.<br />
Il CISIS segue i servizi di rete per la ricerca e il download dei dati a livello nazionale, curandone<br />
la conformità INSPIRE. Le altre sezioni tecniche di CNIPA, AGID e ISPRA predispongono<br />
la comunicazione che il Ministero dell’ambiente invia alla Commissione europea entro il 15<br />
maggio di ogni anno.<br />
Insomma, tutte le attività delle sezioni tecniche menzionate sembrano essere spinte dalla sola<br />
aderenza europea alla convenzione INSPIRE, che non chiedeva altro che omogeneizzare i dati<br />
per l’interscambio tra le nazioni europee.<br />
Possibile che l’unico motore rimasto oggi in Italia per avere una documentazione dello stato di<br />
fatto aggiornato del territorio sia quello della necessità di non essere multati dalla Commissione<br />
Europea per la mancata adesione alle Direttive?<br />
Le numerose commissioni, consulte e comitati esistenti apportano il loro contributo, ma<br />
quello che sembra assolutamente inesistente è la volontà di attuare programmi globali per la<br />
documentazione dello stato del territorio atto ad una vera pianificazione e controllo. Eppure<br />
tempo fa c’erano regole (e leggi regionali) molto semplici, come quella che obbligava le Regioni<br />
ad eseguire voli aerofotogrammetrici a cadenza biennale per il controllo dell’attività urbanistica.<br />
Guardiamo al futuro e orientiamoci oggi verso una vera attività programmatica<br />
dell’aggiornamento delle IDT che dovrebbero guardare alle nuove tecnologie di rilievo e alle<br />
necessità emergenti del 3D per le città nell’ambito del BIM.<br />
Le ultime regole tecniche sono state emanate più di 15 anni fa ed erano relative agli ambiti<br />
di competenza regionale, oggi abbiamo bisogno di entrare nel dettaglio delle città, degli<br />
agglomerati urbani, per renderli intelligenti conoscendone più informazioni che dati, sì, ma<br />
aggiornando il dato di base.<br />
Buona lettura,<br />
Renzo Carlucci
FOCUS<br />
In questo<br />
numero...<br />
FOCUS<br />
REPORT<br />
INTERVISTA<br />
LE RUBRICHE<br />
Mappatura Amianto<br />
con tecniche GIS e di<br />
Intelligenza Artificiale<br />
di Enrico Bonansea, Luca<br />
Forestello, Ivan Cerato, Manuela<br />
Livorno, Gabriele Nicolò,<br />
Fulvio Raviola, Isabella Tinetti,<br />
Teo Ferrero, Roberto Cassulo,<br />
Marcella Alibrando, Massimiliano<br />
Carrino, Stefano Masera,<br />
Maria Cristina Prola<br />
6<br />
44 MERCATO<br />
46 TERRA E SPAZIO<br />
50 AGENDA<br />
14<br />
Interviste ad alcuni<br />
responsabili di IDT<br />
regionali: presente<br />
e prospettive<br />
a cura di Franco Vico<br />
In copertina gli schemi<br />
topografici realizzati per il<br />
modello parametrico HBIM della<br />
“Real Cantina Borbonica” di<br />
Partinico in provincia di Palermo.<br />
Il rilievo laser scanner è stato<br />
eseguito con uno strumento<br />
Topcon GLS-2000; sfruttando<br />
l'approccio topografico per la<br />
registrazione delle scansioni<br />
disponibile con questo<br />
strumento, il rilievo laser scanner<br />
è stato eseguito in modo tale<br />
che tutti i punti di scansione<br />
fossero collegati per formare una<br />
poligonale topografica interna<br />
all’edificio.<br />
La linea sacra<br />
di San Michele e la<br />
sfericità terrestre<br />
di Fabio Crosilla<br />
24<br />
geomediaonline.it<br />
4 <strong>GEOmedia</strong> n°6-<strong>2021</strong><br />
<strong>GEOmedia</strong>, bimestrale, è la prima rivista italiana di geomatica.<br />
Da più di 20 anni pubblica argomenti collegati alle tecnologie dei<br />
processi di acquisizione, analisi e interpretazione dei dati,<br />
in particolare strumentali, relativi alla superficie terrestre.<br />
In questo settore <strong>GEOmedia</strong> affronta temi culturali e tecnologici<br />
per l’operatività degli addetti ai settori dei sistemi informativi<br />
geografici e del catasto, della fotogrammetria e cartografia,<br />
della geodesia e topografia, del telerilevamento aereo e<br />
spaziale, con un approccio tecnico-scientifico e divulgativo.
INSERZIONISTI<br />
Codevintec 29<br />
30<br />
Topografia<br />
Applicata al<br />
Soccorso: la<br />
formazione del<br />
Vigile del Fuoco<br />
di Daniele Mercuri<br />
Datronix 2<br />
Epsilon 45<br />
ESRI 49<br />
Geomax 44<br />
GIS3W 38<br />
Gter 32<br />
ISPRS 33<br />
NAIS 13<br />
Planetek Italia 39<br />
Stonex 51<br />
StrumentiTopografici 52<br />
Topo4qgis-un plugin<br />
per QGIS utile<br />
all'elaborazione di<br />
libretti PreGeo e alla<br />
trattazione di liste di<br />
punti mediante opportuna<br />
rototraslazione<br />
ai minimi quadrati<br />
di Marco Lombardi,<br />
Gianluca Beccaria<br />
34<br />
40<br />
Tecniche di rilievo<br />
integrato per processi<br />
Scan-to-BIM<br />
Teorema 50<br />
ESA - Ghiacciaio Kangerlussuaq<br />
(16 gennaio 2022)<br />
Il ghiacciaio Kangerlussuaq,<br />
uno dei più vasti ghiacciai<br />
di sbocco di marea della<br />
Groenlandia, è mostrato in<br />
questa immagine in falsi colori<br />
acquisita dalla missione<br />
Copernicus Sentinel-1. Kangerlussuaq<br />
si traduce ‘grande<br />
fiordo’ nella lingua groenlandese<br />
ed il suo ghiacciaio<br />
fluisce dentro la parte alta del<br />
Fiordo di Kangerlussuaq, il<br />
secondo fiordo della Groenlandia<br />
orientale in termini di<br />
dimensioni.<br />
Ciascun satellite Sentinel-1<br />
trasporta una strumentazione<br />
radar avanzata, che fornisce<br />
immagini della superficie terrestre<br />
in condizioni di luce sia<br />
diurna che notturna. Il Telerilevamento<br />
consente di monitorare<br />
la calotta di ghiaccio<br />
terrestre e di tenere traccia di<br />
tutti gli stadi di modificazione<br />
- dal rilevamento di crepe<br />
alla rottura di iceberg – come<br />
pure di effettuare la misura<br />
della copertura di ghiaccio e<br />
della deriva degli iceberg.<br />
Crediti:<br />
ESA - Image of the week.<br />
di Mauro Lo Brutto<br />
Traduzione: Gianluca Pititto<br />
una pubblicazione<br />
Science & Technology Communication<br />
<strong>GEOmedia</strong>, la prima rivista italiana di geomatica.<br />
ISSN 1128-8132<br />
Reg. Trib. di Roma N° 243/2003 del 14.05.03<br />
Direttore<br />
RENZO CARLUCCI, direttore@rivistageomedia.it<br />
Comitato editoriale<br />
Vyron Antoniou, Fabrizio Bernardini, Mario Caporale,<br />
Roberto Capua, Luigi Colombo, Mattia Crespi, Luigi Di<br />
Prinzio, Michele Dussi, Michele Fasolo, Marco Lisi, Flavio<br />
Lupia, Luigi Mundula, Beniamino Murgante, Aldo Riggio,<br />
Mauro Salvemini, Attilio Selvini, Donato Tufillaro<br />
Direttore Responsabile<br />
FULVIO BERNARDINI, fbernardini@rivistageomedia.it<br />
Redazione<br />
VALERIO CARLUCCI, GIANLUCA PITITTO,<br />
redazione@rivistageomedia.it<br />
Diffusione e Amministrazione<br />
TATIANA IASILLO, diffusione@rivistageomedia.it<br />
Progetto grafico e impaginazione<br />
DANIELE CARLUCCI, dcarlucci@rivistageomedia.it<br />
Editore<br />
MediaGEO soc. coop.<br />
Via Palestro, 95 00185 Roma<br />
Tel. 06.64871209 - Fax. 06.62209510<br />
info@rivistageomedia.it<br />
Stampa: System Graphics Srl<br />
Via di Torre Santa Anastasia 61 00134 Roma<br />
Condizioni di abbonamento<br />
La quota annuale di abbonamento alla rivista Science è di € & 45,00. Technology Communication<br />
Il prezzo di ciascun fascicolo compreso nell’abbonamento è di € 9,00. Il prezzo di<br />
ciascun fascicolo arretrato è di € 12,00. I prezzi indicati si intendono Iva inclusa.<br />
L’editore, al fine di garantire la continuità del servizio, in mancanza di esplicita<br />
revoca, da comunicarsi in forma scritta entro il trimestre seguente alla scadenza<br />
dell’abbonamento, si riserva di inviare il periodico anche per il periodo successivo.<br />
La disdetta non è comunque valida se l’abbonato non è in regola con i pagamenti.<br />
Il rifiuto o la restituzione dei fascicoli della Rivista non costituiscono disdetta<br />
dell’abbonamento a nessun effetto. I fascicoli non pervenuti possono essere<br />
richiesti dall’abbonato non oltre 20 giorni dopo la ricezione del numero successivo.<br />
Gli articoli firmati impegnano solo la responsabilità dell’autore. È vietata la<br />
riproduzione anche parziale del contenuto di questo numero della Rivista in<br />
qualsiasi forma e con qualsiasi procedimento elettronico o meccanico, ivi inclusi i<br />
sistemi di archiviazione e prelievo dati, senza il consenso scritto dell’editore.<br />
Rivista fondata da Domenico Santarsiero.<br />
Numero chiuso in redazione il 24 gennaio <strong>2021</strong>.
FOCUS<br />
MAIA: Mappatura Amianto con<br />
tecniche GIS e di Intelligenza Artificiale<br />
di Enrico Bonansea, Luca Forestello, Ivan Cerato, Manuela Livorno, Gabriele Nicolò, Fulvio Raviola, Isabella Tinetti,<br />
Teo Ferrero, Roberto Cassulo, Marcella Alibrando, Massimiliano Carrino, Stefano Masera, Maria Cristina Prola<br />
Arpa Piemonte ha avviato nel 2019<br />
un’attività sperimentale finalizzata allo<br />
studio e messa a punto di tecniche<br />
di analisi di immagini basate su deep<br />
learning e reti neurali. Nel 2020 il<br />
progetto ha portato alla realizzazione<br />
ed applicazione del modello<br />
denominato MAIA (Mappatura Amianto<br />
Fig. 1 - Nella figura si vedono due coperture in cemento amianto sulle quali è stata segnalata<br />
la presenza di MCA (evidenziata dalla stellina). Il riquadro rosso rappresenta la porzione<br />
di territorio corrispondente ad un quadrato di 10m x 10m attorno al punto riportato nella<br />
segnalazione (Immagini Ortofoto AGEA 2015).<br />
con tecniche GIS e di Intelligenza<br />
Artificiale) sull’intero territorio<br />
regionale.<br />
L’<br />
amianto rappresenta una<br />
problematica ambientale<br />
e sanitaria di particolare<br />
rilievo in diverse aree del territorio<br />
nazionale.<br />
Con l’emanazione della legge n.<br />
257/1992 che vieta l’estrazione,<br />
la produzione e la commercializzazione<br />
dell’amianto ed<br />
il successivo DM 101/2003 è<br />
iniziata un’importante opera di<br />
monitoraggio e tutela ambientale<br />
attraverso l’avvio del processo<br />
di mappatura della presenza di<br />
amianto sul territorio e la bonifica<br />
dei siti più rilevanti.<br />
La Regione Piemonte si è dotata,<br />
dal 2008, di una specifica<br />
legge per affrontare le problematiche<br />
relative all’amianto<br />
(L.R. n. 30/2008 “Norme per la<br />
tutela della salute, il risanamento<br />
dell’ambiente, la bonifica e<br />
lo smaltimento dell’amianto”).<br />
Da tale legge discende il Piano<br />
Regionale Amianto [1] con cui<br />
la Regione ha posto le basi per la<br />
mappatura dell’amianto di origine<br />
antropica su tutto il territorio<br />
regionale.<br />
Arpa Piemonte ha avviato già<br />
a partire dal 2013 la prima fase<br />
del progetto di mappatura delle<br />
coperture contenenti cementoamianto<br />
(in seguito abbreviato<br />
MCA). La procedura, basata<br />
sull’analisi e classificazione automatica<br />
di tipo object oriented<br />
di ortoimmagini, ha riguardato<br />
un’area di indagine (definita<br />
“area prioritaria”) di circa<br />
10.000 kmq e ha portato all’individuazione<br />
di circa 120.000<br />
coperture georeferenziate di edifici<br />
potenzialmente contenenti<br />
cemento amianto.<br />
Nel 2019 è stata avviata un’attività<br />
sperimentale finalizzata allo<br />
studio e messa a punto di nuove<br />
tecniche di analisi di immagine<br />
basate su deep learning con reti<br />
neurali per il riconoscimento e<br />
la classificazione delle coperture<br />
in cemento amianto.<br />
Nel 2020 l’attività di definizione<br />
metodologica è stata affinata e<br />
completata portando alla realizzazione<br />
ed applicazione del<br />
modello denominato MAIA<br />
(Mappatura Amianto con<br />
tecniche GIS e di Intelligenza<br />
Artificiale) sull’intero territorio<br />
regionale al fine di realizzare<br />
la mappatura a scala regionale,<br />
estendendo lo studio a tutti i<br />
territori non inclusi nella prima<br />
area di studio prioritaria (circa<br />
15.000 kmq), e monitorare nel<br />
tempo le trasformazioni delle coperture<br />
in amianto già oggetto di<br />
verifica con sopralluogo all’interno<br />
dell’area prioritaria.<br />
Metodi<br />
Le reti neurali utilizzano algoritmi<br />
ispirati alla struttura e al<br />
funzionamento delle reti neurali<br />
biologiche. Come queste, la rete<br />
neurale artificiale, è quindi un<br />
“sistema complesso” in grado<br />
di acquisire capacità di analisi<br />
attraverso una fase di addestramento<br />
basata su dati di input<br />
iniziali (training set) e quindi di<br />
analizzare, e classificare, tipologie<br />
di oggetti predefiniti senza<br />
la necessità di imporre modelli<br />
6 <strong>GEOmedia</strong> n°6-<strong>2021</strong>
FOCUS<br />
Fig. 2 - I riquadri verdi identificano una porzione di territorio senza CMA di 10m x 10m (Immagini Ortofoto AGEA 2015).<br />
unità volumetriche del database<br />
topografico della cartografia tecnica<br />
regionale (BDTRE, edizione<br />
2020) [3].<br />
L’intero progetto è stato sviluppato<br />
e gestito attraverso le sole<br />
risorse di calcolo del Sistema<br />
Informativo Geografico di Arpa<br />
Piemonte. La gestione complessiva<br />
dei processi di elaborazione,<br />
analisi immagini, fotointerpretazione<br />
e gestione dei servizi di<br />
editing dei dati geografici, è stata<br />
realizzata attraverso le componenti<br />
dell’infrastruttura geografica<br />
agenziale basata su piattamatematici<br />
ed equazioni predeterminate.<br />
Nel campo dell’analisi delle<br />
immagini le reti neurali possono<br />
infatti essere efficacemente<br />
addestrate per individuare o<br />
classificare oggetti specifici, ad<br />
esempio, attraverso l’analisi delle<br />
sole caratteristiche geometriche,<br />
cromatiche, tessiturali etc.<br />
Il progetto di Arpa Piemonte si è<br />
posto l’obiettivo di definire una<br />
metodologia di analisi integrata<br />
con strumenti di remote sensing,<br />
GIS ed Intelligenza artificiale<br />
per l’analisi e classificazione<br />
automatica di immagini aeree<br />
disponibili su scala regionale. La<br />
metodologia MAIA ha portato<br />
allo sviluppo di un modello di<br />
rete neurale in grado apprendere,<br />
riconoscere e classificare coperture<br />
con potenziale presenza<br />
di amianto, attraverso l’analisi<br />
multitemporale di più serie di<br />
ortoimmagini.<br />
La procedura si basa su una<br />
fase preliminare che prevede la<br />
preparazione dei dati (raccolta,<br />
elaborazione e strutturazione di<br />
tutti i dati di input necessari),<br />
la progettazione e l’allestimento<br />
dell’infrastruttura, lo sviluppo degli<br />
strumenti e dei modelli di calcolo<br />
con reti neurali e una fase di<br />
applicazione del modello su scala<br />
regionale suddivisa in più stadi:<br />
• Addestramento: fasi di<br />
ricerca dei campioni (training<br />
set), addestramento<br />
della rete neurale, valutazione<br />
e ottimizzazione delle<br />
prestazioni.<br />
• Classificazione: preparazione<br />
dei dati di input e applicazione<br />
della rete neurale<br />
sull’intera area di studio.<br />
• Verifica dei dati: integrazione<br />
ed elaborazione dei<br />
risultati in ambiente GIS,<br />
verifica e correzione tramite<br />
fotointerpretazione<br />
• Analisi dei risultati: analisi<br />
statistica dei dati, valutazione<br />
delle performance<br />
Dati di input e strumenti<br />
Per l’addestramento del modello<br />
su base multitemporale sono<br />
state utilizzate tutte le ortoimmagini<br />
disponibili su scala regionale<br />
nel periodo di riferimento ed<br />
in particolare le riprese del volo<br />
regionale ICE del 2010 [2], le<br />
riprese AGEA 2015, 2018 e le<br />
più recenti immagini disponibili<br />
sul territorio regionale del servizio<br />
Google Maps (date variabili<br />
2018-2020, "Map data ©<br />
2018,2019,2020 Google").<br />
L’obiettivo di tale approccio è<br />
duplice: seguire e monitorare nel<br />
tempo le trasformazioni delle coperture,<br />
ricostruendo così su tutto<br />
il territorio regionale lo stesso<br />
quadro di conoscenza e riferimento<br />
temporale, e minimizzare<br />
i potenziali errori di classificazione<br />
introdotti dalla variabilità delle<br />
singole immagini appartenenti<br />
alla stessa ripresa fotogrammetrica<br />
(ombre, coperture arboree,<br />
problemi di ortorettifica, etc ...).<br />
Il livello di riferimento adottato<br />
per l’individuazione vettoriale<br />
delle impronte degli edifici su<br />
scala regionale è il dataset delle<br />
Fig. 3 – Grafici relativi al monitoraggio risultati nella<br />
fase di addestramento della rete neurale (in alto si vede<br />
l’accuratezza di uno dei modelli utilizzati superiore al<br />
95% e in basso la valutazione degli errori compiuti dal<br />
modello vicino allo 0%).<br />
<strong>GEOmedia</strong> n°6-<strong>2021</strong> 7
FOCUS<br />
Fig. 4 - Esempio di evoluzione delle coperture nel tempo e casi di potenziale bonifica intercorsi tra<br />
2010 e 2015.<br />
forma Esri (ArcGISPro, ArcGIS<br />
Enterprise, ArcGIS Online).<br />
Per l’estrazione delle porzioni<br />
di immagini utilizzate in fase di<br />
training e classificazione è stato<br />
utilizzato anche il software Qgis<br />
ed in particolare la funzione del<br />
layout di stampa denominata<br />
Atlante.<br />
La rete neurale è stata invece<br />
implementata con Keras[4],<br />
un framework per Python che<br />
permette di definire e addestrare<br />
vari tipi di modelli di deep learning.<br />
Keras consente di eseguire lo<br />
stesso codice utilizzando diverse<br />
librerie di basso livello<br />
(Tensorflow, Theano, CNTK,<br />
…). Nel presente progetto sperimentale<br />
Arpa ha adottato la<br />
libreria Tensorflow utilizzando il<br />
modello denominato VGG16,<br />
appartenente alla categoria delle<br />
Convolutional Neural Network<br />
[5] specializzate nella classificazione<br />
delle immagini.<br />
Applicazione modello MAIA<br />
a scala regionale<br />
Addestramento<br />
L’addestramento è la fase in cui<br />
la rete neurale impara a svolgere<br />
il compito per cui è stata progettata,<br />
a partire dall’analisi dei<br />
campioni di training set.<br />
Occorre quindi definire e predisporre<br />
i training set attraverso la<br />
selezione di un numero significativo<br />
di campioni di immagini sia<br />
di coperture contenenti amianto,<br />
sia realizzate con altri materiali<br />
(tegole, coppi, lamiere, etc.).<br />
Grazie al lavoro di mappatura e<br />
verifica in campo già realizzato<br />
negli anni precedenti è stato<br />
possibile selezionare dalla banca<br />
dati un numero consistente di<br />
coperture in amianto accertate<br />
ed estrarre da questi i relativi<br />
campioni di immagini a partire<br />
dalle singole serie di ortofoto di<br />
riferimento.<br />
La preparazione dei campioni<br />
di immagini del training set<br />
prevedere l’estrazione di una immagine<br />
quadrata (chips) di 10m<br />
x 10m (Fig. 1) per ciascun punto<br />
centroide rispetto alla copertura<br />
dell’edificio.<br />
Per la preparazione dei training<br />
set relativi a coperture non<br />
contenenti amianto sono stati<br />
identificati campioni rappresentativi<br />
di tetti realizzati con i più<br />
svariati materiali (tetti in tegole,<br />
lamiere, materiali verniciati, rivestimenti<br />
bituminati, pannelli<br />
solari, etc.) e di immagini di<br />
porzioni di terreno libero: prati,<br />
strade, campi coltivati, campi<br />
sportivi, etc… (Fig. 2).<br />
Nel corso del progetto è emersa<br />
inoltre la necessità di fornire ulteriori<br />
campioni di training utili<br />
alla differenziazione di particolari<br />
coperture tipiche di molte aree<br />
collinari e montane realizzate<br />
con materiali litoidi. Tali coperture,<br />
infatti, possono risultare a<br />
livello di ortoimmagini di medio<br />
dettaglio, molto simili alle coperture<br />
in amianto, introducendo<br />
errori nelle fasi di training e<br />
classificazione.<br />
Complessivamente sono stati<br />
creati tre training set (coperture<br />
in MCA, coperture senza MCA,<br />
coperture in materiali litoidi) per<br />
ciascuna serie temporale delle<br />
ortoimmagini di riferimento,<br />
ciascuno contenente oltre 1000<br />
campioni.<br />
In fase di addestramento si vanno<br />
a tarare progressivamente i<br />
diversi parametri in modo da ottimizzare<br />
la risposta della rete.<br />
Tale attività comporta più cicli<br />
di analisi e di valutazione del<br />
livello di accuratezza dei risultati<br />
ottenuti attraverso il confronto<br />
tra immagini di training e immagini<br />
di test.<br />
L’addestramento ottimale di una<br />
rete prevede l’utilizzo di enormi<br />
quantità di dati e ingenti capacità<br />
di elaborazione. Per ridurre<br />
almeno in parte queste necessità<br />
è stata utilizzata la tecnica denominata<br />
fine tuning [6] [7], che<br />
consiste nell’utilizzare i pesi (cioè<br />
i parametri utilizzati dalle reti per<br />
effettuare le elaborazioni) di un<br />
modello già addestrato a riconoscere<br />
diverse tipologie di oggetti<br />
(Fig. 3). Le reti neurali procedono<br />
su livelli di elaborazione in<br />
sequenza: nel modello sono stati<br />
modificati i 4 livelli finali per<br />
adattarli alle esigenze progettuali<br />
e addestrando quest’ultimi a riconoscere<br />
solo due tipologie di<br />
classi principali (tetti con MCA<br />
e tetti senza MCA).<br />
Al fine di ottimizzare la classificazione<br />
di immagini tramite rete<br />
neurale e per evitare il fenomeno<br />
di over fitting (cioè il problema<br />
che si può verificare quando la<br />
rete impara a riconoscere solo<br />
le immagini su cui è stata addestrata<br />
a causa, ad esempio, di<br />
uno scarso numero di campioni<br />
8 <strong>GEOmedia</strong> n°6-<strong>2021</strong>
FOCUS<br />
Fig. 5 - Esempio dell’applicazione WebGIS per l’editing multitemporale (dall’alto in basso le 4 schermate con ortofoto 2010-2015-<br />
2018 e 2020 "Map data © 2020 Google")<br />
forniti) sono state adottate due<br />
tecniche: data augmentation<br />
(prevede la modifica delle immagini<br />
durante l’addestramento<br />
con algoritmi specifici al fine di<br />
aumentare in modo considerevole<br />
il numero di immagini a<br />
disposizione) e dropout (consiste<br />
nell’ignorare in modo casuale<br />
alcune fasi del modello durante<br />
l’addestramento).<br />
Classificazione<br />
Terminato l’addestramento è stata<br />
avviata la classificazione automatica<br />
di tutti gli edifici presenti<br />
sul territorio regionale attraverso<br />
due procedure distinte.<br />
La prima, prevede l’applicazione<br />
della metodologia su Resto<br />
Regione, quindi, l’estensione<br />
della mappatura su tutto il territorio<br />
regionale esterno all’area<br />
prioritaria (oltre 15.000 kmq);<br />
ha comportato un complesso<br />
processo computazionale suddiviso<br />
su più catene di calcolo<br />
in grado di elaborare milioni<br />
di immagini riferite ai singoli<br />
edifici (otre 1.300.000 unità)<br />
per ciascun anno di riferimento<br />
temporale.<br />
La seconda, consiste nell’applicazione<br />
sull’Area Prioritaria cioè<br />
l’applicazione del modello per<br />
il monitoraggio delle trasformazioni<br />
relative a tutte le coperture<br />
in amianto già verificate in<br />
campo con sopralluogo da parte<br />
dei Dipartimenti nel periodo<br />
2013-2020, per un totale di oltre<br />
41.000 punti.<br />
Il processo generale di classificazione<br />
ha restituito per ciascun<br />
edificio analizzato e per ciascun<br />
anno di riferimento, un indice<br />
numerico (variabile tra 0 ed 1)<br />
rappresentativo della probabilità<br />
di appartenenza alla classe delle<br />
coperture con presenza amianto.<br />
Terminata la fase di calcolo, i risultati<br />
prodotti dalla rete neurale<br />
sono stati rielaborati in ambiente<br />
GIS e quindi analizzati al fine<br />
di definire valori soglia e range<br />
di attendibilità differenti per<br />
ciascuno anno di riferimento, in<br />
base alle differenti caratteristiche<br />
spaziali, spettrali e tessiturali delle<br />
diverse serie di ortoimmagini<br />
utilizzate.<br />
Definiti i valori soglia, i risultati<br />
sono stati rielaborati associando<br />
ad ogni edificio e per ciascun<br />
anno di riferimento, la classificazione<br />
finale:<br />
• copertura con potenziale<br />
presenza di amianto<br />
• copertura senza amianto.<br />
Dal confronto multitemporale<br />
dei dataset sono inoltre stati<br />
indentificati range di valori e<br />
combinazioni degli stessi utili a<br />
identificare possibili trasformazioni<br />
delle coperture nel tempo.<br />
Ciò ha consentito di introdurre<br />
una nuova classe riferita alle potenziali<br />
bonifiche intercorse nel<br />
periodo di riferimento.<br />
Ad esempio, nel caso di una copertura<br />
positiva nel 2010 (valori<br />
indice alti e quindi classificata<br />
come “copertura con potenziale<br />
presenza di amianto”), ma negativa<br />
nel 2015, 2018 e 2020<br />
(indice basso e quindi classificata<br />
in quegli anni come “copertura<br />
senza amianto”), la metodologia<br />
prevede la segnalazione e riclassificazione<br />
della copertura come<br />
“potenziale bonifica” (Fig. 4).<br />
In questo modo è possibile<br />
ricomporre un quadro cronologico<br />
coerente su scala regionale<br />
<strong>GEOmedia</strong> n°6-<strong>2021</strong> 9
FOCUS<br />
in grado di mettere a confronto<br />
i dati della prima fase della mappatura<br />
regionale in area prioritaria<br />
con quelli della nuova mappatura<br />
sul resto della Regione<br />
nel decennio 2010-2020.<br />
Inoltre, si possono identificare<br />
non solo le coperture ad oggi<br />
contenenti cemento-amianto,<br />
ma anche quelle che negli ultimi<br />
dieci anni hanno dato evidenza<br />
di potenziale presenza di MCA e<br />
su cui sono state effettuate operazioni<br />
di bonifica e quindi avere<br />
un quadro complessivo delle<br />
attività di riduzione dell’amianto<br />
in Piemonte.<br />
Infine, la procedura consente<br />
di disporre di dati storici su<br />
presenza di potenziali bonifiche<br />
rilevanti, per volumi coinvolti o<br />
situazioni di particolare vulnerabilità<br />
territoriale, su cui eventualmente<br />
effettuare indagini<br />
circa modalità e tempistiche dei<br />
lavori di bonifica.<br />
Verifica dati e collaudo<br />
A partire dai risultati della fase<br />
di classificazione è stata avviata<br />
l’attività di validazione dei<br />
risultati tramite verifica con<br />
fotointerpretazione. Le attività<br />
di correzione e integrazione sono<br />
state realizzate attraverso editing<br />
geografico sul 100% dei risultati<br />
da modello (circa 86.000 punti).<br />
L’attività ha permesso così di migliorare<br />
e consolidare la classificazione<br />
finale degli edifici ed eliminare<br />
dai risultati un numero<br />
significativo di casi catalogabili<br />
come “falsi positivi”. Tali casi,<br />
Tab. 1<br />
PERCENTUALI<br />
VERITÀ<br />
CAMPIONE<br />
STATISTICO<br />
Verità<br />
Amianto<br />
Verità<br />
bonificati<br />
Verità Falso<br />
Positivo<br />
Previsti<br />
come già evidenziato durante la<br />
fase di messa a punto metodologica,<br />
sono riconducibili in gran<br />
parte a problemi locali di consistenza<br />
e georeferenziazione degli<br />
edifici cartografati in BDTRE o<br />
dall’impossibilità di disporre di<br />
un corretto allineamento degli<br />
stessi rispetto alle varie serie di<br />
ortoimmagini utilizzate dalla<br />
metodologia.<br />
Tenuto conto della dimensione<br />
dei dati su cui effettuare la verifica<br />
e della necessità di accedere<br />
a strumenti a supporto della<br />
fotointerpretazione e dell’editing<br />
multitemporale anche da remoto,<br />
è risultato indispensabile progettare<br />
una piattaforma idonea<br />
basata su servizi ed applicazioni<br />
web oriented fruibili anche da<br />
postazioni di lavoro “leggere”.<br />
È stata pertanto sviluppata una<br />
applicazione web basata su API<br />
JS per ArcGIS che consente l’editing<br />
geografico e alfanumerico<br />
attraverso 4 finestre contemporanee<br />
e sincronizzate, ciascuna<br />
riportante i feature services e le<br />
ortofoto dei relativi anni di riferimento<br />
(Fig. 5).<br />
Per garantire il monitoraggio<br />
dell’avanzamento lavori e definire<br />
modifiche alla pianificazione<br />
effettuata è stata sviluppata<br />
un’apposita dashboard di analisi<br />
in tempo reale, in grado di fornire<br />
lo stato di lavorazione delle attività<br />
di verifica totali per singolo<br />
fotointerprete e i dati inerenti<br />
alla quantità e tipo di correzioni<br />
effettuate sul dataset originario<br />
(Fig. 6).<br />
ESITO MODELLO MAIA<br />
Previsti<br />
Falso<br />
Amianto Bonificati Positivo<br />
95,9 2,6 1,5 100.0<br />
11,8 88,2 0,0 100,0<br />
12,5 0,8 86,7 100,0<br />
Analisi statistica e documentazione<br />
dei risultati<br />
La fase finale della metodologia<br />
prevede la verifica e il collaudo<br />
statistico dei dati al fine di valutare<br />
quantitativamente l’accuratezza<br />
e l’attendibilità dei risultati<br />
ottenuti dalla metodologia.<br />
A tal fine dal dataset inziale dei<br />
risultati dell’Area di indagine<br />
(resto regione) è stato pertanto<br />
estratto un campione statistico<br />
casuale di 384 punti corrispondente<br />
ad un livello di confidenza<br />
del 95% con un intervallo di<br />
confidenza del 5%[8].<br />
Su questo campione è stata<br />
quindi avviata l’attività di collaudo<br />
tramite verifica puntuale<br />
dei risultati attraverso una nuova<br />
fase di fotointerpretazione. Per<br />
ciascun punto è stato quindi registrato<br />
l’esito del collaudo.<br />
Gli esiti sono stati quindi rielaborati<br />
per calcolare le percentuali<br />
di accuratezza su ciascuna<br />
classe (Tab. 1).<br />
L’analisi di tipo statistico fornisce<br />
chiaramente una prima<br />
valutazione dell’accuratezza del<br />
lavoro effettuato nell’applicare<br />
la metodologia in tutte le sue<br />
fasi: la verifica stessa dei risultati<br />
è basta su fotointerpretazione e<br />
quindi anche gli errori riscontrati<br />
sono di fatto interpretati attraverso<br />
la sola lettura del territorio<br />
da immagini telerilevate a media<br />
risoluzione.<br />
Analizzando i risultati inerenti la<br />
classe dei punti con potenziale<br />
presenza di amianto la percentuale<br />
di accuratezza è risultata<br />
del 95,9%.<br />
Nel 2,6% dei casi in cui il modello<br />
ha fornito indicazioni di<br />
potenziale bonifica la verifica ha<br />
indicato presenza di amianto:<br />
tali casi seppur percentualmente<br />
minimi non incidono sul risultato<br />
atteso finale, individuando<br />
comunque coperture su cui si<br />
intende indirizzare l’attività di<br />
verifica con sopralluogo. Solo<br />
l’1.5% dei casi riguarda invece<br />
10 <strong>GEOmedia</strong> n°6-<strong>2021</strong>
FOCUS<br />
situazioni in cui in cui il modello<br />
non ha individuato coperture<br />
con amianto rispetto alla realtà<br />
riscontrata con il controllo finale.<br />
Per quanto concerne la classe<br />
delle potenziali bonifiche la<br />
percentuale di accuratezza netta<br />
risulta pari all’88,2%. Tale valore<br />
apparentemente inferiore<br />
ai valori di accuratezza registrati<br />
sulle coperture in amianto, va<br />
però analizzato congiuntamente<br />
alle altre percentuali riportate in<br />
tabella: l’11,8 % dei punti non<br />
classificati come bonifica rientrano<br />
infatti nella classe delle coperture<br />
con amianto, mentre la<br />
percentuale di erronea classificazione<br />
(copertura non in amianto<br />
o falso positivo) è pari allo 0%.<br />
Ciò significa che la totalità dei<br />
casi (100%) indica comunque la<br />
presenza di amianto ad una certa<br />
data, fornendo quindi una corretta<br />
indicazione per lo svolgimento<br />
delle attività di sopralluogo<br />
e verifica in campo da parte<br />
dei Dipartimenti Territoriali.<br />
Risultati<br />
L’applicazione della metodologia<br />
MAIA per l’estensione e il<br />
completamento della mappatura<br />
sulla scala regionale ha permesso<br />
di individuare circa 33.000 nuovi<br />
edifici di cui circa 27.000 con<br />
attuale presenza di MCA.<br />
Attraverso l’analisi multitemporale<br />
la metodologia ha consentito<br />
di identificare inoltre<br />
circa 6200 casi di coperture che<br />
hanno subito nell’arco temporale<br />
considerato (2010-2020), delle<br />
trasformazioni legate a potenziali<br />
processi di bonifica.<br />
Sono state riscontrate molte<br />
situazioni, anche con caratteristiche<br />
dimensionali rilevanti<br />
(coperture industriali di migliaia<br />
di mq), che allo stato attuale<br />
sarebbero difficilmente rilevabili<br />
con le sole attività di verifica in<br />
campo in quanto ormai totalmente<br />
rinnovate e senza traccia<br />
delle situazioni pregresse.<br />
Fig. 6 - Esempio di dashboard per il monitoraggio in tempo reale delle attività di verifica dei risultati.<br />
Ciò consente da una parte di<br />
avere elementi di conoscenza<br />
utili a valutare i procedimenti di<br />
bonifica attuati, dall’altra di ricostruire<br />
e aggiornare nel tempo<br />
un quadro di riferimento dello<br />
stato del territorio e delle sue<br />
evoluzioni.<br />
L’applicazione della metodologia<br />
all’interno dell’area prioritaria<br />
già oggetto della prima mappatura<br />
si è posta invece l’obiettivo<br />
di individuare potenziali cambiamenti<br />
intercorsi sulle coperture<br />
in amianto già verificate da parte<br />
di Arpa negli anni passati.<br />
Tale ipotesi progettuale nasce dal<br />
fatto che tali coperture possono<br />
aver subito, in data successiva al<br />
controllo in campo, trasformazioni<br />
e bonifiche non segnalate o<br />
non ancora verificate.<br />
Attraverso l’applicazione del modello<br />
MAIA su ortofoto di anni<br />
diversi è stato possibile analizzare<br />
e confrontare l’evoluzione nel<br />
tempo degli indici di probabilità<br />
di presenza di amianto sulla<br />
stessa copertura ed individuare<br />
così i casi potenziali di bonifica o<br />
rimozione dell’edificio.<br />
In questo modo sono stati identificati<br />
circa 4.900 casi di nuove<br />
potenziali bonifiche ed è stata<br />
confermata la presenza di MCA<br />
su oltre 36.400 coperture. I successivi<br />
sopralluoghi e controlli<br />
in campo da parte dei tecnici<br />
dell’Agenzia potranno confermare<br />
o meno il processo di bonifica<br />
dell’amianto e aggiornare il<br />
quadro di conoscenza sullo stato<br />
della presenza dell’amianto su<br />
base regionale.<br />
A termine dei lavori, tutti i risultati<br />
sono stati quindi elaborati<br />
ed integrati nel geodatabase del<br />
Sistema Informativo Mappatura<br />
Amianto [9] e messi a disposizione<br />
dei dipartimenti territoriali<br />
per l’avvio delle nuove fasi di<br />
sopralluogo, verifica e analisi.<br />
Conclusioni<br />
L’esperienza maturata in<br />
Piemonte negli anni ha dimostrato<br />
le potenzialità e l’efficacia<br />
del telerilevamento e delle<br />
tecnologie di analisi GIS, quali<br />
strumenti fondamentali per l’analisi<br />
speditiva su vasta scala e in<br />
particolare per i processi di mappatura<br />
a scala regionale, come<br />
richiesto dalla normativa vigente.<br />
Il processo di riconoscimento e<br />
classificazione delle coperture in<br />
cemento amianto, sia in loco e<br />
ancor più da telerilevamento, è<br />
tuttavia fortemente condizionato<br />
dalla complessità e dall’estrema<br />
variabilità delle differenti<br />
tipologie di prodotti e materiali<br />
impiegati in edilizia nel corso dei<br />
decenni. Per tali motivi, anche<br />
<strong>GEOmedia</strong> n°6-<strong>2021</strong> 11
FOCUS<br />
durante le attività di sopralluogo<br />
per la verifica in campo delle<br />
coperture è frequente la necessita<br />
di dover ricorrere, oltre all’analisi<br />
visiva e fisico-meccanica, a specifici<br />
campionamenti e successive<br />
analisi chimico-fisiche di laboratorio<br />
per accertare con sicurezza<br />
la presenza dei minerali asbestiformi<br />
nei materiali.<br />
Ciononostante, quanto realizzato<br />
nello sviluppo del modello<br />
MAIA, dimostra come l’utilizzo<br />
integrato del remote sensing e<br />
delle nuove tecnologie di deep<br />
learning possano aprire possibilità<br />
e scenari di analisi assolutamente<br />
sorprendenti.<br />
La capacità delle reti neurali di<br />
apprendere e analizzare in modo<br />
massivo grandi moli di dati, attraverso<br />
la sola lettura di immagini,<br />
consente di attuare processi<br />
di analisi che per dimensioni e<br />
scala non sarebbero altrimenti<br />
attuabili con metodi tradizionali.<br />
Selezionare e discriminare fra<br />
milioni di oggetti permette di<br />
aumentare la capacità predittiva<br />
e di individuare quelle tipologie<br />
di coperture su cui concentrare<br />
le verifiche, guidando in modo<br />
mirato e più efficiente le campagne<br />
di controllo in campo.<br />
Il progetto, realizzato con sole<br />
risorse interne e senza investimenti<br />
aggiuntivi, ha permesso<br />
di completare in tempi molto<br />
ridotti la mappatura sull’intero<br />
territorio regionale e di impostare<br />
un modello per il monitoraggio<br />
periodico dei processi di<br />
bonifica.<br />
In questo senso riteniamo che<br />
il lavoro effettuato e i risultati<br />
raggiunti rappresentino oltre che<br />
un modello innovativo di ricerca<br />
applicata replicabile anche in<br />
altre realtà regionali, uno strumento<br />
fondamentale per l’azione<br />
di Arpa e più in generale per il<br />
perseguimento degli obiettivi<br />
definiti dal Piano Regionale<br />
Amianto.<br />
RIFERIMENTI E SITOGRAFIA<br />
Piano regionale Amianto: https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/ambiente/amianto-bonifiche-terre-rocce-scavo/amianto<br />
Regione Piemonte: Ripresa Aerea Ice 2009-2011 Ortofoto RGB e NIR: http://www.<br />
geoportale.piemonte.it/geocatalogorp/?sezione=catalogo<br />
http://www.geoportale.piemonte.it/geonetworkrp/srv/ita/metadata.show?uuid=r_<br />
piemon:ec27a3da-2bd8-4f7d-8905-3ac28f488943<br />
Regione Piemonte - BDTRE: https://www.geoportale.piemonte.it/cms/bdtre/bdtre-2<br />
Keras - https://keras.io/<br />
https://www.sciencedirect.com/topics/computer-science/convolutional-neural-networks<br />
https://learnopencv.com/keras-tutorial-fine-tuning-using-pre-trained-models/<br />
https://keras.io/guides/transfer_learning/<br />
https://www.quadernodiepidemiologia.it/epi/campion/dimens.htm<br />
https://webgis.arpa.piemonte.it/amianto_storymap_webapp/<br />
BIBLIOGRAFIA<br />
BONANSEA E., 2018 - “Il Progetto di mappatura dell’amianto in Piemonte” in<br />
ECOSCIENZA, Volume 1 - Anno 2018, edito da Arpa Emilia Romagna, marzo<br />
2018<br />
Radovic, M.; Adarkwa, O.; Wang, Q. “Object Recognition in Aerial Images Using<br />
Convolutional Neural Networks.” J. Imaging 2017, 3, 21. https://doi.org/10.3390/<br />
jimaging3020021<br />
Pirotti, F., Zanchetta, C., Previtali, M., and Della Torre, S.: DETECTION OF<br />
BUILDING ROOFS AND FACADES FROM AERIAL LASER SCANNING<br />
DATA USING DEEP LEARNING, Int. Arch. Photogramm. Remote Sens. Spatial<br />
Inf. Sci., XLII-2/W11, 975–980, https://doi.org/10.5194/isprs-archives-XLII-<br />
2-W11-975-2019, 2019.<br />
Partovi, Tahmineh und Fraundorfer, Friedrich und Azimi, Seyedmajid und Marmanis,<br />
Dimitrios und Reinartz, Peter (2017) Roof Type Selection based on patch-based classsification<br />
using deep learning for high Resolution Satellite Imagery. In: International<br />
Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences -<br />
ISPRS Archives, XLII-1 (W1), Seiten 653-657. Copernicus Publications. ISPRS Hannover<br />
Workshop: HRIGI 17, 06.-09. Juni 2017, Hannover, Germany. doi: 10.5194/<br />
isprs-archives-XLII-1-W1-653-2017.<br />
Francois Chollet - Deep learning with python, Novembre 2017<br />
PAROLE CHIAVE<br />
Intelligenza Artificiale; Sistemi Informativi; Ortofoto; Amianto<br />
ABSTRACT<br />
In 2013 Arpa Piemonte launched a first mapping of buildings potentially containing<br />
asbestos cement that identified over 120.000 roofs in the most densely populated<br />
areas of Regione Piemonte. The map was based on supervised image classification<br />
techniques and traditional photo interpretation.<br />
In 2020 (based on an experimental activity launched in 2019), Arpa Piemonte created<br />
and applied a model called MAIA (Mapping of Asbestos with GIS and Artificial Intelligence<br />
techniques) aimed at extending the mapping started in 2013 to the whole Piemonte<br />
area and including the monitoring of asbestos roofs transformation over time,<br />
already subjected to inspection, located in the areas analyzed in the first mapping.<br />
MAIA has identified over 26.600 new buildings on a regional scale with potential<br />
presence of asbestos and over 6.200 buildings whose roofs have undergone, potential<br />
remediation processes between 2010 and 2020. In the area already subjected to<br />
inspection, the model confirmed the presence of asbestos in over 36.400 roofs and it<br />
has identified over 4.900 cases of new potential remediation.<br />
AUTORE<br />
Enrico Bonansea, Luca Forestello*, Ivan Cerato, Manuela Livorno, Gabriele<br />
Nicolò, Fulvio Raviola, Isabella Tinetti, Teo Ferrero, Roberto Cassulo, Marcella<br />
Alibrando, Massimiliano Carrino, Stefano Masera, Maria Cristina Prola<br />
*Autore corrispondente: l.forestello@arpa.piemonte.it<br />
Arpa Piemonte - Sistema Informativo Ambientale e Geografico, Comunicazione e<br />
Educazione Ambientale<br />
12 <strong>GEOmedia</strong> n°6-<strong>2021</strong>
FOCUS<br />
<strong>GEOmedia</strong> n°6-<strong>2021</strong> 13
INTERVISTA<br />
Interviste ad alcuni responsabili<br />
di IDT regionali: presente e<br />
prospettive<br />
a cura di Franco Vico<br />
Le infrastrutture di dati geografici di livello<br />
regionale sono un tassello fondamentale nel<br />
sistema complessivo di produzione, catalogazione,<br />
distribuzione dell’informazione geografica. Questo<br />
è certamente vero in Italia, ma anche in altri paesi<br />
europei. Le regioni hanno le capacità finanziarie e<br />
tecniche necessarie, quelle capacità che spesso<br />
mancano ai livelli sotto-ordinati, ad es. ai comuni.<br />
Mentre il livello nazionale è più lontano dal territorio e<br />
ha altri ruoli.<br />
Con questo in mente, abbiamo chiesto ai responsabili<br />
di alcune IDT regionali di parlarci delle loro<br />
esperienze, presentandole nella loro realtà concreta.<br />
In questo numero sono pubblicate le interviste<br />
relative alle Regioni Basilicata, Lazio e Lombardia,<br />
mentre le interviste relative alle Regioni Veneto e<br />
Piemonte sono già state pubblicate nel numero<br />
5/<strong>2021</strong> di <strong>GEOmedia</strong> (https://www.yumpu.com/<br />
it/document/read/66063687/geomedia-5-<strong>2021</strong>).<br />
Abbiamo anche chiesto ai responsabili delle IDT,<br />
parlandoci delle loro esperienze, di confrontarsi con<br />
i “punti di convergenza” del dibattito internazionali<br />
sul futuro delle Spatial Data Infrastructure, individuati<br />
nell’articolo Oltre le SDI: quali prospettive, pubblicato<br />
sullo stesso numero 5/<strong>2021</strong> di <strong>GEOmedia</strong>. Questo<br />
ha fatto sì che le domande che abbiamo rivolto ai<br />
responsabili delle 5 IDT, siano state più o meno<br />
sempre le stesse. Anche l’ordine delle domande è<br />
più o meno sempre lo stesso. Tutto ciò dovrebbe<br />
rendere più facilmente confrontabili le interviste. E noi<br />
sappiamo che è il confronto che fa capire le cose.<br />
La Infrastruttura<br />
per l’Informazione<br />
Territoriale (IIT) della<br />
Regione Lombardia<br />
Colloquio con Fabio Conzi<br />
e Piera Belotti, Struttura<br />
SIT Integrato di Regione<br />
Lombardia<br />
<strong>GEOmedia</strong> (G):<br />
Cominciamo con un inquadramento<br />
della vostra<br />
esperienza nel suo contesto.<br />
Regione Lombardia<br />
(RL): La Lombardia<br />
con la l.r. 12/2005 per il<br />
Governo del Territorio è<br />
stata tra le prime a sviluppare<br />
l’embrione (ovvero<br />
il SIT) di quella che poi<br />
sarebbe stata istituita dalla<br />
Direttiva INSPIRE/2007<br />
quale “Infrastruttura<br />
per l’Informazione<br />
Territoriale” (IIT), che<br />
costituisce la base dati per<br />
la progettazione del Piano<br />
Territoriale Regionale,<br />
strumento di attuazione<br />
territoriale della strategia<br />
regionale di sviluppo<br />
sostenibile inserita nel<br />
programma regionale<br />
di sviluppo (PRS). Dal<br />
punto di vista organizzativo<br />
l’IIT si colloca nella<br />
Direzione competente in<br />
materia urbanistico-edilizia,<br />
ed è stata concepita<br />
per sostenere le politiche<br />
regionali di governo e<br />
sviluppo del territorio,<br />
attraverso svariati strumenti/servizi<br />
rivolti ad<br />
una pluralità di utenti,<br />
in particolare ai professionisti<br />
e agli enti locali<br />
che pianificano le scelte<br />
di sviluppo urbanistico a<br />
scala locale. Basti pensare<br />
al fatto che tutti i piani<br />
urbanistici per il governo<br />
14 <strong>GEOmedia</strong> n°6-<strong>2021</strong>
INTERVISTA<br />
del territorio e gli studi<br />
di settore vengono<br />
raccolti all’interno<br />
del medesimo Portale<br />
“Multiplan” accessibile<br />
a tutti, dai regolamenti<br />
edilizi comunali ad<br />
altri servizi che interoperano<br />
con sistemi<br />
terzi, tra cui merita<br />
citare il “Cruscotto<br />
delle Emergenze” condiviso<br />
con i soggetti<br />
preposti al soccorso/<br />
sicurezza e protezione<br />
civile. I servizi geografici<br />
realizzati dalla IIT<br />
lombarda supportano<br />
anche applicazioni<br />
verticali in uso presso<br />
altre Direzioni, quali<br />
la D.G. Welfare (applicazioni<br />
geografiche<br />
per il sistema veterinario<br />
e a supporto della<br />
prevenzione), la D.G.<br />
Formazione e Lavoro<br />
(applicativi di supporto<br />
all’offerta formativa<br />
e sistema duale alternanza<br />
scuola lavoro),<br />
la DG Infrastrutture<br />
(sistema della mobilità<br />
e dei trasporti),<br />
la DG Ambiente e<br />
Clima (es. gestione<br />
istanze di VIA), la DG<br />
Agricoltura (applicativi<br />
gestionali di ambito<br />
agro-ambientale).<br />
Tecnologicamente<br />
l’attuale IIT lombarda<br />
si fonda sulla piattaforma<br />
“Regional<br />
Enterprise platform<br />
for Geographic<br />
Information Services”<br />
(REGIS) offrendo servizi<br />
digitali geografici<br />
alla PA, ai professionisti<br />
alle imprese e<br />
ai cittadini, grazie al<br />
supporto della propria<br />
società in house ARIA<br />
Spa.<br />
Per garantire prodotti<br />
e servizi necessari, sia<br />
internamente a Regione<br />
sia agli enti collegati<br />
del territorio, la scelta<br />
è ricaduta molti anni fa<br />
sulla piattaforma ESRI<br />
che assicura un sistema<br />
scalabile, affidabile e<br />
basato su standard di<br />
mercato. Di recente si è<br />
aperto anche al mercato<br />
Open Source, ad es.<br />
predisponendo la distribuzione<br />
del Database<br />
Topografico in formato<br />
gpkg (Geopackage) che<br />
permette di superare le<br />
considerando che il<br />
concetto di utente<br />
unico assume sfumature<br />
differenti in funzione<br />
dello strumento<br />
di misura (in RL ci<br />
si avvale di Google<br />
Analytics per questo<br />
tipo di conteggio).<br />
Non essendo richiesta<br />
profilazione/registrazione<br />
per l’accesso<br />
al Geoportale, non<br />
siamo in grado di<br />
individuare con precisione<br />
le specifiche<br />
tipologie di utente,<br />
tuttavia sappiamo che<br />
‟La maggior parte<br />
dei dati della IIT è<br />
open, ad eccezione di<br />
informazioni che non<br />
sono di proprietà di<br />
Regione.<br />
limitazioni del formato<br />
shapefile, sviluppando<br />
un SW gratuito in via<br />
di sperimentazione,<br />
per predisporre gli elaborati<br />
del PGT.<br />
G: Un mantra del dibattito<br />
internazionale<br />
sulle infrastrutture di<br />
dati territoriali è “user<br />
centric”: che cosa sapete<br />
sugli utilizzatori<br />
della vostra IIT?<br />
RL: Gli utilizzatori<br />
sono circa 17.000<br />
nuovi utenti/mese,<br />
ma è più significativo<br />
l’elevato numero di<br />
accessi/mese, pari a<br />
circa 25.000/mese,<br />
‟<br />
si tratta - principalmente<br />
- di professionisti<br />
e tecnici degli<br />
Enti locali, studenti/<br />
ricercatori, imprese e<br />
grandi player di mercato.<br />
Altrettanto vale<br />
per quanto riguarda<br />
l’utilizzo dei dati: non<br />
si ha un quadro preciso,<br />
ma il feedback<br />
degli utenti che comunicano<br />
attraverso<br />
la casella mail “contattaci”<br />
consente di<br />
conoscerne la provenienza,<br />
con l’ulteriore<br />
vantaggio di migliorare<br />
il Geoportale o<br />
di rilevarne eventuali<br />
malfunzionamenti.<br />
Ad esempio, la de-<br />
cisione di predisporre<br />
“basi cartografiche<br />
semplificate” partendo<br />
dal DBT da utilizzare<br />
per la redazione degli<br />
elaborati della pianificazione<br />
è emersa<br />
proprio dalle proposte<br />
di tecnici/professionisti<br />
che operano in questo<br />
ambito.<br />
G: Anche colleghi di<br />
altre IDT regionali<br />
hanno rilevato questa<br />
contraddizione: la<br />
scelta della massima<br />
apertura, il fatto di<br />
non richiedere registrazione<br />
si porta dietro<br />
un effetto negativo, si<br />
conoscono poco utenti<br />
e utilizzi. Sono state<br />
comunque intraprese<br />
azioni specifiche per<br />
conoscere meglio utenti<br />
e utilizzi?<br />
RL: Stiamo valutando<br />
la riprogettazione del<br />
Geoportale per semplificarne<br />
l’utilizzo, ampliarne<br />
i servizi in base<br />
alle diverse tipologie di<br />
utenza, non rivolgendosi<br />
esclusivamente a<br />
tecnici comunali e professionisti.<br />
Più in specifico<br />
ogni anno viene<br />
svolta una “Customer<br />
Satisfaction Survey”,<br />
con la quale valutiamo<br />
la soddisfazione relativa<br />
a 5 parametri: trasparenza<br />
(la reperibilità<br />
delle informazioni sul<br />
servizio); accessibilità<br />
(la facilità di utilizzo<br />
del servizio); tempestività<br />
(tempi di risposta<br />
del servizio durante<br />
l’utilizzo per la ricerca,<br />
il caricamento e il<br />
download dei dati); efficacia<br />
(corrispondenza<br />
del servizio rispetto alle<br />
<strong>GEOmedia</strong> n°6-<strong>2021</strong> 15
INTERVISTA<br />
aspettative); assistenza<br />
(la qualità complessiva<br />
del servizio di assistenza).<br />
Le percentuali<br />
di soddisfazione sono<br />
tutte superiori all’80%;<br />
solo la valutazione della<br />
tempestività è un po’<br />
più bassa.<br />
G: Caratterizziamo i<br />
contenuti della IIT:<br />
quali sono i dataset<br />
presenti e quali i dataset<br />
più utilizzati?<br />
RL: I dataset più scaricati<br />
sono:<br />
4Carta Tecnica<br />
Regionale 1:10.000<br />
- CT10<br />
4Tavola delle<br />
Previsioni di Piano<br />
dei Piani di Governo<br />
del Territorio (a livello<br />
del comune)<br />
4Tavole piani territoriali<br />
coordinamento<br />
provinciali (PTCP)<br />
4Aree Protette<br />
4 Strade, ferrovie e<br />
metropolitane<br />
4Reticolo idrografico<br />
regionale unificato<br />
4Limiti amministrativi<br />
2020-<strong>2021</strong><br />
4Vincoli paesaggistici<br />
4Piano paesaggistico<br />
regionale<br />
4Piano di tutela e uso<br />
delle acque (PTUA<br />
2016)<br />
Con accesso dal singolo<br />
metadato:<br />
4Database<br />
Topografico (DBT)<br />
regionale: data di rilievo/aggiornamento<br />
4Direttiva Alluvioni<br />
2007/60/CE -<br />
Revisione 2020<br />
4Direttiva alluvioni<br />
2007/60/CE -<br />
Revisione 2015<br />
4Evoluzione temporale<br />
ortofoto<br />
4Mappe catastali<br />
4Carta Base da DBT<br />
(raster)<br />
4Aree Protette<br />
4Ortofoto AGEA<br />
2018<br />
4Uso e copertura del<br />
suolo 2018 (DUSAF<br />
6.0)<br />
4Reticolo Idrografico<br />
Regionale Unificato<br />
Tutti questi dati trovano<br />
corrispondenza<br />
nei temi INSPIRE: il<br />
Geoportale facilita la<br />
ricerca mettendo a<br />
disposizione la sezione<br />
delle categorie ISO e<br />
INSPIRE all’interno<br />
della quale è possibile<br />
utilizzare specifici filtri.<br />
G: Quali sono i servizi<br />
presenti e servizi più<br />
utilizzati?<br />
RL: Detto che la IIT<br />
di Regione Lombardia<br />
eroga oltre 700 servizi<br />
di mappa configurabili<br />
con tutti gli standard<br />
(es. WMS, WMTS,<br />
WFS), sono presenti<br />
tutti i servizi che ci<br />
si aspetta: servizio di<br />
consultazione del catalogo<br />
dei metadati;<br />
servizio di download<br />
dati vettoriali/raster;<br />
servizi OGC; Galleria<br />
delle mappe; statistiche<br />
del Geoportale, tool<br />
che evidenzia le parole<br />
chiave più usate.<br />
G: Nella costruzione<br />
di una IDT, in particolare<br />
al livello di una<br />
Regione, è normale<br />
scoprire che esistono<br />
dataset che in parte si<br />
sovrappongono, gestiti<br />
da soggetti diversi che<br />
non si parlano... Cosa<br />
state facendo in materia?<br />
RL: La “Struttura SIT<br />
Integrato” partecipa<br />
come rappresentante di<br />
RL agli incontri della<br />
Consulta Nazionale per<br />
l’Informazione Territoriale<br />
ed Ambientale<br />
(CNITA), che, attraverso<br />
diverse sezioni<br />
tecniche, ha ruolo di<br />
governance dell’informazione<br />
geografica<br />
a livello nazionale,<br />
rispondendo in primis<br />
alla direttiva INSPIRE;<br />
si sta attivando un coordinamento<br />
regionale<br />
in merito alla produzione<br />
di informazioni<br />
e dati cartografici tra<br />
tutti i soggetti che li<br />
detengono, partendo<br />
dalla mappatura delle<br />
competenze e delle<br />
materie delegate. Questo<br />
implica il raccordo<br />
con tutte le PA locali e<br />
le società controllate/<br />
partecipate lombarde<br />
che gestiscono dati<br />
geografici utili a tutti e<br />
che ancora non li condividono.<br />
G: Harvesting di dataset<br />
di altri soggetti PA<br />
(Comuni, ASL…)?<br />
RL: Scambiamo informazioni<br />
geografiche<br />
con tutte le PA lombarde<br />
(e non) tramite applicativi<br />
web ma anche<br />
manualmente, ai fini<br />
della messa a disposizione<br />
nel Geoportale<br />
o in aggiornamento di<br />
prodotti quali, ad es., il<br />
Database Topografico.<br />
Il DBT regionale di<br />
primo impianto è nato<br />
credendo in un modello<br />
“bottom up” fondato<br />
sulle capacità delle PA<br />
locali di gestire, attraverso<br />
consorzi, appalti<br />
di produzione con<br />
il co-finanziamento<br />
regionale. La frammentazione<br />
a volte ha funzionato<br />
bene, a volte<br />
meno, il risultato ha<br />
portato alla produzione<br />
parziale del DBT e alla<br />
disomogeneità nei contenuti<br />
e nella qualità,<br />
che si rileva osservando<br />
il DBT attuale. Non a<br />
caso si prevede di adeguarlo<br />
puntando anche<br />
ad un raccordo con il<br />
Catasto per future integrazioni<br />
tra le banche<br />
dati di rispettiva competenza.<br />
Purtroppo, a<br />
causa principalmente<br />
dell’endemica carenza<br />
di competenze (in particolare<br />
in ambito GIS)<br />
nelle PA, RL è dovuta<br />
intervenire per completare<br />
il DBT, e analoga<br />
azione verrà portata<br />
avanti con l’appalto per<br />
il suo aggiornamento,<br />
già programmato.<br />
Concludendo, la scala<br />
regionale è quella migliore<br />
per la produzione/aggiornamento<br />
di<br />
uno strumento come<br />
il DBT, ma è necessario<br />
coinvolgere le PA<br />
locali nella verifica dei<br />
contenuti, e in futuro<br />
nell’aggiornamento<br />
puntuale, partendo<br />
dalla necessaria diffusione<br />
delle competenze<br />
in ambito GIS. Un<br />
passo indietro per<br />
poterne fare uno più<br />
significativo in avanti.<br />
G: Chi finanzia e chi<br />
gestisce la IDT?<br />
16 <strong>GEOmedia</strong> n°6-<strong>2021</strong>
INTERVISTA<br />
RL: La copertura dei<br />
contratti di gestione<br />
e manutenzione evolutiva<br />
della IIT è in<br />
buona parte finanziata<br />
con risorse autonome.<br />
Grazie alla partecipazione<br />
a progetti della<br />
UE (Interreg, POR),<br />
si riesce ad intercettare<br />
risorse utili. La carenza<br />
maggiore si riscontra<br />
per le risorse umane<br />
e la formazione, con<br />
particolare riferimento<br />
all’attività di coordinamento<br />
e ai tavoli di<br />
lavoro citati in precedenza.<br />
G: Open data, qual è la<br />
situazione?<br />
RL: La maggior parte<br />
dei dati della IIT è<br />
open, ad eccezione di<br />
informazioni che non<br />
sono di proprietà di<br />
Regione. Di recente<br />
abbiamo modificato la<br />
licenza per i dati aperti<br />
in CC 4.0 internazionale.<br />
G: INSPIRE compliant:<br />
che cosa è stato<br />
fatto? Quanto rilevante<br />
in pratica è valutato<br />
questo aspetto?<br />
RL: Per quanto riguarda<br />
i metadati, si è<br />
lavorato per essere conformi<br />
alle specifiche<br />
INSPIRE almeno per<br />
quanto riguarda i priority<br />
dataset (come indicato<br />
da AgID/RNDT)<br />
in modo da contribuire<br />
all’harvesting annuale.<br />
Siamo consapevoli<br />
di che cosa si debba<br />
realizzare; dobbiamo<br />
investire molte risorse/<br />
attività nella creazione<br />
di servizi in quanto - al<br />
momento - disponiamo<br />
di molti servizi<br />
di consultazione che<br />
aggregano più livelli<br />
informativi (in questo<br />
caso il metadato non<br />
è associato al singolo<br />
dataset ma al servizio).<br />
Successivamente si<br />
dovrà investire nell’aggiornamento<br />
dei dati<br />
coinvolgendo i produttori<br />
dei dati e sull’armonizzazione.<br />
G: Si dice, non dati ma<br />
informazione. Quali<br />
tools di visualizzazione,<br />
analisi, simulazione…<br />
utili per rendere più facile,<br />
ma soprattutto più<br />
efficace l’uso dell’informazione<br />
geografica<br />
della IIT, avete messo<br />
in campo o state progettando?<br />
RL: Dal Geoportale si<br />
accede ai servizi della<br />
rete interregionale di<br />
stazioni permanenti<br />
GNSS (SPIN3 GNSS)<br />
che integra in un unico<br />
centro di gestione le<br />
stazioni di Piemonte,<br />
Lombardia e Valle d’Aosta,<br />
e fornisce all’utenza<br />
pubblica/privata<br />
il posizionamento di<br />
precisione e diffusione<br />
delle coordinate nel<br />
sistema di riferimento<br />
ufficiale.<br />
Abbiamo realizzato dei<br />
tools che consentono<br />
di confrontare tra loro<br />
ortofoto storiche, l’evoluzione<br />
storica dei<br />
limiti amministrativi<br />
(fusioni dei comuni nel<br />
tempo), l’uso agricolo<br />
del suolo.<br />
Abbiamo sviluppato<br />
due applicativi, il<br />
primo, l’ ”Attestato<br />
del Territorio”, consente<br />
di ottenere, su<br />
un punto definito<br />
dall’utente, una serie<br />
di informazioni che<br />
inquadrano il territorio<br />
nei suoi aspetti legati<br />
all’atmosfera (vento,<br />
precipitazioni, fulmini,<br />
inquinanti, classificazione<br />
acustica), al suolo<br />
(quota, pendenza,<br />
numero del mappale<br />
catastale, uso del suolo,<br />
max altezza neve, frane,<br />
aree allagabili, classe<br />
di fattibilità geologica,<br />
interferometria radar,<br />
vincoli), al sottosuolo<br />
(accelerazione sismica,<br />
geologia, radon). Il<br />
secondo applicativo,<br />
"Interroga il Territorio"<br />
(a breve diventerà<br />
“Interroga il Territorio<br />
e il Paesaggio”), analogamente<br />
al precedente,<br />
evidenzia la vincolistica<br />
urbanistica, paesaggistica,<br />
ambientale presente.<br />
Entrambi gli applicativi<br />
producono una<br />
reportistica che aiuta la<br />
consultazione integrata<br />
di informazioni geografiche,<br />
e aiuta nella<br />
corretta progettazione<br />
del territorio.<br />
G: Il concetto del<br />
Geospatial Ecosystem,<br />
inteso come integrazione<br />
di dati provenienti<br />
da crowdsourcing, da<br />
fonti commerciali o<br />
private..., è una prospettiva<br />
praticabile?<br />
RL: Al momento<br />
Regione Lombardia<br />
non ha collaborazioni<br />
attive con soggetti<br />
privati in tal<br />
senso, o iniziative di<br />
crowdsourcing. In realtà<br />
un primo ecosistema<br />
digitale era stato realizzato<br />
in occasione di<br />
EXPO Milano 2015, il<br />
Cruscotto Emergenze,<br />
per gestire sicurezza/<br />
emergenze legate all’evento.<br />
Certamente<br />
c’è l’intenzione di<br />
proseguire il percorso<br />
creando ecosistemi<br />
che integrino le informazioni<br />
geografiche<br />
e non, a disposizione<br />
delle diverse Direzioni<br />
Generali dell’Ente.<br />
Idealmente, in RL si<br />
potrebbero individuare<br />
5 “ecosistemi digitali”:<br />
Ambiente e Clima,<br />
Casa, Mobilità sostenibile<br />
e qualità dell’Aria,<br />
Safe&Security e Tutela<br />
e valorizzazione del<br />
Territorio.<br />
Siamo ben consapevoli<br />
dei benefici ottenibili<br />
lavorando per ecosistemi<br />
digitali: scambio di<br />
patrimonio informativo<br />
tra soggetti/Enti<br />
diversi; incidere sulle<br />
“sinergie” dei sistemi<br />
più maturi e strategici,<br />
agevolando il raccordo<br />
tra le politiche digitali<br />
delle diverse Direzioni<br />
Regionali/Enti e<br />
Società del Sistema<br />
regionale allargato.<br />
Siamo altrettanto consapevoli<br />
delle difficoltà<br />
connesse alla carenza<br />
di competenze e personale<br />
all’interno della<br />
PA, e non solo: oltre a<br />
sensibilizzare i decisori<br />
politici, ai vari livelli<br />
istituzionali, della necessità<br />
di valorizzazione<br />
delle competenze dei<br />
funzionari tecnici e<br />
dei loro responsabili,<br />
occorre incentivare for-<br />
<strong>GEOmedia</strong> n°6-<strong>2021</strong> 17
INTERVISTA<br />
me di collaborazione<br />
pubblico/privato che<br />
accrescano le capacità<br />
di gestire la pianificazione<br />
territoriale negli<br />
ambiti locali in cui ciò<br />
avviene, quindi presso i<br />
Comuni e gli Enti che<br />
operano sul territorio.<br />
In Lombardia ci sono<br />
diversi esempi che<br />
hanno attuato queste<br />
politiche realizzando<br />
sinergie virtuose con<br />
ricadute molto positive<br />
sul territorio, sia<br />
per chi lo amministra,<br />
sia per chi lo vive e ci<br />
lavora.<br />
G: Per concludere,<br />
parlando della vostra<br />
IIT, quale è l’aspetto<br />
che vorreste mettere in<br />
evidenza?<br />
LR: Ha per certi versi<br />
a che vedere con le origini<br />
della IIT. Regione<br />
Lombardia, facendo seguito<br />
alla riforma della<br />
propria legislazione in<br />
materia urbanistica, avvenuta<br />
come detto nel<br />
2005, ha scelto di costituire<br />
una banca dati<br />
della pianificazione<br />
comunale/provinciale<br />
attraverso la collaborazione<br />
diretta degli<br />
Enti Locali, ai quali<br />
viene chiesta la fornitura<br />
dei dati secondo<br />
specifiche comuni.<br />
Questo, per citare un<br />
caso di successo, ha<br />
permesso di progettare<br />
il Piano Territoriale<br />
Regionale per la riduzione<br />
del consumo di<br />
suolo con i dati reali<br />
delle previsioni urbanistiche<br />
dei singoli<br />
Comuni (oltre 1500 in<br />
Lombardia). Il processo<br />
vede l’acquisizione<br />
di una media di 400<br />
diversi piani/varianti<br />
di piano urbanistici<br />
all’anno, consentendo<br />
di ottenere una banca<br />
dati con un grado di<br />
aggiornamento adeguato;<br />
recentemente si<br />
è resa automatica l’acquisizione<br />
delle informazioni<br />
sul consumo<br />
di suolo dai Comuni.<br />
Al fine di migliorarne<br />
ulteriormente la precisione<br />
e soprattutto per<br />
aumentare la velocità<br />
con cui avvengono le<br />
forniture, come sopra<br />
detto è in corso un<br />
progetto di prima sperimentazione<br />
volto alla<br />
realizzazione di un software<br />
che permetterà<br />
la redazione dei PGT<br />
già sotto forma di banca<br />
dati geografica, già<br />
rispondente alle specifiche<br />
regionali e quindi<br />
pronto alla pubblicazione<br />
sul BURL. E’<br />
una evidente semplificazione<br />
procedurale,<br />
oltre ad una garanzia<br />
di maggior qualità e<br />
controllo dei dati geografici<br />
di ritorno, che<br />
sono subito rimessi alla<br />
disponibilità di tutti gli<br />
interessati attraverso il<br />
Geoportale.<br />
La Infrastruttura Dati<br />
Territoriali (IDT) della<br />
Regione Lazio<br />
Colloquio con Simone<br />
Patella, Responsabile<br />
della IDT della Regione<br />
Lazio<br />
<strong>GEOmedia</strong> (G):<br />
Cominciamo con un<br />
inquadramento della<br />
vostra esperienza<br />
Regione Lazio (RL):<br />
Le Infrastrutture Dati<br />
Territoriali sono un<br />
importante strumento<br />
di analisi e condivisione<br />
delle informazioni,<br />
tanto che è in continua<br />
crescita la richiesta di<br />
accesso ad un numero<br />
sempre maggiore di<br />
banche dati, di alta<br />
qualità ed aggiornate.<br />
L’Assessorato alle<br />
Politiche Abitative,<br />
Urbanistica, Ciclo<br />
dei Rifiuti e Impianti<br />
di Trattamento,<br />
Smaltimento e<br />
Recupero, della<br />
Regione Lazio ha da<br />
tempo investito nella<br />
realizzazione di queste<br />
piattaforme, facendo<br />
propria la prospettiva<br />
che vede i dati quale<br />
patrimonio della comunità.<br />
G: Entrando nel merito,<br />
pensiamo sia giusto<br />
cominciare dagli utilizzatori<br />
e dagli utilizzi.<br />
Quanto li conoscete?<br />
RL: La IDT regionale<br />
non richiede registrazione,<br />
se non per personalizzare<br />
l’esperienza<br />
di navigazione o fruire<br />
dei servizi verticali: in<br />
questi casi, l’utente può<br />
autenticarsi con SPID,<br />
CIE o CNS.<br />
La Regione applica by<br />
default un approccio<br />
minimale alla raccolta<br />
dei dati e non ci sono<br />
quindi grandi possibilità<br />
di classificare la<br />
tipologia di utenti; tramite<br />
il servizio Google<br />
Analytics, sappiamo<br />
però che l’utilizzo della<br />
piattaforma si attesta<br />
sui 5.000 utenti unici<br />
al mese.<br />
Tanto premesso, la<br />
IDT si rivolge ad<br />
un’ampia platea di<br />
utilizzatori: i tecnici<br />
della PA, che la utilizzano<br />
come supporto<br />
per le istruttorie delle<br />
pratiche; imprese e<br />
professionisti, che ne<br />
fanno uso per la predisposizione<br />
di progetti<br />
da presentare alle PA;<br />
gli studenti o gli enti<br />
di ricerca e, infine, i<br />
cittadini, che possono<br />
trovare all’interno del<br />
Geoportale una prima<br />
risposta alle proprie<br />
curiosità.<br />
G: Dunque gli utenti<br />
non si registrano. Avete<br />
comunque attivato<br />
canali per ricevere<br />
feedback, commenti...<br />
dagli utenti?<br />
RL: Certamente, l’help<br />
18 <strong>GEOmedia</strong> n°6-<strong>2021</strong>
INTERVISTA<br />
desk è il primo di questi<br />
canali. Gli utenti si<br />
rivolgono agli operatori<br />
per avere informazioni<br />
sull’utilizzo della<br />
piattaforma, i dati<br />
pubblicati e i servizi<br />
erogati: dai colloqui<br />
spesso nascono dei<br />
suggerimenti che permettono<br />
di migliorare<br />
le modalità di fruizione<br />
del Geoportale.<br />
Un altro strumento<br />
sono i questionari di<br />
gradimento, che vengono<br />
periodicamente<br />
sottoposti e permettono<br />
di conoscere<br />
meglio l’utenza e di<br />
raccogliere idee o<br />
commenti su come<br />
migliorare la piattaforma.<br />
La Regione organizza<br />
inoltre dei webinar<br />
(7 nel <strong>2021</strong>),<br />
per formare gli<br />
utenti sui GIS e sul<br />
migliore utilizzo del<br />
Geoportale; a volte, da<br />
questi incontri scaturiscono<br />
ulteriori collaborazioni<br />
con l’utenza<br />
interessata.<br />
Quello che riscontriamo<br />
è l’esigenza<br />
di poter attingere ad<br />
un maggior numero<br />
di dati cartografici,<br />
nonché alle specifiche<br />
tecniche sulla loro realizzazione<br />
(informazioni<br />
spesso non reperibili<br />
nel solo metadato);<br />
alcune richieste si focalizzano<br />
invece sulla<br />
possibilità di avere<br />
ulteriori servizi sul<br />
Geoportale e strumenti<br />
di analisi ancora più<br />
evoluti.<br />
G: A grandi linee,<br />
quali sono i dataset<br />
presenti e quali i dataset<br />
più utilizzati?<br />
RL: Il Geoportale<br />
pubblica circa 300<br />
strati, per lo più<br />
sotto forma di dati<br />
vettoriali; il 36%<br />
riguarda dati cartografici<br />
di base<br />
o di urbanistica<br />
(es. il Database<br />
Geotopografico<br />
Regionale); il 22%<br />
riguarda l’Ambiente<br />
e la Natura; il 21%<br />
afferisce all’ambito<br />
‟Tutti i dati pubblicati<br />
sul Geoportale,<br />
ad eccezione di quelli<br />
non di proprietà regionale<br />
o aventi un<br />
contenuto sensibile,<br />
sono distribuiti in<br />
Open Data<br />
dell’Agricoltura; il<br />
19% fa riferimento<br />
alla salvaguardia del<br />
Paesaggio; il restante<br />
2% comprende l’archivio<br />
della fototeca<br />
regionale.<br />
Tutti i dataset pubblicati<br />
sono realizzati<br />
dalle strutture<br />
regionali che hanno<br />
competenza sulla<br />
specifica materia;<br />
la IDT regionale,<br />
infatti, pur essendo<br />
il punto unico di<br />
divulgazione, delega<br />
ad ogni struttura<br />
regionale la pubblicazione<br />
e gestione<br />
dei propri contenuti<br />
cartografici.<br />
G: Quali sono i servizi<br />
più utilizzati?<br />
RL: La IDT Regionale<br />
è stata costruita interamente<br />
con software<br />
open source e più del<br />
95% dei dati pubblicati<br />
sono liberamente accessibili<br />
da chiunque;<br />
il restante 5% sono<br />
dati non divulgabili<br />
per via delle licenze<br />
d’uso applicate o per<br />
problematiche afferenti<br />
‟<br />
alla privacy (es. il dato<br />
catastale).<br />
Tutti i dati pubblicati<br />
sono accessibili tramite<br />
i servizi OGC<br />
standard (come richiesto<br />
dalla Direttiva<br />
INSPIRE), quali il<br />
Web Map Service<br />
(WMS), il Web<br />
Feature Service (WFS)<br />
e il Web Coverage<br />
Service (WCS), che<br />
ne permettono l’accesso,<br />
l’interrogazione ed<br />
il download tramite<br />
software di terze parti,<br />
anche in sistemi di coordinate<br />
differenti.<br />
Ad ogni dato sono<br />
associati dei metadati,<br />
costruiti conformemente<br />
alle linee guida<br />
prodotte dall’AGID;<br />
anche i metadati sono<br />
accessibili da remoto<br />
(operazione di harvesting)<br />
utilizzando il<br />
Catalogue Services for<br />
the Web (CSW).<br />
Di questi servizi, sicuramente<br />
il WMS è<br />
quello più richiesto,<br />
seguito dal WFS, dal<br />
CSW ed infine dal<br />
WCS.<br />
Oltre ai servizi OGC<br />
standard, la piattaforma<br />
è anche lo strumento<br />
ideale sul quale<br />
far convergere gli sforzi<br />
di digitalizzazione di<br />
quelle procedure amministrative<br />
di competenza<br />
regionale che<br />
hanno nel dato cartografico<br />
il fondamento<br />
del loro iter; queste<br />
procedure possono<br />
essere erogate online<br />
sotto forma di servizi<br />
verticali della IDT. La<br />
Regione ha avviato una<br />
prima sperimentazione,<br />
realizzando tre diversi<br />
servizi verticali.<br />
Il primo servizio, ad<br />
uso esclusivo regionale,<br />
riguarda l’integrazione<br />
con il sistema di<br />
interscambio del dato<br />
catastale dell’Agenzia<br />
delle Entrate; il servizio<br />
permette di ricevere<br />
gli aggiornamenti<br />
vettoriali e censuari del<br />
catasto, che i funzionari<br />
regionali possono<br />
visualizzare ed interrogare<br />
per verificare i<br />
dati delle loro pratiche.<br />
Un secondo servizio<br />
riguarda gli impianti<br />
geotermici; il terzo<br />
è rivolto alle attività<br />
inerenti alla gestione<br />
<strong>GEOmedia</strong> n°6-<strong>2021</strong> 19
INTERVISTA<br />
forestale (tagli, piantumazioni,<br />
ecc.). In<br />
entrambi questi casi,<br />
i servizi permettono<br />
all’utente autenticato<br />
di avviare una procedura<br />
amministrativa<br />
online, di caricare la<br />
documentazione necessaria<br />
e di identificare la<br />
componente geografica<br />
oggetto della richiesta;<br />
questi servizi possono<br />
fornire una prima<br />
risposta operando un<br />
incrocio delle informazioni<br />
inserite con,<br />
ad esempio, i vincoli<br />
urbanistici e ambientali;<br />
altrimenti, la pratica<br />
viene assegnata digitalmente<br />
al funzionario<br />
di riferimento, che<br />
procede con l’istruttoria,<br />
fino all’emanazione<br />
dell’atto finale.<br />
G: Uno dei principi<br />
fondativi delle IDT è<br />
il riuso dei dati, il che<br />
comporta che siano<br />
individuati i dataset<br />
di riferimento, chi li<br />
gestisce e chi ne è responsabile:<br />
cosa fate in<br />
questa direzione?<br />
RL: Il Sistema<br />
Informativo<br />
Territoriale Regionale,<br />
della Direzione<br />
Regionale per le<br />
Politiche Abitative<br />
e la Pianificazione<br />
Territoriale, Paesistica<br />
e Urbanistica, che<br />
gestisce la IDT con il<br />
supporto della Società<br />
in-house LazioCREA<br />
SpA., è da sempre in<br />
stretto contatto con le<br />
altre strutture regionali<br />
al fine di fornire supporto<br />
nella individuazione,<br />
trasformazione<br />
o realizzazione di banche<br />
dati spaziali. Con<br />
Delibera di Giunta<br />
Regionale n. 663/<strong>2021</strong><br />
è stato inoltre istituito<br />
un tavolo tecnico per<br />
l’informazione geografica,<br />
nel quale sono<br />
chiamate a partecipare<br />
tutte le strutture regionali<br />
che hanno interesse<br />
nella tematica.<br />
G: Harvesting da dataset<br />
di altre PA subregionali:<br />
che cosa è in<br />
atto e/o in progetto?<br />
RL: Attualmente,<br />
l’harvesting dei dati<br />
cartografici avviene<br />
soltanto dalla piattaforma<br />
regionale, verso il<br />
Repertorio Nazionale<br />
dei Dati Territoriali,<br />
gestito da AGID. Il<br />
passaggio successivo<br />
sarà, senz’altro, anche<br />
quello di avviare una<br />
maggiore integrazione<br />
con le piattaforme<br />
sub-regionali, tramite<br />
harvesting dei dati pubblicati<br />
sui loro sistemi.<br />
G: Open data: qual è la<br />
situazione?<br />
RL: Tutti i dati pubblicati<br />
sul Geoportale,<br />
ad eccezione di quelli<br />
non di proprietà regionale<br />
o aventi un<br />
contenuto sensibile,<br />
sono distribuiti in open<br />
data, sulla base della<br />
legge regionale n. 7 del<br />
2012. La licenza d’uso<br />
applicata è la Creative<br />
Commons By 4.0, che<br />
prevede il solo vincolo<br />
dell’indicazione della<br />
fonte da cui proviene il<br />
dato utilizzato.<br />
G: INSPIRE compliant:<br />
anche in questo<br />
caso, qual è la situazione?<br />
RL: La realizzazione<br />
della piattaforma è<br />
stata sin dall’inizio<br />
vincolata agli standard<br />
richiesti dalla Direttiva<br />
INSPIRE, al fine chiaramente<br />
di esserne<br />
conformi. Attualmente<br />
la IDT regionale risponde<br />
ai requisiti della<br />
Direttiva e, nel corso<br />
dei suoi aggiornamenti,<br />
si provvede a mantenere<br />
il passo anche<br />
con le evoluzioni che<br />
inevitabilmente vengono<br />
apportate a livello<br />
Europeo o Nazionale.<br />
Anche per quanto<br />
riguarda i metadati si<br />
seguono le linee guida<br />
predisposte da AGID,<br />
che a loro volta assicurano<br />
la conformità ad<br />
INSPIRE.<br />
Più difficoltoso è<br />
il processo di adeguamento<br />
alle Data<br />
Specifications relative ai<br />
diversi temi INSPIRE.<br />
Finora, l’attenzione è<br />
stata rivolta alla promozione<br />
dei sistemi<br />
geografici e alla pubblicazione<br />
dei dati,<br />
meno alla conformità<br />
di questi alla Direttiva<br />
INSPIRE.<br />
È questo chiaramente<br />
un tema che dovrà essere<br />
affrontato in futuro,<br />
dalla Commissione<br />
Europea al fine di semplificare<br />
tale aspetto, o<br />
dagli enti pubblici che<br />
dovranno conformare<br />
i loro dati a tali indicazioni.<br />
G: Non dati ma informazione:<br />
quali sono i<br />
tools accessibili attraverso<br />
il Geoportale utili<br />
per rendere più facile e<br />
efficace l’uso dell’informazione<br />
geografica?<br />
RL: Il Geoportale<br />
fornisce ovviamente<br />
tutti gli strumenti di<br />
base per la navigazione<br />
dei livelli informativi<br />
presenti a catalogo,<br />
come zoom, pan, interrogazione<br />
e così via.<br />
È possibile ricercare<br />
una posizione per coordinate,<br />
indirizzi (servizio<br />
di geo-codifica<br />
di OpenStreetMap) o<br />
tramite fogli e particelle<br />
catastali; stampare<br />
o scaricare i contenuti<br />
caricati in mappa;<br />
visualizzare le tabelle<br />
alfanumeriche associate<br />
ai dati vettoriali, con la<br />
possibilità di applicare<br />
dei filtri sia alfanumerici,<br />
che spaziali (buffer,<br />
intersezioni, ecc).<br />
I referenti regionali<br />
possono predisporre<br />
delle mappe costituite<br />
da più livelli informativi,<br />
di modo che l’utente<br />
possa concentrarsi<br />
principalmente sulla<br />
navigazione e l’interrogazione,<br />
e tralasciare<br />
i dettagli sull’impostazione<br />
del progetto.<br />
Con gli ultimi aggiornamenti<br />
della piattaforma,<br />
è stata inoltre<br />
introdotta la possibilità<br />
di editare online gli<br />
strati informativi, così<br />
da permettere anche<br />
ad utenti non esperti il<br />
popolamento e la gestione<br />
del dato spaziale.<br />
G: Ha preso piede il<br />
concetto del Geospatial<br />
Ecosystem, cioè l’integrazione<br />
tra fonti<br />
20 <strong>GEOmedia</strong> n°6-<strong>2021</strong>
INTERVISTA<br />
pubbliche, fonti commerciali<br />
o private,<br />
crowdsourcing...: è una<br />
prospettiva praticabile?<br />
RL: La possibilità di<br />
integrare informazione<br />
pubblica e privata è<br />
senz’altro interessante,<br />
ma la pubblica amministrazione<br />
è tenuta a<br />
fornire un dato certificato<br />
e preciso, e non<br />
sempre il dato raccolto<br />
in crowdsourcing è in<br />
grado di rispettare questi<br />
vincoli. Pertanto, si<br />
accede a queste risorse<br />
solo qualora il dato<br />
necessario non sia altrimenti<br />
disponibile (es.<br />
il già citato servizio di<br />
geo-codifica fornito da<br />
OpenStreetMap).<br />
Considerando che il<br />
Geoportale permette<br />
ora di operare editing<br />
online sui livelli vettoriali,<br />
sarà comunque<br />
possibile avviare una<br />
sperimentazione in tal<br />
senso, per poi verificare<br />
la qualità di quanto<br />
raccolto.<br />
‟La politica<br />
utilizzata<br />
dalla Regione<br />
è che ogni<br />
dato validato<br />
è un dato a<br />
disposizione<br />
della comunità,<br />
ed è quindi disponibile<br />
in Open Data<br />
‟<br />
La Regional Spatial<br />
Data Infrastructure<br />
(RSDI) della<br />
Regione Basilicata<br />
Colloquio con Anna<br />
Maria Grippo,<br />
Responsabile della<br />
RSDI della Regione<br />
Basilicata; Vincenzo<br />
Viti, Ingegnere GIS<br />
Senior, e Francesco Di<br />
Trani, Ingegnere GIS<br />
Senior<br />
<strong>GEOmedia</strong> (G):<br />
Comincerei con un<br />
dettaglio, perché avete<br />
deciso di utilizzare<br />
l’acronimo RSDI, cioè<br />
Regional Spatial Data<br />
Infrastructure, in inglese?<br />
Regione Basilicata<br />
(RB): La strategia di<br />
sviluppo della IDT regionale<br />
è nata intorno<br />
ad un progetto pilota<br />
in collaborazione con<br />
il CNR di Basilicata,<br />
nel 2006. Con la<br />
pubblicazione della<br />
Direttiva INSPIRE<br />
nel 2007, si consolidò<br />
l’idea di implementare<br />
una infrastruttura basata<br />
sulla disponibilità<br />
di informazioni e dati<br />
riguardanti il territorio<br />
condivisi fra tutti i<br />
soggetti operanti ai vari<br />
livelli istituzionali. Lo<br />
scopo era creare una<br />
federazione di tutti i<br />
SIT esistenti, e costituire<br />
una community<br />
di soggetti produttori,<br />
distributori e utilizzatori<br />
dell’informazione<br />
geografica attraverso<br />
una gestione del dato<br />
basata sui principi<br />
dell’interoperabilità e<br />
della multidisciplinarietà.<br />
Pertanto, per distinguere<br />
questa infrastruttura<br />
dal tradizionale<br />
concetto di SIT si scelse<br />
l’acronimo inglese:<br />
RSDI.<br />
G: Ma entriamo nel<br />
merito, cominciando<br />
da a che serve la IDT:<br />
chi sono i suoi utilizzatori<br />
e gli utilizzi più<br />
importanti?<br />
RB: Ci sono due<br />
modalità di accesso<br />
all’Infrastruttura dei<br />
Dati Territoriali della<br />
Regione Basilicata<br />
(rsdi.regione.basilicata.<br />
it). Gran parte dei dati<br />
e delle applicazioni è<br />
ad accesso libero, con<br />
licenza IODL 2.0. Ci<br />
sono dei dati riservati<br />
al personale della PA<br />
lucana: l’accesso è regolato<br />
mediante l’uso<br />
dello SPID e ciascun<br />
utente può utilizzare<br />
solo le applicazioni e i<br />
dati per cui è autorizzato.<br />
Ogni mese, in media,<br />
su tutta la infrastruttura,<br />
si contano circa<br />
150.000 visualizzazioni,<br />
quindi 5000 al<br />
giorno, effettuate da<br />
circa 1500 utenti al<br />
giorno, fra accesso libero<br />
e riservato.<br />
Gli utenti autorizzati<br />
ad accedere alla sezione<br />
riservata sono circa<br />
1000, e sono utenti<br />
afferenti principalmente<br />
alle PA operanti<br />
sul territorio lucano,<br />
ma anche Guardia di<br />
Finanza, Carabinieri,<br />
Università degli Studi<br />
della Basilicata. A<br />
questa comunità si aggiungono<br />
anche liberi<br />
professionisti, aziende,<br />
e, più in generale, privati<br />
cittadini che, per<br />
esigenze lavorative o<br />
personali, utilizzano<br />
applicazioni e dati<br />
pubblici.<br />
G: Mentre sapete chi<br />
sono gli utilizzatori<br />
della PA e sapete (o<br />
vi immaginate) quali<br />
utilizzi fanno dei dati e<br />
dei servizi, cosa sapete<br />
degli utilizzatori non<br />
registrati?<br />
RB: Diamo molta importanza<br />
alla creazione<br />
di un rapporto diretto<br />
e bidirezionale con gli<br />
utilizzatori della IDT.<br />
Perciò, da oltre 6 anni<br />
stiamo impegnando<br />
risorse nella gestione di<br />
strumenti comunicativi<br />
quali newsletter e<br />
social.<br />
Questo ha permesso di<br />
<strong>GEOmedia</strong> n°6-<strong>2021</strong> 21
INTERVISTA<br />
costruire un forte legame<br />
con la comunità,<br />
che attivamente partecipa<br />
al mantenimento<br />
della piattaforma (ad<br />
es. segnalando malfunzionamenti)<br />
ed anche<br />
al miglioramento dei<br />
servizi offerti. Ne è un<br />
esempio il servizio di<br />
download dei progetti<br />
QGIS, suddivisi per<br />
comuni, della Carta<br />
Tecnica Regionale<br />
vettoriale, nato su proposta<br />
della comunità.<br />
Questi project files<br />
servono a chi vuole<br />
avere tutto quanto è<br />
necessario per ulteriori<br />
eleborazioni in locale<br />
con QGIS.<br />
G. Caratterizziamo la<br />
IDT regionale: quali<br />
dataset sono presenti e<br />
quali sono i dataset più<br />
utilizzati?<br />
RB: Per quanto riguarda<br />
i dataset (disponibili<br />
in parte anche per il<br />
download), il punto di<br />
partenza è il Catalogo<br />
Regionale dei Geodati.<br />
In questo Catalogo<br />
sono presenti attualmente<br />
284 schede di<br />
metadati, riguardanti<br />
i dataset e i servizi disponibili,<br />
secondo le<br />
linee guida indicate da<br />
AgID.<br />
Questi metadati sono<br />
periodicamente raccolti,<br />
tramite harvesting,<br />
dal Catalogo del<br />
Repertorio Nazionale<br />
dei Dati Territoriali<br />
(RNDT) di AgID.<br />
Il Catalogo regionale è<br />
inserito nel Geoportale<br />
di RSDI-Basilicata,<br />
insieme a varie applicazioni<br />
web che consentono<br />
di visualizzare<br />
i dataset come layers<br />
sovrapposti, realizzando<br />
così una serie di<br />
tematismi specifici.<br />
La RSDI utilizza<br />
poi anche dati provenienti<br />
da altre<br />
fonti (AGEA, IGM,<br />
Portale Cartografico<br />
Nazionale, Agenzia<br />
delle Entrate), non<br />
presenti nel Catalogo,<br />
che consentono di<br />
completare e migliorare<br />
la visualizzazione e la<br />
consultazione dei dati.<br />
Alcuni di questi dati<br />
sono disponibili solo<br />
nella sezione riservata<br />
alla PA.<br />
Tra i dati che la IDT<br />
rende disponibili,<br />
sono importanti i dati<br />
catastali. Un servizio<br />
accessibile liberamente,<br />
piuttosto utilizzato, è<br />
la consultazione delle<br />
Mappe Catastali di<br />
Impianto. La Regione<br />
Basilicata, in seguito ad<br />
un accordo con la ex<br />
Agenzia del Territorio,<br />
ha effettuato la scansione<br />
delle Mappe<br />
Catastali originali di<br />
impianto, e ne consente<br />
il download attraverso<br />
una specifica<br />
applicazione inserita<br />
nel Geoportale. Sono<br />
disponibili per la consultazione<br />
anche i dati<br />
catastali geografici, aggiornati<br />
periodicamente<br />
tramite un sistema<br />
di interscambio con<br />
l’Agenzia delle Entrate,<br />
e rielaborati in modo<br />
da essere sovrapponibili<br />
ad altri layer di base<br />
(Ortofoto, CTR, etc.).<br />
Non hanno carattere<br />
di ufficialità dal punto<br />
di vista legale, ma sono<br />
comunque ritenuti di<br />
grande utilità da parte<br />
degli utenti.<br />
G: E per quanto riguarda<br />
i servizi, quali<br />
sono quelli presenti e<br />
quali sono i più utilizzati?<br />
RB: Le tipologie di servizi<br />
presenti nell’Infrastruttura<br />
RSDI appartengono<br />
a 3 categorie<br />
principali:<br />
4servizio di consultazione<br />
CSW per il<br />
Catalogo dei metadati<br />
4servizi di visualizzazione<br />
WMS utilizzati<br />
nelle applicazioni<br />
WebGis<br />
4servizi di download<br />
WFS, anch’essi<br />
presenti in alcune<br />
applicazioni<br />
Questi servizi sono<br />
tutti conformi alle<br />
normative RNDT e<br />
INSPIRE.<br />
Gli strumenti utilizzati<br />
per realizzarli sono tutti<br />
di tipo opensource<br />
o comunque molto<br />
diffusi (Geonetwork,<br />
Geoserver, Mapserver),<br />
come anche i Database<br />
(PostGis), opportunamente<br />
personalizzati.<br />
I servizi più utilizzati<br />
sono quelli di visualizzazione,<br />
ma un grande<br />
utilizzo ne viene fatto<br />
anche per il download,<br />
utilizzando le applicazioni<br />
che lo consentono,<br />
e per la ricerca<br />
e consultazione dei<br />
metadati.<br />
Gli stessi servizi sono<br />
comunque utilizzabili<br />
tramite software GIS di<br />
tipo desktop (come ad<br />
es. QGIS) per visualizzare<br />
e/o scaricare dati.<br />
G: Focalizziamo l’attenzione<br />
sui flussi<br />
informativi tra la IDT<br />
regionale e gli altri<br />
soggetti pubblici attivi<br />
nella Regione: che cosa<br />
è in atto e/o in progetto?<br />
RB: Possiamo dire che<br />
non esiste un vero e<br />
proprio harvesting da<br />
altri enti o soggetti<br />
pubblici, non essendovi<br />
altri servizi locali da cui<br />
attingere in automatico<br />
dati e informazioni, ma<br />
comunque la RSDI-<br />
Basilicata, attraverso<br />
opportuni accordi,<br />
pubblica dati provenienti<br />
da altri Enti,<br />
come Consorzio di<br />
Bonifica di Basilicata,<br />
Acquedotto Lucano,<br />
Autorità di Bacino,<br />
Sistema Informativo<br />
della Montagna<br />
(Carabinieri Forestali).<br />
G: Open Data, certamente<br />
l’attenzione per<br />
questo tema è qualificante<br />
per una IDT:<br />
quali azioni sono state<br />
fatte, quali azioni sono<br />
previste, quali azioni<br />
sono auspicabili su<br />
questo tema?<br />
RB: La politica utilizzata<br />
dalla Regione è<br />
che ogni dato validato<br />
è un dato a disposizione<br />
della comunità, ed<br />
è quindi disponibile<br />
in Open Data (non i<br />
layer sensibili, l’utilizzo<br />
dei quali è comunque<br />
sempre possibile previa<br />
autorizzazione).<br />
In conseguenza<br />
dell’harvesting automa-<br />
22 <strong>GEOmedia</strong> n°6-<strong>2021</strong>
INTERVISTA<br />
tico effettuato periodicamente<br />
dal RNDT,<br />
tutto quanto pubblicato<br />
è anche trasferito nel<br />
Catalogo Open Data<br />
nazionale (dati.gov.it)<br />
ed europeo. In questo<br />
modo viene ampliata<br />
la potenziale platea di<br />
utilizzatori dei dati.<br />
Il nostro impegno sul<br />
tema degli OpenData è<br />
stato riconosciuto già 5<br />
anni fa dall’Associazione<br />
OpenGeoData Italia<br />
che ha assegnato alla<br />
Regione Basilicata il riconoscimento<br />
Regione<br />
OpenGeoData 2016,<br />
per aver seguito un<br />
iter virtuoso di pubblicazione<br />
di dati<br />
geografici opendata,<br />
compresa la pubblicazione<br />
nel 2015 e 2016,<br />
con licenza open,<br />
di tutto il DataBase<br />
GeoTopografico.<br />
G: Conformità a<br />
INSPIRE: che cosa è<br />
stato fatto e/o sarebbe<br />
ancora necessario fare<br />
perché metadati e dataset<br />
lo siano?<br />
RB: Siamo orgogliosi<br />
di essere stata una delle<br />
prime regioni italiane<br />
a rendere compatibile<br />
il Catalogo regionale<br />
dei Metadati con le<br />
specifiche contenute<br />
nelle Linee Guida<br />
del RNDT vers.3.0,<br />
e conseguentemente<br />
anche con gli standard<br />
INSPIRE 2.0.<br />
Anche i servizi sono<br />
conformi alle specifiche<br />
INSPIRE.<br />
La compatibilità dei<br />
dataset, che in generale<br />
hanno provenienze<br />
diverse, non può allo<br />
stato attuale essere assicurata,<br />
non essendovi<br />
regole uniche da seguire<br />
da parte di tutti.<br />
G: Si dice che le IDT<br />
devono fornire “non<br />
dati ma informazione”,<br />
qualcuno dice che<br />
devono fornire “actionable<br />
information”, che<br />
a mio avviso è un passettino<br />
in più rispetto a<br />
informazione. Questo<br />
vuol dire tools di visualizzazione,<br />
analisi,<br />
simulazione… utili per<br />
rendere più facile, ma<br />
soprattutto più efficace<br />
l’uso dell’informazione<br />
geografica delle IDT.<br />
Che cosa state facendo<br />
in questa direzione?<br />
RB: Per facilitare gli<br />
utenti dell’Infrastruttura<br />
nella fruizione dei<br />
dati disponibili, all’interno<br />
del Geoportale<br />
sono presenti varie<br />
applicazioni web, che,<br />
utilizzando i servizi<br />
(WMS/WMTS), permettono<br />
di visualizzare<br />
tematismi ottenuti per<br />
sovrapposizione di più<br />
layers.<br />
Se consentito, tramite<br />
queste applicazioni è<br />
anche possibile scaricare<br />
i dati stessi in forma<br />
vettoriale o raster<br />
(tramite link diretti o<br />
servizi WFS), per utilizzarli<br />
per le proprie<br />
necessità.<br />
I tools più complessi,<br />
al momento, sono riservati<br />
agli utenti che<br />
accedono alla sezione<br />
riservata della RSDI:<br />
chi è autorizzato, può<br />
accedere ad alcuni software<br />
web interamente<br />
progettati e realizzati<br />
dalla Regione Basilicata<br />
per creare progetti<br />
webgis, e per compilare<br />
e pubblicare le schede<br />
dei metadati nel catalogo<br />
regionale.<br />
Stiamo valutando di realizzare<br />
due strumenti<br />
da integrare nella piattaforma<br />
informatica già<br />
esistente:<br />
4una app per l’invio<br />
di segnalazioni georeferenziate<br />
di criticità<br />
del territorio<br />
lucano;<br />
4una piattaforma<br />
geografica per la partecipazione<br />
pubblica<br />
su procedure legate<br />
alla pianificazione di<br />
vasta scala.<br />
G: Un’ultima domanda.<br />
Nel dibattito internazionale<br />
è emerso il<br />
concetto del Geospatial<br />
Ecosystem, cioè non<br />
solo l’integrazione<br />
tra le molteplici fonti<br />
pubbliche (che è da<br />
sempre un principio<br />
base delle IDT) ma<br />
anche di dati risultato<br />
di crowdsourcing o<br />
proveniente da soggetti<br />
privati: avete fatto<br />
qualcosa in questa direzione?<br />
La ritenete una<br />
prospettiva praticabile?<br />
RB: Andrà nella direzione<br />
di integrare<br />
il crowdsourcing nella<br />
IDT l’app per segnalazioni<br />
di cui si è detto<br />
prima.<br />
E’ risultata poi molto<br />
interessante l’esperienza<br />
di pubblicazione<br />
della Carta Regionale<br />
della Attitudine<br />
alla Coltivazione<br />
Corilicola, realizzata<br />
dalla Ferrero Trading<br />
Lux S.A. e trasmessa<br />
alla Regione Basilicata,<br />
al fine di agevolare gli<br />
imprenditori agricoli<br />
nel processo di valutazione<br />
attitudinale<br />
alla coltivazione del<br />
nocciolo delle proprie<br />
aziende agricole.<br />
La carta è consultabile<br />
in ambiente IDT come<br />
applicazione webGIS,<br />
con possibilità di interrogazione<br />
del layer.<br />
PAROLE CHIAVE<br />
IDT; SDI; geoportale;<br />
INSPIRE<br />
ABSTRACT<br />
<strong>GEOmedia</strong> interviews<br />
the managers of 3 Italian<br />
regional Spatial Data<br />
Infrastructures: Basilicata,<br />
Lazio and Lombardia. The<br />
questions concern main<br />
datasets published by the<br />
SDI, the relationship with<br />
users, the services and<br />
advanced tools provided<br />
(for visualization, analysis<br />
and simulations) the prospects<br />
for integration with<br />
data from non-public<br />
sources and crowdsourced<br />
data.... Two interviews<br />
with the same structure,<br />
relating to regional SDIs of<br />
Piemonte and Veneto, were<br />
published in the previous<br />
issue 5/<strong>2021</strong>.<br />
AUTORE<br />
Redazione <strong>GEOmedia</strong><br />
redazione@rivistageomedia.it<br />
Franco Vico<br />
franco.vico@formerfaculty.<br />
polito.it<br />
<strong>GEOmedia</strong> n°6-<strong>2021</strong> 23
REPORT<br />
La linea sacra di S. Michele<br />
e la sfericità terrestre<br />
di Fabio Crosilla<br />
Nel 709, l'Arcangelo apparve a Saint Aubert, esortandolo a costruire una chiesa nella roccia.<br />
I lavori iniziarono subito, ma l'abbazia benedettina non fu completamente costruita<br />
fino all'anno 900. (Foto Ryan R Zhao, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons)<br />
Secondo diverse fonti, non del settore<br />
cartografico, la Linea Sacra di San<br />
Michele unisce sette santuari dedicati<br />
all’Arcangelo, dall’Irlanda a Israele, con<br />
una misteriosa e suggestiva linea retta.<br />
L’articolo, dopo aver ricordato la generale<br />
arbitrarietà di tale affermazione in un<br />
contesto cartografico, dimostra in maniera<br />
statisticamente rigorosa che la Linea<br />
Sacra di S. Michele segue effettivamente<br />
una linea retta sulla rappresentazione<br />
di Mercatore, dimostrando così<br />
l’appartenenza dei sette santuari ad<br />
una curva lossodromica sulla superficie<br />
terrestre. Si riportano infine i risultati dello<br />
studio di allineamento della Linea Sacra<br />
con il tramonto del sole nel giorno del<br />
solstizio d’estate.<br />
Ai numerosi fenomeni inspiegabili che si<br />
verificano attorno a noi, l’uomo ha da<br />
sempre cercato una giustificazione che<br />
coinvolgesse il soprannaturale. Uno di questi è la<br />
cosiddetta Linea Sacra di San Michele Arcangelo,<br />
che collega sette santuari ubicati in Europa<br />
Occidentale, nel bacino del Mediterraneo e in<br />
Israele. Il tracciato ha inizio in Irlanda, su un’isola<br />
deserta, con il monastero di Skelling Michael<br />
del VI secolo a cui fa seguito il monastero Saint<br />
Michael’s Mount in Cornovaglia del XVI secolo.<br />
Il terzo monastero è Mont Saint Michel in<br />
Normandia del X secolo, mentre il quarto è la<br />
Sacra di San Michele in val di Susa anch’esso<br />
del X secolo. Seguono poi il santuario di San<br />
Michele Arcangelo sul Gargano, in Puglia del V<br />
secolo, il monastero di San Michele Arcangelo di<br />
Panormitis, nell’isola di Simi in Grecia (V secolo)<br />
ed infine quello del Monte Carmelo, in prossimità<br />
della città di Haifa in Israele del XIX secolo,<br />
fondato su una grotta che fu dimora del profeta<br />
Elia, già citata in documenti egizi del XIV secolo<br />
A.C.<br />
La linea sacra di San Michele è celebre perché i<br />
vari santuari sono collegati fra loro da una linea<br />
retta che, secondo la leggenda, è frutto del colpo<br />
di spada che S. Michele Arcangelo inflisse al<br />
Diavolo per rimandarlo all’inferno. Inoltre è interessante<br />
il fatto che tutti questi santuari furono<br />
costruiti indipendentemente l’uno dall’altro, quasi<br />
tutti ospitando una o più apparizioni dell’Arcangelo.Parlare<br />
di una linea retta su una rappresentazione,<br />
che nella fattispecie è di tipo cartografico,<br />
è improprio, in quanto le caratteristiche geometriche<br />
degli elementi riprodotti dipendono dalla<br />
cartografia utilizzata. Come è ben noto, tutte le<br />
cartografie deformano la realtà (pseudo) sferica<br />
della superficie terrestre. Riprodurre su un piano<br />
gli elementi geometrici di una superficie a doppia<br />
curvatura, come è quella terrestre, richiede necessariamente<br />
l’introduzione di deformazioni che<br />
possono essere di tipo lineare, angolare e areale.<br />
24 <strong>GEOmedia</strong> n°6-<strong>2021</strong>
REPORT<br />
Ne segue che la linea sacra di San Michele<br />
Arcangelo può essere rappresentata con una retta<br />
su un tipo di cartografia, ed allo stesso tempo<br />
può corrispondere ad una curva su un’altra rappresentazione<br />
cartografica. Proprio questo fatto<br />
viene appellato da alcuni interlocutori, poco<br />
avvezzi con le rappresentazioni cartografiche, per<br />
denigrare il fenomeno.<br />
Per venire a capo del problema sarebbe pertanto<br />
necessario fare analoghe considerazioni sulla superficie<br />
che non subisce deformazioni, cioè sulla<br />
superficie terrestre.<br />
Per chiarire il problema è stato condotto un semplice<br />
esperimento che ha consentito di giungere<br />
ad un risultato di sicuro interesse.<br />
Si è dapprima preso in considerazione un estratto<br />
della rappresentazione di Mercatore per la<br />
zona interessata dalla Linea Sacra di San Michele<br />
Arcangelo. La rappresentazione di Mercatore<br />
gode della proprietà di essere “conforme”, cioè<br />
di conservare gli angoli misurati sulla superficie<br />
terrestre e sulla rappresentazione. In base a questa<br />
proprietà, sulla rappresentazione di Mercatore le<br />
trasformate dei meridiani e dei paralleli si intersecano<br />
ad angolo retto come sulla superficie terrestre.<br />
Dopo aver riportato sulla rappresentazione<br />
di Mercatore la posizione geografica dei sette santuari<br />
e dopo averli graficamente collegati fra loro,<br />
si evince visivamente che gli stessi si dispongono<br />
secondo una linea retta che collega il punto che<br />
rappresenta il Monastero di Skelling Michael con<br />
quello di Haifa in Israele (vedi Fig.1).<br />
Per fornire un riscontro rigoroso all’affermazione<br />
che i sette santuari si dispongono secondo una<br />
linea retta sulla rappresentazione di Mercatore, è<br />
necessario però eseguire una serie di calcoli basati<br />
sull’impiego di alcuni principi della statistica matematica<br />
applicati ad un problema specificamente<br />
di natura geometrica. La procedura di calcolo<br />
e i risultati ottenuti sono riportati di seguito. I<br />
risultati confermano quanto intuitivamente interpretato<br />
visivamente sulla rappresentazione cartografica<br />
di Mercatore.<br />
MODELLO ANALITICO<br />
Una delle proprietà della rappresentazione di<br />
Mercatore è quella che garantisce che linee rette<br />
sulla rappresentazione corrispondano alle cosiddette<br />
linee “lossodromiche” sulla superficie terrestre.<br />
Si ricorda che una linea lossodromica è la<br />
curva descritta sulla superficie terrestre che interseca<br />
i meridiani con lo stesso angolo definito sulla<br />
rappresentazione di Mercatore dalla trasformata<br />
dei meridiani e dalla retta considerata. Molto<br />
usata nella navigazione marittima, consente ad un<br />
Fig. 1 - La Linea Sacra di S. Michele (Aleteia.org)<br />
natante di navigare da un porto ad un altro mantenendo<br />
sempre lo stesso angolo di rotta.<br />
La proprietà della curva lossodromica, che sulla<br />
superficie terrestre unisce fra loro i sette santuari,<br />
è pertanto quella di conservare lo stesso angolo di<br />
direzione per i vari tratti.<br />
L’esperimento numerico è stato condotto partendo<br />
dalle coordinate geografiche (latitudine<br />
e longitudine) dei sette santuari riportate da<br />
Wikipedia (fonte Open Street Map, ellissoide<br />
WGS84)<br />
1.<br />
2.<br />
3.<br />
4.<br />
5.<br />
Skelling Michael<br />
Saint Michael’s Mount<br />
Mont Saint Michel<br />
Sacra di San Michele val di Susa<br />
San Michele Arcangelo Gargano<br />
6.<br />
San Michele Arcangelo di Panormitis<br />
7.<br />
Monte Carmelo, Haifa<br />
Tab. 1 Coordinate geografiche dei sette santuari, da Wikipedia<br />
(sistema sessagesimale)<br />
51°46’16’’ N 10°32’26’’ W<br />
50°06’58’’ N 05°28’38’’ W<br />
48°38’10’’ N 01°30’40’’ W<br />
45°05’52” N 07°20’36” E<br />
41°42’29” N 15°57’17” E<br />
36°32’54” N 27°50’46” E<br />
32°49’36” N 34°58’13” E<br />
Fig.2 Rappresentazione di Mercatore. Le curve lossodromica (in verde) e<br />
ortodromica (in rosso) (dm.unife.it)<br />
<strong>GEOmedia</strong> n°6-<strong>2021</strong> 25
REPORT<br />
1.<br />
2.<br />
Skelling Michael<br />
Utilizzando una routine di calcolo del software<br />
QGIS, sono state calcolate le coordinate cartografiche<br />
nella rappresentazione di Mercatore dei<br />
sette santuari.<br />
Saint Michael’s Mount<br />
3.<br />
Mont Saint Michel<br />
4.<br />
5.<br />
Sacra di San Michele val di Susa<br />
San Michele Arcangelo Gargano<br />
6725257.50 N -1173369.28 W<br />
6433601.56 N -609721.59 W<br />
6181254.95 N -168216.12 W<br />
5606650.53 N 817456.13 W<br />
5088911.03 N 1776071.55 W<br />
6. San Michele Arcangelo di Panormitis 4350889.24 N 3099814.91 W<br />
7.<br />
Monte Carmelo, Haifa<br />
3849157.82 N 3892873.52 W<br />
Tab. 2 Coordinate cartografiche nel sistema di Mercatore dei<br />
sette santuari (in metri)<br />
Non conoscendo il grado di precisione e accuratezza<br />
delle coordinate geografiche riportate su<br />
Wikipedia e neppure il livello di semplificazione<br />
del modello analitico utilizzato per trasformare le<br />
coordinate nella rappresentazione di Mercatore,<br />
è necessario procedere con un processo di calcolo,<br />
il più possibile rigoroso, tale da evidenziare e<br />
quantificare le possibili incertezze geometriche.<br />
Come è ben noto, gli errori con i quali ogni prova<br />
sperimentale deve confrontarsi sono essenzialmente<br />
di tre tipi: accidentali, sistematici e grossolani.<br />
I primi sono di piccola entità e fluttuano casualmente<br />
attorno al valore vero. Gli errori sistematici<br />
sono dovuti ad un errore di modellazione<br />
del fenomeno o a una cattiva calibrazione delle<br />
osservazioni. Gli errori grossolani sono dovuti alla<br />
sbadataggine dell’operatore e la loro presenza è di<br />
regola molto ridotta nel campione.<br />
La classica teoria degli errori prevede di procedere<br />
con il calcolo rigoroso dei parametri incogniti<br />
del problema ipotizzando la presenza esclusiva di<br />
errori accidentali nelle osservazioni, demandando<br />
ad una verifica finale l’eventuale presenza di errori<br />
di altra natura. Tale procedura è stata seguita<br />
per verificare le caratteristiche geometriche della<br />
Sacra Linea di San Michele.<br />
Si è ipotizzata una linea retta congiungente i sette<br />
santuari. L’equazione della retta è:<br />
y-v = mx + q<br />
dove x e y sono le coordinate di Mercatore (W e<br />
N) dei sette punti;<br />
m è il valore della tangente dell’azimut della retta;<br />
q è il valore dell’intercetta per x = 0 (lungo il meridiano<br />
di Greenwich)<br />
v è il residuo incognito della coordinata y dovuto<br />
alla presenza di errori.<br />
Per stimare il valore delle incognite del problema<br />
(m e q), è stato applicato ai residui il principio<br />
statistico dei minimi quadrati (= min).<br />
Il sistema di equazioni della retta risulta, in forma<br />
matriciale:<br />
(1)<br />
che, in forma compatta, si può anche scrivere<br />
AX=Y-V<br />
Applicando la condizione = min si perviene<br />
alla soluzione ai minimi quadrati del vettore X:<br />
(2)<br />
Il vettore contiene la stima ai minimi quadrati<br />
della tangente dell’azimut della retta ( ) e dell’intercetta<br />
( ).<br />
Noto il vettore , è sempre possibile procedere<br />
alla stima ai minimi quadrati delle coordinate di<br />
partenza contenute nel vettore<br />
(3)<br />
al vettore dei residui incogniti<br />
(4)<br />
e allo scarto quadratico medio a posteriori delle<br />
osservazioni (coordinate dei punti)<br />
(5)<br />
dove n è il numero delle equazioni (in questo<br />
caso 7)<br />
r è il numero delle incognite (in questo caso 2).<br />
Un ulteriore parametro per definire la qualità<br />
della stima è la cosiddetta matrice di varianza covarianza<br />
del vettore delle incognite<br />
(6)<br />
da cui è possibile ottenere lo scarto quadratico<br />
medio dei termini incogniti (m e q) come radice<br />
quadrata dei termini diagonali della matrice .<br />
E’ necessario infine verificare il tipo di distribuzione<br />
degli scarti , ottenuti con la formula (4).<br />
Ovvero è necessario verificare se gli scarti<br />
seguono una distribuzione normale a media nulla,<br />
confermando così sia la loro appartenenza alla<br />
26 <strong>GEOmedia</strong> n°6-<strong>2021</strong>
REPORT<br />
La teoria statistica afferma che se il valore standardizzato<br />
così ottenuto è minore o uguale in<br />
valore assoluto a |1,96|, allora si può concludere<br />
che il residuo è distribuito normalmente a media<br />
nulla e varianza 1, cioè appartiene alla categoria<br />
degli errori accidentali, con un intervallo di confidenza<br />
del 95%.<br />
RISULTATI<br />
Per verificare le caratteristiche geometriche della<br />
linea che unisce i sette santuari sono stati condotti<br />
alcuni esperimenti numerici che hanno fornito<br />
i risultati riportati di seguito. Per semplificare le<br />
operazioni di calcolo, tenuto anche conto della<br />
probabile scarsa accuratezza delle coordinate geografiche<br />
(latitudine e longitudine) dei sette punti,<br />
dedotte da Wikipedia, i valori numerici delle<br />
coordinate di Mercatore dei punti sono stati approssimati<br />
al chilometro. Per tale ragione la precisione<br />
finale dei risultati deve considerarsi limitata<br />
al chilometro.<br />
Applicando il modello analitico della retta, sono<br />
stati calcolati la matrice dei coefficienti e il vettore<br />
dei termini noti riportati nella formula (1). Dopo<br />
aver applicato il principio dei minimi quadrati,<br />
sono stati stimati con la formula (2) i parametri<br />
incogniti della retta, [il valore della tangente dell’azimut<br />
della retta (m) e l’intercetta (q)].<br />
Mediante le formule (3), (4), (5) e (6), sono stati<br />
poi calcolati ed estratti i termini diagonali della<br />
matrice di varianza - covarianza delle incognite. La<br />
radice quadrata di tali valori fornisce gli scarti quadratici<br />
medi da associare al valore della tangente<br />
dell’azimut della retta e al valore dell’intercetta.<br />
Passando dal valore della tangente all’angolo di<br />
direzione, si ottiene:<br />
119°,4955 +/- 0°,2546<br />
(in gradi sessadecimali)<br />
mentre l’intercetta vale<br />
6079 +/- 9 (in chilometri).<br />
Per confermare la significatività di questi risultati,<br />
dalle coordinate di Mercatore dei punti sono stati<br />
calcolati manualmente, per ogni singolo tratto<br />
della spezzata, i corrispondenti angoli di direzione.<br />
Questi risultano essere (in gradi sessadecimali):<br />
Az (1-2) = 117°,3590<br />
Az (2-3) = 119°,7505<br />
Az (3-4) = 120°,2403<br />
Az (4-5) = 118°,3731<br />
Az (5-6) = 119°,1408<br />
Az (6-7) = 122°,3196<br />
La media degli angoli di direzione e l’errore quadratico<br />
medio della serie di valori sono:<br />
Az(m) = 119°,5306 +/- 1°,5566<br />
Si noti la corrispondenza fra la media dei singoli<br />
tratti (119°,5306) e il valore risultante dal calcolo<br />
rigoroso, ottenuto applicando il principio dei minimi<br />
quadrati (119°,4955). Inoltre, moltiplicando<br />
per 1,96 il valore dell’errore quadratico medio,<br />
ed associando tale intervallo alla media Az(m), si<br />
evince che tutti i valori degli angoli di direzione<br />
ricadono entro tale intervallo, confermando il fatto<br />
che tutti i valori si possono considerare affetti<br />
da errori accidentali con un intervallo di confidenza<br />
pari al 95%.<br />
Ritornando al modello di calcolo rigoroso, l’analisi<br />
successiva ha consentito di verificare l’appartenenza<br />
dei residui delle equazioni ad una<br />
distribuzione normale a media 0 e varianza 1. Il<br />
vettore dei residui (in chilometri) calcolato con la<br />
formula (3) risulta:<br />
[-18, 9, 7, -10, 14, 25, -28]’<br />
Si noti immediatamente l’entità dei residui dei<br />
punti 7 e 8, ovvero i monasteri Panormitis sull’isola<br />
di Simi e il Monte Carmelo vicino ad Haifa.<br />
L’entità di tali valori sembrerebbe rigettare a prima<br />
vista il modello di una retta che unisce i sette<br />
santuari.<br />
In realtà, procedendo con il calcolo dei residui<br />
standardizzati, è stato possibile rifiutare tale ipotesi.<br />
Con la formula (7) sono stati calcolati gli<br />
scarti quadratici medi dei residui. Facendo il rapporto<br />
dei residui e dei rispettivi scarti quadratici<br />
medi, si ottengono i seguenti valori:<br />
[-1,07; 0,53; 0,37; -0,53; 0,75; 1,47; -1,90]’<br />
Come si può vedere anche i residui standardizzati<br />
del monastero dell’Isola di Simi e del Monte<br />
Carmelo sono inferiori al valore soglia di |1,96|,<br />
garantendo l’appartenenza dei punti ad un’unica<br />
retta sulla rappresentazione di Mercatore, con un<br />
intervallo di confidenza del 95%.<br />
Un’ulteriore caratteristica che viene attribuita alla<br />
Linea Sacra di san Michele è il fatto che tutti i<br />
sette punti siano allineati lungo la direzione del<br />
tramonto del sole in occasione del solstizio estivo.<br />
Il fatto che i punti si allineino sulla superficie terrestre<br />
secondo una linea lossodromica, sembra ribadire<br />
la veridicità di tale affermazione. In base ai<br />
calcoli rigorosi sopra riportati, tale allineamento<br />
dovrebbe verificarsi con un azimut di 119°,4955<br />
a partire dalla direzione Sud in senso orario. Il<br />
fatto di utilizzare la direzione Sud come origine<br />
dell’azimut del tramonto del sole appartiene alla<br />
cultura astronomica.<br />
Attingendo da uno dei fogli elettronici presenti<br />
su internet, è possibile, note le coordinate geo-<br />
<strong>GEOmedia</strong> n°6-<strong>2021</strong> 27
REPORT<br />
grafiche di un punto, il giorno e l’ora, calcolare la<br />
posizione del sole in un dato istante (azimut ed<br />
elevazione). Fissando a zero il valore dell’elevazione,<br />
è possibile calcolare l’azimut al tramonto.<br />
Di seguito sono riportati i valori dell’azimut del<br />
sole al tramonto del 21 giugno <strong>2021</strong> (solstizio<br />
estivo) per i sette punti della Linea Sacra di San<br />
Michele calcolati con il foglio elettronico fornito<br />
da centrometeo.com. (valori espressi in gradi sessadecimali).<br />
Come si può notare, esiste una corrispondenza<br />
sorprendente fra l’azimut della lossodromica<br />
fornito dal calcolo rigoroso (119°,4955) e l’azimut<br />
del tramonto del sole per i monasteri<br />
di Panormitis, sull’isola di Simi, e sul Monte<br />
Carmelo. Tale valore tende a variare sistematicamente<br />
fino a raggiungere una deviazione massima<br />
piuttosto un invito a mantenere nel corso della<br />
nostra vita la medesima direzione, la medesima<br />
condotta, auspicabilmente rivolta al bene, evitando<br />
di sbandare e di perdere la retta via.<br />
Il colpo di spada, la linea ortodromica, rappresenta<br />
una scorciatoia, il percorso di minima lunghezza,<br />
che non consente, in generale, di conservare la<br />
stessa direzione di marcia.<br />
RINGRAZIAMENTI<br />
Si ringraziano i colleghi Alberto Beinat ed<br />
Eleonora Maset per la collaborazione nella fase di<br />
elaborazione dei dati.<br />
Si ringrazia inoltre il prof. Luigi Tomasi dell'Università<br />
di Ferrara per aver acconsentito l'utilizzo<br />
dell'immagine riportata nella figura 2.<br />
1. Skelling Michael 130°,85<br />
2. Saint Michael’s Mount 129°,13<br />
3. Mont Saint Michel 127°,76<br />
4. Sacra di San Michele val di Susa 125°,05<br />
5. San Michele Arcangelo Gargano 122°,69<br />
6. San Michele Arcangelo di Panormitis 120°,04<br />
7. Monte Carmelo, Haifa 118°,66<br />
Tab. 3. Azimut (dal Sud in senso orario) del tramonto del sole il 21<br />
giugno <strong>2021</strong> per i sette santuari della Linea Sacra di San Michele (in<br />
gradi sessadecimali)<br />
di 10° circa in corrispondenza dei monasteri inglese<br />
e irlandese. Si tratta di un valore contenuto,<br />
difficile da cogliere senza una strumentazione<br />
adeguata, ma che, in ogni caso, indica una lieve<br />
deviazione sistematica di allineamento della lossodromica<br />
e della direzione di tramonto del sole<br />
per i punti della Linea Sacra in occasione del solstizio<br />
estivo.<br />
CONCLUSIONI<br />
Ritornando a considerazioni di natura mitologica,<br />
la leggenda, che vorrebbe che la linea fosse<br />
stata generata da un colpo di spada che San<br />
Michele Arcangelo inflisse al Diavolo, è scarsamente<br />
proponibile, in quanto il colpo di spada<br />
avrebbe dato origine ad una curva “ortodromica”<br />
e non lossodromica. La curva ortodromica (fig.<br />
2), è la sezione normale alla superficie terrestre, di<br />
minima lunghezza fra tutte le possibili linee congiungenti<br />
i due estremi. Corrisponde al percorso<br />
seguito dagli aerei per minimizzare il tempo di<br />
percorrenza e risparmiare carburante.<br />
Sembra quindi che il messaggio che metaforicamente<br />
i sette santuari allineati vogliono darci sia<br />
PAROLE CHIAVE<br />
ortodromia, lossodromia, san michele, linea sacra<br />
ABSTRACT<br />
According to several sources, not from the cartographic<br />
world, the Sacred Line of San Michele unites seven<br />
dedicated shrines to the Archangel, from Ireland to Israel,<br />
with a mysterious and suggestive straight line. The article,<br />
after recalling the general arbitrariness of this statement<br />
in a cartographic context, demonstrates in a manner<br />
statistically strict that the Line Sacra di S. Michele actually<br />
follows a straight line on the representation of Mercator,<br />
thus proving the membership of the seven sanctuaries at a<br />
rhumb line on the earth surface.<br />
AUTORE<br />
Fabio Crosilla<br />
fabio.crosilla@uniud.it<br />
Già Professore Ordinario<br />
Dipartimento Politecnico di Ingegneria<br />
e Architettura<br />
Università di Udine<br />
28 <strong>GEOmedia</strong> n°6-<strong>2021</strong>
REPORT<br />
Tecnologie<br />
per le Scienze<br />
della Terra e del Mare<br />
Strumenti ad alta tecnologia<br />
anche a noleggio per:<br />
Studio dei fondali e delle coste<br />
Multibeam, SSS, SBP, sismica marina …<br />
Ingegneria civile<br />
Georadar 3D, laser scanner, inclinometri …<br />
Studio del sottosuolo<br />
Georadar, sismica, geoelettrica …<br />
Monitoraggio ambientale<br />
Magnetometri, elettromagnetismo,<br />
sonde oceanografiche …<br />
Monitoraggio sismico<br />
Sismometri, strong motion, reti early warning …<br />
CODEVINTEC<br />
Tecnologie per le Scienze della Terra e del Mare<br />
tel. +39 02 4830.2175 | info@codevintec.it | www.codevintec.it<br />
<strong>GEOmedia</strong> n°6-<strong>2021</strong> 29
REPORT<br />
Topografia Applicata al Soccorso:<br />
la formazione del Vigile del Fuoco<br />
di Daniele Mercuri<br />
Il Servizio di Topografia<br />
Applicata al Soccorso (TAS)<br />
supporta l'attività del Corpo<br />
Nazionale dei Vigili del<br />
Fuoco con l'impiego di<br />
un'informazione geografica<br />
avanzata riferita allo<br />
scenario emergenziale ed,<br />
in particolare, agli scenari<br />
che richiedono l'intervento<br />
del Sistema nazionale di<br />
protezione civile.<br />
Da sempre chi si occupa<br />
di emergenza guarda<br />
all’innovazione tecnologica<br />
come un settore fondamentale<br />
per il miglioramento<br />
degli interventi, cercando di<br />
introdurre tali innovazioni nel<br />
tessuto organizzativo del soccorso<br />
tecnico urgente.<br />
E’ il caso del sistema satellitare<br />
globale di navigazione,<br />
(global navigation satellite<br />
system, acronimo GNSS) un<br />
sistema di geo-radio-localizzazione<br />
e navigazione, in<br />
grado di fornire un servizio di<br />
posizionamento geo-spaziale<br />
a copertura globale, e del sistema<br />
informativo geografico,<br />
(Geographic information<br />
system, acronimo GIS) un sistema<br />
informativo computerizzato<br />
in grado di associare dati<br />
alla loro posizione geografica<br />
sulla superficie terrestre, analizzarli,<br />
elaborarli, condividerli<br />
e restituirli in elaborati grafici<br />
o presentazioni.<br />
Queste nuove tecnologie sono<br />
utilizzate a supporto delle<br />
esigenze interventistiche del<br />
Corpo Nazionale dei Vigili<br />
del Fuoco. Infatti dall’esperienza<br />
maturata durante le<br />
grandi emergenze: l’ultimo<br />
sisma dell’Italia Centrale, l’emergenza<br />
della nave “Costa<br />
Concordia” e la tragedia di<br />
“Rigopiano”, sono solo alcuni<br />
degli esempi da poter annoverare,<br />
in occasione dei quali si<br />
è evidenziato come l’impiego<br />
di tali tecnologie siano state di<br />
grande utilità per la gestione<br />
delle risorse umane e squadre<br />
specialistiche, per la gestione<br />
dei mezzi tecnici e per il raggiungimento<br />
diretto dei luoghi<br />
di intervento riducendo sensibilmente<br />
i tempi di intervento,<br />
consentendo inoltre la velocizzazione<br />
e l’ottimizzazione<br />
dei rapporti con altre amministrazioni<br />
ed enti, accrescendo<br />
la sicurezza degli operatori del<br />
soccorso, generando in definitiva<br />
una risposta più efficiente<br />
nell’ambito del soccorso tecnico<br />
urgente.<br />
Come si interveniva prima<br />
dell’avvento di tali tecnologie?<br />
Cosa fare però se l’intervento<br />
era al di fuori dell’area urbana?<br />
Si consultava una carta topografica<br />
o escursionistica e da<br />
questa si risaliva alle informa-<br />
30 <strong>GEOmedia</strong> n°6-<strong>2021</strong>
REPORT<br />
zioni necessarie per raggiungere<br />
il luogo dell’intervento. Queste<br />
carte risultavano talvolta di difficile<br />
interpretazione, oltre che<br />
complicate da reperire e gestire.<br />
Il linguaggio comune di tutti<br />
questi sistemi fin ora visti,<br />
compresi quelli più tradizionali<br />
come le carte topografiche, è<br />
quello delle Coordinate, utilizzate<br />
nella determinazione in<br />
modo univoco della posizione<br />
di un punto sulla superfice terreste.<br />
La conoscenza cartografia, le<br />
coordinate in primis, l’utilizzo<br />
della tecnologia GNSS, in<br />
particolare il sistema GPS e<br />
l’impiego di supporti informatici<br />
per la gestione dei dati,<br />
sono gli elementi alla base<br />
dell’attuale modo di operare<br />
ed hanno consentito l’introduzione<br />
nell’ambito del Corpo<br />
Nazionale dei Vigili del Fuoco<br />
della Topografia Applicata al<br />
Soccorso acronimo T.A.S., il<br />
cui obbiettivo formativo è quello<br />
di fornire ai Vigili del Fuoco<br />
un impiego professionale di<br />
tali strumenti nell’ambito della<br />
pianificazione e della gestione<br />
degli interventi di soccorso.<br />
Il corso T.A.S. prevede due<br />
Lezione T.A.S., un momento della formazione in aula<br />
livelli di apprendimento ed il<br />
primo livello è quello rivolto al<br />
personale allievo dei vigili del<br />
fuoco.<br />
È incentrato sulla conoscenza<br />
del concetto di coordinate che<br />
permette poi di affrontare l’utilizzo<br />
delle carte topografiche<br />
e successivamente quello del<br />
sistema GPS. Un corso teorico-<br />
pratico strutturato sulla realtà<br />
interventistica e mirato a far<br />
comprendere al discente l’importanza<br />
di queste conoscenze<br />
per il soccorso tecnico e per la<br />
sicurezza dell’operatore stesso.<br />
Si analizzano, in aula e successivamente<br />
in ambiente, le<br />
procedure operative standard<br />
per intervento di soccorso<br />
Topografia applicata al soccorso, redazione di carte tematiche<br />
<strong>GEOmedia</strong> n°6-<strong>2021</strong> 31
TELERILEVAMENTO<br />
REPORT<br />
Obiettivi del Corso per<br />
Allievi Vigili del Fuoco:<br />
Interpretare ed utilizzare<br />
correttamente una carta<br />
topografica; utilizzare<br />
correttamente gli strumenti<br />
di carteggio GPS,<br />
bussola, altimetro; muoversi<br />
in ambienti impervi<br />
o sconosciuti in e con<br />
sicurezza; applicare il sistema<br />
ICS negli scenari<br />
operativi; saper utilizzare<br />
i programmi informatici<br />
cartografici GIS; sapere<br />
il quadro legislativo riferito<br />
al soccorso tecnico<br />
urgente.<br />
come ad esempio la ricerca a<br />
persona dispersa, mettendo in<br />
campo quelle conoscenze che<br />
permettono ad ogni operatore<br />
di entrare in un bosco, svolgere<br />
in team la propria attività in<br />
un determinata zona assegnata<br />
e di rientrare all’unità di comando<br />
avanzato, certificando<br />
il lavoro svolto. Un modo di<br />
operare che rende l’operatore<br />
consapevole della sua posizione<br />
attimo dopo attimo e che al<br />
tempo stesso consente di lasciare<br />
traccia dell’attività svolta<br />
riferita ad una base cartografica<br />
di riferimento per mezzo di coordinate.<br />
Perché tutto funzioni<br />
bene è necessario parlare la<br />
stessa lingua ovvero quella delle<br />
coordinate geografiche, questo<br />
rende il T.A.S. una delle materie<br />
base per il Corpo Nazionale<br />
dei Vigili del Fuoco a supporto<br />
dell’attività delle discipline interne<br />
quali l’attività di soccorso<br />
con tecniche di derivazione<br />
Speleo Alpino Fluviale e Unità<br />
Cinofile per “ricerca persona<br />
dispersa”, Emergenze Post<br />
Sisma per la realizzazione di<br />
mappe tematiche fondamentali<br />
per la pianificazione e la verifica<br />
dell’attività svolta.<br />
PAROLE CHIAVE<br />
T.A.S.; Topografia applicata; soccorso;<br />
protezione civile; vigili<br />
del fuoco<br />
ABSTRACT<br />
The Italian T.A.S. (Applied<br />
Topography to Rescue Service)<br />
supports the activities of the<br />
National Fire Brigade with the<br />
use of advanced geographical<br />
information referring to the<br />
emergency scenario and, in<br />
particular, to the scenarios that<br />
require the intervention of the<br />
National System of civil protection.<br />
The training focuses on<br />
the knowledge of the concept of<br />
coordinates which then allows to<br />
deal with the use of topographic<br />
maps and subsequently that of<br />
the GNSS system. A theoreticalpractical<br />
course structured on<br />
interventional reality and aimed<br />
at making the learner understand<br />
the importance of this<br />
knowledge for technical rescue<br />
and for the safety of the operator<br />
himself.<br />
AUTORE<br />
Daniele Mercuri, ingegnere<br />
VICE COMANDANTE DELLE<br />
SCUOLE CENTRALI ANTIN-<br />
CENDI VV.F.<br />
daniele1.mercuri@vigilfuoco.it<br />
MONITORAGGIO 3D<br />
GIS E WEBGIS<br />
www.gter.it info@gter.it<br />
32 <strong>GEOmedia</strong> n°6-<strong>2021</strong><br />
GNSS<br />
FORMAZIONE<br />
RICERCA E INNOVAZIONE
XXIV TH<br />
CONGRESS OF THE INTERNATIONAL SOCIETY<br />
FOR PHOTOGRAMMETRY AND REMOTE SENSING<br />
NICE, FRANCE<br />
6 - 11 JUNE 2022<br />
Don't miss the major meeting of<br />
the Geospatial Community<br />
www.isprs2022-nice .com<br />
PLATINUM GOLD SILVER BRONZE
REPORT<br />
Topo4qgis-un plugin per QGIS utile all'elaborazione<br />
di libretti PreGeo e alla trattazione di liste di punti<br />
mediante opportuna rototraslazione ai minimi quadrati<br />
di Marco Lombardi, Gianluca Beccaria<br />
"sarebbe utile poter elaborare i<br />
libretti PreGeo su di un GIS, così<br />
da poter valutare la bontà del<br />
rilievo eseguito dal Professionista,<br />
proiettandolo su foto aeree o<br />
basi cartografiche, al netto degli<br />
aggiustamenti introdotti in fase<br />
di redazione della proposta di<br />
aggiornamento cartografica":<br />
da questa frase scambiata<br />
nel gennaio 2020 tra l'allora<br />
responsabile del settore PreGeo<br />
dell'Ufficio Provinciale di Roma -<br />
Territorio, il Geometra Giovanni<br />
Camponeschi e l’Architetto<br />
Marco Lombardi, nasce l'idea di<br />
recuperare il plug-in topog4qgis,<br />
pubblicato nel 2013 per QGIS<br />
(versioni 2.xx) con licenza FOSS<br />
dall'Architetto Giuliano Curti e da<br />
Giuseppe Patti.<br />
Fig. 2 - Menu di Elaborazione del rilievo.<br />
Fig. 1 – topog4qgis – rilievo rototraslato.<br />
Ma cos’è topog4qgis? E’<br />
un plug-in topografico<br />
gratuito per QGIS,<br />
utile alla rototraslazione ai minimi<br />
quadrati di rilievi su rete di<br />
capisaldi (PSR o trigonometrici)<br />
o di Punti Fiduciali (PF) così<br />
come introdotti dalla Circolare<br />
n.2/1988, rilevati durante le operazioni<br />
di rilievo sul campo.<br />
Il plug-in supporta il formato<br />
DAT, come definito a partire<br />
dalla già citata Circolare ma accetta<br />
anche il libretto delle misure<br />
contenuto nella modulistica PDF,<br />
generata dal software PreGeo.<br />
topog4qgis può anche trattare<br />
liste di punti in formato CSV<br />
(con schema: nome;x;y;z;note),<br />
eventualmente già elaborate da<br />
altri software topografici.<br />
I capisaldi o punti fiduciali su<br />
cui il rilievo verrà rototraslato,<br />
possono essere desunti dal<br />
file TAF rilasciato dall’Ufficio<br />
Provinciale o attraverso un elenco<br />
di punti in formato .csv fornito<br />
dall’utente, anche in questo<br />
caso sarà un file con schema:<br />
nome;x;y;z;note.<br />
Il rilievo, una volta rototraslato<br />
sarà automaticamente salvato<br />
su layers di tipo puntuale e<br />
potrà essere visualizzato su basi<br />
cartografiche scelte dall'utente,<br />
opportunamente georeferite,<br />
proiettando i layers nel corretto<br />
sistema di riferimento attraverso<br />
i tools presenti in QGIS.<br />
Teoria e tecnica<br />
La trattazione dei libretti avviene<br />
in maniera totalmente automatica<br />
a seconda della tipologia<br />
di rilievo contenuta tra le righe:<br />
un rilievo celerimetrico definito<br />
da riga 1 (stazione) e riga 2<br />
34 <strong>GEOmedia</strong> n°6-<strong>2021</strong>
REPORT<br />
(osservazione), un rilievo GNSS<br />
o un rilievo misto contenente<br />
quindi stazioni celerimetriche<br />
e le corrispondenti osservazioni<br />
GNSS del punto di stazione<br />
e di orientamento. La giusta<br />
modalità di elaborazione viene<br />
scelta approcciando all'analisi<br />
del libretto attraverso uno flusso<br />
condizionato a blocchi dove<br />
ogni casistica viene trattata con<br />
un apposito algoritmo.<br />
Gli algoritmi per la trattazione<br />
dei dati celerimetrici sono stati<br />
scritti partendo dallo studio dei<br />
testi sacri delle topografia classica<br />
mentre per la trattazione delle<br />
osservazioni GNSS si è fatto<br />
ampio uso di quanto riportato<br />
nei capitoli relativi alle trasformazioni<br />
geocentriche e topocentriche<br />
per dati WGS84 contenute<br />
nella IOGP Publication<br />
373-7- 2 – Geomatics Guidance<br />
Note number 7, part 2 –<br />
September 2019.<br />
La rototraslazione ai minimi<br />
quadrati del rilievo in formato<br />
PreGeo o della lista di punti sui<br />
capisaldi avviene attraverso l'esecuzione,<br />
in ordine, delle seguenti<br />
quattro operazioni: calcolo dei<br />
4 parametri di rototraslazione<br />
ai minimi quadrati, esecuzione<br />
della matrice di rotazione e esecuzione<br />
della matrice di traslazione;<br />
in particolare l'algoritmo<br />
di calcolo dei 4 parametri restituisce:<br />
1) la traslazione sull'asse<br />
delle ascisse dei punti del rilievo<br />
(locale) rispetto alla cartografia,<br />
2) la traslazione sull'asse delle<br />
ordinate dei punti del rilievo<br />
(locale) rispetto alla cartografia,<br />
3) l'angolo di rotazione tra il<br />
"sistema di coordinate" del rilievo<br />
(locale) e il "sistema di coordinate"<br />
della cartografia e 4) il<br />
fattore di scala tra i due "sistemi<br />
di coordinate".<br />
Il plug-in topog4qgis, a differenza<br />
di PreGeo, non effettua<br />
invece il calcolo degli scarti<br />
quadratici metrici delle singole<br />
Fig. 3 - Avvenuta rototraslazione del rilievo e layers creati.<br />
osservazioni e non tratta i dati<br />
altimetrici combinandoli con<br />
quelli contenuti nella TAF,<br />
quindi le quote restituite dall'elaborazione<br />
sono calcolate a<br />
partire dai dati contenuti nella<br />
baseline GNSS definita con riga<br />
1 o calcolate in maniera assoluta<br />
partendo dalla prima stazione<br />
celerimetrica usando i dati contenuti<br />
nelle osservazioni.<br />
Utilizzo in campo<br />
La prima operazione è quella di<br />
importare il libretto PreGeo (in<br />
formato PDF o DAT) attraverso<br />
l’apposita voce contenuta nel<br />
menu File. La versatilità d’uso<br />
di topog4qgis si apprezza già in<br />
Fig. 4 - Panoramica delle funzionalità presenti nel plugin.<br />
questa fase poichè senza alcun<br />
intervento da parte dell’utente<br />
il libretto, sia esso celerimetrico<br />
o misto celerimetrico-gnss o<br />
solamente gnss, viene elaborato<br />
in maniera completamente automatica<br />
andando a considerare<br />
anche gli eventuali contorni<br />
(riga 7) o allineamenti e squadri<br />
(riga 4 e 5) presenti nel listato.<br />
La seconda operazione è quella<br />
dell’importazione, ai fini della<br />
rototraslazione, delle coordinate<br />
dei PF collimati in campo<br />
e questo avviene andando a<br />
scegliere il file TAF relativo<br />
alla provincia su cui si sta operando<br />
dall’apposita funzione<br />
raggiungibile dal menu "File".<br />
<strong>GEOmedia</strong> n°6-<strong>2021</strong> 35
REPORT<br />
Tra le funzioni utili troviamo<br />
anche la possibilità di importare<br />
l’estratto di mappa digitale<br />
fornito dall’Ufficio Provinciale<br />
in formato ascii su file “.emp”<br />
come base o per eventuali verifiche<br />
e considerazioni sulle<br />
geometrie in esso contenute.<br />
Eseguito l'import delle coordinate<br />
dei PF può essere eseguita<br />
la rototraslazione ai minimi<br />
quadrati del rilievo elaborato<br />
attraverso la voce "Rototrasla<br />
su PF/PSR" presente nel menu<br />
"Elaborazione".<br />
A questo punto è utile però fare<br />
un'osservazione: topog4qgis<br />
non è in grado di riconoscere<br />
se stiamo trattando un rilievo<br />
appartenente allo spazio definito<br />
da un sistema cartografico<br />
Cassini-Soldner o Gauss-Boaga<br />
perchè è un “calcolatore” o meglio<br />
“un esecutore di istruzioni”<br />
i cui risultati non sono altro che<br />
punti, individuati con coordinate<br />
cartesiane, appartenenti ad<br />
un sistema locale che possiamo<br />
considerare "indefinito".<br />
Il punto di contatto tra il rilievo<br />
elaborato e rototraslato nel<br />
sistema locale e la cartografia<br />
di destinazione sta nella definizione<br />
del sistema di riferimento<br />
(meglio conosciuto in ambiente<br />
QGIS come “SR”). Definito<br />
Fig. 5 - Menu relativo al trattamento dell'archivio TAF.<br />
il corretto riferimento sarà poi<br />
QGIS, attraverso i suoi tools<br />
interni, ad occuparsi della trasformazione<br />
tra diversi sistemi.<br />
La conoscenza del sistema di riferimento,<br />
soprattutto nel caso<br />
di un Cassini-Soldner, mette in<br />
condizione il Professionista di<br />
dover approfondire il contesto<br />
ove andrà a lavorare attraverso<br />
lo studio delle cartografie d’impianto<br />
e delle monografie dei<br />
trigonometrici (purtroppo non<br />
sempre di facile reperibilità) che<br />
lo porterà ad individuare correttamente<br />
l’origine locale, un<br />
passaggio questo che sottolinea<br />
il legame che esiste, semmai<br />
ci fosse ancora il bisogno di<br />
ricordarlo, tra conoscenza e innovazione<br />
tecnologica il quale<br />
passa, in questo caso, attraverso<br />
la figura del Geometra quale<br />
esperto del luogo in cui andrà<br />
ad operare.<br />
Il plug-in topog4qgis per questa<br />
fase del lavoro contribuisce ad<br />
alimentare il bisogno di un ritorno<br />
ad una conoscenza che in<br />
molti casi si è andata perdendo<br />
a causa di tutti gli automatismi<br />
che oggi ci sono in topografia.<br />
A questo punto, attribuita la<br />
corretta proiezione al nostro<br />
progetto, vedremo su layers opportunamente<br />
separati il rilievo<br />
collimato sui PF o sui PSR, i<br />
PF desunti dalla TAF o i PF/<br />
PSR desunti da file di testo e<br />
l'eventuale estratto di mappa digitale.<br />
Questa visione globale ci<br />
permetterà, anche graficamente,<br />
di apprezzare la bontà dei PF e<br />
delle loro coordinate.<br />
Continuando sulla questione<br />
PF, non dimentichiamoci che<br />
il sistema introdotto a partire<br />
dalla Circolare n.2/88 ha il suo<br />
"zoccolo duro" nel collaudo<br />
del Tipo (di Frazionamento o<br />
Mappale) attraverso le misurate<br />
presenti nell'archivio dell'Agenzia<br />
e NON nelle coordinate<br />
dei PF le quali che vengono<br />
solamente usate nel processo di<br />
rototraslazione. Purtroppo però,<br />
molto spesso le coordinate dei<br />
PF presenti sulla TAF sono affette<br />
da errori e questi, in fase<br />
di elaborazione fanno si che il<br />
rilievo venga proiettato in posizione<br />
distante anche rispetto<br />
a quella corretta sia in PreGeo<br />
che in QGIS.<br />
Il plug-in topog4qgis si rileva<br />
quindi utile anche a controllare<br />
la distorsione cartografica,<br />
infatti se utilizzato durante il<br />
rilievo in campo si avrà anche la<br />
possibilità di valutare la qualità<br />
dei PF collimati e eventualmente<br />
decidere di usarne degli altri<br />
senza dover necessariamente<br />
tornare una seconda volta sul<br />
posto (che magari si trova lontano<br />
centinaia di chilometri<br />
da casa), con lo stesso criterio<br />
si ha la possibilità di scegliere<br />
in itinere punti vertice o punti<br />
direzione da collimare in fase di<br />
rilievo come punti di aggancio<br />
per il successivo adattamento<br />
cartografico durante la stesura<br />
della proposta cartografica che<br />
avverrà in PreGeo.<br />
Il limite di topog4qgis nella<br />
sua attuale versione (0.3.7) è<br />
quello non gestire la rototraslazione<br />
in presenza di PF riferiti<br />
ad origini tra loro diverse ma<br />
si potrà comunque proiettare<br />
36 <strong>GEOmedia</strong> n°6-<strong>2021</strong>
REPORT<br />
il rilievo su cartografia georeferita<br />
in WSG84 qualora<br />
nel libretto “.dat” PreGeo sia<br />
presente una baseline gps/gnss<br />
valida. L'informazione sulla<br />
baseline gps/gnss potrà essere<br />
utilizzata ai fini del calcolo richiamando<br />
l'apposita funzione<br />
di proiezione presente del menu<br />
"Elaborazione".<br />
Conclusioni<br />
Al momento topog4qgis viene<br />
utilizzato anche in contesti<br />
diversi e con finalità diverse da<br />
quelle per cui è stato pensato<br />
dagli autori, viene infatti usato,<br />
in via sperimentale, dall’unità<br />
patrimonio edilizio di una società<br />
operante nel settore energetico<br />
per raccogliere in unico<br />
database geografico gli aggiornamenti<br />
cartografici, aventi ad<br />
oggetto l’inserimento in mappa<br />
dei propri fabbricati eseguiti<br />
con procedura PreGeo.<br />
Il plug-in viene anche utilizzato,<br />
sempre in via sperimentale,<br />
da alcuni uffici tecnici comunali<br />
per la verifica dei Tipi di<br />
Frazionamento depositati in via<br />
telematica ai sensi dell’art.30<br />
co.5 del D.P.R. 380/01. Per<br />
questo utilizzo topog4qgis è<br />
riuscito a rispondere alla necessità<br />
di visualizzare la particella<br />
oggetto di frazionamento sulla<br />
base cartografica (prescrittiva e<br />
gestionale) in possesso dell’Amministrazione.<br />
I due utilizzi “alternativi” sopra<br />
descritti denotano la versatilità<br />
del plug-in anche in conseguenza<br />
dei sempre più disponibili<br />
dataset cartografici e lasciano<br />
sperare che nel suo ciclo di<br />
vita,il software, possa beneficiaredi<br />
contributi di diversa<br />
natura.<br />
Ad oggi topog4qgis viene sviluppato<br />
e testato su base completamente<br />
gratuita volontaria, il<br />
suo punto di forza è certamente<br />
la licenza FOSS con cui viene<br />
pubblicato il software e il codice<br />
sorgente, questo ne ha permesso<br />
infatti la rinascita a distanza di<br />
sette anni dall'ultima versione<br />
pubblicata dall'Architetto<br />
Giuliano Curti. Inoltre la gratuità<br />
del plug-in ha dato luogo alla<br />
spontanea costituzione di una<br />
comunità di utilizzatori, composta<br />
in gran parte da Geometri,<br />
i quali comunicano allo sviluppatore<br />
input utili allo studio e<br />
all'implementazione di nuove<br />
funzionalità.<br />
Proprio dai feedback ricevuti<br />
dalla comunità è nata una funzionalità<br />
a partire dalla versione<br />
0.3.6, si tratta di uno strumento<br />
utile per lo studio preliminare<br />
dei Punti Fiduciali oggetto di rilievo<br />
introducendo la possibilità<br />
di importare su QGIS il file TAF<br />
direttamente dal menu File.<br />
Una volta scelto l'archivio provinciale,<br />
in formato TAF, presente<br />
sul nostro PC, una finestra<br />
ci mostrerà l'elenco dei comuni<br />
presenti al suo interno. Scelto il<br />
comune da importare in QGIS<br />
basterà cliccare su "Crea layer<br />
con il Comune selezionato" per<br />
avere un layer di punti dove ogni<br />
PF completo di monografia sarà<br />
individuato graficamente con un<br />
triangolo verde.<br />
Possiamo inoltre indicare a<br />
topog4qgis di creare un layer<br />
contenente solamente i PF privi<br />
di monografia e questi verranno<br />
graficamente individuati<br />
con un triangolo rosso e con<br />
gli "Strumenti di Geometria"<br />
disponibili in QGIS possiamo<br />
a questo collegare i punti con<br />
il metodo di Delaunay così da<br />
avere l'evidenza dei PF c.d. "di<br />
primo perimetro" (definizione<br />
contenuta nella già citata<br />
Circolare n.2/1988) rispetto alla<br />
nostra area oggetto di rilievo.<br />
E qualora fossimo già in possesso<br />
dell'estratto di mappa<br />
digitale (non sempre nella disponibilità<br />
del tecnico prima<br />
del rilievo) possiamo importarlo<br />
per avere l'evidenza dei PF senza<br />
monografia o con coordinate<br />
cartografiche diverse da quelle<br />
presenti nella TAF.<br />
Risulta utile ricordare che<br />
già dalle ultime versioni di<br />
topog4qgis il file relativo all'estratto<br />
di mappa digitale può<br />
essere importato dal menu<br />
Funzioni e gli eventuali PF con<br />
coordinate cartografiche diverse<br />
da quelle presenti in TAF<br />
verranno automaticamente<br />
rappresentati con un triangolo<br />
di colore viola. Questo tipo di<br />
verifica preliminare eviterà il<br />
Fig. 6 - Immagine relativa ad un caso pratico, dove uno dei PF era privo di monografia e con coordinate cartografiche<br />
diverse da quelle contenute nella TAF e quindi l'oggetto del rilievo risultava negativamente influenzato<br />
dal PF errato. Il risultato è stato ottenuto utilizzando la funzionalità per il trattamento dell'archivio TAF<br />
e attraverso gli "Strumenti di Geometria" disponibili in QGIS con cui si sono generati i triangoli fiduciali.<br />
<strong>GEOmedia</strong> n°6-<strong>2021</strong> 37
REPORT<br />
problema dello scarto automatico<br />
del libretto delle misure da<br />
parte del sistema informatico in<br />
uso presso l'AdE - Territorio per<br />
"PF di primo perimetro fuori<br />
dal rilievo".<br />
L'augurio che vogliamo fare a<br />
topog4qgis è quello di continuare<br />
ad essere scaricato e utilizzato<br />
(soprattutto dai giovani),<br />
studiato e ulteriormente sviluppato<br />
da appassionati come noi<br />
alla materia topografica, cartografica<br />
e catastale. Appassionati<br />
che come noi sposano l'idea che<br />
la condivisione della conoscenza<br />
e la presenza di applicazioni<br />
gratuite e open source siano<br />
un volano utile per tutti quei<br />
giovani che si avvicinano alla<br />
professione ma che desistono<br />
perché scoraggiati dall'alto costo<br />
dei software e delle attrezzature<br />
topografiche.<br />
RIFERIMENTI<br />
Pagina ufficiale sul repository QGis -> https://plugins.qgis.org/plugins/topog4qgis/<br />
Blog ufficiale - > https://topog4qgis.wordpress.com/<br />
PAROLE CHIAVE<br />
catasto; pregeo; qgis; rototraslazione; Open Source<br />
minimi quadrati<br />
ABSTRACT<br />
topog4qgis is a QGis 3 plugin for the italian cadastre update procedure (PreGeo)<br />
that allowing the user to manage classical surveys and gps or points list (.csv files).<br />
Least mean square method georeferencing the survey in an absolute official geographic<br />
space is allowed by measuring, during surveys, the trigonometrical points<br />
and by using the official map from the cadastre database (.edm files) or by reading<br />
the trigonometricals table (.taf files). Surveying of delimiting lines (e.g. between<br />
particles, or delimiting a building) is correctly interpreted by the plugin.<br />
Please note that this plugin is mainly related to datas provided by the italian<br />
surveying agency (former Agenzia del Territorio is now Agenzia delle Entrate), and<br />
its use is then strictly limited to the italian country but use of points lists (.csv files)<br />
allows to use for other country with the same cadastre cartografy system.<br />
Autore<br />
Marco Lombardi,<br />
marco.lombardi.rm@gmail.com<br />
Architetto<br />
Gianluca Beccaria<br />
geom.beccaria@gmail.com<br />
Geometra<br />
38 <strong>GEOmedia</strong> n°6-<strong>2021</strong>
REPORT<br />
Tecniche di rilievo integrato<br />
per processi Scan-to-BIM<br />
di Mauro Lo Brutto<br />
Utilizzo del processo HBIM<br />
(Historic o Heritage - Building<br />
Information Modeling)<br />
applicato a edifici di valore<br />
storico e architettonico,<br />
combinato con l’approccio<br />
Scan-to-BIM attraverso<br />
l’esecuzione di moderne<br />
tecniche di rilievo integrato<br />
3D nel caso di studio della<br />
“Real Cantina Borbonica" di<br />
Partinico (PA).<br />
Fig. 1 - Facciata principale della "Real Cantina Borbonica".<br />
Negli ultimi anni, l'innovazione<br />
tecnologica<br />
per la pianificazione,<br />
la gestione e la conservazione<br />
degli edifici è stata notevolmente<br />
potenziata dall'approccio<br />
BIM (Building Information<br />
Modeling). Come è noto il BIM<br />
è usato per definire un processo<br />
collaborativo per la realizzazione<br />
e la gestione di un edificio o di<br />
una infrastruttura durante il suo<br />
intero ciclo di vita, dalla pianificazione<br />
alla demolizione. Il BIM<br />
è stato originariamente sviluppato<br />
come un processo per il settore<br />
delle nuove costruzioni, ma in<br />
considerazione dei notevoli benefici<br />
per i settori dell'architettura,<br />
dell'ingegneria e delle costruzioni<br />
(Architectural, Engineering and<br />
Construction - AEC) il suo impiego<br />
è stato esteso con successo<br />
anche per gli edifici esistenti,<br />
specialmente per quelli storici.<br />
Quando il processo BIM è applicato<br />
a edifici di valore storico<br />
e architettonico viene in genere<br />
definito con l’acronimo HBIM<br />
(Historic o Heritage - Building<br />
Information Modeling).<br />
Per lo sviluppo di un HBIM è<br />
però necessario far precedere la<br />
fase di modellazione parametrica,<br />
tipica del processo BIM, da un<br />
rilievo 3D per acquisire tutti i<br />
dati geometrici utili alla produzione<br />
del modello tridimensionale<br />
as-built dell'edificio stesso<br />
(Murphy et al., 2017). Questo<br />
approccio è chiamato Scan-to-<br />
BIM e prevede l'utilizzo di moderne<br />
tecniche di rilievo 3D (laser<br />
scanner e/o fotogrammetria)<br />
che permettono la generazione<br />
di nuvole di punti utilizzate per<br />
la successiva fase di modellazione<br />
parametrica (Wang et al, 2019).<br />
L’approccio Scan-to-BIM (cioè<br />
il processo di creazione di un<br />
modello informativo parametrico<br />
dell'edificio da una nuvola di<br />
punti) è una delle maggiori sfide<br />
nello sviluppo dell'HBIM che<br />
può però presentare alcune difficoltà<br />
dovute sia alla fase di rilievo<br />
3D che alla fase di modellazione<br />
parametrica. Le dimensioni e la<br />
complessità architettonica dell'edificio,<br />
così come la situazione<br />
logistica, spesso condizionano<br />
il rilievo 3D; le forme degli elementi<br />
architettonici delle architetture<br />
storiche, più particolari<br />
rispetto a quelle dell’architettura<br />
moderna, e la conseguente<br />
mancanza di appropriati oggetti<br />
parametrici o "famiglie" nella<br />
libreria del software BIM potrebbero<br />
rendere la modellazione<br />
parametrica molto più difficile o<br />
addirittura impossibile.<br />
Per l'acquisizione dei dati 3D,<br />
l'integrazione di diverse tecniche<br />
e l’utilizzo di diverse "strategie"<br />
40 <strong>GEOmedia</strong> n°6-<strong>2021</strong>
REPORT<br />
di rilievo sono spesso essenziali<br />
per superare le difficoltà logistiche,<br />
soprattutto quando gli<br />
oggetti da rilevare sono edifici<br />
complessi o si trovano in luoghi<br />
dove è difficile operare (per<br />
esempio all’interno dei centri<br />
storici). In genere, una delle<br />
strategie di rilievo più utilizzate<br />
prevede che l'acquisizione dei<br />
dati 3D dell'interno dell'edificio<br />
possa essere effettuata tramite un<br />
rilievo laser scanner mentre i dati<br />
dell'esterno vengano ricavati con<br />
rilievi laser scanner e/o fotogrammetrici<br />
soprattutto tramite UAS<br />
(Unmanned Aircraft Systems)<br />
(Rocha et al., 2020).<br />
Uno dei problemi più comuni<br />
nell'acquisizione dei dati durante<br />
un processo Scan-to-BIM è<br />
comunque quello di collegare i<br />
rilievi effettuati all'interno con<br />
quelli all'esterno dell'edificio, soprattutto<br />
in tutti quei casi in cui<br />
le aperture o i passaggi tra interno<br />
ed esterno sono molto limitati<br />
(Murtiyoso e Grussenmeyer,<br />
2018). La corretta unione delle<br />
nuvole di punti generate per<br />
l'interno con quelle ottenute<br />
per l'esterno è un passo molto<br />
importante per garantire l’esatta<br />
ricostruzione della geometria<br />
complessiva dell'edificio.<br />
Per verificare approcci basati<br />
sull'integrazione di diverse tecniche<br />
di rilievo (topografia, fotogrammetria<br />
e laser scanning)<br />
che migliorino la fase di acquisizione<br />
dei dati nel processo<br />
Scan-to-BIM è stato sperimentato<br />
un metodo di rilievo basato<br />
esclusivamente su un vincolo<br />
topografico per unire nello stesso<br />
sistema di riferimento tutti i<br />
dati acquisiti (nuvole di punti<br />
laser scanner, nuvole di punti<br />
fotogrammetriche). Questo<br />
metodo è stato applicato per<br />
realizzare il modello parametrico<br />
HBIM della “Real Cantina<br />
Borbonica” di Partinico in provincia<br />
di Palermo.<br />
La "Real Cantina Borbonica"<br />
di Partinico costruita per ordine<br />
del re Ferdinando I di<br />
Borbone tra il 1800 e il 1802<br />
rappresenta un singolare esempio<br />
dell'architettura industriale<br />
avanzata dell'epoca. L’edificio<br />
ha una pianta rettangolare di<br />
circa 1000 m2 (circa 36 metri<br />
in lunghezza per 26 m in larghezza)<br />
ed è composto da un<br />
corpo principale più una parte<br />
secondaria (sul lato sud-est)<br />
che era pre-esistente rispetto al<br />
corpo principale. Il corpo principale<br />
dell’edificio è diviso in<br />
tre navate sostenute da pilastri e<br />
archi. La navata destra e quella<br />
centrale sono aperte (Fig. 1),<br />
mentre la navata sinistra è stata<br />
chiusa con un muro.<br />
L'acquisizione dei dati è stata<br />
pianificata eseguendo un rilievo<br />
topografico finalizzato a misurare<br />
una poligonale topografica<br />
chiusa all’esterno dell'edificio,<br />
un rilievo laser scanning per<br />
acquisire una nuvola di punti<br />
degli ambienti interni e un rilievo<br />
fotogrammetrico da UAS<br />
per ottenere una nuvola di<br />
punti delle parti esterne dell'edificio.<br />
Il risultato del rilievo<br />
doveva essere una nuvola di<br />
punti unica dell’intero edificio<br />
con una risoluzione inferiore<br />
ad 1 centimetro e utilizzabile<br />
per le successive operazioni di<br />
Fig. 3 – Fasi del rilievo laser scanner all’esterno e all’interno dell’edificio.<br />
Fig. 2 - Interno della "Real Cantina Borbonica".<br />
modellazione. L'aspetto più critico<br />
del rilievo era rappresentato<br />
dal collegamento tra l'ambiente<br />
interno e quello esterno. Questo<br />
collegamento poteva essere fatto<br />
solo attraverso i due ingressi nella<br />
facciata principale (Fig. 2).<br />
La poligonale topografica esterna,<br />
<strong>GEOmedia</strong> n°6-<strong>2021</strong> 41
REPORT<br />
Fig. 4 - Schema della poligonale topografica esterna (in rosso) e della poligonale<br />
laser scanner (in giallo).<br />
misurata con una stazione totale,<br />
era composta da 12 vertici ed è<br />
stata calcolata in un sistema di riferimento<br />
locale ottenendo scarti<br />
quadratici medi delle coordinate<br />
nell’ordine di qualche millimetro<br />
sia in planimetria che in quota.<br />
La poligonale topografica è stata<br />
utilizzata per definire un sistema<br />
di riferimento comune per tutti<br />
i dati e per misurare i Ground<br />
Control Points (GCPs) e i Check<br />
Points (CPs) per il rilievo fotogrammetrico.<br />
Fig. 5 - Schema di prese per il rilievo fotogrammetrico da UAS.<br />
Il rilievo laser scanner è stato<br />
eseguito con uno strumento<br />
Topcon GLS-2000; sfruttando<br />
l'approccio topografico per la<br />
registrazione delle scansioni disponibile<br />
con questo strumento,<br />
il rilievo laser scanner è stato<br />
eseguito in modo tale che tutti i<br />
punti di scansione fossero collegati<br />
per formare una poligonale<br />
topografica interna all’edificio<br />
(Fig. 3). La poligonale laser scanner<br />
è stata realizzata imponendo<br />
che due punti di scansione<br />
fossero posizionati all'esterno<br />
dell'edificio in corrispondenza<br />
di due vertici della poligonale<br />
topografica (il primo vertice della<br />
poligonale e il punto di orientamento<br />
della poligonale) (Fig. 4).<br />
Le scansioni sono state quindi<br />
registrate automaticamente in<br />
fase di acquisizione. Questo<br />
metodo consente di utilizzare il<br />
laser scanner come strumento<br />
topografico e ha il vantaggio di<br />
permettere il collegamento di<br />
scansioni senza elevate percentuali<br />
di aree comuni. L'approccio<br />
topografico nella registrazione<br />
delle scansioni laser rappresenta<br />
un metodo particolarmente utile<br />
per superare i problemi di allineamento<br />
tra le scansioni all'interno<br />
e all'esterno degli edifici.<br />
Inoltre, consente anche di avere<br />
tutti i dati laser scanner già in<br />
fase di acquisizione nello stesso<br />
sistema di riferimento topografico<br />
utilizzato per le altre tecniche<br />
di misura (rilievo topografico e<br />
fotogrammetrico).<br />
Per completare il rilievo 3D della<br />
"Real Cantina Borbonica", è stato<br />
necessario eseguire le acquisizioni<br />
laser scanner anche del lato<br />
sud-est. Questo è composto da<br />
diverse stanze al piano terra non<br />
accessibili dalla sala principale e<br />
da un portico esterno superiore.<br />
L'acquisizione dei dati di questi<br />
spazi è stata effettuata con un<br />
laser scanner Faro Focus 120 S<br />
applicando la tipica metodologia<br />
di scansione laser (diverse scansioni<br />
con un'alta percentuale di<br />
sovrapposizione per garantire una<br />
corretta registrazione).<br />
L'elaborazione e l'allineamento<br />
delle scansioni acquisite con il<br />
laser scanner GLS-2000 sono<br />
stati eseguiti con il software<br />
MAGNET Collage di Topcon.<br />
Con questo software, è stato possibile<br />
gestire i dati della poligonale<br />
laser scanner correggendo i<br />
piccoli errori di allineamento che<br />
si erano verificati durante l'acquisizione.<br />
Inoltre, è stato anche<br />
possibile eseguire l’allineamento<br />
42 <strong>GEOmedia</strong> n°6-<strong>2021</strong>
REPORT<br />
tramite procedure automatiche<br />
delle nuvole di punti non direttamente<br />
collegate alla poligonale<br />
laser scanner.<br />
Il rilievo fotogrammetrico è stato<br />
effettuato utilizzando un UAS<br />
per rilevare tutte le parti esterne<br />
dell'edificio. Per l'acquisizione<br />
delle immagini è stato utilizzato<br />
un multirotore ultraleggero, che<br />
ha permesso di sorvolare le aree<br />
di studio superando le restrizioni<br />
imposte dai regolamenti ENAC.<br />
Sono state utilizzate diverse configurazioni<br />
di presa per rilevare il<br />
tetto e le facciate: un volo nadirale<br />
per il tetto, due voli circolari<br />
con prese oblique per il tetto e le<br />
facciate, e voli con una vista parallela<br />
delle facciate (Fig. 5).<br />
Il rilievo ha permesso di ottenere<br />
una nuvola di punti complessiva<br />
dell'edificio a partire da due<br />
nuvole di punti perfettamente<br />
sovrapponibili; una dell'interno<br />
ottenuta dal rilievo laser scanner<br />
e una dell'esterno ottenuta dal rilievo<br />
UAS (Fig. 6). Le due nuvole<br />
di punti sono state sovrapposte<br />
e unite semplicemente in base<br />
alle loro coordinate. I controlli e<br />
le verifiche eseguite sulla nuvola<br />
di punti complessiva (soprattutto<br />
lungo sezioni orizzontali e verticali)<br />
non ha evidenziato anomalie<br />
o discordanze dal punto di<br />
vista geometrico, confermando la<br />
bontà dell’approccio adoperato.<br />
La nuvola di punti finale è stata<br />
quindi utilizzata per la modellazione<br />
parametrica in ambiente<br />
BIM utilizzando il software Revit<br />
di Autodesk. Ogni elemento<br />
architettonico dell'edificio è<br />
stato ricostruito come elemento<br />
parametrico usando le informazioni<br />
della nuvola di punti. La<br />
modellazione parametrica degli<br />
elementi architettonici non è<br />
risultata così semplice poiché<br />
molti elementi avevano spesso<br />
forme uniche che le tipiche<br />
librerie BIM non includono.<br />
Per questo motivo, sono state<br />
create nuove famiglie per alcuni<br />
elementi architettonici come<br />
porte, finestre e volte. Il prodotto<br />
finale è rappresentato dal modello<br />
parametrico HBIM della<br />
Real Cantina Borbonica (Fig.<br />
7). Questo modello costituisce<br />
la base geometrica per qualsiasi<br />
futuro intervento di manutenzione<br />
e restauro dell’edificio che<br />
può essere progettato e gestito in<br />
ambiente HBIM.<br />
Fig. 6 - Sovrapposizione delle due nuvole di punti relative all’interno<br />
e all’esterno dell’edificio per ottenere la nuvola di punti<br />
complessiva.<br />
BIBLIOGRAFIA<br />
Lo Brutto, M., Iuculano, E., and Lo Giudice, P.:<br />
INTEGRATING TOPOGRAPHIC,<br />
PHOTOGRAMMETRIC AND LASER SCANNING<br />
TECHNIQUES FOR A SCAN-TO-BIM PROCESS,<br />
Int. Arch. Photogramm. Remote Sens. Spatial Inf.<br />
Sci., XLIII-B2-<strong>2021</strong>, 883–890, https://doi.org/10.5194/<br />
isprs-archives-XLIII-B2-<strong>2021</strong>-883-<strong>2021</strong>, <strong>2021</strong><br />
Murphy, M., Corns, A., Cahill, J., Eliashvili, K.,<br />
Chenau, A., Pybus, C., Shaw, R., Devlin, G., Deevy, A.,<br />
and Truong-Hong, L., 2017. Developing historic build-ing<br />
information modelling guidelines and procedures for<br />
architectural heritage in Ireland. Int. Arch. Photogramm.<br />
Remote Sens. Spatial Inf. Sci., XLII-2/W5, 539–546.<br />
Murtiyoso, A., Grussenmeyer, P., 2018. Comparison and<br />
assessment of 3D registration approaches of point clouds in<br />
the case of exterior and interior heritage building recording.<br />
Int. Arch. Photogramm. Remote Sens. Spatial<br />
Inf. Sci., XLII-2, 745–751.<br />
Rocha, G., Mateus, L., Fernández, J., Ferreira, V., 2020. A<br />
Scan-to-BIM Methodology Applied to Heritage<br />
Buildings. Heritage, 3(1), 47-67.<br />
Wang, Q., Guo, J., Kim, M.-K., 2019. An Application<br />
Oriented Scan-to-BIM Framework. Remote Sensing,<br />
11(3), 365, 2-27.<br />
PAROLE CHIAVE<br />
Laser scanner; UAV; Point cloud;<br />
3D modeling; HBIM; Scan-to-BIM<br />
ABSTRACT<br />
The preservation of historic buildings can often be particularly<br />
difficult due to the lack of detailed information<br />
about architectural features, construction details, etc.<br />
However, in recent years considerable technological innovation<br />
in the field of Architecture, Engineering, and<br />
Construction (AEC) has been achieved by the Building<br />
Information Modeling (BIM) process. In this case, it is more<br />
properly referred to as Historic - or Heritage - Building<br />
Information Modeling (HBIM). In the HBIM process, it is<br />
essential to precede the parametric modeling phase of the<br />
building with a detailed 3D survey that al-lows the<br />
acquisition of all geometric information. This<br />
methodology,called Scan-to-BIM, involves the use of 3D<br />
survey techniques to produce point clouds as a geometric<br />
“database” for parametric modeling.<br />
The “Real Cantina Borbonica" (Cellar of Royal House of<br />
Bourbon) in Partinico (Sicily, Italy) was chosen as a case<br />
study. The work has allowed achieving the HBIM of the<br />
"Real Cantina Borbonica" and testing an approach based<br />
exclusively on a topographic constraint to merge in the same<br />
reference system all the survey data (laser scan-ner and<br />
photogrammetric point clouds).<br />
Fig. 7 - Spaccato assonometrico del modello parametrico.<br />
AUTORE<br />
Mauro Lo Brutto,<br />
mauro.lobrutto@unipa.it<br />
Dipartimento di Ingegneria, Università di Palermo<br />
<strong>GEOmedia</strong> n°6-<strong>2021</strong> 43
MERCATO<br />
IL VERO ECOSCANDAGLIO MULTIBEAM AD<br />
ALTA FREQUENZA: TELEDYNE RESON -<br />
SEABAT T51-R<br />
1024 Beam con apertura di soli 0,25°x0,5° disponibili<br />
su tutti i 170 gradi di swath? È possibile, grazie al<br />
trasduttore specifico per le alte frequenze installato nei<br />
nuovissimi Reson T-51. Come sono necessari altoparlanti<br />
diversi per basse e alte frequenze per riprodurre la<br />
musica, anche l'acustica subacquea segue le stesse regole.<br />
Reson non si è limitata a far cantare in falsetto un baritono,<br />
ma ha dato una nuova voce al suo già completo T-50<br />
aggiungendo un array specifico per le alte frequenze.<br />
Risultato?<br />
• Risoluzione e definizione a livelli mai visti<br />
• Copertura di 170° disponibile su tutte le frequenze,<br />
anche a 800kHz.<br />
• Dati puliti e definiti pronti all'uso con tempi di elaborazione<br />
ridotti.<br />
• Comandi sonar autonomi gestiti da Intelligenza<br />
Artificiale: tutto più facile.<br />
• Tre anni di garanzia standard per la massima tranquillità.<br />
• Reson e Codevintec ancora una volta leader negli ecoscandagli<br />
multibeam.<br />
Oltre alle rivoluzionarie prestazioni a 800kHz, il SeaBat<br />
T51-R è dotato anche di una gamma flessibile di frequenza<br />
inferiore a 350-430kHz, destinata a quei rilievi<br />
in cui sono richieste prestazioni a più ampio raggio,<br />
offrendo una soluzione veramente flessibile per tutte le<br />
occasioni.<br />
I controlli autonomi del sonar SeaBat T51, un’innovazione<br />
esclusiva di SeaBat, forniscono dati affidabili e un<br />
funzionamento del sonar veramente a mani libere, consentendo<br />
una maggiore efficienza di indagine con un ridotto<br />
carico di lavoro dell’operatore.<br />
Nuovo trasduttore T51 con doppio Array (immagine)<br />
1. Array per basse frequenze<br />
2. Array per alte frequenze<br />
Per ulteriori informazioni:<br />
www.codevintec.it info@codevintec.it<br />
Works when you do<br />
X-PAD Ultimate<br />
Tutto in un unico software<br />
X-PAD Ultimate è un software modulare, facile da usare per lavori<br />
topografici e del cantiere, come rilievi, tracciamenti, catasto,<br />
controlli BIM, strade, mappe, batimetria e GIS.<br />
Il software è disponibile sulla piattaforma Android e porta le<br />
migliori tecnologie direttamente in campo nella tua mano: una<br />
completa visualizzazione 3D ed un sistema CAD per visualizzare e<br />
modificare i disegni, integrazione dei tuoi dati con tutte le tipologie<br />
di mappe, supporti per la realtà aumentata e molto altro.<br />
44 <strong>GEOmedia</strong> n°2-<strong>2021</strong><br />
XPad Ultimate ti assicura la produttività e ti permette di avere una<br />
perfetta integrazione con tutti gli strumenti.<br />
Disponibile in due versioni, una dedicata a chi lavora nel campo<br />
della topografia ed una dedicata alle imprese di costruzioni,<br />
offrendo ad entrambi delle caratteristiche dedicate.<br />
geomax-positioning.it<br />
©2020 Hexagon AB and/or its subsidiaries<br />
and affiliates. All rights reserved.
MERCATO<br />
TPAD: IL FUTURO DEL RILIEVO<br />
TOPOGRAFICO CON GNSS È QUI<br />
“Il rilievo topografico è un’operazione piuttosto facile<br />
per un topografo!” Detto a parole può sembrare un<br />
lavoro piuttosto semplice ma la realtà dei fatti è ben<br />
diversa, e molti professionisti del settore lo possono<br />
confermare! Oltre al tempo da dedicare alle operazioni<br />
comuni, come il montaggio della strumentazione<br />
e il rilievo in sé, ci sono da considerare anche i problemi<br />
che si possono verificare in corso d’opera, la<br />
connessione tentennante dell’antenna alla rete, se si<br />
lavora, ad esempio, con il solo Rover e il corretto funzionamento<br />
degli strumenti.<br />
Avere un buon GPS è sicuramente la base di partenza<br />
per effettuare un rilievo topografico ad-hoc ma il vero<br />
protagonista nei rilievi, oltre al topografo, è l’applicativo<br />
utilizzato per il rilievo/tracciamento dei punti.<br />
Stonex, Emlid, Tersus, Geomax, Kolida; non importa<br />
quale sia la marca del GPS, chi fa la differenza è l’applicazione<br />
da campo che si utilizza.<br />
Avere piena libertà nella gestione delle operazioni permette<br />
al topografo, di avere tutto sotto controllo e al<br />
GPS, di diventare un potente strumento di rilievo.<br />
TPad è un applicativo topografico per Android, capace<br />
di adattarsi ai dispositivi GNSS con protocollo<br />
NMEA, garantendo massima precisione nei rilievi. È<br />
possibile, infatti, gestire strumenti topografici di marche<br />
diverse tramite connessione WiFi e Bluetooth.<br />
Finalmente è possibile dire addio ai vecchi palmari, ai<br />
tablet Windows, ai software obsoleti e complicatissimi!<br />
Con TPad, tutto quello di cui si ha bisogno, lo si<br />
trova direttamente sul proprio cellulare o tablet.<br />
Dotato di tantissime funzionalità, TPad regala forti<br />
emozioni!<br />
Progettato su misura del topografo, ad ogni punto inserito,<br />
è possibile associare codici e descrizioni, fotografie<br />
o addirittura video; in questo modo, si è sicuri<br />
di non dimenticare niente anche se si elabora il rilievo<br />
dopo tanto tempo.<br />
Nel caso in cui il punto da rilevare fosse uno spigolo<br />
di fabbricato o un punto nascosto, utilizzando il comando<br />
“Punto per intersezione”, TPad potrà calcolare<br />
l’esatta posizione del punto grazie alla classica intersezione<br />
in avanti (mediante due ausiliari).<br />
Per scoprire tutte le funzionalità su TPad, visita il sito<br />
Strumenti Topografici a questo link (https://www.<br />
strumentitopografici.it/tpad/).<br />
È possibile provare l’app topografica, scaricandola<br />
gratis da Google Play Store su un cellulare o tablet<br />
Android.<br />
C’è vita nel nostro mondo.<br />
Trasformazione e pubblicazione di dati<br />
territoriali in conformità a INSPIRE<br />
Assistenza su Hight Value Datasets,<br />
APIs, Location Intelligence, Data Spaces<br />
INSPIRE Helpdesk<br />
We support all INSPIRE implementers<br />
Epsilon Italia S.r.l.<br />
Viale della Concordia, 79<br />
87040 Mendicino (CS)<br />
Tel. e Fax (+39) 0984 631949<br />
info@epsilon-italia.it<br />
www.epsilon-italia.it<br />
www.inspire-helpdesk.eu<br />
<strong>GEOmedia</strong> n°2-<strong>2021</strong> 45
TERRA E SPAZIO<br />
La navigazione<br />
astronomica è<br />
sempre attuale<br />
di Marco Lisi<br />
La navigazione astronomica è<br />
quella basata sull’osservazione<br />
di corpi celesti (stelle, pianeti,<br />
sole e luna), ovviamente quando<br />
visibili.<br />
Parlare di navigazione<br />
astronomica, in un’epoca<br />
di diffusione capillare delle<br />
più moderne tecnologie, in<br />
particolare quelle basate<br />
sulle costellazioni globali<br />
di satelliti (GPS, GLONASS,<br />
Galileo e Beidou) può sembrare<br />
anacronistico e poco utile.<br />
Prenderemo il discorso molto<br />
alla lontana, raccontando una<br />
storia di guerra molto triste,<br />
ma al contempo estremamente<br />
educativa, quella di un<br />
bombardiere della US Air Force<br />
B24D Liberator, soprannominato<br />
“Lady be good” dal suo<br />
Siamo nell’aprile del<br />
1943 e il “Lady be<br />
good”, partito da una<br />
base vicino a Bengasi in Libia,<br />
era di ritorno da una missione<br />
di bombardamento su Napoli,<br />
con il suo equipaggio di nove<br />
uomini, fra i quali due piloti<br />
ed un navigatore.<br />
Qui è necessaria una prima<br />
precisazione: erano tempi di<br />
guerra, la richiesta di nuovi<br />
aviatori era pressante ed i corsi<br />
di formazione erano stati<br />
ridotti al minimo indispensabile,<br />
per esempio, non sempre<br />
includevano l’utilizzo di strumenti,<br />
quali il sestante, per la<br />
navigazione astronomica.<br />
La navigazione astronomica<br />
con il sestante veniva utilizzata<br />
sui bombardieri di lungo raggio,<br />
quali le famose “fortezze<br />
volanti” (figura 1).<br />
Sui bombardieri di corto e<br />
medio raggio il metodo di<br />
navigazione utilizzato era<br />
esclusivamente quello della<br />
“navigazione stimata” (“dead<br />
reckoning”), basato sulla registrazione<br />
quanto più accurata<br />
possibile della direzione, della<br />
velocità e dell’ora sul libro di<br />
bordo, eseguita dal navigatore.<br />
L’aereo in questione era anche<br />
dotato di un rudimentale sistema<br />
di radionavigazione che,<br />
attraverso un’antenna direzionale,<br />
era in grado di rilevare<br />
la posizione relativamente<br />
equipaggio.<br />
Fig. 1 - La cupola (“astrodome”) sulla fusoliera del Boeing B-17 “Flying Fortress”, utilizzata per le<br />
rilevazioni col sestante.<br />
46 <strong>GEOmedia</strong> n°6-<strong>2021</strong>
TERRA E SPAZIO<br />
ad eventuali radiofari (“beacons”).<br />
Nella confusione della missione<br />
e, forse, per l’inesperienza<br />
e l’emozione del navigatore, il<br />
sistema di navigazione stimata<br />
andò a pallino e l’equipaggio<br />
si rese presto conto di essersi<br />
perso sulla via del ritorno: a<br />
parte la certezza di volare verso<br />
sud, non avevano più alcuna<br />
idea della loro latitudine e<br />
della distanza dalla base di<br />
partenza.<br />
Pensarono allora di ricorrere<br />
all’apparato di radionavigazione,<br />
orientandolo verso un<br />
radiofaro situato a Benina, sulla<br />
costa della Libia e vicino a<br />
Bengasi. Il rilevamento sembrò<br />
confermare che stavano procedendo<br />
nella giusta direzione,<br />
anche se la loro base continuava<br />
a non essere visibile ed il<br />
carburante cominciava a scarseggiare.<br />
Lo sfortunato equipaggio non<br />
aveva tenuto conto che l’antenna<br />
direzionale non era in<br />
grado di distinguere il senso di<br />
provenienza dei segnali del radiofaro,<br />
il quale non era in realtà<br />
a sud, ma a nord della loro<br />
posizione: avevano superato da<br />
tempo la costa libica, Bengasi<br />
e la loro base e si erano inconsapevolmente<br />
addentrati nel<br />
deserto.<br />
Aereo ed equipaggio furono<br />
dati per dispersi. Solo nel<br />
1958 un gruppo di geologi<br />
della British Petroleum (BP)<br />
ritrovò i rottami dell’aereo nel<br />
deserto ed i poveri resti dell’equipaggio<br />
(figura 2).<br />
Qualcuno potrebbe sicura-<br />
mente obiettare che oggigiorno<br />
una tragedia del genere non<br />
potrebbe ripetersi, dotati come<br />
siamo di ricevitori GNSS financo<br />
nei nostri smartphone.<br />
Sta però di fatto che nel 2015<br />
l’accademia della marina militare<br />
americana di Annapolis<br />
ha reintrodotto nei suoi corsi<br />
obbligatori quello di “celestial<br />
navigation”, eliminato alla<br />
fine degli anni ’90, sull’onda<br />
dell’entusiasmo<br />
derivante dal successo operativo<br />
del sistema GPS. I vertici<br />
militari statunitensi hanno<br />
giustificato la loro decisione<br />
molto semplicemente: senza<br />
GPS saremmo ciechi, abbiamo<br />
bisogno di un backup. Inoltre,<br />
di fronte ai sempre maggiori<br />
rischi di attacchi agli utenti<br />
GNSS, nella forma di “jamming”<br />
(segnali di disturbo) o<br />
di “spoofing” (segnali contraffatti),<br />
si fa notare che le stelle<br />
non si possono né oscurare né<br />
contraffare (anche se a volte<br />
non sono visibili).<br />
La navigazione astronomica è<br />
Fig. 3 - La statua di Flavio Gioia ad Amalfi e la “rosa dei venti”, da lui probabilmente introdotta<br />
come parte integrante della bussola.<br />
Fig. 2 - I resti<br />
del bombardiere<br />
“lady be<br />
good” ritrovati<br />
nel deserto<br />
libico nel<br />
1958.<br />
<strong>GEOmedia</strong> n°6-<strong>2021</strong> 47
TERRA E SPAZIO<br />
Fig. 4 - Il sestante, strumento fondamentale per la<br />
rilevazione del cosiddetto “punto nave”.<br />
stata di fatto la più antica tecnica<br />
di navigazione ed è rimasta<br />
incontrastata per qualche<br />
migliaio di anni.<br />
I primi marinai seguivano la<br />
costa da vicino per evitare<br />
di perdersi in mare aperto.<br />
Quando i primi navigatori<br />
veleggiarono verso l’oceano,<br />
essi scoprirono di poter tracciare<br />
il loro percorso seguendo<br />
le stelle. Le stelle appaiono<br />
differenti da differenti luoghi<br />
della Terra, pertanto osservando<br />
le stelle i marinai traevano<br />
indicazioni sulla direzione<br />
da prendere. L’osservazione<br />
delle stelle è stato per secoli il<br />
metodo principale di navigazione.<br />
Gli antichi Fenici usarono<br />
la Stella Polare per navigare<br />
dall’Egitto a Creta e, secondo<br />
Omero, la dea Atena disse ad<br />
Ulisse di ”tenere la Grande<br />
Orsa (cioè il nord) sulla sua<br />
sinistra” durante il suo viaggio<br />
dall’isola di Calipso (probabilmente<br />
Gibilterra) verso Itaca.<br />
Sfortunatamente le stelle sono<br />
visibili solo di notte (e solo<br />
con il bel tempo).<br />
I più importanti sviluppi nella<br />
ricerca per il metodo ideale<br />
di navigazione furono segnati<br />
dall’invenzione della bussola<br />
magnetica e del sestante. L’ago<br />
di una bussola punta sempre<br />
verso nord (in realtà verso il<br />
nord “magnetico”), fornendo<br />
quindi a qualunque ora del<br />
giorno ed in qualsiasi condizione<br />
atmosferica la direzione<br />
nella quale si sta procedendo.<br />
L’origine della bussola è oscura<br />
ed incerta: alcuni dicono<br />
che essa sia un’invenzione dei<br />
cinesi, altri degli arabi o dei<br />
marinai amalfitani. È tuttavia<br />
Fig. 5 - I predecessori del sestante: in senso antiorario, kamal, astrolabio e quadrante.<br />
abbastanza certo che questo<br />
strumento apparve in Europa<br />
intorno all’anno mille e che<br />
prese la sua forma definitiva<br />
nel 1300, ad opera del (forse)<br />
mitico Flavio Gioia di Amalfi<br />
(“Prima dedit nautis usum<br />
magnetis Amalphis”) (figura<br />
3).<br />
Il sestante usa un sistema di<br />
specchi per misurare l’angolo<br />
esatto delle stelle, della luna e<br />
del sole sopra l’orizzonte (figura<br />
4).<br />
Esso è l’evoluzione di una<br />
serie di predecessori sempre<br />
più elaborati, dei quali il più<br />
famoso e diffuso fu l’astrolabio,<br />
del quale si avvalse,<br />
insieme alla bussola, lo stesso<br />
Cristoforo Colombo durante i<br />
suoi viaggi verso il continente<br />
americano (figura 5).<br />
All’inizio comunque era possibile<br />
determinare con il sestante<br />
solo la latitudine (cioè la<br />
posizione sulla Terra misurata<br />
a nord o a sud dell’Equatore).<br />
I marinai erano ancora<br />
incapaci di calcolare la loro<br />
longitudine (cioè la posizione<br />
sulla Terra a est o ovest di un<br />
meridiano di riferimento).<br />
Il problema della determinazione<br />
della longitudine in<br />
mare aperto appassionò per<br />
oltre due secoli le menti più illuminate<br />
d’Europa e fu risolto<br />
solo nel 1761 da un artigiano<br />
inglese autodidatta di nome<br />
John Harrison, che costruì<br />
uno speciale orologio meccanico<br />
da imbarcare a bordo delle<br />
navi, chiamato cronometro<br />
marino, in grado di perdere<br />
o guadagnare non più di un<br />
secondo al giorno (un’accu-<br />
48 <strong>GEOmedia</strong> n°6-<strong>2021</strong>
TERRA E SPAZIO<br />
ratezza incredibile per quel<br />
tempo!). Ma questa è un’altra<br />
storia, anch’essa pienamente<br />
degna di essere raccontata, anche<br />
perché dimostra una volta<br />
di più, qualora fosse necessario,<br />
la stretta correlazione esistente<br />
fra misure di posizione<br />
e misure di tempo.<br />
Bussola, sestante e cronometro<br />
marino rimasero per altri due<br />
secoli gli strumenti fondamentali<br />
per la navigazione, fino a<br />
quando, all’inizio del ventesimo<br />
secolo, l’invenzione della<br />
radio ed i primi esperimenti<br />
di radionavigazione compiuti<br />
dallo stesso Marconi aprirono<br />
la strada ai sistemi di navigazione<br />
terrestri (quali il Loran)<br />
e, più recentemente, ai sistemi<br />
satellitari globali.<br />
Ma l’utilizzo delle osservazioni<br />
astronomiche per determinare<br />
la posizione non è mai stato<br />
completamente abbandonato.<br />
La navigazione dei missili<br />
intercontinentali e<br />
“cruise”, e quella dei<br />
satelliti artificiali,<br />
ad esempio, si basa,<br />
insieme ad altri sistemi<br />
(quali GNSS e<br />
piattaforme inerziali),<br />
sull’uso degli “star trackers”,<br />
strumenti ottici<br />
che utilizzano cortine<br />
di fotocellule o videocamere,<br />
associate a potenti processori<br />
e ad archivi delle stelle visibili,<br />
per riconoscere posizione ed<br />
anche assetto dei veicoli che li<br />
imbarcano (figura 6).<br />
PAROLE CHIAVE<br />
Navigazione astronomica; navigazione<br />
stimata; timing; positioning; GNSS<br />
AUTORE<br />
Dott. ing. Marco Lisi<br />
ingmarcolisi@gmail.com<br />
Independent Consultant<br />
Aerospace & Defense<br />
Fig. 6 - “star<br />
tracker” utilizzato<br />
a bordo<br />
dei satelliti<br />
<strong>GEOmedia</strong> n°6-<strong>2021</strong> 49
AGENDA<br />
23-24 Marzo 2022<br />
Geo Connect Asia 2022<br />
Singapore<br />
https://www.<br />
geoconnectasia.com/<br />
27 – 29 Aprile 2022<br />
GISTAM<br />
gistam.scitevents.org/<br />
Online Streaming<br />
6 - 11 Giugno 2022<br />
XXIV ISPRS Congress<br />
Nice (France)<br />
www.geoforall.it/kyx8u<br />
16-18 Giugno 2022<br />
D-SITE Drones -<br />
Systems of Information<br />
on culTural hEritage<br />
Pavia (Italy)<br />
www.geoforall.it/kyw6u<br />
20-25 June 2022,<br />
Nessebar (Bulgaria)<br />
The 8th International<br />
Conference on<br />
Cartography and GIS<br />
www.geoforall.it/kywu9<br />
20-24 giugno 2022<br />
ASITA 2022 Conferenza<br />
Nazionale di Geomatica<br />
e Informazione<br />
Geografica<br />
Genova<br />
www.geoforall.it/kyfh6<br />
22-24 giugno 2022,<br />
Potsdam (Germania)<br />
- 12th EARSeL<br />
Workshop on Imaging<br />
Spectroscopy<br />
www.geoforall.it/kyx46<br />
LEICA BLK2GO<br />
MAPPATURA MOBILE SEMPLIFICATA,<br />
SCANSIONA OGNI TIPO DI AMBIENTE IN MOVIMENTO<br />
EFFETTUANDO MILIONI DI MISURAZIONI.<br />
◗ BLK2GO utilizza una tecnologia avanzatissima che permette<br />
di ottenere le migliori prestazioni di mappatura disponibili<br />
nella categoria dei dispositivi mobili portatili.<br />
◗ Maggiore velocità e sicurezza durante la cattura di immagini e<br />
scansioni, anche nel caso di ampi spazi interni, esterni, interrati,<br />
complessi e su più livelli.<br />
◗ Identifica diverse superfici ed analizza i dati LiDAR per<br />
calcolare la propria posizione in 3D.<br />
◗ Tre fotocamere panoramiche identificano le analogie tra<br />
immagini consecutive per calcolare il movimento dello scanner<br />
attraverso lo spazio 3D.<br />
◗ Leggero: pesa solo 775 grammi.<br />
◗ Portata Lidar fino a 25 metri.<br />
◗ Fotocamera “inquadra & scatta” per catturare dettagli specifici.<br />
◗ Molto altro ancora.<br />
per maggiori<br />
informazioni<br />
Contattaci, scoprirai molto di più!<br />
Via A. Romilli, 20/8 - 20139 Milano • Tel. 02 5398739<br />
E-mail: teorema@geomatica.it<br />
www.geomatica.it • www.disto.it • www.termocamere.com
Sede in Italia<br />
Più di 100 distributori nel mondo<br />
Una linea di prodotti Made in Italy<br />
Dove siamo Chiamaci Contattaci<br />
Seguici sui Social<br />
Viale dell’Industria 53<br />
20037, Paderno Dugnano (MI)<br />
Tel. +39 02 78619201<br />
www.stonex.it<br />
info@stonex.it - italia@stonex.it