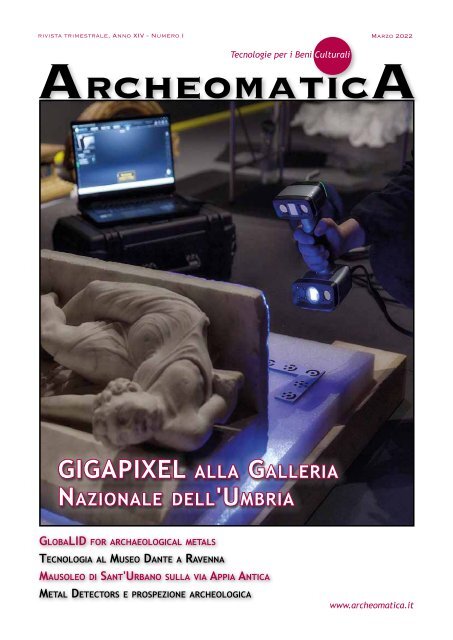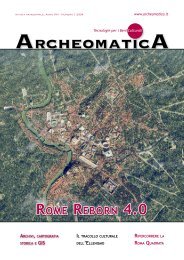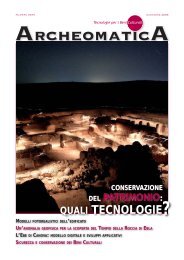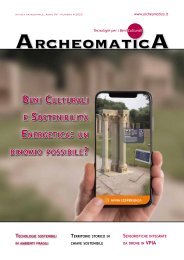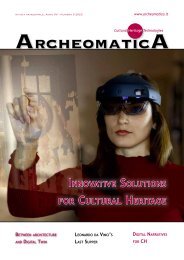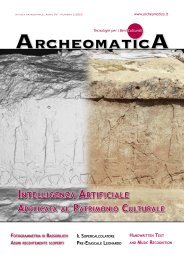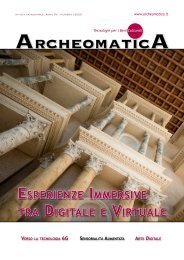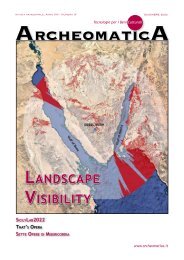Archeomatica_1_2022
GIGAPIXEL ALLA GALLERIA NAZIONALE DELL'UMBRIA
GIGAPIXEL ALLA GALLERIA NAZIONALE DELL'UMBRIA
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
ivista trimestrale, Anno XIV - Numero I Marzo <strong>2022</strong><br />
ArcheomaticA<br />
Tecnologie per i Beni Culturali<br />
GIGAPIXEL alla Galleria<br />
Nazionale dell'Umbria<br />
GlobaLID for archaeological metals<br />
Tecnologia al Museo Dante a Ravenna<br />
Mausoleo di Sant'Urbano sulla via Appia Antica<br />
Metal Detectors e prospezione archeologica<br />
www.archeomatica.it
Robotica e compatibilità<br />
EDITORIALE<br />
Cari lettori,<br />
solo nell’area archeologica delle tombe di Saqqara nel Basso Egitto a Il Cairo i risultati delle<br />
campagne di rilevamento, a partire dalle missioni italiane condotte da Edda Bresciani, di recente<br />
scomparsa, con tecnologie e metodi d’indagine cartografica hanno apportato, negli ultimi anni,<br />
un progresso reale ed un avanzamento tale da non avere confronti. Un progresso che è provato<br />
dall’ingente numero di reperti portati alla luce dalle tombe catalogate, come ormai quasi<br />
quotidianamente si legge nella cronaca, nei reportages e nei dossier internazionali. Non sarebbe<br />
improprio dire che le indagini archeologiche anche dall’anticipazione dell’esperienza di Saqqara<br />
si siano sempre più spesso estese ad un territorio e alle sue caratteristiche geomorfologiche e<br />
di antropizzazione. La mole di metadati vecchi e nuovi da archiviare e archiviati, nelle diverse<br />
condizioni e soprattutto nei componenti materiali non soltanto degli oggetti ritrovati, ma anche dei<br />
materiali di riproduzione e scansione, hanno sempre più affinato la capacità di immagazzinamento,<br />
collegamento e trasmissione dei codici che regolano l’oggettività e il funzionamento<br />
dell’accessione alla banca dati, rispondendo al linguaggio naturale ed all’informazione numerica<br />
trasmigrata o traslitterata. Non può stupire che la robotica attuale di droni, aerei e natanti da<br />
rilevamento, di sonde spaziali e di stazioni fisse e mobili, cosiddette autonome, di monitoraggio<br />
museale e archeologico seguano le impostazioni e i metodi ricettivi della comunicazione di uno<br />
smartphone, utilizzabili da chiunque.<br />
L’elettronica non ha mai smesso di lavorare, come i primi archeologi e storici, sulla concordanza<br />
dei rispettivi parametri di catalogazione dei documenti, sempre più spesso ancorati ad<br />
un’immagine diversificata nelle diverse discipline e tecnologie di profondità applicate, che non<br />
deve essere per forza omologata, ma il più possibile definita, perché non solo l’esperto, ma<br />
chiunque possa afferrarne l’oggetto.<br />
Eppure anche gli studiosi, i ricercatori, gli specialisti, i curatori, i periti, gli esperti e i visitatori<br />
e i lettori in genere affrontano ogni giorno le difficoltà delle differenze non solo dei dati di<br />
definizione, ma delle immagini risultanti di uno stesso oggetto quando provengono da differenti<br />
archivi e anche di uno stesso sistema che su base nazionale abbia adottato caratteristiche uniformi<br />
di comunicazione nel secolo scorso. Sistema in cui il copyright ha la funzione primaria di certificare<br />
l’oggetto in sua assenza e la proprietà del museo per la sua conservazione, come il perito di CTU<br />
che offra ad un giudice la propria esperienza di interprete: per chi non lo identifica e perché se ne<br />
possa parlare.<br />
Questo numero di <strong>Archeomatica</strong> si è occupato di esperienze disparate e localizzate che abbiano<br />
avuto il fine ultimo di reperibilità dell’opera catalogata dentro la memoria del robot, come a<br />
Pompei lo Spot, o la banca dati a questo collegata nei diversi formati e display di scorrimento,<br />
come al Museo Dante di Ravenna.<br />
Un robot di monitoraggio non del tutto dissimile dal Metal Detector, ancora oggi di uso<br />
generalizzato e del quale in questo numero di <strong>Archeomatica</strong> si legge un’interessante cronistoria<br />
dell’impiego dapprima in archeologia. Ma anche il robot che ha cominciato su Marte ad essere<br />
pensato come sonda di restituzione del dato e dell’immagine conoscitiva a tutti sconosciuta, non<br />
per questo irraggiungibile, conoscibile invece nella sua provenienza e perfino nel materiale grezzo<br />
di cui è fatta, da dove prelevato.<br />
Ogni analisi del trasporto effettivo su un nuovo supporto linguistico, materiale o alfanumerico si<br />
fonda, in termini informatici, sulla compatibilità, che non deve essere congelata strutturalmente<br />
ad un’identità presunta o ad un’idea, fisica o matematica, ma in quanto esistita commisurata<br />
all’oggetto, tanto all’impressione visiva che contiene e che esprime, quanto all’impulso che ha<br />
generato, sinergico, con tutti i suoi errori scientifici o opinabili di trasmissione al futuro, compresa<br />
l’immensità bibliografica che travalica i suoi confini naturali ed i sostrati intangibili di cui l’oggetto<br />
si compone e che solo un computer è in grado di restituire alla percezione, e di surrogarlo quando<br />
l’oggetto non c’è o ve ne siano altri al suo posto.<br />
Buona lettura,<br />
Francesca Salvemini
IN QUESTO NUMERO<br />
DOCUMENTAZIONE<br />
6 Conoscenza e<br />
divulgazione del<br />
patrimonio culturale.<br />
Analisi e rilievo del<br />
Mausoleo di Sant’Urbano<br />
sulla via Appia Antica<br />
di Maria Grazia Cianci,<br />
Sara Colaceci<br />
Un nuovo modo di vedere l'arte con la tecnologia<br />
di Haltadefinizione. In copertina<br />
la ripresa 3D di Arnolfo di Cambio, Figura<br />
maschile, frammento della Fontana degli<br />
assetati, conservato presso la Galleria Nazionale<br />
dell’Umbria.<br />
28 “Metal Detectors”: la<br />
tecnologia<br />
attuale per la<br />
prospezione archeologica<br />
di Renato Di Cesare, Marco Lisi<br />
Segui l'account di <strong>Archeomatica</strong><br />
su Twitter, Facebook e Instagram<br />
ArcheomaticA<br />
Tecnologie per i Beni Culturali<br />
Anno XIV, N° 1 - MARZO <strong>2022</strong><br />
<strong>Archeomatica</strong>, trimestrale pubblicata dal 2009, è la prima rivista<br />
italiana interamente dedicata alla divulgazione, promozione<br />
e interscambio di conoscenze sulle tecnologie per la tutela,<br />
la conservazione, la valorizzazione e la fruizione del patrimonio<br />
culturale italiano ed internazionale. Pubblica argomenti su<br />
tecnologie per il rilievo e la documentazione, per l'analisi e la<br />
diagnosi, per l'intervento di restauro o per la manutenzione e,<br />
in ultimo, per la fruizione legata all'indotto dei musei e dei<br />
parchi archeologici, senza tralasciare le modalità di fruizione<br />
avanzata del web con il suo social networking e le periferiche<br />
"smart". Collabora con tutti i riferimenti del settore sia italiani<br />
che stranieri, tra i quali professionisti, istituzioni, accademia,<br />
enti di ricerca e pubbliche amministrazioni.<br />
Direttore<br />
Renzo Carlucci<br />
dir@archeomatica.it<br />
Direttore Responsabile<br />
Michele Fasolo<br />
michele.fasolo@archeomatica.it<br />
Comitato scientifico<br />
Giuseppe Ceraudo, Annalisa Cipriani, Maurizio<br />
Forte, Bernard Frischer, Giovanni Ettore<br />
Gigante, Mario Micheli, Stefano Monti,<br />
Luca Papi, Marco Ramazzotti,<br />
Antonino Saggio, Francesca Salvemini,<br />
Rodolfo Maria Strollo<br />
Redazione<br />
Maria Chiara Spezia<br />
redazione@archeomatica.it<br />
Matteo Serpetti<br />
matteo.serpetti@archeomatica.it<br />
Valerio Carlucci<br />
valerio.carlucci@archeomatica.it
MUSEI<br />
14 Tra innovazione e<br />
conservazione: i gigapixel in<br />
Galleria Nazionale dell’Umbria<br />
di Eleonora Ligas, Luca Ponzio,<br />
GUEST PAPER<br />
10 GlobaLID : A new<br />
database and interactive<br />
web tool for provenancing<br />
archaeological metals<br />
By Thomas Rose, Sabine Klein, Katrin<br />
J. Westner, Yiu-Kang Hsu<br />
RUBRICHE<br />
24 ARCHEOLOGIA<br />
FORENSE<br />
32 AZIENDE E<br />
PRODOTTI<br />
Soluzioni allo Stato<br />
dell'Arte<br />
36 AGORÀ<br />
Notizie dal mondo delle<br />
Tecnologie dei Beni<br />
Culturali<br />
42 EVENTI<br />
Anna Umattino<br />
INSERZIONISTI<br />
ASITA 19<br />
BMTA 27<br />
ESRI 43<br />
ISPRS 35<br />
NAIS 44<br />
28 Riqualificazione del Museo<br />
Dante a Ravenna in chiave<br />
tecnologica<br />
PLANETEK 2<br />
STONEX 13<br />
STRUMENTI TOPOGRAFICI 43<br />
TEOREMA 42<br />
di Touchwindow<br />
una pubblicazione<br />
Science & Technology Communication<br />
Science & Technology Communication<br />
Diffusione e Amministrazione<br />
Tatiana Iasillo<br />
diffusione@archeomatica.it<br />
MediaGEO soc. coop.<br />
Via Palestro, 95<br />
00185 Roma<br />
tel. 06.64.87.12.09<br />
fax. 06.62.20.95.10<br />
www.archeomatica.it<br />
Progetto grafico e impaginazione<br />
Daniele Carlucci<br />
daniele@archeomatica.it<br />
Editore<br />
MediaGEO soc. coop.<br />
<strong>Archeomatica</strong> è una testata registrata al<br />
Tribunale di Roma con il numero 395/2009<br />
del 19 novembre 2009<br />
ISSN 2037-2485<br />
Stampa<br />
System Graphic Srl<br />
Via di Torre Santa Anastasia 61 00134 Roma<br />
Condizioni di abbonamento<br />
La quota annuale di abbonamento alla rivista è di<br />
€ 45,00. Il prezzo di ciascun fascicolo compreso<br />
nell’abbonamento è di € 12,00.<br />
Il prezzo di ciascun fascicolo arretrato è di<br />
€ 15,00. I prezzi indicati si intendono Iva inclusa.Per<br />
abbonarsi: www.archeomatica.it<br />
Gli articoli firmati impegnano solo la responsabilità<br />
dell’autore. È vietata la riproduzione anche parziale<br />
del contenuto di questo numero della Rivista<br />
in qualsiasi forma e con qualsiasi procedimento<br />
elettronico o meccanico, ivi inclusi i sistemi di<br />
archiviazione e prelievo dati, senza il consenso scritto<br />
dell’editore.<br />
Data chiusura in redazione: 30 maggio <strong>2022</strong>
DOCUMENTAZIONE<br />
Conoscenza e divulgazione del patrimonio<br />
culturale. Analisi e rilievo del Mausoleo di<br />
Sant’Urbano sulla via Appia Antica<br />
di Maria Grazia Cianci, Sara Colaceci<br />
Fig. 1 - Pietro Rosa. Tavola seconda della via Appia e Tavola terza della via<br />
Appia Antica, 1849 (ASR, Stragr. 301 tav. 2 e Stragr. 301 tav. 3).<br />
Fig. 2 - Il Mausoleo di Sant’Urbano con la domus<br />
Marmeniae in primo piano, foto Alinari, 1910.<br />
Le metodologie di rilievo<br />
integrato, costituite da<br />
acquisizioni con laser<br />
scanner, fotogrammetria<br />
terrestre ed aerea, applicate<br />
al Mausoleo di Sant’Urbano<br />
al IV miglio della via Appia<br />
Antica, consentiranno di<br />
mettere in atto un processo<br />
di conoscenza finalizzato<br />
alla valorizzazione e alla<br />
divulgazione.<br />
INQUADRAMENTO DELLA RICERCA<br />
Il Mausoleo di Sant’Urbano, al IV miglio della via Appia<br />
Antica, è stato acquisito dallo Stato italiano nel 2021,<br />
entrando così a far parte del Parco Archeologico dell’Appia<br />
Antica.<br />
Tale occasione ha permesso di stipulare un accordo di<br />
collaborazione scientifica tra il medesimo parco, il Dipartimento<br />
di Architettura dell’Università degli Studi Roma<br />
Tre e il Dipartimento di Studi umanistici, filosofici e di<br />
Storia dell’arte dell’Università degli Studi di Roma Tor<br />
Vergata.<br />
Gli intenti prefissati mirano all’attuazione di attività di<br />
studio, di rilievo e di analisi del manufatto. In particolare,<br />
il Dipartimento di Architettura si occuperà del rilevamento<br />
architettonico attraverso metodologie integrate<br />
strumentali e fotogrammetriche, nell’ambito di un processo<br />
più vasto finalizzato alla conoscenza, alla valorizzazione<br />
e alla divulgazione del patrimonio culturale.<br />
Tali tematiche inducono ad un’ampia riflessione sul patrimonio<br />
culturale, sul ruolo che esso assume all’interno<br />
della città contemporanea, le misure di tutela, le modalità<br />
di fruizione e le strategie di valorizzazione.<br />
Per attuare efficaci criteri di tutela e adeguate procedure<br />
di valorizzazione dei beni materiali è necessario saper<br />
identificare strumenti e metodologie in grado di fornire<br />
dati e promuovere analisi indispensabili per affrontare i<br />
differenti processi connessi alla conoscenza.<br />
6 ArcheomaticA N°1 marzo <strong>2022</strong>
Tecnologie per i Beni Culturali 7<br />
IL CONTESTO<br />
Partendo dal concetto di sistema storico-ambientale, secondo<br />
il quale “Le risorse e i caratteri fisico-naturalistici<br />
e quelli storici – considerati come sistema e nella loro reciproca<br />
interrelazione – siano da assumere come elemento<br />
primario e prioritario, ordinatore e qualificatore nella riorganizzazione<br />
fisica, funzionale e formale del territorio<br />
antropizzato” (Calzolari 1999), è indispensabile considerare<br />
i contesti in cui viviamo come l’interrelazione di componenti<br />
naturali e di componenti antropiche.<br />
È d’obbligo, dunque, analizzare gli ambiti fisico-naturalistici<br />
per comprendere il nesso che i manufatti costruiti<br />
instaurano con il luogo.<br />
Il mausoleo è parte integrante del sistema storico-ambientale<br />
dell’Appia Antica, quindi occorrerà tener conto<br />
dell’oggetto e del contesto in cui esso si inserisce (Bonamico,<br />
Colini & Fidenzoni 1968) (Canina 1853) (Spera 1999).<br />
L’area è caratterizzata, dal punto di vista geo-morfologico,<br />
dal pianoro vulcanico compreso tra il fosso dell’Almone<br />
e il fosso di Grotta Perfetta caratterizzato, a sua volta,<br />
dalla colata lavica di Capo di Bove. Il pianoro deriva, infatti,<br />
dalle eruzioni dell’antico Vulcano dei Colli Albani, il<br />
quale ha avuto un ruolo fondamentale e determinante per<br />
la formazione e per la costituzione del territorio romano<br />
(Parotto 2008).<br />
I numerosi pianori vulcanici, provenienti dal centro eruttivo<br />
e discendenti verso la piana alluvionale del Tevere, sono<br />
solcati da valli con i rispettivi fossi che arrivano al fiume.<br />
Le valli incise dai corsi d’acqua sono state formate dai<br />
complessi ed articolati fenomeni di erosione delle acque<br />
durante le fasi geologiche.<br />
Tali condizioni geo-morfologiche hanno condizionato la nascita<br />
e lo sviluppo della città di Roma (Funiciello, Grant,<br />
De Rita & Parotto 2006). L’intima relazione tra fisicità e<br />
antropizzazione è evidente leggendo il sistema storicoambientale<br />
dell’Appia Antica.<br />
Sul pianoro alle quote più alte, infatti, si impianta l’infrastruttura<br />
antropica lineare viaria, la quale traeva vantaggio<br />
dell’essere tracciato di crinale poiché sfruttava una<br />
particolare porzione fisica, aveva maggiore visibilità, aveva<br />
maggiore sicurezza ed era lontana dalle acque.<br />
Accanto a tale tracciato di percorrenza dal valore di strutturazione<br />
territoriale di crinale, furono costruite numerose<br />
strutture antropiche dalle funzioni variegate (fig. 1).<br />
Ai lati di essa, infatti, insistono le strutture antropiche<br />
puntiformi di carattere sepolcrale, le strutture abitative<br />
con valenza produttiva, i complessi cimiteriali cristiani e<br />
i casali agricoli.<br />
Tale ricchezza, insieme al sistema vegetazionale del settore<br />
meridionale della città di Roma, costituisce un patrimonio<br />
culturale ancora da valorizzare pienamente (Tomassetti<br />
1975) (Bortolotti 1988).<br />
È manifesta, pertanto, la valenza di sistema, quale interrelazione<br />
di componenti, che coinvolge le stratificazioni<br />
naturali e le sovrapposizioni antropiche (fig. 2).<br />
IL RILEVAMENTO INTEGRATO DELL’ARCHITETTURA PER LA<br />
CONOSCENZA DEL MANUFATTO<br />
Il sito presso il quale si trova il Mausoleo di Sant’Urbano è<br />
un’area tra la via Appia antica e via dei Lugari. Allo stato<br />
attuale, si accede tramite due ingressi posti ognuno su entrambe<br />
le vie. Il mausoleo si trova nella parte meridionale<br />
dell’area e un breve tracciato con basolato, di cui una<br />
porzione ancora visibile, lo congiunge alla Regina Viarum.<br />
Alberi, prevalentemente pini, e arbusti punteggiano l’a-<br />
Fig. 3 – Stato di fatto del Mausoleo di Sant’Urbano dopo l’acquisizione da<br />
parte del Parco Archeologico dell’Appia Antica e prima degli interventi di<br />
ripulitura, luglio 2021.<br />
rea verde, alcuni dei quali situati in aiuole realizzate dalla<br />
proprietà precedente (figg. 3-4).<br />
Il rilevamento, inteso come operazione di lettura del manufatto<br />
architettonico da attuarsi con metodo scientifico,<br />
è una fase fondamentale e imprescindibile per costruire<br />
quel processo di conoscenza indispensabile per ogni tipo<br />
di indagine e punto di riferimento costante per le analisi<br />
generali e puntuali (Docci & Maestri 2009).<br />
Esso consente la definizione di un modello geometricodimensionale<br />
del mausoleo corretto in ogni sua parte, il<br />
quale permette non soltanto una comprensione generale<br />
della configurazione spaziale tridimensionale e dell’articolazione<br />
strutturale, bensì costituisce la base per le successive<br />
indagini.<br />
In tale ottica, in effetti, esso favorisce il monitoraggio<br />
dello stato di fatto, il controllo della stabilità strutturale,<br />
l’individuazione delle patologie di degrado, la progettazione<br />
di interventi per il restauro e la pianificazione della<br />
gestione del sito.<br />
È possibile effettuare un rilevamento completo del mausoleo<br />
se si applicano metodi integrati, ossia l’interazione<br />
di più metodologie distinte in maniera tale da compensare<br />
le criticità di ciascun metodo ottimizzando i vantaggi di<br />
ognuno (Bianchini, Inglese & Ippolito 2016).<br />
Il progetto di rilievo del mausoleo prevede una fase di acquisizione<br />
dati con laser scanner 3d e con fotogrammetria<br />
digitale terrestre e aerea.<br />
Con il laser scanner ci si prefigge di acquisire la maggior<br />
parte dei dati metrici, interni ed esterni, che consentiranno<br />
di restituire l’articolazione architettonico-volumetrica.<br />
Considerata la situazione attuale del sito in cui sorge il<br />
mausoleo, caratterizzato dalla presenza di numerosi alberi,<br />
si predisporranno le posizioni dei punti di stazione<br />
per le acquisizioni con il laser scanner in maniera tale da<br />
ridurre le zone d’ombra causate dai tronchi e dalle parti<br />
inferiori delle chiome (fig. 5).<br />
La fotogrammetria digitale sarà utilizzata non soltanto per<br />
contenere ed uniformare le zone d’ombra che si potrebbero<br />
determinare durante la scansione laser, ma soprattutto<br />
per acquisire le parti superiori inaccessibili tramite tecni-
Fig. 4 – Resti della scalinata d’accesso nella parete frontale, luglio 2021.<br />
ca strumentale (Cianci & Colaceci 2017). Tale metodo di<br />
rilevamento sarà preceduto da un progetto di ripresa finalizzato<br />
alla corretta acquisizione di immagini fotografiche,<br />
con l’obiettivo di garantire l’adeguata sovrapposizione<br />
delle medesime per ricavare un valido modello numerico<br />
per punti (Russo 2020). Il rilievo aerofotogrammetrico<br />
del mausoleo tramite SAPR (sistemi aeromobili a pilotaggio<br />
Fig. 5 – Progetto di rilievo con evidenziate le posizioni delle stazioni da cui acquisire con il laser scanner.<br />
remoto), comunemente detto drone, georeferenziato con<br />
rete topografica di ancoraggio, sarà necessario per acquisire<br />
immagini ad alta risoluzione dall’alto.<br />
Questo permetterà di acquisire: lo stato di fatto delle coperture<br />
del mausoleo, laddove siano ancora presenti e laddove<br />
siano crollate come nella camera principale, il tracciato<br />
con basolato che congiungeva il mausoleo alla via<br />
Appia Antica, i resti della scalinata frontale d’accesso e la<br />
situazione generale del sito. L’acquisizione di dati dall’alto<br />
del mausoleo, inoltre, è indispensabile per le analisi<br />
planimetriche sul rapporto che esso stabilisce con la via<br />
Appia Antica, sulla relazione con la domus Marmeniae attualmente<br />
interrata.<br />
Si comprende, dunque, come sia indispensabile ottenere<br />
un modello che permetta di arrivare alla conoscenza profonda<br />
del manufatto, basata non soltanto sulla mole dei<br />
dati acquisiti ma soprattutto alla qualità dell’informazione,<br />
che è sia stazionale, sia metrica, sia dimensionale, sia<br />
cromatica. Ciò impone una corretta capacità di lettura del<br />
dato, una competenza disciplinare e una consapevole interpretazione<br />
delle componenti dell’architettura.<br />
Dunque, l’obiettivo di avere informazioni tridimensionali<br />
complete, fondate sulla quantità e sulla qualità dei dati,<br />
impone l’integrazione di molteplici metodi di rilevamento.<br />
Tali operazioni sono finalizzate ad una piena conoscenza<br />
del patrimonio culturale permettendone la sua lettura<br />
multidisciplinare.<br />
VALORIZZAZIONE E COMUNICAZIONE DEL BENE CULTURALE<br />
Il rilievo strumentale con laser scanner consente l’acquisizione<br />
di dati metrici, e non solo, in tempi rapidi, grazie<br />
alla produzione del modello numerico per punti (ossia la<br />
nuvola di punti).<br />
La scansione laser ha la caratteristica di associare il dato<br />
metrico ad un valore RGB. Il primo corrisponde al valore<br />
X, Y, Z di ogni punto rispetto ad un unico sistema di rifermento<br />
basandosi su principi di acquisizione di coordinate<br />
polari. Il secondo è ottenuto dalle riprese fotografiche di<br />
una macchina interna al laser scanner.<br />
Tale caratteristica permette di considerare<br />
la nuvola di punti secondo<br />
una duplice valenza: da una parte, la<br />
valenza oggettiva dell’informazione<br />
metrica; dall’altra parte, la valenza<br />
di simulazione del reale dal forte impatto<br />
visuale.<br />
Questa fase può essere sviluppata<br />
tramite la componente relativa agli<br />
aspetti visuali e alla simulazione del<br />
reale del modello numerico per punti<br />
del mausoleo navigabile ed esplorabile,<br />
oppure tramite la ricostruzione<br />
del modello virtuale NURBS. Lo scopo<br />
mira a ridurre la quantità elevata<br />
dei dati in un modello che, tramite<br />
enti geometrici definiti, consenta una<br />
adeguata corrispondenza con il manufatto<br />
reale grazie ad ottimali livelli di<br />
discretizzazione.<br />
Questo modello può essere interattivo,<br />
sperimentando ed applicando<br />
modalità immersive con tecniche di<br />
realtà virtuale e realtà aumentata<br />
(VR/AR) e rispondendo, in tal modo,<br />
alle nuove esigenze richieste dai Beni<br />
Culturali. Le modalità di fruizione virtuale,<br />
a volte, sono l’unica possibilità<br />
8 ArcheomaticA N°1 marzo <strong>2022</strong>
Tecnologie per i Beni Culturali 9<br />
per consentire condizioni di divulgazione.<br />
Ulteriore campo di ricerca è la possibilità di creare database<br />
associati ai modelli tridimensionali, in maniera tale da<br />
determinare dei modelli informatizzati provvisti dell’apparato<br />
grafico, dell’apparato geometrico-dimensionale e<br />
dell’apparato descrittivo-informativo.<br />
Il modello virtuale digitale diventa, così, il fulcro della<br />
raccolta di dati sia metrici che informativi del manufatto e<br />
del contesto storico, archeologico e materico, utile a facilitare<br />
l’insieme delle strategie di osservazione, di ricerca<br />
e di esplorazione.<br />
Tali operazioni, basandosi sull’interazione dei saperi, favoriscono<br />
tutti quei processi volti alla gestione e al monitoraggio<br />
del singolo manufatto e all’amministrazione<br />
dell’area.<br />
L’importanza del rilievo del mausoleo si colloca, pertanto,<br />
anche all’interno della digitalizzazione del patrimonio<br />
culturale per favorirne la valorizzazione, la divulgazione e<br />
la fruizione.<br />
In tal senso, esso è propedeutico alla costruzione di modelli<br />
interattivi per la comprensione e la ricezione del bene<br />
da parte dei visitatori interessati alle trasformazioni del<br />
manufatto e dell’area in cui esso si colloca. Esso sostiene<br />
l’approfondimento dell’architettura esistente nella sua<br />
componente spaziale e nella sua percezione immersiva. La<br />
consapevolezza della multidimensionalità dei fenomeni è<br />
condizione basilare per poter attuare simili procedure.<br />
La digitalizzazione del patrimonio culturale, architettonico-archeologico,<br />
è uno dei punti HORIZON EUROPE, ed è<br />
strettamente legato alle direttive della Carta di Londra e<br />
della Carta di Atene, che configurano gli aspetti essenziali<br />
da seguire per la rappresentazione digitale dell’architettura<br />
e dell’archeologia.<br />
I vantaggi e le problematiche degli strumenti e delle tecniche<br />
digitali per la documentazione e la condivisione dei<br />
dati costituiscono tematiche attuali nel campo della comunicazione<br />
e della fruizione del patrimonio culturale.<br />
L’obiettivo ambizioso mira a sfruttare le potenzialità delle<br />
tecniche digitali per mettere a sistema dati eterogenei<br />
provenienti da strumenti e processi di acquisizione ed elaborazione<br />
differenti.<br />
Esso, inoltre, punta a riconquistare organicità, oltre che<br />
fruibilità, del bene inserito in un contesto più ampio, recuperando<br />
quel legame esistente tra l’ambito territoriale e<br />
l’ambito architettonico, considerati come parte integrande<br />
del sistema storico-ambientale.<br />
Le procedure e le strategie descritte, attuabili attraverso<br />
la fase di acquisizione dei dati con differenti strumenti<br />
tra loro integrati, la fase di elaborazione con applicativi<br />
specifici e la fase di restituzione tramite molteplici output<br />
grafici, offrono la possibilità di restituzione grafica<br />
digitale e la possibilità di esposizione museale immersiva<br />
virtuale. A tal proposito, gli obiettivi di documentazione/<br />
monitoraggio, da un lato, e gli obiettivi di valorizzazione/<br />
divulgazione, dall’altro lato, possono essere condotti simultaneamente.<br />
L’attuale esigenza nel campo dei Beni Culturali riguardante<br />
la conoscenza, la valorizzazione e la comunicazione del<br />
patrimonio culturale sollecita ampi filoni di ricerca, teorici<br />
e applicativi, e richiede saperi disciplinari multipli. La<br />
collaborazione di ricercatori afferenti a settori disciplinari<br />
diversi è punto di forza nel condurre i processi di indagine,<br />
in cui ogni contributo permette di affrontare problematiche,<br />
materiali e immateriali, da punti di vista diversi.<br />
Gli istituti culturali e gli enti di ricerca, soprattutto in<br />
seguito all’emergenza pandemica, saranno sempre più<br />
impegnati a trovare nuovi sistemi di conoscenza, di valorizzazione<br />
e di divulgazione del patrimonio culturale. In<br />
tale scenario, in cui il settore dell’ICT vedrà una maggiore<br />
crescita, è necessario sperimentare metodi innovativi di<br />
conoscenza delle aree archeologiche e paesaggistiche attraverso<br />
modelli interattivi e fruibili da diverse tipologie<br />
di utenti.<br />
Bibliografia<br />
Bianchini C, Inglese C. & Ippolito A. (2016) I teatri del Mediterraneo<br />
come esperienza di rilevamento integrato. Roma:<br />
Sapienza Università Editrice<br />
Bonamico S., Colini A.M. & Fidenzoni P. (a cura di) (1968) La<br />
carta storico-monumentale dell’Agro Romano. Capitolium,<br />
(11-12), 1-25<br />
Bortolotti L. (1988) Roma fuori le mura. Bari-Roma: Laterza<br />
Calzolari V. (1999) Storia e natura come sistema. Roma: Argos<br />
Canina L. (1853) La prima parte della Via Appia dalla Porta<br />
Capena a Boville, vol. 1. Roma<br />
Cianci M. G. & Colaceci S. (2017) The methodology of interpreting<br />
and promoting historical heritage: the Maxentius complex<br />
on the Appia Antica. Disegnarecon, vol. 10 (19), 1-18.<br />
Docci M. & Maestri D. (2009) Manuale di rilevamento architettonico<br />
e urbano. Bari-Roma: Laterza<br />
Funiciello R., Grant H., De Rita D. & Parotto M. (2006). I sette<br />
colli. Guida geologica a una Roma mai vista. Milano: Raffaello<br />
Cortina Editore<br />
Parotto M. (2008). Evoluzione paleogeografica dell’area romana:<br />
una breve sintesi. In Funiciello R. (a cura di). La geologia<br />
di Roma dal centro storico alla periferia. Firenze: Istituto Poligrafico<br />
e Zecca dello Stato, 25-38<br />
Russo M. (2020) La fotomodellazione in ambito archeologico.<br />
Potenzialità, limiti e prospettive. In Asciutti M. (a cura di).<br />
Storia-Restauro. Ricerche a Roma e nel Lazio. Roma: GBE /<br />
Ginevra Bentivoglio EditoriA, 133-147<br />
Spera L. (1999) Il paesaggio suburbano di Roma dall’antichità<br />
al Medioevo. Roma: L’Erma di Bretschneider<br />
Tomassetti G. (1975) La campagna romana antica, medievale e<br />
moderna. Nuova edizione aggiornata (a cura di) Chiumenti L.<br />
& Bilancia F. Firenze: Leo S. Olschki<br />
Abstract<br />
The paper focuses on the basilica in Contrada S. Salvatore and the epigean The<br />
Mausoleum of Sant’Urbano is located on the IV mile of the Via Appia Antica.<br />
The Italian State acquired the mausoleum in 2021, which became part of the<br />
Appia Antica Archaeological Park. This opportunity made it possible to enter<br />
into a scientific collaboration agreement between the park, the Department<br />
of Architecture of the University of Roma Tre and the Department of Humanities,<br />
Philosophy and History of Art of the University of Rome Tor Vergata. The<br />
objectives aim at the implementation of study, survey and analysis activities<br />
of the artifact.<br />
Parole Chiave<br />
Rilievo; Archeologia; Mausoleo di Sant’Urbano; Parco Archeologico Appia<br />
Antica; rilevamento; divulgazione; valorizzazione; conoscenza; patrimonio<br />
culturale; AR/VR; Laser scanner<br />
Autore<br />
Maria Grazia Cianci<br />
mariagrazia.cianci@uniroma3.it<br />
Dipartimento di Architettura, Università degli Studi Roma Tre<br />
Sara Colaceci<br />
sara.colaceci@uniroma1.it<br />
Dipartimento di Storia, Disegno e Restauro dell’Architettura, Sapienza<br />
Università di Roma
GUEST PAPER<br />
GlobaLID: A new database and<br />
interactive web tool for<br />
provenancing archaeological metals<br />
By Thomas Rose, Sabine Klein, Katrin J. Westner, Yiu-Kang Hsu<br />
Lead isotopes are an<br />
everyday method to reconstruct<br />
the raw material origin<br />
of metal objects by comparison<br />
of sample data with<br />
reference data. Until this<br />
point, no global and open<br />
infrastructure exists that<br />
collects and provides access<br />
to such reference data. GlobaLID<br />
aims to provide such an<br />
infrastructure.<br />
Reconstructing the raw material<br />
source of archaeological<br />
objects can provide valuable<br />
insights into past exchange<br />
networks. Usually a range of<br />
scientific methods like petrography,<br />
elemental analyses, and<br />
isotope analyses is used for this<br />
task. In most cases, the data of<br />
the archaeological materials are<br />
compared to reference data, i.e.<br />
data acquired from source materials<br />
than can be firmly linked to<br />
a geographic location, like metal<br />
ores of known deposits (Wilson<br />
and Pollard 2001).<br />
For tracing sources of metal in<br />
copper, lead, and silver artifacts,<br />
the analysis of their lead isotope<br />
ratios is a standard method nowadays.<br />
Lead isotopes are a radiogenic<br />
isotope system and hence<br />
their ratios change with time.<br />
Formation of an ore deposit stops<br />
this clock because the radioactive<br />
parent isotopes are separated<br />
from the lead. Consequently no<br />
further radiogenic growth of lead<br />
can occur. Lead isotopes are thus<br />
an indicator for the formation<br />
ages of the ore deposits. Ores<br />
for archaeological metal artifacts<br />
usually contain traces of lead,<br />
which are incorporated into the<br />
finished products during the metalworking<br />
processes. The isotopic<br />
signature is not altered during<br />
smelting, allowing to directly link<br />
the metal to its ore. The latter is<br />
what makes lead isotopes particu-<br />
10 ArcheomaticA N°1 marzo <strong>2022</strong>
Tecnologie per i Beni Culturali 11<br />
Fig. 2 - The plot area to create and customize plots and inspect data from the database more closely.<br />
larly well suited for the raw material reconstruction (Killick<br />
et al. 2020).<br />
An extensive reference database is indispensable for a successful<br />
reconstruction of the raw material origin using lead<br />
isotopes. If ore deposits are not represented in the database,<br />
either because they were not sampled, all ore was<br />
mined in the past or the mine is not recognised as such<br />
anymore, it will be impossible to link the metal object to<br />
this deposit. Another problem is that ore deposits can form<br />
at the same time and hence will have widely overlapping<br />
isotope signatures. Conversely, multiple ore-forming stages<br />
can occur in the same deposit and result in different<br />
lead isotope signatures for each stage. Hence, it is often<br />
necessary to include additional information in the database<br />
like the geology and mineralogy of the deposits or for which<br />
metal(s) it was exploited in the past (Baron et al. 2014).<br />
Lead isotope reference data are currently scattered across<br />
publications of all kinds and vary in their quality and amount<br />
of additional information. Consequently, each group has to<br />
build its own reference database, facing in one way or another<br />
the same problems: (1) findability and accessibility of<br />
the respective publications, (2) comparability of the data<br />
and especially their meta-information, (3) and language<br />
barriers. Moreover, the published lists are necessarily static<br />
and therefore quickly become outdated.<br />
It was more than 20 years ago that the Oxford group made<br />
a first attempt to overcome at least the first obstacle by<br />
publishing their reference database OXALID in open access<br />
(Stos-Gale and Gale 2009). It gained wide popularity over<br />
the years because it was only until the last couple of years<br />
that similar databases became available (e. g. Artioli et al.<br />
2016; García de Madinabeitia et al. 2021). Nevertheless, a<br />
central repository for lead isotope data that would overcome<br />
all the above-listed obstacles and provide a common<br />
interface to lead isotope reference data is still missing.<br />
GlobaLID aims not only to provide such a repository but also<br />
to design an infrastructure that facilitates the interaction<br />
with lead isotope data (Klein et al. <strong>2022</strong>). The Global Lead<br />
Isotope Database (https://globalid.dmt-lb.de/) consists of<br />
two parts: a database (Westner et al. 2021) and an interactive<br />
web application (GlobaLID Core Team 2021). The<br />
database is the core of GlobaLID. It stores all the reference<br />
data, their meta-information and the original reference of<br />
the publication it is taken from. A lot of effort is made to<br />
harmonise the additional information (e.g. reconstruction<br />
of geographical locations) and to ensure that all data are<br />
available in the highest possible quality. The second part is<br />
an interactive web application (Fig. 1) that allows an easy<br />
Fig. 3 - Example plots exported from the GlobaLID web application.
Fig. 4 - The current coverage of the GlobaLID web application.<br />
access to the database through a web browser and to compare<br />
one’s own data with the database (Fig. 2). The functionality<br />
of the web application includes the most common<br />
tasks in raw material reconstructions with lead isotope<br />
data: various filters to interact with the database; a map<br />
to inspect the geolocations; various plotting options (e. g.<br />
histograms, density estimates, scatter plots) with different<br />
axes (lead isotope ratios, parameters of different lead isotope<br />
age models); customisation of the plots; download of<br />
publication-ready plots (Fig. 3), the references from which<br />
the data in the respective plot is taken from, and of the<br />
reference data itself. The interface of the web application<br />
was kept intentionally simple to provide easy access for all<br />
users, including researchers without detailed knowledge in<br />
lead isotope geochemistry. The database can also be downloaded<br />
and used independently from the web application to<br />
e. g. carry out more advanced data analyses than currently<br />
possible with the web application.<br />
Database and web application are published in open access<br />
and open source and are free to use without a registration.<br />
Both are under constant development to include more reference<br />
data (Fig. 4), to design them closer to the needs and<br />
expectations of the users, and to include additional features.<br />
Stable versions of the database (published with a DOI)<br />
are further available in a certified repository (Westner et al.<br />
2021) while all working versions are available on the Github<br />
pages of the database (https://github.com/archmetalDBM/<br />
GlobaLID-database) and web application (https://github.<br />
com/archmetalDBM/GlobaLID-App).<br />
The aim of GlobaLID cannot be reached without the support<br />
of the community (Klein et al. <strong>2022</strong>). A high quality of the<br />
reference data can only be achieved with expertise in different<br />
scientific disciplines such as ore geology, mineralogy,<br />
and isotope geochemistry. Of particular importance is the<br />
contribution from local experts who specialize in ore deposit<br />
geologies of certain regions. Additionally, the core team<br />
neither has access to all lead isotope publication nor can it<br />
read all non-English publications. Hence, the web application<br />
also includes the option to upload data for the database.<br />
These data will be checked for their consistency by the<br />
core team and enriched with additional meta-information<br />
before being made available in the database. Each contributor<br />
is mentioned in the web application and wherever<br />
possible.<br />
Similarly, everybody is invited to get involved in the development<br />
of the web application by providing feedback,<br />
suggesting features etc. on its GitHub page – the web application<br />
can only be as good as it meets the needs of its users<br />
and we are firmly committed to make it as good as possible.<br />
Bibliografia<br />
Artioli G, Angelini I, Nimis P, Villa IM (2016) A lead-isotope database of<br />
copper ores from the Southeastern Alps: A tool for the investigation of<br />
prehistoric copper metallurgy. J. Archaeol. Sci. 75:27–39. https://doi.<br />
org/10.1016/j.jas.2016.09.005<br />
Baron S, Tămaş CG, Le Carlier C (2014) How Mineralogy and Geochemistry<br />
Can Improve the Significance of Pb Isotopes in Metal Provenance Studies.<br />
Archaeometry 56:665–680. https://doi.org/10.1111/arcm.12037<br />
García de Madinabeitia S, Gil Ibarguchi JI, Santos Zalduegui, J. F. (2021)<br />
IBERLID: A lead isotope database and tool for metal provenance and<br />
ore deposits research. Ore Geology Reviews 137:104279. https://doi.<br />
org/10.1016/j.oregeorev.2021.104279<br />
GlobaLID Core Team (2021) GlobaLID web application: V. 1.0, database<br />
status: 15 November 2021. https://globalid.dmt-lb.de/<br />
Killick DJ, Stephens JA, Fenn TR (2020) Geological constraints on the use of<br />
lead isotopes for provenance in archaeometallurgy. Archaeometry 62:86–<br />
105. https://doi.org/10.1111/arcm.12573<br />
Klein S, Rose T, Westner KJ, Hsu Y-K (<strong>2022</strong>) From OXALID to GlobaLID:<br />
Introducing a modern and FAIR lead isotope database with an interactive<br />
application. Archaeometry. https://doi.org/10.1111/arcm.12762<br />
Stos-Gale ZA, Gale NH (2009) Metal provenancing using isotopes and the<br />
Oxford archaeological lead isotope database (OXALID). Archaeol Anthropol<br />
Sci 1:195–213. https://doi.org/10.1007/s12520-009-0011-6<br />
Westner KJ, Rose T, Klein S, Hsu Y-K (2021) GlobaLID – Global Lead Isotope<br />
Database: V. 1.0. GFZ Data Services<br />
Wilson L, Pollard AM (2001) The provenance hypothesis. In: Brothwell DR,<br />
Pollard AM (eds) Handbook of archaeological sciences. Wiley, Chichester,<br />
New York, pp 507–517.<br />
Abstract<br />
Lead isotope signatures of non-ferrous metals are a well-established approach<br />
to tracing ore sources, which can provide important information to reconstruct<br />
past exchange networks. Like many other provenancing methods, the<br />
usefulness of lead isotopes in provenance studies relies heavily on a comprehensive<br />
reference database. GlobaLID aims to provide an infrastructure<br />
for a central storage of lead isotope data. It consists of a comprehensively<br />
evaluated database with extensive geological and contextual information and<br />
of a web application that provides an intuitive interface to interact with the<br />
database, options for comparison with own sample data, and to design and<br />
download publication-ready lead isotope plots.<br />
Parole chiave<br />
Lead isotopes; exchange networks; archaeometallurgy; provenance; open access<br />
Autore<br />
Thomas Rose, Thomas.Rose@bergbaumuseum.de<br />
Sabine Klein, Sabine.Klein@bergbaumuseum.de<br />
Yiu-Kang Hsu, yiu-kang.hsu@bergbaumuseum.de<br />
Deutsches Bergbau-Museum Bochum<br />
Leibniz-Forschungsmuseum für Georessourcen<br />
Am Bergbaumuseum 31<br />
44791 Bochum<br />
Katrin J. Westner<br />
katrin.westner@ens-lyon.fr<br />
Laboratoire de Géologie de Lyon : Terre, Planètes, Environnement<br />
UMR CNRS 5276 (CNRS, ENS, Université Lyon1, UJM)<br />
Ecole Normale Supérieure de Lyon<br />
46, Allée d'Italie 69364 Lyon cedex 07 France<br />
12 ArcheomaticA N°1 marzo <strong>2022</strong>
Tecnologie per i Beni Culturali 13<br />
Sede in Italia<br />
Più di 100 distributori nel mondo<br />
Una linea di prodotti Made in Italy<br />
Dove siamo Chiamaci Contattaci<br />
Seguici sui Social<br />
Viale dell’Industria 53<br />
20037, Paderno Dugnano (MI)<br />
Tel. +39 02 78619201<br />
www.stonex.it<br />
info@stonex.it - italia@stonex.it
MUSEI<br />
Tra innovazione e conservazione:<br />
i gigapixel in Galleria Nazionale dell’Umbria<br />
di Eleonora Ligas, Luca Ponzio, Anna Umattino<br />
Fig. 1 - Digitalizzazione FlyBy-O, Polittico di San Francesco al prato, Taddeo di Bartolo. Galleria Nazionale dell’Umbria.<br />
Gigapixel, 3D e indagini diagnostiche:<br />
parole chiave per<br />
narrare l’ambizioso progetto<br />
di digitalizzazione messo<br />
in campo dalla Galleria<br />
Nazionale dell’Umbria, con<br />
la collaborazione di Haltadefinizione,<br />
in occasione<br />
del riallestimento del museo<br />
perugino.<br />
Conservare, valorizzare, divulgare, tutelare la memoria del<br />
passato per trasmetterla in una nuova forma, sono solo alcune<br />
delle opportunità che oggi l’evoluzione tecnologica applicata<br />
ai beni culturali offre ai musei e agli enti preposti alla conservazione.<br />
Copie digitali di opere d’arte, cloni fisici ottenuti attraverso<br />
la mappatura e la stampa 3D sono i nuovi strumenti su cui possono<br />
contare le realtà museali per valorizzare le loro collezioni.<br />
Le nuove modalità di fruizione permettono infatti di proporre l’opera<br />
attraverso strumenti in grado non solo di accrescere l’esperienza<br />
dal vivo all’interno di un percorso museale, ma anche di essere utili<br />
per la comunicazione e la divulgazione online, per supportare le<br />
attività di restauro o per dare vita a esperienze immersive.<br />
Il riallestimento della Galleria Nazionale dell’Umbria è un eccellente<br />
‘caso’ per indagare la relazione tra arte e tecnologia.<br />
Accanto ai lavori, la Direzione ha scelto di condurre una ambiziosa<br />
campagna di digitalizzazione su cento opere d’arte tra dipinti,<br />
statue, sculture, pale d’altare e arredi, affidata ad Haltadefinizione,<br />
tech company della casa editrice Franco Cosimo Panini S.p.a.,<br />
specializzata nell’acquisizione di beni culturali con tecnologie in-<br />
14 ArcheomaticA N°1 marzo <strong>2022</strong>
Tecnologie per i Beni Culturali 15<br />
novative.<br />
Tra i capolavori selezionati vi sono importanti<br />
opere del Medioevo e del Rinascimento di artisti<br />
quali Arnolfo di Cambio, Nicola e Giovanni Pisano,<br />
Duccio, Gentile da Fabriano, Beato Angelico,<br />
Benozzo Gozzoli, Giovanni Boccati e Piero della<br />
Francesca e artisti umbri tra cui Benedetto Bonfigli,<br />
Bartolomeo Caporali, Fiorenzo di Lorenzo,<br />
Perugino, Pinturicchio e ai loro allievi e seguaci.<br />
UN NUOVO MODO DI VEDERE L’ARTE CON LA<br />
TECNOLOGIA DI HALTADEFINIZIONE<br />
Dal 2017 tech company della casa editrice Franco<br />
Cosimo Panini, Haltadefinizione nasce nel<br />
2004 come azienda indipendente concentrando<br />
le proprie attività sulle immagini d’arte in altissima<br />
definizione e sulle tecnologie di acquisizione<br />
in gigapixel. Sin dall’inizio, infatti, si è<br />
dedicata esclusivamente al mondo dei beni culturali<br />
e alla loro conservazione e valorizzazione<br />
attraverso le tecnologie digitali, al cui sviluppo<br />
ha contribuito grazie alla collaborazione con il<br />
partner tecnologico Memooria.<br />
Già nel 2007, infatti, Haltadefinizione aveva pubblicato la più<br />
grande immagine in gigapixel disponibile all’epoca, l’Ultima<br />
Cena di Leonardo da Vinci (un’immagine da 16.1 gigapixel) –<br />
per alcuni anni la più grande foto panoramica in gigapixel mai<br />
pubblicata. In seguito, ha continuato a sviluppare software e<br />
tecnologie per l’acquisizione di immagini in gigapixel, collaborando<br />
al contempo con le più importanti istituzioni culturali<br />
italiane e straniere, mettendo al loro servizio il know-how<br />
via via sviluppato. Se da un lato è stato ideato un nuovo modo<br />
di vedere le opere d’arte, allo stesso tempo Haltadefinizione<br />
ha garantito alle istituzioni una collaborazione costante<br />
basata sulla fornitura delle più aggiornate tecnologie per la<br />
conservazione, la tutela e lo studio di capolavori quali il già<br />
citato Cenacolo di Leonardo, la Cappella degli Scrovegni a Padova<br />
o numerose opere della Pinacoteca di Brera, degli Uffizi<br />
o delle Gallerie Nazionali di Arte Antica di Roma. Sono oltre<br />
700 le opere digitalizzate e fruibili gratuitamente nell’image<br />
bank, la galleria virtuale disponibile sul sito, tra cui lo<br />
Sposalizio della Vergine o la Fornarina di Raffaello, il Bacio<br />
di Hayez, la Nascita di Venere o la Primavera di Botticelli,<br />
il Bacco o la Vocazione di San Matteo di Caravaggio, il Tondo<br />
Doni di Michelangelo o l’Annunciazione e<br />
l’Adorazione dei Magi di Leonardo, solo per<br />
citarne alcuni.<br />
Da sempre impegnata nell’attività di promozione<br />
di un approccio innovativo alla valorizzazione<br />
delle opere d’arte e dei beni culturali<br />
attraverso la gestione di un percorso creativo<br />
che parte dall’acquisizione digitale di<br />
immagini in altissima definizione (gigapixel)<br />
e 3D, per arrivare alla diffusione di contenuti<br />
di eccezionale qualità tramite una piattaforma<br />
software appositamente sviluppata che<br />
permette di gestire l’incredibile risoluzione<br />
delle immagini digitali.<br />
Fig.2 - Allestimento scanner FlyBy-O presso la Galleria Nazionale dell’Umbria.<br />
IL PROGETTO DI DIGITALIZZAZIONE DELLA<br />
GALLERIA<br />
NAZIONALE DELL’UMBRIA<br />
Dal mese di marzo presso la Galleria Nazionale<br />
dell’Umbria è in corso una intensa campagna<br />
di digitalizzazione. L’obiettivo finale<br />
è fornire al museo un archivio digitale di immagini<br />
in altissima definizione per soddisfare tutte le esigenze<br />
di valorizzazione digitale online e offline, di catalogazione, di<br />
riproduzione, di documentazione dello stato di conservazione<br />
e di studio. L’acquisizione digitale delle opere viene effettuata<br />
con diversi sistemi hardware e restituita con metodi software<br />
di elaborazione sviluppati da Haltadefinizione, i quali consentono<br />
di raggiungere risoluzioni molto elevate, mantenendo un<br />
ottimo livello di nitidezza, bassissimi valori di distorsione e<br />
colori fedeli, grazie anche all’utilizzo di target cromatici specifici.<br />
In passato queste tecnologie sono state utilizzate per i<br />
progetti portati avanti, tra i tanti, con la Galleria degli Uffizi e<br />
la Galleria dell’Accademia di Firenze, la Pinacoteca di Brera,<br />
il Cenacolo Vinciano e la Pinacoteca Ambrosiana di Milano. La<br />
stessa tecnologia è stata utilizzata per realizzare l’immagine<br />
più grande e dettagliata esistente in altissima definizione del<br />
Telo della Sindone, per la cui realizzazione nel 2008 la Santa<br />
Sede ha autorizzato una apertura straordinaria del sistema di<br />
conservazione della Reliquia.<br />
Per pianificare ad hoc la campagna è stato fondamentale effettuare<br />
un sopralluogo per studiare gli spazi e l’allestimento,<br />
Fig.3 - Ripresa 3D, Arnolfo di Cambio, Figura maschile, frammento della Fontana degli assetati,<br />
Galleria Nazionale dell’Umbria.
Fig. 4 - Modello 3D, Agostino di Duccio, Madonna con Bambino in terracotta, Galleria Nazionale dell’Umbria.<br />
tenendo in considerazione non solo le caratteristiche delle<br />
opere, in particolar modo le dimensioni, la presenza di vetri<br />
conservativi, la possibilità, o talvolta l’impossibilità, di movimentare<br />
un’opera dalla sua collocazione, ma anche gli spazi a<br />
disposizione, le fonti di luce presenti e la necessità di operare<br />
in modo assolutamente sicuro per le opere e per i tecnici preposti.<br />
Un attento studio preliminare delle condizioni di lavoro<br />
ha permesso al team di Haltadefinizione di progettare le attività<br />
da svolgere fin nel più piccolo dettaglio, consentendo così<br />
un’esecuzione del lavoro veloce, sicura per le opere e scarsamente<br />
invasiva anche per la Galleria.<br />
TECNICHE DI ACQUISIZIONE<br />
Digitalizzazione con macchina di ripresa nodale<br />
La tecnica nodale permette l’acquisizione di formati grandi<br />
e piccoli da un unico punto di ripresa con risoluzioni che possono<br />
superare i 1000 ppi a seconda del formato e prevede la<br />
Fig. 5 e 6 - Acquisizione gigapixel, Maestro del Crocifisso di Roncione, Crocifisso di Roncione, Galleria Nazionale dell’Umbria.<br />
16 ArcheomaticA N°1 marzo <strong>2022</strong>
Tecnologie per i Beni Culturali 17<br />
realizzazione di scatti multipli successivamente montati per<br />
ottenere un’immagine in gigapixel. La ripresa viene effettuata<br />
con l’utilizzo di illuminanti privati della radiazione ultravioletta,<br />
dannosa per le opere. Questa tecnica consente<br />
di ottenere immagini ad alta risoluzione con grande fedeltà<br />
nella riproduzione del colore. Nel caso delle opere della<br />
Galleria la risoluzione di acquisizione sarà di circa 600 ppi<br />
sulla misura reale degli oggetti.<br />
Digitalizzazione con macchina Fly By-O<br />
La macchina Fly By-O utilizza una tecnica di ripresa automatica<br />
a matrice, lavora in modalità orizzontale ed è utile per<br />
riprendere dipinti, arazzi e documenti di grande dimensione<br />
come mappe e carte di grandissimi formati che necessitano<br />
di un appoggio orizzontale. Il carrello mobile del macchinario<br />
orizzontale può essere esteso fino a consentire la scansione<br />
di formati alti 150 cm e con lunghezze notevoli, come<br />
ad esempio rotoli manoscritti o stampati su supporti eterogenei.<br />
Anche in questo caso la zona illuminata è circoscritta<br />
all’area fotografata, limitando al minimo l’esposizione alla<br />
luce ed eliminando la possibilità che vi siano radiazioni termiche<br />
causate dalle lampade. Gli illuminanti sono filtrati<br />
in maniera da eliminare la radiazione UV. L’applicazione di<br />
questa tecnologia viene eseguita attraverso molteplici scatti<br />
di dettaglio successivamente ricomposti digitalmente a<br />
formare un’unica immagine in altissima definizione del singolo<br />
oggetto. Vengono così realizzate immagini con risoluzioni<br />
ottiche compresa tra i 400 e i 2000 ppi calcolati sulla<br />
misura reale dei documenti, con livelli di accuratezza e di<br />
dettaglio molto elevati, nel rispetto dei parametri A della<br />
ISO/TS19264-1, che consentono di fruire in maniera semplice<br />
e rapida di immagini digitali di qualità, che permettono<br />
un’analisi estremamente approfondita dell’oggetto ripreso.<br />
Inoltre, il Fly By-O dispone di un modulo aggiuntivo robotizzato<br />
per realizzare acquisizioni 3D, utile per eseguire la<br />
fotogrammetria rapida dei dipinti.<br />
di conservazione preventiva e alerting (semi) automatico su<br />
situazioni di criticità.<br />
Per l’acquisizione 3D il sistema manuale è stato affiancato,<br />
nei casi in cui si è ritenuto più efficace, da un sistema combinato<br />
di laser scanner e scansione a luce strutturata, la nuova<br />
frontiera degli scanner 3D ibridi portatili a luce strutturata che<br />
combinano le migliori tecnologie di scansione 3D e diverse sorgenti<br />
luminose.<br />
DOCUMENTAZIONE PER FINALITÀ DIAGNOSTICHE<br />
Il Fly By-O e il sistema nodale dispongono di un modulo aggiuntivo<br />
per realizzare acquisizioni diagnostiche con UV e IR.<br />
La ripresa con fluorescenza visibile indotta da radiazione UV<br />
(365 nm) con illuminazione led con spettro di emissione 365-<br />
370 nm, fornisce la possibilità di osservare il comportamento<br />
degli strati più superficiali dell’opera (vernici, strati filmogeni<br />
protettivi) e il riconoscimento di alcuni pigmenti, leganti, adesivi<br />
e prodotti di restauro. Nel caso di opere di tipo cartaceo<br />
può aiutare a distinguere eventuali pattern di deterioramento<br />
e per la migliore lettura delle aree in cui l’inchiostro risulta<br />
sbiadito, prezioso aiuto in fase di restauri digitali dei documenti.<br />
Attraverso la riflettografia del vicino infrarosso (780 - 950 nm)<br />
è possibile descrivere contestualmente elementi della pellicola<br />
pittorica e appartenenti a porzioni stratigraficamente inferiori<br />
come, ad esempio, il disegno preparatorio realizzato con<br />
materiali carboniosi sulla preparazione.<br />
Nel caso della campagna di digitalizzazione presso la Galleria<br />
Digitalizzazione Pano 360<br />
Nelle due sale della Galleria in cui sono presenti affreschi<br />
sono state utilizzate tecniche di ripresa su testa nodale in<br />
grado di acquisire l’intera stanza a 360°, che successivamente<br />
potrà essere fruita con visori appositi.<br />
Attraverso i visori sarà possibile ammirare gli affreschi nella<br />
loro collocazione originaria con un visore multimediale a<br />
360° che consentirà di ingrandire l’immagine decine di volte<br />
senza mai perdere definizione.<br />
Digitalizzazione 3D<br />
Nel caso di statue e arredi sono state utilizzate tecniche di<br />
ripresa fotogrammetriche manuali macro per l’acquisizione<br />
3D. I risultati saranno modelli tridimensionali sotto forma di<br />
mesh colorate .obj con risoluzione fino a 0,5mm. L’acquisizione<br />
fotogrammetrica prevede la realizzazione di una rete<br />
di fotografie del soggetto, acquisite da più punti di vista,<br />
che permettono così di effettuare una triangolazione spaziale<br />
degli elementi ripresi. Tale triangolazione permette di<br />
rappresentare una nuvola di punti aventi coordinate spaziali<br />
(X, Y, Z) e cromatiche (L, A, B) accurate, metriche e confrontabili<br />
nel tempo.<br />
La scansione fotogrammetrica, pertanto, è particolarmente<br />
efficace nella riproduzione affidabile del colore per ogni<br />
punto nello spazio e permette di ottenere una immagine<br />
metrica ortorettificata (senza distorsioni prospettiche)<br />
dell’opera.<br />
Tali dati saranno particolarmente utili per indagini di tipo<br />
conservativo e monitoraggio periodico dello stato di conservazione<br />
del bene, e consentiranno la definizione di politiche
Nazionale dell’Umbria sono stati valutati i singoli scenari e per<br />
alcune opere si è proceduto con l’esecuzione di analisi diagnostiche<br />
focalizzate solo su alcune zone e non sull’intera opera.<br />
Tra le opere oggetto di indagine possono essere citati il Polittico<br />
dei Domenicani di Beato Angelico, la Pala della Sapienza<br />
Nuova di Benozzo Gozzoli.<br />
LA RESTITUZIONE DEI CAPOLAVORI IN DIGITALE<br />
I capolavori digitalizzati saranno restituiti alla Galleria Nazionale<br />
dell’Umbria attraverso la piattaforma evoluta per la gestione<br />
delle immagini (Coosmo) di Haltadefinizione.<br />
Dal momento che le immagini gigapixel sono costituite da file<br />
di grandissime dimensioni, misurabili nell’ordine di decine di<br />
Gigabyte, la piattaforma online appositamente sviluppata agevola<br />
la gestione e la fruizione dei file stessi.<br />
La piattaforma includerà l’accesso riservato per l’Ente alle<br />
proprie opere in gigapixel con visualizzazione in tempo reale<br />
dell’immagine, un’infrastruttura in grado di erogare le immagini<br />
gigapixel e 360 verso terzi (ad esempio il sito della Gallerie<br />
Nazionale dell’Umbria) in modo facile e veloce, senza che sia<br />
necessario disporre di server particolari o di una banda particolarmente<br />
potente per la trasmissione dei dati.<br />
Le immagini inoltre possono essere protette con filigrana visibile,<br />
personalizzabile e multilivello per garantire la massima<br />
protezione del contenuto, o con filigrana invisibile attraverso<br />
un algoritmo che inserisce nell’immagine un codice invisibile e<br />
rintracciabile successivamente sui file digitali.<br />
CONCLUSIONI E SVILUPPI FUTURI<br />
Durante questi mesi tre set up hanno lavorato contemporaneamente<br />
per portare avanti nel più breve tempo possibile la<br />
campagna di acquisizione che ha interessato cento opere della<br />
Galleria Nazionale dell’Umbria, un progetto che sintetizza<br />
perfettamente come le tecnologie sviluppate da Haltadefinizione<br />
possono essere applicate agilmente a qualsiasi tipologia<br />
di opera d’arte ottenendo la massima qualità possibile. Le tecniche<br />
di acquisizione fotografica adottate sono state validate<br />
dall’Istituto Centrale per il Restauro, il quale ha constatato<br />
la completa non invasività e dannosità per gli oggetti fotografati,<br />
una garanzia molto importante per i musei e gli enti che<br />
decidano di intraprendere un percorso di digitalizzazione di<br />
singole opere o di intere collezioni. Il ramo ricerca e sviluppo<br />
di Haltadefinizione è costantemente impegnato nella studio<br />
e nella progettazione di nuove tecnologie custom applicabili<br />
all’acquisizione e alla fruizione di immagini di altissima qualità,<br />
sia con tecnologia gigapixel che 3D, per garantire risultati<br />
eccellenti in ogni condizione di ripresa.<br />
Per quanto riguarda l'archiviazione dei fotogrammi i metadati<br />
associati alle immagini sono compatibili con le specifiche ICCD<br />
OA/O3.<br />
Abstract<br />
The rennovation of the National Gallery of Umbria is an excellent case study<br />
of the relationship between art and technology. Beside the construction work,<br />
Haltadefinizione conducted an ambitious digitization project involving more<br />
than one hundred works of art, including paintings, statues, altarpieces and<br />
furnishings. Ultra-high definition 3D digitization delivers a digital archive to<br />
the museum, which supports enhanced uses online and offline, including cataloging,<br />
reproductions, documentation of conservation status and scholarship.<br />
Parole Chiave<br />
Musei; digitale; tecnologie beni culturali; tutela; gigapixel<br />
Autore<br />
Eleonora Ligas, Storica dell’arte<br />
eleonora.ligas@haltadefinizione.com<br />
Luca Ponzio, Fondatore di Haltadefinizione<br />
luca.ponzio@haltadefinizione.com<br />
Anna Umattino, Conservation scientist<br />
18 ArcheomaticA N°1 marzo <strong>2022</strong>
MUSEI<br />
Riqualificazione del Museo Dante<br />
a Ravenna in chiave tecnologica<br />
di Touchwindow<br />
Il museo è un luogo del tempo nel<br />
tempo, dove l’interattività e la multimedialità<br />
si uniscono al prestigio di<br />
reperti storici di inestimabile valore.<br />
Proiezioni immersive e nuovi applicativi<br />
software per il Museo Dante<br />
di Ravenna, un allestimento contemporaneo<br />
e fruibile per consolidare la<br />
valorizzazione della poesia di Dante.<br />
L’Amministrazione Comunale ha affidato<br />
il progetto per la riqualifica globale<br />
del museo all’azienda Touchwindow<br />
pionieri dell’innovazione digitale.<br />
In occasione delle celebrazioni dell’anno dantesco il Comune<br />
di Ravenna ha omaggiato l’illustre poeta con la scelta<br />
di rinnovare e riqualificare in chiave tecnologica il Museo<br />
Dante. Sito all’interno del complesso conventuale francescano<br />
a pochi passi dalla tomba del poeta lo spazio che in passato<br />
era deposito di cimeli comunali danteschi si trasforma<br />
oggi in spazio interattivo. Richiamando le parole di Dante:<br />
“e quindi uscimmo a riveder le stelle”,(canto XXXIV dell’Inferno,<br />
verso 139), il comune di Ravenna ha commissionato il<br />
totale refitting tecnologico delle sale espositive all’azienda<br />
Touchwindow, professionisti nella creazione, progettazione,<br />
produzione, attivazione e gestione di spazi altamente interattivi.<br />
Un vero e proprio viaggio, lungo le diverse sale dove<br />
vengono rivissute le opere e i giorni, la vita e la memoria del<br />
poeta più conosciuto al mondo.<br />
CONCEPT<br />
Touchwindow ha reso i diversi ambienti più attrattivi per i<br />
visitatori rivoluzionando completamente la customer experience<br />
attraverso percorsi immersivi dagli effetti audio-visivi<br />
e software capaci di veicolare le informazioni in modalità<br />
interattiva. Sin dai primi incontri per la definizione del<br />
nuovo allestimento del museo l’azienda ha individuato due<br />
precise aree di lavoro: da un lato rendere fruibili le informazioni<br />
storiche, artistiche e letterarie attraverso software<br />
e strumenti audiovisivi altamente innovativi, dall’altro creare<br />
aree immersive di forte impatto che potessero dare al<br />
visitatore la possibilità di ripercorrere gli episodi più intensi<br />
della vita di Dante Alighieri o di vivere la suggestiva atmosfera<br />
dei canti della Divina Commedia. Il dipartimento grafico,<br />
i visual artist e gli sviluppatori software hanno messo in<br />
atto un’intensa attività di ricerca per individuare le migliori<br />
modalità di presentazione dei contenuti sia didascalici che<br />
grafici, focalizzandosi sull’obiettivo di sorprendere il visitatore<br />
e coinvolgerlo nelle dinamiche di attivazione delle diverse<br />
installazioni audiovisive, senza mai perdere di vista la<br />
funzione divulgativa e formativa del museo. In parallelo il<br />
dipartimento tecnico ha sviluppato materialmente la vision<br />
dei creativi, attraverso la scelta di strumentazioni e materiali<br />
che potessero massimizzare la resa dei contenuti e gli effetti<br />
scenografici, integrandosi perfettamente all’estetica delle<br />
varie sale del museo, nel totale rispetto del valore storico<br />
dell’edificio e del progetto globale di restyling.<br />
20 ArcheomaticA N°1 marzo <strong>2022</strong>
Tecnologie per i Beni Culturali 21<br />
PROGETTAZIONE<br />
L’intervento è stato inquadrato all’interno di una più ampia<br />
opera di totale rinnovamento funzionale ed impiantistico del<br />
museo che ha richiesto una stretta e costante collaborazione<br />
con gli architetti, attraverso la quale sono state definite le<br />
linee guida estetiche, gestione dell’immagine coordinata, la<br />
rivalorizzazione di tutti i suoi spazi e la rielaborazione del<br />
marchio del museo. L’allestimento fisico dei device e delle<br />
strumentazioni così come i contenuti caricati sui software e le<br />
immagini proiettate, sono stati sviluppati in totale conformità<br />
del concept e dell’allestimento scenografico globale progettato<br />
assieme agli architetti. Trattandosi di un edificio dall’inestimabile<br />
valore storico l’azienda ha operato nel massimo<br />
rispetto della struttura preesistente, minimizzando l’impatto<br />
degli interventi sulle pareti e sui soffitti, ricercando materiali<br />
funzionali, leggeri e flessibili. Difatti sono state create strutture<br />
ad hoc per sostenere il peso delle installazioni, senza mai<br />
perdere di vista l’estetica di ogni elemento. Ogni sala ha conservato<br />
intatta la propria antica bellezza risaltata rispettosamente<br />
dalle tecnologie di Touchwindow . Grazie all'esperienza<br />
di system integrator e alla collaborazione con Crestron è<br />
stato sviluppato parallelamente un capillare sistema di<br />
controllo delle sale che tramite un touch panel permette al<br />
personale del museo di gestire in maniera automatizzata<br />
l’accensione e lo spegnimento di tutti i dispositivi connessi<br />
alla rete, di controllare singolarmente ogni sala e di<br />
scegliere la modalità di fruizione dei contenuti a seconda che<br />
siano presenti utenti singoli o gruppi guidati. In questo modo<br />
è possibile monitorare in maniera non invasiva ogni angolo<br />
del museo, garantendone la tutela ed il corretto<br />
funzionamento.<br />
PRODUZIONE<br />
L’ intervento ha interessato tutte le otto sale che compongono<br />
il Museo Dante nelle quale è stato messo in campo il completo<br />
know-how dell’azienda: dalla programmazione software alla<br />
creazione di contenuti, dalle installazioni audiovisive al controllo<br />
automatizzato degli ambienti. Il viaggio del visitatore<br />
inizia nella “Sala del tempo” in cui è presente una duplice<br />
installazione. Lungo la parete è stata realizzata una timeline<br />
tramite la proiezione di sfere fluttuanti sulle quali sono<br />
riportate le date più significative della vita di Dante. Grazie<br />
ai sensori di prossimità, quando il visitatore si avvicina ad un<br />
determinato punto della timeline, la stessa reagisce con una<br />
vera e propria esplosione di immagini ed informazioni completata<br />
dai relativi contenuti audio, fruibili tramite le cuffie<br />
single-cup installate a parete.<br />
Nella parte opposta della sala sono invece stati installati degli<br />
schermi circolari olografici da retroproiezione sui quali il visitatore<br />
può osservare immagini relative alla vita di Dante mentre<br />
ascolta gli approfondimenti provenienti dalle campane sonore<br />
che si attivano assieme alla proiezione tramite i sensori<br />
di presenza. Nella “Sala del volto” è stata creata una proiezione<br />
tramite video mapping su tre sculture in gesso raffiguranti<br />
il volto di Dante, rivalorizzate diventando veri e propri display<br />
dinamici. La parete opposta è stata adibita alla proiezione di<br />
alcuni versi del Boccaccio, in cui vengono descritti i lineamenti<br />
del poeta, udibili in contemporanea tramite diffusione audio.<br />
Nella “Sala Montevideo” riccamente affrescata e custode<br />
di alcuni preziosi cimeli, sono stati installati 4 QR-code che<br />
reindirizzano i visitatori ad approfondimenti e dettagli inerenti<br />
agli oggetti presenti nella sala, consultabili su smartphone e<br />
tablet. Nella “Sala del culto”, così come all’ingresso, è stato<br />
fatto un totale restyling dei contenuti e del software dei tavoli<br />
interattivi preesistenti. Il software Touchviewer, tramite<br />
la sua interfaccia intuitiva e alla sua struttura a cartelle ha<br />
permesso di predisporre numerosi approfondimenti legati alla<br />
presenza di Dante a Ravenna, accessibili tramite un semplice<br />
tocco. È stato possibile inoltre creare una mappa del museo<br />
e della città di Ravenna, sulle quali, grazie alla funzione POI<br />
(point of interest), il visitatore può selezionare i luoghi evi-
denziati e scoprire anteprime e spunti per proseguire la visita.<br />
Nella “Sala della fama” si offre un’esperienza immersiva<br />
nel mondo della pop art, grazie alle proiezioni su tre pareti<br />
verticali di locandine, francobolli e prodotti commerciali in<br />
cui è raffigurato Dante Alighieri le quali, tramite un software<br />
custom sviluppato ad hoc, si ingrandiscono e rimpiccioliscono<br />
creando un effetto fortemente suggestivo. Il percorso termina<br />
con le ultime sale dedicate alle tre cantiche della Divina Commedia,<br />
dove la vera protagonista è la customer experience.<br />
Grazie a una successione di schermi olografici in policarbonato<br />
che sembrano sospesi a mezz’aria, le proiezioni dei passaggi<br />
più significativi prendono vita e diventano tridimensionali, i<br />
colori variano a seconda dell’angolazione e l’audio completa il<br />
quadro creando una dimensione parallela nella quale il visitatore<br />
ripercorre l’esperienza di Dante, incontrando i personaggi<br />
più celebri della Divina Commedia. Circondato da immagini<br />
e suoni suggestivi il visitatore può inoltre dedicarsi agli approfondimenti<br />
presso le dodici postazioni di ascolto composte da<br />
altrettanti pannelli informativi e cuffie single-cup. Il prestigioso<br />
progetto, tracciato da un Comitato Scientifico (in base<br />
alle convenzione del Nov.2018 stilata tra Comune di Ravenna,<br />
Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna e Centro Dantesco<br />
dei frati minori conventuali) ha previsto numerosi interventi,<br />
realizzati nel massimo rispetto della struttura preesistente,<br />
ed ha richiesto una stretta e costante collaborazione tra tutti<br />
i professionisti coinvolti e lo staff del Comune di Ravenna,<br />
un gruppo di lavoro composto da professionalità dell’ufficio<br />
cultura e della Biblioteca Classense che ha realizzato l’imponente<br />
lavoro di redazione dei testi e la selezione delle oltre<br />
quattrocento immagini fruibili attraverso le installazioni interattive<br />
che accompagnano i visitatori in tutte e nove le sale<br />
del museo.<br />
ATTIVAZIONE E MANUTENZIONE<br />
Nell’ottica di rendere il museo un vero e proprio polo culturale<br />
non solo per la divulgazione dell’incredibile eredità culturale<br />
di Dante, ma anche per la valorizzazione e la promozione di<br />
tutto l’immenso patrimonio culturale della città di Ravenna,<br />
Touchwindow è riuscita a rappresentare il passato in chiave futuristica.<br />
Utilizzando il potere evocativo delle immagini -come<br />
lo stesso Dante ricorda: “Pigliare occhi, per aver la mente”<br />
(canto XXVII del Paradiso)- e potenziandolo con strumenti tecnologici<br />
d’avanguardia, ha permesso di creare un allestimento<br />
coinvolgente, ipnotico, contemporaneo ed educativo in grado<br />
22 ArcheomaticA N°1 marzo <strong>2022</strong>
Tecnologie per i Beni Culturali 23<br />
di partecipare ai visitatori di ogni età un percorso che punta<br />
dritto al cuore della Divina Commedia e di Dante stesso.<br />
Museo Dante di Ravenna è un luogo del tempo nel tempo, in<br />
cui il visitatore non può far altro che immergersi, un percorso<br />
fisico e immaginifico vero e proprio, concepito per offrire<br />
anche ai turisti un’esperienza emozionale ed educativa, attraverso<br />
un progetto pensato in chiave contemporanea, dove<br />
l’interattività e la multimedialità del nostro tempo si uniscono<br />
al prestigio di reperti storici di inestimabile valore.<br />
Abstract<br />
The Municipality of Ravenna has commissioned the total technological refitting<br />
of the exhibition rooms of the Dante Museum to the company Touchwindow,<br />
professionals in the creation, design, production, activation and<br />
management of highly interactive spaces. Touchwindow has made the different<br />
environments more attractive to visitors, completely revolutionizing the<br />
customer experience through immersive paths with audio-visual effects and<br />
software capable of conveying information in interactive mode.<br />
Parole Chiave<br />
Digitalizzazione; musei; innovazione; allestimento multimediale; multimedialità;<br />
esperienze digitali; interactive experience; parete Interattiva; multiutente;<br />
system integrator; digital environment<br />
Autore<br />
Touchwindow<br />
info@touchwindow.it -<br />
Digital Experience & Interaction: Touchwindow<br />
Allestimento a cura di Comune di Ravenna ai sensi della convenzione tra Comune<br />
di Ravenna, Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna e Centro dantesco dei<br />
frati minori conventuali.
ARCHEOLOGIA FORENSE<br />
L'Archeologia Forense tra etica e deontologia<br />
L’etica e la deontologia dell’archeologo forense:<br />
tra rispetto delle norme e coscienza morale e professionale<br />
di Pier Matteo Barone<br />
Negli ultimi anni, sempre più spesso il professionista archeologo viene incaricato dai Tribunali<br />
civili e penali dello svolgimento di consulenze tecniche d'ufficio (CTU) e perizie. Lo sviluppo<br />
della professione dell’archeologo in ambito forense può essere collegato ad un principale fattore:<br />
i magistrati si stanno rendendo conto, sempre di più, quanto la consulenza archeologica<br />
sia assolutamente necessaria per far luce in molti casi di illeciti civili e penali.<br />
In ambito sia civile che penale, il Giudice ha<br />
facoltà di incaricare un professionista, un esperto<br />
o un tecnico come suo ausiliario, quando occorre<br />
redimere questioni tecniche complesse, svolgere<br />
indagini o acquisire dati o valutazioni che richiedono<br />
specifiche competenze tecniche, scientifiche o<br />
artistiche (art. 221 c.p.p. e art. 61 c.p.c.).<br />
Il ruolo dell’esperto incaricato non è solo di riferire<br />
al Giudice, ma piuttosto di fornirgli una conoscenza<br />
che non può possedere, una regola scientifica o una<br />
tecnica che può essere necessaria, nel corso di un<br />
procedimento, per accertare e/o per valutare una<br />
situazione o una problematica.<br />
In tale inquadramento il professionista incaricato dal<br />
Giudice svolge un’attività in funzione del processo<br />
e nel superiore interesse della giustizia, quindi, la<br />
sua relazione tecnica deve essere per sua natura<br />
neutra, non classificabile né a carico né a discarico<br />
dell’imputato o delle parti, sottratta al potere<br />
dispositivo delle parti e rimessa essenzialmente al<br />
potere discrezionale del Giudice. Per tale motivo<br />
l’ausiliario del giudice, sia in ambito civile che penale,<br />
in sede di conferimento dell’incarico, deve prestare<br />
giuramento “di bene e fedelmente adempiere le<br />
funzioni affidategli al solo scopo di fare conoscere<br />
ai giudici la verità” (art. 193 c.p.c.). Il giuramento<br />
obbliga l’ausiliario del giudice a determinate<br />
responsabilità ed a rispettare strettamente le norme<br />
deontologiche e morali.<br />
È opportuno precisare che il professionista iscritto<br />
Fig. 1 - Alcuni requisiti essenziali che il consulente dovrebbe possedere.<br />
24 ArcheomaticA N°1 marzo <strong>2022</strong>
Tecnologie per i Beni Culturali 25<br />
all’albo dei Consulenti tecnici del Tribunale civile e/o<br />
all›albo dei Periti del Tribunale penale non può rifiutarsi<br />
di adempiere al mandato assegnato dal Giudice, (art. 63<br />
c.p.c. e 221 c.p.p.), salvo nei casi in cui ricorrano i motivi<br />
di astensione tassativamente previsti dalla legge (art.<br />
51 c.p.c. e 36 c.p.p.), nel qual caso il professionista ha<br />
l'obbligo di dichiararlo. La domanda di iscrizione ai suddetti<br />
albi costituisce infatti una sorta di consenso preventivo del<br />
consulente/perito ad esercitare tali funzioni.<br />
Di seguito viene illustrata la distinzione degli incarichi<br />
conferiti in ambito civile e penale al fine di definire<br />
successivamente le responsabilità relative.<br />
INCARICO AL CTU<br />
In ambito civile il professionista incaricato dal Giudice è<br />
definito Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU), la cui nomina è<br />
normata principalmente dagli articoli 61 e 191 c.p.c. Il CTU<br />
deve essere scelto tra i soggetti iscritti nell’apposito Albo<br />
dei Consulenti tecnici istituito presso ogni Tribunale civile.<br />
Il giudice non è tenuto in modo vincolante ad operare una<br />
scelta esclusivamente sulla base del suddetto albo; infatti,<br />
egli può nominare un consulente iscritto nell’albo di un<br />
tribunale diverso rispetto a quello di causa o può scegliere<br />
un esperto non iscritto in alcun albo.<br />
All’udienza fissata per la raccolta del giuramento e il<br />
conferimento dell’incarico del CTU, il giudice, oltre a<br />
ricordare al consulente l’importanza delle funzioni e a<br />
ricevere il giuramento di rito, assume ulteriori provvedimenti<br />
quali: determina, insieme al CTU, la data, l’ora e il luogo<br />
d’inizio delle operazioni peritali; espone il quesito e<br />
delimita i poteri di indagine del consulente; autorizza il<br />
CTU al ritiro dei fascicoli di parte ovvero copia di atti del<br />
fascicolo d’ufficio ove ciò è necessario; assegna un termine<br />
per la consegna della bozza di relazione tecnica alle parti<br />
e per il deposito della relazione tecnica finale; conferisce<br />
l’incarico al fine di esperire il tentativo di conciliazione tra<br />
le parti; provvede sulla richiesta di proroga, ove il termine<br />
non sia già scaduto, del termine per la nomina dei consulenti<br />
di parte; autorizza eventuali richieste del CTU (l’uso del<br />
mezzo proprio, la collaborazione di coadiutori, accesso a<br />
luoghi, acconto spese, ecc.).<br />
L’elaborazione della consulenza tecnica d’ufficio si articola<br />
in tre fasi:<br />
1. la relazione del CTU, in bozza ma già completa, viene<br />
inviata alle Parti nel termine disposto dal giudice durante<br />
l’udienza di affidamento dell’incarico;<br />
2. le Parti trasmettono al consulente le proprie osservazioni<br />
sulla relazione di consulenza tecnica entro l’ulteriore<br />
termine fissato dal giudice;<br />
3. nell’ulteriore termine assegnato dal giudice, il consulente<br />
deve depositare in cancelleria la relazione, le osservazioni<br />
delle parti e una sintetica valutazione conclusiva sulle<br />
stesse.<br />
Quindi, il CTU, a conclusione del proprio lavoro, deve<br />
tener conto delle osservazioni di parte dandone atto nel<br />
corpo della relazione finale, fornendo eventuali risposte o<br />
chiarimenti.<br />
Una volta depositata la consulenza tecnica d’ufficio, il<br />
Giudice non è strettamente vincolato alle conclusioni<br />
a cui è pervenuto il CTU. Infatti, il giudice può: aderire<br />
alle conclusioni della CTU senza particolare motivazione;<br />
discostarsene, dando adeguata motivazione; aderire alla<br />
CTU dandone motivazione, se la consulenza tecnica d’ufficio<br />
non abbia dato risposta alle critiche di una consulenza<br />
tecnica di parte.<br />
INCARICO AL PERITO<br />
In ambito penale, il professionista incaricato dal giudice è<br />
definito Perito, la cui nomina è normata dagli articoli da<br />
220 a 232 e 508 c.p.p. Il Perito deve essere scelto tra i<br />
soggetti iscritti nell’apposito Albo dei Periti istituito presso<br />
ogni Tribunale penale e, solo in via meramente sussidiaria,<br />
può essere scelto tra persone particolarmente competenti<br />
nella materia.<br />
La perizia può essere disposta in diverse fasi del processo<br />
penale: in incidente probatorio; in udienza preliminare; nel<br />
giudizio abbreviato; in dibattimento; nel procedimento di<br />
esecuzione; nel giudizio di revisione.<br />
All’udienza fissata per il conferimento dell’incarico al<br />
perito, il giudice, accertate le generalità del Perito, gli<br />
chiede se si trova in una delle condizioni di incapacità o<br />
incompatibilità previste dalla legge, lo avverte degli obblighi<br />
e delle responsabilità previste dalla legge penale (tra cui<br />
rispettare il segreto nello svolgimento delle operazioni<br />
peritali) e lo invita a giurare la seguente dichiarazione:<br />
“consapevole della responsabilità morale e giuridica che<br />
assumo nello svolgimento dell’incarico, mi impegno ad<br />
adempiere al mio ufficio senza altro scopo che quello di far<br />
conoscere la verità”. Inoltre, nella stessa sede, il Giudice:<br />
formula i quesiti, sentiti il Perito, i Consulenti tecnici di<br />
parte, il Pubblico Ministero e i Difensori presenti; autorizza<br />
il Perito a prendere visione degli atti, dei documenti e<br />
delle cose prodotti dalle parti, dei quali la legge prevede<br />
l’acquisizione al fascicolo per il dibattimento; determina<br />
che il Perito debba procedere immediatamente ai necessari<br />
accertamenti e rispondere ai quesiti con parere messo a<br />
verbale e/o concede un termine (del quale devono essere<br />
avvertiti le parti e i consulenti tecnici), che non può<br />
superare i novanta giorni e può essere prorogato dal giudice;<br />
autorizza eventuali richieste del Perito (assistere all’esame<br />
delle parti e all’assunzione di prove, servirsi di ausiliari di<br />
sua fiducia, ecc.). Riguardo l’opera dei collaboratori del<br />
Perito, la normativa indica specificatamente che essa debba<br />
essere limitata solo allo svolgimento di attività materiali,<br />
non implicanti apprezzamenti e valutazioni, e ad analisi di<br />
laboratorio (art. 228 c.p.p.).<br />
L’art. 227 c.p.p. stabilisce che il parere peritale debba<br />
essere espresso in forma orale, con dichiarazioni raccolte<br />
a verbale, e solo eccezionalmente mediante il deposito<br />
di una relazione scritta. Anche se nella pratica la seconda<br />
modalità di esplicitazione dei risultati dell’attività peritale<br />
costituisce la regola, il deposito della relazione scritta<br />
rimane un elemento accessorio rispetto all’esposizione orale<br />
del parere da parte del Perito. La lettura della relazione<br />
peritale, quindi, è disposta solo dopo l’esame orale del<br />
Perito, che è condizione necessaria ai fini dell’acquisizione<br />
della prova (art. 511 c.p.p.); infatti, secondo la normativa<br />
(art. 501 c.p.p.) l’esame orale del perito in dibattimento<br />
rientra nelle disposizioni dettate in tema di esame dei<br />
testimoni, e il suo mancato svolgimento determina<br />
l’inutilizzabilità della prova o per lo meno, produce una<br />
nullità a regime intermedio per violazione dei diritti di<br />
difesa delle parti.<br />
APPROCCIO DEONTOLOGICO E RESPONSABILITÀ<br />
DEL CTU E DEL PERITO<br />
Il consulente archeologo forense deve possedere alcuni<br />
requisiti essenziali sintetizzati nella Figura 1.<br />
Le consulenze tecniche d’ufficio, le perizie e le operazioni<br />
svolte dal CTU e/o dal Perito devono essere inattaccabili sul<br />
piano della forma. Si sottolinea che il compito dell’ausiliario<br />
del giudice non è quello di fornire valutazioni di tipo
giuridico o attribuire responsabilità, ma solo di sviluppare<br />
gli elementi tecnici sui quali si fonderà il giudizio del<br />
magistrato competente.<br />
I CTU ed i Periti, nell’adempimento delle proprie funzioni,<br />
possono incorrere in tre tipologie di responsabilità: la<br />
responsabilità disciplinare, la responsabilità civile e la<br />
responsabilità penale.<br />
La responsabilità disciplinare dei consulenti tecnici e periti<br />
viene valutata dal presidente del Tribunale e interessa i<br />
seguenti aspetti: non aver tenuto una “condotta morale<br />
specchiata” (riguardanti casi non necessariamente riferiti a<br />
violazioni dell’incarico di CTU); non aver ottemperato agli<br />
obblighi derivanti dagli incarichi ricevuti (art. 19 disp. att.<br />
c.p.c. e artt.69 e 70 disp. att. c.p.p.). Le sanzioni disciplinari<br />
applicabili ai CTU ed ai Periti sono: l’avvertimento; la<br />
sospensione dall’albo per un tempo non superiore a un<br />
anno; la cancellazione dall’albo (art. 20 disp. att. c.p.c. e<br />
art. 70 disp. att. c.p.p.).<br />
La responsabilità civile obbliga il CTU o il Perito a risarcire i<br />
danni arrecati alle parti a causa della propria condotta, per<br />
violazione dei doveri di diligenza e correttezza e per infedele<br />
o cattivo espletamento dell’incarico. Ciò trova fondamento<br />
nell’art. 64 c.p.c. secondo il quale “il consulente tecnico<br />
che incorre in colpa grave nell’esecuzione degli atti che gli<br />
sono richiesti, è punito con l’arresto fino a un anno o con<br />
l’ammenda fino a 10.329 euro . . .. In ogni caso è dovuto il<br />
risarcimento dei danni causati alle parti”.<br />
La responsabilità penale del CTU e/o del Perito è dovuta al<br />
fatto che esso, in quanto ausiliario del giudice, riveste la<br />
qualifica di pubblico ufficiale conforme alla definizione data<br />
all’art. 357 c.p., secondo il quale “agli effetti della legge<br />
penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una<br />
pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa”.<br />
All’ausiliare del Giudice, quindi, si applicano le fattispecie<br />
di reato collegate a questa peculiare qualifica (es. peculato,<br />
concussione, corruzione, abuso d’ufficio, falsità in atti sia<br />
materiale che ideologica, ecc). In tabella 1 vengono riportate<br />
le tipologie di reati penali maggiormente ricorrenti in tema<br />
di CTU e perizie.<br />
Tra i reati indicati in tabella 1, merita un approfondimento il<br />
reato per falsa perizia, normato dall’art.373 c.p., secondo il<br />
quale “Il perito o l’interprete, che, nominato dall’Autorità<br />
giudiziaria dà parere o interpretazioni mendaci, o afferma<br />
fatti non conformi al vero, soggiace alle pene stabilite<br />
nell’articolo precedente 1 . La condanna importa, oltre<br />
l’interdizione dai pubblici uffici, l’interdizione dalla<br />
professione o dall’arte”.<br />
È da sottolineare che il perito incorre nel reato di falsa<br />
perizia quando: nasconda la sua incompetenza; nasconda<br />
la sua incapacità naturale o legale nel redigere la perizia;<br />
taccia sulla sua condizione di incompatibilità; non si attivi<br />
nelle indagini necessarie; non fornisca determinati elementi<br />
di valutazione o fornisca interpretazioni compendiate in<br />
affermazioni non rispondenti al vero.<br />
Generalmente, per casi in cui sia da accertare un reato<br />
penale compiuto da un CTU o un Perito, il giudice si riserva<br />
di nominare un proprio Perito. È naturale che il Perito<br />
incaricato a stabilire la sussistenza di un reato penale<br />
nell’attività, la consulenza o la perizia di un altro Perito o CTU<br />
debba necessariamente esercitare la stessa professione del<br />
perito indagato. Questo aspetto, particolarmente delicato,<br />
determina la scelta da parte del Giudice di nominare come<br />
Perito un professionista che non sia iscritto nello stesso Albo<br />
professionale regionale del perito indagato.<br />
CONCLUSIONI<br />
Appare evidente come nello svolgimento di Consulenze<br />
Tecniche d’Ufficio e Perizie, l’aspetto etico e deontologico<br />
del tecnico incaricato sia di primaria importanza, non<br />
solo per evitare di incorrere in “spiacevoli incidenti” che<br />
possono minare la pratica della professione, ma anche per<br />
poter fornire all’organo giudicante un mezzo, corretto sia<br />
nella forma che nella sostanza, che possa essere utile alla<br />
giustizia e quindi alla società.<br />
La famosa “regola 702” (dedotta dalle sentenze Freye<br />
e Daubert) afferma che un testimone esperto deve: i)<br />
presentare fatti e dati sufficienti; ii) ricostruire gli eventi sulla<br />
Reato Esempio di condotta Pena<br />
Reclusione fino a 6 mesi o multa<br />
Art.366 c.p.<br />
Rifiuto di uffici<br />
legalmente dovuti.<br />
Art.328 c.p.<br />
Omissione di atti<br />
d’ufficio.<br />
Art.373 c.p.<br />
Falsa Perizia<br />
Art.374 c.p.<br />
Frode processuale<br />
Il CTU/Perito non si presenta all’udienza per assumere<br />
l’incarico e prestare il giuramento, oppure fornisce false<br />
giustificazioni per essere sostituito.<br />
Il CTU/Perito ritarda il deposito della relazione senza<br />
addurre alcuna valida giustificazione; oppure si rifiuta di<br />
adempiere all’incarico assunto senza giustificato motivo.<br />
Il CTU/Perito fornisce dolosamente un parere falso o<br />
afferma l’esistenza di fatti non veri e da ciò deriva una<br />
condanna per la parte che subisce la falsità.<br />
Il CTU/Perito modifica artificiosamente lo stato dei luoghi o<br />
delle cose su cui si deve svolgere la consulenza.<br />
da 30 a 516 euro.<br />
Pena accessoria: interdizione<br />
dall’esercizio della professione<br />
Reclusione fino a 1 anno o multa<br />
fino a 1.032 euro.<br />
Pena accessoria: interdizione<br />
dall’esercizio della professione<br />
Reclusione da 2 a 6 anni.<br />
Pena accessoria: interdizione<br />
dall’esercizio della professione<br />
Reclusione da 6 mesi a 3 anni.<br />
Pena accessoria: interdizione<br />
dall’esercizio della professione<br />
Tab. 1 - Principali tipologie di reati penali ricorrenti in tema di CTU e perizie.<br />
26 ArcheomaticA N°1 marzo <strong>2022</strong>
Tecnologie per i Beni Culturali 27<br />
base di principi e metodi affidabili; e 3) applicare in modo<br />
affidabile i principi e i metodi al caso. In Daubert, la Corte<br />
non aveva ancora sottolineato il principio dell’accettazione<br />
generale da parte della comunità scientifica, ma ha posto<br />
l’onere su un giudice di determinare l’ammissibilità di<br />
nuove prove sulla base della valutazione critica del giudice<br />
dell’affidabilità dei metodi e delle procedure utilizzate<br />
da un esperto. Questa valutazione deve essere condotta<br />
considerando principi come la possibilità di sottoporre la<br />
teoria o la tecnica scientifica ad un’analisi empirica per<br />
verificarla o confutarla; l’esistenza di una revisione critica<br />
da parte di esperti del settore; un’indicazione del margine<br />
di errore noto o potenziale; e l’esistenza di standard relativi<br />
all’uso della tecnica impiegata. Da quel caso, la “regola<br />
702” è diventata un punto di riferimento per la valutazione<br />
delle prove scientifiche. Questa sentenza ha reso i giudici<br />
i custodi della legge e ha ribadito che essi hanno l’ultima<br />
parola sulla validità delle conoscenze presentate al<br />
processo. Anche se una parte riconosce di aver bisogno della<br />
scienza per far luce su questioni particolarmente complesse<br />
per le quali un giudice non possiede gli strumenti necessari<br />
all’interpretazione, il giudice si riserva comunque il diritto<br />
di decidere a chi riconoscere il titolo di scienziato.<br />
Note<br />
1 Art. 372 c.p. Falsa testimonianza: chiunque, deponendo come testimone innanzi all’autorità<br />
giudiziaria o alla Corte penale internazionale afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in<br />
tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali è interrogato, è punito con la reclusione da<br />
due a sei anni.<br />
Abstract<br />
In recent years, more and more often the professional archaeologist is commissioned<br />
by civil and criminal courts to carry out technical consultations and expert<br />
reports. The development of the archaeological profession in the forensic field<br />
can be linked to two main factors: the justice system is realizing, more and more,<br />
how much the archaeological consultancy is absolutely necessary to shed light on<br />
many cases of civil and criminal offences.<br />
Bibliografia<br />
Buckles, T. Crime Scene Investigation, Criminalistics, and The<br />
Law, 2006, Cengage Learning. ISBN: 978-1401859299<br />
Dixon, L., Gill, B. Changes in the Standards for Admitting Expert<br />
Evidence in Federal Civil Cases Since the Daubert Decision,<br />
RAND Institute for Civil Justice, 2002.<br />
Morgan, R.M. Bull, P.A., Forensic geoscience and crime detection,<br />
Minerva Med. Leg., 127, 2007, pp. 73-89.<br />
Barone, P.M. Contestualizzare l’Archeologia Forense; <strong>Archeomatica</strong><br />
- Tecnologie per i Beni Culturali, Anno XII - Numero 2 Giugno 2020<br />
Barone, P.M. Legal Consultancy in Forensic Archaeology: An Introduction<br />
to Italian Regulations and Professional Ethics. Glob<br />
J of Forensic Sci & Med 1(3): 2019. GJFSM.MS.ID.000511.<br />
Barone, P.M.; Groen, W.J.M. Multidisciplinary Approaches to Forensic<br />
Archaeology: Topics discussed During the European Meetings<br />
on Forensic Archaeology (EMFA); Springer, 2018; ISBN 978-3-<br />
319-94397-8.<br />
Di Maggio, R.M., Barone, P.M. (eds.) Geoscientists at Crime Scenes:<br />
A Companion to Forensic Geoscience; Soil Forensics; Springer International<br />
Publishing, 2017; ISBN 978-3-319-58047-0.<br />
Parole chiave<br />
Archeologia forense; Deontologia; Etica; Consulenza<br />
Autore<br />
Pier Matteo Barone<br />
matteo.barone@ntu.ac.uk<br />
Archaeology and Classics Program, The American University of Rome, Via P. Roselli,<br />
4 – 00153 Roma, Italia<br />
Geoscienze Forensi Italia® -Forensic Geoscience, Italy, Rome, Italy<br />
ORCID: 0000-0002-8232-4935<br />
(P.M. Barone)<br />
1998 2 022<br />
ideazione e organizzazione<br />
27-30 ottobre <strong>2022</strong> Paestum ● Tabacchificio Cafasso ● Parco Archeologico Museo Basilica<br />
12 eventi unici al mondo tutti in una Borsa<br />
ArcheoExperience<br />
Laboratori di Archeologia Sperimentale con le tecniche utilizzate<br />
dall’uomo per realizzare i manufatti di uso quotidiano.<br />
ArcheoIncoming<br />
Spazio espositivo e Workshop in qualità di Buyer dei tour operator<br />
specialisti del turismo archeologico per l’incoming verso le<br />
destinazioni italiane.<br />
ArcheoIncontri<br />
Conferenze stampa e presentazioni di progetti culturali e di sviluppo<br />
territoriale.<br />
ArcheoLavoro<br />
Orientamento post diploma e post laurea con area espositiva<br />
dedicata alle Università e presentazione dell’offerta formativa.<br />
ArcheoStartUp<br />
Presentazione di neo imprese per l’innovazione nel turismo<br />
culturale e nella valorizzazione dei beni culturali.<br />
In collaborazione con Associazione Startup Turismo<br />
ArcheoVirtual<br />
Workshop e Mostra multimediale sulle applicazioni digitali e sui<br />
progetti di archeologia virtuale.<br />
In collaborazione con ISPC Istituto di Scienze del Patrimonio<br />
Culturale del CNR<br />
Conferenze<br />
Organizzazioni Governative e di Categoria, Istituzioni ed Enti Locali,<br />
Associazioni Culturali e Professionali si confrontano su promozione<br />
del turismo culturale, valorizzazione, gestione e fruizione del<br />
patrimonio.<br />
Incontri con i Protagonisti<br />
Il grande pubblico con i più noti Divulgatori culturali, Archeologi,<br />
Direttori di Musei, Accademici, Giornalisti.<br />
International Archaeological Discovery Award “Khaled al-Asaad”<br />
Il Premio alla scoperta archeologica dell’anno intitolato all’archeologo<br />
di Palmira.<br />
Premi “Antonella Fiammenghi”, “Paestum Mario Napoli”, “Sebastiano Tusa”<br />
Alle personalità impegnate a favore dell’archeologia, del dialogo<br />
interculturale, del patrimonio sommerso e ai laureati con tesi<br />
sul turismo archeologico e sull’archeologia subacquea.<br />
Salone Espositivo<br />
Salone Internazionale unico al mondo delle destinazioni turisticoarcheologiche.<br />
da giovedì 27 a sabato 29 ottobre ore 10-19 domenica 30 ottobre ore 10-13<br />
Workshop con i Buyer europei selezionati dall’ENIT e i Buyer nazionali<br />
di ArcheoIncoming<br />
I Buyer incontrano gli operatori turistici dell’offerta.<br />
sabato 29 ottobre ore 10-14 | 15-18<br />
INGRESSO GRATUITO<br />
REGISTRAZIONE ONLINE<br />
SUPER GREEN PASS<br />
info 089.253170<br />
info@bmta.it seguici su #BMTA<strong>2022</strong><br />
www.bmta.it
DOCUMENTAZIONE<br />
“Metal Detectors”: la tecnologia<br />
attuale per la prospezione archeologica<br />
di Renato Di Cesare, Marco Lisi<br />
Il “metal detector” (in italiano, cercametalli)<br />
è uno strumento che utilizza alcune<br />
proprietà elettromagnetiche dei metalli<br />
per rilevare la presenza di oggetti metallici<br />
sepolti nel terreno.<br />
Originariamente sviluppati per applicazioni<br />
militari, più precisamente per<br />
bonificare i campi minati, i cercametalli<br />
trovano uso in molte altre applicazioni:<br />
dalla rilevazione di armi sui passeggeri<br />
negli aeroporti alle ricerche geologiche e<br />
(con molte riserve) archeologiche, ovvero,<br />
più banalmente, all’individuazione di<br />
cavi elettrici o tubi metallici interrati o<br />
nelle pareti di edifici.<br />
Parlando più specificatamente di archeologia,<br />
i cercametalli hanno svolto e svolgono tuttora<br />
un ruolo significativo come strumento nella ricerca<br />
di reperti archeologici sepolti. Purtroppo sono<br />
spesso associati, soprattutto in Italia, ad una nomea<br />
negativa, che li associa ai “tombaroli” e ad attività in<br />
generale poco legali.<br />
Rispettando la legislazione vigente e le regole del<br />
buon senso e della buona creanza, questi strumenti<br />
possono tuttavia essere un ausilio utilissimo ad una<br />
ricerca archeologica professionalmente condotta.<br />
Il dibattito sul loro uso è tuttavia molto acceso, non<br />
solo in Italia. Prestigiosi quotidiani americani, come<br />
il New York Times, sono arrivati ad esaltare l’uso dei<br />
“metal detectors” come valido ausilio all’archeologia.<br />
In Gran Bretagna il “metal detecting” è un hobby<br />
diffusissimo, spesso assurto agli onori della cronaca<br />
per ritrovamenti archeologici importanti, tanto che<br />
si è resa necessaria una regolamentazione “ad hoc”,<br />
gestita dal British Museum. Lo scopo è quello di evitare<br />
gli abusi di un uso indiscriminato ed illegale dei<br />
cercametalli, documentando al contempo i ritrovamenti<br />
e dando loro un significato storico e scientifico.<br />
In Italia, a parte le leggi dello Stato, che però rischiano,<br />
con un’eccessiva semplificazione, di equiparare<br />
hobbisti con “tombaroli”, molto dipende in pratica<br />
dai regolamenti delle singole Regioni.<br />
Piuttosto che entrare in una discussione di principio<br />
sull’utilizzo dei cercametalli, lo scopo del presente<br />
articolo vuole essere quello di descrivere da un punto<br />
di vista prettamente tecnico la loro tecnologia,<br />
con la convinzione che essi possano svolgere un ruolo<br />
utile nell’ambito della prospezione archeologica del<br />
sottosuolo.<br />
BREVE STORIA DEL “METAL DETECTOR”<br />
I primi esperimenti sull’uso dell’elettromagnetismo<br />
per individuare oggetti metallici cominciarono alla<br />
fine del diciannovesimo secolo, mentre un primo rudimentale<br />
(e molto ingombrante) modello di “metal<br />
detector” fu utilizzato in Francia, nel 1919, per trovare<br />
bombe inesplose dopo la Prima Guerra Mondiale<br />
(fig. 1).<br />
Il moderno sviluppo dei cercametalli cominciò tuttavia<br />
negli anni ’20, con i primi brevetti di apparati<br />
portatili. Uno degli inventori, l’americano Shirl Herr,<br />
prestò la sua consulenza durante il rinvenimento delle<br />
galee romane dell’imperatore Caligola nel lago di<br />
Nemi, nell’agosto del 1929.<br />
28 ArcheomaticA N°1 marzo <strong>2022</strong>
Tecnologie per i Beni Culturali 29<br />
Il merito di aver migliorato in modo decisivo le prestazioni<br />
del “metal detector” è universalmente attribuito ad un ingegnere<br />
polacco, Józef Stanisław Kosacki, negli anni della<br />
Seconda Guerra mondiale.<br />
Kosacki, ingegnere e professore, aveva resistito come ufficiale<br />
all’invasione della Polonia da parte dei Tedeschi.<br />
Fatto prigioniero, era riuscito a fuggire in Inghilterra, continuando<br />
a servire come ufficiale dell’esercito polacco in<br />
esilio. Nel 1941 egli perfezionò un suo precedente progetto<br />
e lo offrì all’esercito inglese il quale, sotto il nome di<br />
“Polish Mine Detector”, lo produsse immediatamente e ne<br />
inviò cinquecento esemplari all’ Ottava Armata britannica<br />
del generale Montgomery ad El Alamein (figure 2 e 3), per<br />
bonificare i campi minati lasciati dalle truppe del generale<br />
Rommel.<br />
Durante il resto della guerra furono prodotte oltre centomila<br />
unità del modello. Adottato anche dagli Americani, esso<br />
fu utilizzato praticamente su tutti i fronti della guerra, in<br />
Europa come nel Pacifico (fig. 4). Un modello molto simile<br />
all’originale è stato utilizzato in Gran Bretagna fino al 1995.<br />
Rimandando ad un successivo paragrafo la descrizione tecnica<br />
del cercametalli “polacco”, vale la pena ricordare che<br />
l’apparato funzionava a valvole ed era alimentato con batterie,<br />
raggiungendo un peso complessivo di 14 chilogrammi.<br />
Dagli anni ’40 ad oggi sia la ricerca che la tecnologia hanno<br />
messo a disposizione, dei militari e dei civili, una grande<br />
varietà di apparati basati su differenti principi fisici, con<br />
soluzioni circuitali sempre più miniaturizzate e di avanguardia.<br />
PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEI “METAL DETECTORS”<br />
Limitandoci alle applicazioni civili, i “metal detectors”, nel<br />
senso stretto del termine, trovano ampia applicazione nella<br />
rilevazione di piccoli oggetti metallici in terreni ove è probabile<br />
che siano presenti.<br />
L’utilità di un metal detector è abbastanza intuitiva e con<br />
esso è possibile effettuare delle prospezioni che mediamente<br />
possono arrivare anche ad un metro di profondità o,<br />
più realisticamente, intorno ai 20 ÷ 30 cm per piccole monetine<br />
isolate o oggetti metallici di dimensioni equivalenti.<br />
In prima analisi, da profani, tali prestazioni sembrerebbero<br />
limitative ma, invece, sono di tutto rispetto se l’apparato<br />
riesce a segnalare la presenza di questi oggetti in maniera<br />
deterministica e, cioè, con una bassa probabilità di errore<br />
e di inutili scavi.<br />
È utile definire quali sono le caratteristiche principali che,<br />
se soddisfatte, fanno di un apparato un oggetto professionale.<br />
Tali caratteristiche, elencate in ordine di importanza,<br />
sono:<br />
• Stabilità relativa;<br />
• Esclusione automatica del suolo o bilanciamento<br />
automatico;<br />
• Eliminazione automatica di oggetti da ritenere inquinanti;<br />
• Regolazione della sensibilità;<br />
• Discriminazione dei metalli.<br />
Un buon metal detector deve assicurare, oltre ad una buona<br />
sensibilità, la reiezione dell’“effetto terreno” e una discreta<br />
stabilità della catena amplificatrice (cioè dell’elettronica)<br />
in modo da non costringere a continui ritocchi della<br />
stessa.<br />
In genere i cercametalli commerciali di classe economica<br />
attualmente disponibili in commercio sono dotati di buona<br />
sensibilità, ma raramente sono in grado di minimizzare<br />
in maniera significativa l’influenza negativa del suolo,<br />
Fig. 1 - Cercametalli “portatile” usato in Francia dopo la Prima Guerra<br />
Mondiale<br />
non permettendo, quindi, la rilevazione di piccoli oggetti<br />
metallici in terreni non “omogenei”. Inoltre richiedono la<br />
massima attenzione dell’operatore per mantenere costante<br />
la distanza della bobina di ricerca dalla superficie sottostante.<br />
Anche i cercamine militari, utilizzati nel secondo conflitto<br />
mondiale, erano affetti da tali problemi, ma solitamente il<br />
loro utilizzo era orientato alla ricerca di ordigni metallici<br />
di dimensioni molto più significative di una moneta. Eventuali<br />
segnalazioni di “falsi bersagli” erano ovviamente ben<br />
accette, mentre il contrario avrebbe rappresentato il “disastro”<br />
e la probabile morte dell’operatore.<br />
Un’altra caratteristica soddisfatta in quasi tutti i modelli<br />
professionali, è la discriminazione della tipologia di metallo<br />
(cioè la possibile reiezione di manufatti non “nobili”) che,<br />
però, può considerarsi veramente efficace solo se indipendente<br />
dalla forma, dalle dimensioni e dalla profondità di<br />
interramento dell’oggetto.<br />
PRINCIPI DI FUNZIONAMENTO E POSSIBILI CONFIGURAZIONI<br />
Tutte le possibili architetture di “metal detectors” si basano,<br />
in un modo o nell’altro, sul comportamento dei materiali<br />
metallici in presenza di un campo magnetico, fisso o<br />
variabile nel tempo.<br />
In particolare alcuni materiali, quali appunto il ferro (ma<br />
anche il nickel e molti tipi di acciaio), rispondono ad un<br />
campo magnetico esterno magnetizzandosi essi stessi, e<br />
sono detti “ferromagnetici”. Altri, detti “diamagnetici”,<br />
generano all’opposto un campo magnetico che si oppone al<br />
campo magnetico esterno. Appartengono a questa categoria<br />
molti materiali, anche non metallici, quali il rame, l’argento,<br />
il mercurio, l’oro, il bismuto e il carbonio (negli stati<br />
Fig. 2 - Cercametalli britannico nel deserto di El Alamein.
Fig. 3 - Mina anticarro metallica.<br />
di diamante o di grafite). Questa distinzione dei materiali<br />
sulla base della loro interazione con i campi magnetici (ed<br />
elettromagnetici) è molto importante al fine di comprendere<br />
le tecniche di ricerca.<br />
La configurazione più antica di cercametalli è quella definita<br />
con l’acronimo BFO (Beat Frequency Oscillation) in<br />
relazione alla soluzione circuitale ed al principio su cui si<br />
basa (fig. 5).<br />
In pratica è equipaggiato con due oscillatori, di cui uno è<br />
quello di riferimento (f1) ed è a frequenza fissa (tipicamente<br />
stabilizzato da un quarzo), mentre l’altro (f2) è basato su<br />
un circuito LC (Induttanza/Capacità).<br />
La bobina di quest’ultimo circuito è la “testa” di ricerca<br />
ed è dimensionata in modo da ottenere una frequenza di<br />
oscillazione poco discosta da quella di riferimento (ragione<br />
di pochi o centinaia di Herz).<br />
I segnali provenienti dai due generatori confluiscono in un<br />
circuito miscelatore (mixer) in modo da ottenere il battimento<br />
tra gli stessi ovvero la somma e la differenza delle<br />
due frequenze.<br />
Un filtro passa basso, a valle del mixer, elimina il segnale<br />
“somma” lasciando integro l’altro che è a frequenza audio<br />
e si manifesta come un tono continuo.<br />
Quando vi è un metallo nelle vicinanze della testa di ricerca,<br />
si ha una variazione dell’induttanza della bobina con<br />
conseguente variazione della frequenza di oscillazione e,<br />
quindi, del tono audio che amplificato giunge sulle cuffie<br />
dell’operatore.<br />
Questa configurazione è di facile progettazione e realizzazione<br />
ma, per contro, è caratterizzata da una eccessiva<br />
influenza degli effetti del suolo. Infatti il suolo, che è<br />
un miscuglio disomogeneo di materiali con caratteristiche<br />
dielettriche differenti, causa una variazione dei parametri<br />
elettrici della bobina di ricerca, e le immancabili variazioni<br />
di quota di questa generano continue variazioni di frequenza<br />
che, seppur piccole, rendono il sistema poco efficace.<br />
Le caratteristiche di un cercametalli in configurazione BFO<br />
possono essere così riassunte:<br />
• Stabilità: buona<br />
• Esclusione automatica del suolo o bilanciamento<br />
automatico: difficile<br />
• Eliminazione automatica di oggetti inquinanti:<br />
improbabile<br />
• Regolazione della sensibilità: buona<br />
• Discriminazione dei metalli: possibile<br />
Il più grande progresso nella tecnologia dei cercametalli è<br />
avvenuto con lo sviluppo della configurazione cosiddetta<br />
“Induction Balanced” (fig. 6).<br />
Il sistema è basato su due avvolgimenti (bobine), delle quali<br />
una agisce come trasmettitore, l’altra come ricevitore. Esse<br />
possono lavorare in un intervallo di frequenze fra i 3 ed i<br />
100 kHz.<br />
Quando un oggetto metallico sepolto viene eccitato dal<br />
campo elettromagnetico della bobina trasmittente, si generano<br />
in esso correnti indotte che vengono rivelate dalla<br />
bobina ricevente.<br />
Questa configurazione permette di discriminare fra differenti<br />
metalli, contando sul fatto che ogni metallo ha una<br />
sua caratteristica risposta alle correnti alternate. In particolare<br />
le frequenze più basse (Very long Frequencies, VLF)<br />
penetrano più in profondità e sono adatte a materiali ad<br />
alta conducibilità come l’oro, l’argento ed il rame, mentre<br />
frequenze più alte, sebbene meno penetranti, sono più sensibili<br />
a materiali meno conducibili, come il ferro (purtroppo,<br />
anche ai terreni molto mineralizzati).<br />
Per poter ottenere una buona eliminazione degli effetti del<br />
terreno, compresi quelli dell’acqua salata, si può utilizzare<br />
una configurazione di cercametalli molto più avanzata (e<br />
Fig. 4 - Cercamine<br />
usato dalle<br />
truppe statunitensi<br />
durante la<br />
Seconda Guerra<br />
Mondiale<br />
Fig. 5 - Schema a blocchi di un cercametalli a BFO.<br />
30 ArcheomaticA N°1 marzo <strong>2022</strong>
Tecnologie per i Beni Culturali 31<br />
complicata), definita “Pulse Induction” (PI).<br />
Un cercametalli “Pulse Induction” ha un principio di funzionamento<br />
che ricorda in qualche modo quello di un radar<br />
(fig. 7).<br />
Un generatore invia un serie di impulsi di corrente alla testa<br />
di ricerca, producendo un intenso campo magnetico<br />
impulsato. L’avvolgimento (bobina) nella testa di ricerca<br />
trasmette gli impulsi verso il terreno, generando, con un<br />
piccolo ritardo, una serie di impulsi di risposta dall’oggetto<br />
metallico eventualmente sepolto, eccitato dal campo elettromagnetico<br />
esterno.<br />
I cercametalli PI superano tutte le altre configurazioni<br />
quando si tratta d’individuare oggetti piccoli in terreni intrisi<br />
di acqua salmastra (spiagge) o molto ricchi di minerali<br />
metallici. Per contro, non hanno la capacità di discriminare<br />
fra differenti tipi di metalli.<br />
Le caratteristiche di un cercametalli “Pulse Induction” possono<br />
essere riassunte come segue:<br />
Fig. 6 - Schema a blocchi di un cercametalli “Induction Balanced”.<br />
APPLICAZIONI DEI “METAL DETECTORS” NELLA<br />
RICERCA ARCHEOLOGICA<br />
Il primo utilizzo storicamente riportato dell’utilizzo dei cercametalli<br />
in ambito archeologico risale al 1958 ed è quello<br />
dello storico militare americano Don Rickey che li utilizzò<br />
per ricostruire lo scenario della storica battaglia di Little<br />
Big Horn. Nel Nord-America, l’uso dei “metal detectors”<br />
come strumento di ricerca storico-archeologica è stato per<br />
lo più rivolto alla ricostruzione di teatri di guerra e di battaglie,<br />
con il ritrovamento di manufatti ed esse relativi.<br />
Nel 1995 uno studio molto esteso condotto sull’uso dei cercametalli<br />
in archeologia nel Regno Unito dimostrò che ogni<br />
anno decine di migliaia di ritrovamenti significativi erano<br />
dovuti a cercatori amatoriali, animati dalla passione più che<br />
da motivazioni disoneste (fig. 8).<br />
Lo studio concluse che, nonostante le giustificate remore<br />
nei confronti di scavi condotti in modo non scientifico, i<br />
vantaggi di questo “hobby” erano di gran lunga maggiori<br />
degli aspetti negativi. Da questa conclusione scaturì il già<br />
citato “Treasure Code of Practice” del 1996 che stabiliva<br />
linee guida sulla reportistica, il coordinamento da parte di<br />
musei ed archeologi professionali ed alcune regole generali<br />
da rispettare a livello governativo.<br />
Al giorno d’oggi gli ausili tecnici in supporto alla prospezione<br />
archeologica non invasiva sono vari e numerosi: fotografie<br />
aeree e immagini da satellite, georadar (“ground<br />
penetrating radar”), magnetometria, mappatura della conducibilità<br />
del suolo. Anche i “metal detectors” di per sé<br />
sono strumenti non invasivi: l’ostilità nei loro confronti è<br />
principalmente dovuta all’abuso che se ne fa, da parte di<br />
persone senza scrupoli ovvero prive di sensibilità culturale<br />
nei confronti del patrimonio storico.<br />
A loro merito si deve ascrivere il fatto che sono relativamente<br />
economici e facili da usare. Se usati in maniera controllata<br />
e sistematica, possono costituire un valido aiuto<br />
alla ricerca archeologica, soprattutto nell’identificazione<br />
di nuovi siti d’interesse e nella loro delimitazione.<br />
Ancora una volta, si può dire che non è lo strumento ad<br />
essere di per sé cattivo, ma è l’uso sbagliato che se ne fa a<br />
renderlo tale.<br />
• Stabilità: buona<br />
• Esclusione automatica del suolo: ottima<br />
• Eliminazione automatica di oggetti inquinanti: buona<br />
• Regolazione della sensibilità: buona<br />
• Discriminazione dei metalli: difficile<br />
Tutte le configurazioni finora esposte si avvalgono negli ultimi<br />
anni delle più moderne tecnologie elettroniche, quali<br />
il processamento digitale dei segnali (“digital Signal Processing”,<br />
DSP) e la localizzazione GNSS/GPS, utile quest’ultima<br />
a memorizzare l’esatta posizione di possibili manufatti<br />
interrati.<br />
Fig. 7 - Schema a blocchi di un cercametalli “pulse induction”<br />
Fig. 8 - Vaso di terracotta trovato da un cercatore amatoriale nel Somerset,<br />
in Inghilterra. Il vaso conteneva più di cinquantamila monete romane<br />
del terzo secolo dopo Cristo.<br />
Abstract<br />
The "metal detector" is an instrument that uses some electromagnetic properties<br />
of metals to detect the presence of metal objects buried in the ground.<br />
Originally developed for military applications, more precisely to clear minefields,<br />
metal detectors find use in many other applications: from the detection<br />
of weapons on passengers in airports to geological and (with many<br />
reserves) archaeological research, or, more simply, to the identification of<br />
electrical cables or metal pipes underground or in the walls of buildings.<br />
Parole Chiave<br />
Metal detectors; archeologia; tecnologia;<br />
prospezione archeologica; ricerca<br />
Autore<br />
Marco Lisi, ingmarcolisi@gmail.com<br />
Renato di Cesare, alphagrby9@gmail.com
AZIENDE E PRODOTTI<br />
CULTURAL HERITAGE –<br />
NEXTGEN: INNOVATIVE AP-<br />
PROACHES IN DOCUMENTA-<br />
TION, RESEARCH, MANA-<br />
GEMENT AND EDUCATION<br />
This year's International<br />
Conference on Cultural Heritage<br />
and New Technologies<br />
will be titled Cultural<br />
Heritage – NextGen: Innovative Approaches in Documentation,<br />
Research, Management and Education.<br />
50 years after the adoption of the UNESCO World Heritage<br />
Convention, the protection of World Heritage<br />
seems to be at a crossroads. While awareness of the<br />
value of universal Cultural Heritage has raised considerably<br />
and the number of sites enlisted at UNESCO<br />
has been growing steadily, so has the pressure under<br />
which global Cultural Heritage has found itself.<br />
In 2008, UNESCO published a list with 14 categories<br />
and many subcategories of threats to Cultural Heritage.<br />
The threats range from war and crisis, weather<br />
and climate change impact, natural disasters,<br />
encroaching development, resource extraction, illegal<br />
activities as well as management issues, such as<br />
shortage of funding and/or skilled labor. Given the<br />
challenges outlined above, there is an active process<br />
of rethinking the policies to protect Cultural<br />
Heritage in general, taking place within and between<br />
political institutions, scientific communities and<br />
civic society around the world.<br />
We believe that technology can make a difference<br />
and help to protect, research and valorize Cultural<br />
Heritage in a sustainable way and to thereby<br />
preserve it for the next generation. Technological<br />
innovations enable the investigation of cultural heritage<br />
assets following minimally invasive approaches,<br />
they allow the wide dissemination of research<br />
outcomes and the promotion of Cultural Heritage<br />
to a broad audience, even during a global pandemic<br />
that seriously affected free movement. Digital<br />
technology and the scientific communities around it<br />
provide research tools, knowledge and educational<br />
opportunities to a practically unlimited audience,<br />
thereby making Cultural Heritage more inclusive<br />
and accessible. This increases the potential of Cultural<br />
Heritage to contribute to the shaping of identities<br />
and social cohesion of communities around the<br />
world. Finally, technology offers the means for the<br />
rapid documentation of the state of Cultural Heritage<br />
assets and the monitoring of potential alterations<br />
over time. It can, therefore, support management,<br />
decision-making, restoration and conservation actions<br />
for a sustainable Cultural Heritage around the<br />
world.<br />
case and discuss new research, exchange experiences<br />
and ideas and to build an ever-growing community<br />
around these topics. Since CHNT 26, 2021, the conference<br />
on Cultural Heritage and New Technologies is<br />
being organised by the CITY of Vienna (Department 7 –<br />
Cultural Affairs) together with CHNT-ICOMOS Austria, a<br />
sister association of the Austrian National Committee<br />
of ICOMOS. With the upcoming conference we want to<br />
contribute to the ongoing discussions by again bringing<br />
together cultural heritage professionals, decision<br />
makers, tech enthusiasts and other stakeholders with<br />
a strong interest in the application of new technologies<br />
in the field of cultural heritage.<br />
The organizing committee invites all interested participant<br />
and invites to submit the following contributions<br />
by 27 June:<br />
4 papers<br />
4 short papers<br />
4 posters<br />
4 apps<br />
Please find the Call for Papers here: https://chnt.at/<br />
call-for-papers/<br />
Publication formats for the Proceedings of CHNT 27 I<br />
<strong>2022</strong>:<br />
Presenters and session chairs who participated in<br />
CHNT 27 have the possibility to publish their contributions<br />
in the proceedings of the conference. From 2019<br />
on, the proceedings of the Conference on Cultural Heritage<br />
and New Technologies are being published as an<br />
e-book series on propylaeum, the information service<br />
for the classics in Heidelberg. The book and all of its<br />
papers will be available permanently with persistent<br />
identifiers (doi). The papers or the whole book will be<br />
available there in open access under a creative commons<br />
license. There are two formats for publishing in<br />
the proceedings: Papers and short papers.<br />
The first fixed sessions and round tables can be found<br />
in the conference programme: https://chnt.at/programme/<br />
CHNT-ICOMOS Austria<br />
info@chnt.at<br />
www.chnt.at<br />
The Conference on Cultural Heritage and New<br />
Technologies (CHNT) provides a platform to show-<br />
32 ArcheomaticA N°1 marzo <strong>2022</strong>
Tecnologie per i Beni Culturali 33<br />
Tecnologie per i Beni Culturali 33<br />
SPOT IL QUADRUPEDE MECCANICO<br />
MONITORA L’ANTICA POMPEI<br />
Nell’antica Pompei un bizzarro quadrupede<br />
meccanico avanza con agilità<br />
e autonomia. È lo SPOT di Boston<br />
Dynamics - sviluppato dall’azienda<br />
americana di robotica Boston Dynamics<br />
- un robot che cammina su diversi<br />
tipi di terreni e monitora le<br />
rovine del sito archeologico. SPOT,<br />
equipaggiato in due modalità rispettivamente<br />
con Leica BLKARC e con il<br />
sensore Spot CAM+, ispeziona luoghi<br />
anche di piccole dimensioni in tutta<br />
sicurezza, acquisisce e registra dati<br />
utili allo studio e alla progettazione<br />
di interventi.<br />
Per queste attività il Parco si sta<br />
avvalendo della collaborazione di<br />
aziende di Information Technology in<br />
continua ricerca e innovazione, come<br />
Leica Geosystems (part of Hexagon)<br />
e Sprint Reply, società del Gruppo<br />
Reply specializzata in robotica e process<br />
automation. In questa prima fase<br />
di sperimentazione è stato utilizzato<br />
anche il Leica BLK2FLY, il primo laser<br />
scanner volante in grado di effettuare<br />
scansioni 3D in autonomia. Queste<br />
piattaforme intelligenti per l’analisi<br />
dei dati, come quella realizzata da<br />
Sprint Reply, sono la necessaria base<br />
per rendere i dati, acquisiti durante<br />
le ispezioni dei robot, fruibili e utili<br />
per le applicazioni del parco archeologico<br />
di Pompei.<br />
Parco Archeolgico di Pompei<br />
“I progressi tecnologici nel mondo<br />
della robotica, dell’intelligenza artificiale<br />
e dei sistemi cosiddetti autonomi,<br />
hanno prodotto soluzioni e<br />
innovazioni più facilmente associate<br />
al mondo industriale e manifatturiero,<br />
che finora non avevano trovato<br />
applicazione all’interno dei siti archeologici<br />
a causa dell’eterogeneità<br />
delle condizioni ambientali, dell’estensione<br />
del sito”, dichiara il direttore<br />
generale, Gabriel Zuchtriegel.<br />
L'obiettivo, hanno aggiunto, è quello<br />
di “migliorare sia la qualità del monitoraggio<br />
delle aree esistenti, sia di<br />
approfondire la nostra conoscenza<br />
dello stato di avanzamento dei lavori<br />
nelle aree in fase di recupero o ripristino,<br />
e quindi gestire la messa in<br />
sicurezza del sito, così come quella<br />
dei lavoratori”.<br />
STONEX CUBE-3D – SOFTWARE<br />
DI FOTOGRAMMETRIA ED ELA-<br />
BORAZIONE DATI 3D<br />
Cube-3d è un software di Fotogrammetria,<br />
per la mappatura<br />
e l'elaborazione di immagini aeree,<br />
dedicato agli specialisti del<br />
rilevamento del territorio. È in<br />
grado di trasformare con estrema<br />
precisione le immagini rilevate,<br />
creando mappe digitali altamente<br />
accurate e modelli 3D.<br />
Il programma può importare i rilievi<br />
Cube-a ed è completamente<br />
compatibile con le scansioni<br />
registrate Stonex e con qualsiasi<br />
“Nuvola di punti” di terze parti.<br />
È possibile disegnare su nuvole<br />
di punti o mesh e unire i dati<br />
importati da strumenti di rilievo<br />
tradizionali, il tutto in un unico<br />
software. I dati possono poi essere<br />
elaborati e migliorati grazie<br />
ai vari strumenti CAD. Tra<br />
le molte funzioni disponibili, le<br />
più apprezzate sono la classificazione<br />
automatica, l'ortofoto,<br />
le sezioni trasversali e le linee<br />
di profilo, il calcolo del<br />
volume, e altro ancora.<br />
La configurazione delle<br />
licenze è molto flessibile,<br />
dall'abbonamento<br />
perpetuo a quello temporaneo,<br />
ogni esigenza<br />
può essere soddisfatta.<br />
Generatore di punti 3D<br />
e modelli digitali<br />
Il programma può elaborare,<br />
in un unico progetto,<br />
immagini catturate da qualsiasi<br />
fotocamera manuale, drone<br />
UAV o fotocamera multipla, e<br />
creare modelli 3D ad alta definizione,<br />
estremamente accurati e<br />
dettagliati.<br />
Vasta gamma di opzioni di importazione<br />
Senza selezionare un sistema di<br />
riferimento o inserire dettagli<br />
sui formati utilizzati, Cube-3d<br />
può ricevere dati direttamente<br />
da Cube-a, con le impostazioni<br />
definite in quest'ultimo, e utilizzarli,<br />
per esempio, come punto<br />
di controllo per la georeferenziazione<br />
dei modelli.<br />
È possibile importare nuvole di<br />
punti da lidar, laser scanner, e<br />
senza limitazioni, da qualsiasi<br />
strumento in grado di generarle.<br />
Orientamento infallibile<br />
Cube-3d rileva automaticamente<br />
sia i GCP che i punti di dettaglio,<br />
permettendo all'operatore<br />
di controllare la posizione dei<br />
target rilevati, nella prima fase<br />
dell'orientamento.
REALIZZAZIONE DEL DIGITAL TWIN DELLA STATUA<br />
DEL SAN GIUSEPPE DI MACERATA<br />
Nuove tecnologie e nuovi metodi di rappresentazione<br />
portano alla nascita della 4Dservice guidata<br />
dall’ingegnere Carlo Muffato, libero professionista<br />
specializzato in rilievi laser scanner, fotogrammetria<br />
terrestre ed aerea, modellazione 3d, rendering,<br />
tour virtuali e BIM. Nel 2021 l’artista Madrileno Jesus<br />
Arevalo Jimenez, specializzato nella scultura in<br />
legno e operante principalmente in Spagna, Regno<br />
Unito (County Hall, Londra) e Israele (Domus Galilaeae<br />
International Center), aveva realizzato per il<br />
Seminario Diocesano Redemptoris Mater di Macerata<br />
la statua del San Giuseppe.<br />
La caratteristica principale delle opere dell’artista è<br />
l’intaglio di pezzi direttamente su grandi tronchi di<br />
cedro, l'intaglio diretto su tronchi d'albero e blocchi<br />
di pietra, attivando e sviluppando enormemente la<br />
naturalezza dell'arte sacra attraverso la composizione<br />
scultorea ottenuta anche dai frammenti più minuti<br />
e riconnettendo la stratificazione dei materiali<br />
prelevati nei due emisferi. Insieme alla modellazione<br />
degli agenti naturali, la memoria dell'evoluzione<br />
conservata nei materiali della ricerca dell'artista è<br />
fondamentale per l'evoluzione umana, incalcolabilmente<br />
anteriore all'uomo stesso.<br />
Il 7 febbraio <strong>2022</strong> il Vice Rettore del Seminario ha<br />
affidato l’incarico di svolgere la scansione della statua<br />
per creare un file.stl alla 4Dservice.Il lavoro si<br />
è basato principalmente sulla realizzazione di un<br />
digital twin modello 3d fedele all’originale - della<br />
statua del S. Giuseppe. La statua in legno alta<br />
1.92 m, raffigura il S. Giuseppe che regge con la<br />
mano destra il Gesù bambino<br />
e con la mano sinistra un<br />
bastone. Per la scansione è<br />
stata utilizzata la tecnica<br />
della fotogrammetria digitale<br />
e per evitare errori di<br />
modellazione il bastone è<br />
stato rimosso per essere poi<br />
modellato successivamente.<br />
Nella prima fase sono state<br />
scattate numerose foto da<br />
angolazioni diverse della<br />
statua e la creazione di un<br />
set di luci che ha permesso<br />
una perfetta ed omogenea<br />
illuminazione da tutti i lati.<br />
Successivamente sono stati<br />
posizionati dei punti di riferimento<br />
(target) intorno<br />
all’oggetto, con lo scopo di<br />
avere nelle foto dei punti<br />
riconoscibili, risultati utili in una fase successiva, ovvero<br />
per scalare il modello in maniera precisa.<br />
La seconda fase si è basata sul processo di ricostruzione<br />
ed elaborazione tramite il software Reality Capture,<br />
che, in automatico, ha generato nuvole di punti<br />
delle varie porzioni della statua. Tali porzioni sono state<br />
unite in seguito tra loro tramite punti omologhi impostati<br />
dall’operatore per avere un unico modello sul<br />
quale calcolare la mesh, ovvero un insieme di poligoni<br />
che formano il modello 3D.<br />
L’oggetto virtuale così ottenuto è stato quindi “semplificato”,<br />
riducendone i vertici eccessivi e poi ottimizzato<br />
per la stampa 3D, chiudendo tutti i buchi eventualmente<br />
presenti nella mesh e rimodellando aree dove<br />
la fotogrammetria non è riuscita a creare superfici (ad<br />
esempio il buco nella mano che teneva il bastone).<br />
La fase finale è stata quella della texturizzazione,<br />
dove al modello sono stati applicati i materiali per una<br />
resa fotorealistica. Tale processo ha reso possibile la<br />
fedele riproduzione dell’oggetto, permettendone poi<br />
la stampa in 3D.<br />
34 ArcheomaticA N°1 marzo <strong>2022</strong>
XXIV TH<br />
CONGRESS OF THE INTERNATIONAL SOCIETY<br />
FOR PHOTOGRAMMETRY AND REMOTE SENSING<br />
NICE, FRANCE<br />
6 - 11 JUNE <strong>2022</strong><br />
Don't miss the major meeting of<br />
the Geospatial Community<br />
www.isprs<strong>2022</strong>-nice .com<br />
PLATINUM GOLD SILVER BRONZE
AGORÀ<br />
Il progetto VADUS: un metaforico<br />
guado verso i beni culturali difficilmente<br />
raggiungibili – Il progetto VA-<br />
DUS (Virtual Access and Digitization<br />
for Unreachable Sites), il cui acronimo<br />
significa guado, ha come obiettivo<br />
primario quello di offrire ai turisti<br />
la possibilità di fruire di beni culturali<br />
non facilmente raggiungibili mediante<br />
l’utilizzo di un metaforico passaggio<br />
sicuro di natura virtuale atto a superare<br />
le difficoltà legate al loro accesso<br />
fisico (per guerre e ostacoli ambientali)<br />
e alla loro completa e facile comprensibilità<br />
creata da una mancanza<br />
di parti significative del bene stesso<br />
(disperse, allocate in altre strutture e<br />
contesti, evidenziabili solo con strumentazione<br />
scientifica dedicata).<br />
Tale obiettivo è raggiunto da VADUS attraverso<br />
la creazione di un servizio SaaS<br />
(Software as a Service) pre-commerciale<br />
che, sfruttando la convergenza tra<br />
5G, infrastruttura Cloud e asset satellitari,<br />
possa offrire una nuova esperienza<br />
di fruizione dei beni culturali in realtà<br />
virtuale; quest’ultima sarà infatti non<br />
solo basata su modelli 3D accurati e ad<br />
alta definizione, ma anche arricchita<br />
da informazioni multimediali in grado<br />
di rivelare anche gli aspetti più nascosti<br />
e segreti delle opere d’arte grazie ad<br />
un utilizzo, opportunamente filtrato<br />
ed elaborato, di risultati provenienti<br />
da ricostruzioni fotogrammetriche<br />
e modellazioni digitali, da storytelling<br />
accattivanti con strati informativi<br />
scientificamente corretti e da tecnologie<br />
diagnostiche strumentali basate<br />
su RGB & IR - ITR (Red Green Blue &<br />
Infrared Imaging Topological Radar) LIF<br />
(Laser Induced Fluorescense). In particolare,<br />
queste ultime permetteranno<br />
rispettivamente di produrre modelli<br />
puntiformi di natura colorimetrica, rilevare<br />
particolari nascosti che non sono<br />
direttamente visibili ad occhio nudo,<br />
nonché di individuare la natura dei materiali<br />
utilizzati.<br />
Gli elementi caratterizzanti il progetto<br />
VADUS risiedono nei seguenti aspetti:<br />
4 Utilizzo di servizi Satellitari (Galileo<br />
e EO) per supportare la mobilità<br />
del turista nei siti visitati.<br />
4 Utilizzo di strumenti diagnostici<br />
nel campo del patrimonio culturale,<br />
sviluppati per azioni di conservazione<br />
e restauro, al fine di<br />
ottenere informazioni aggiuntive<br />
che possono riguardare la tipologia<br />
dei materiali utilizzati e lo stato di<br />
salute dell’opere.<br />
4 Creazione modelli 3D accurati e<br />
ad alta definizione che, oltre ad<br />
essere impiegati nello sviluppo del<br />
servizio offerto da VADUS, possono<br />
essere non solo di diretto supporto<br />
all’interpretazione storico/<br />
archeologica e antropica dei beni<br />
culturali, ma anche di base per<br />
sviluppo di nuovi servizi e prodotti<br />
(virtual tour, 360°views, HBIM, digital<br />
twin) utilizzabili nella progettazione<br />
di interventi e strategie di<br />
conservazione, valorizzazione e<br />
fruizione.<br />
4 Implementazione di storytelling<br />
caratterizzati da contenuti<br />
informativi affidabili e scientificamente<br />
corretti in quanto sviluppati<br />
in accordo con le autorità delegate<br />
alla fruizione, gestione e conservazione<br />
dei beni culturali.<br />
4 Utilizzo di piattaforme Cloud per<br />
la storicizzazione e conservazione<br />
dei dati e delle risorse multimediali<br />
da condividere con la comunità<br />
scientifica preservando la proprietà<br />
intellettuale e l’integrità delle<br />
risorse anche rispetto a cyber-attack.<br />
4 Utilizzo del 5G per soddisfare contemporaneamente<br />
molti utenti,<br />
senza vincoli nei percorsi di vista<br />
e di collegamenti (fisici mediante<br />
cavo o digitali) dei devices utilizzati<br />
a sistemi IT locali e/o a computer<br />
grafici; a ciò si aggiunge la<br />
disponibilità di un’ampia banda<br />
per il trasferimento di modelli ad<br />
alta risoluzione con assenza di latenza.<br />
Nel quadro di riferimento suddetto, le<br />
attività dimostrative del servizio sono<br />
previste per la Casa di Diana ad Ostia<br />
Antica, per l’Aula Isiaca del Palatino e<br />
per la Fortezza del Pastiss (Museo civico<br />
Pietro Micca di Torino); per ciascuna<br />
di esse, in coerenza con le finalità di<br />
valorizzazione e gestione dell’istituzione<br />
culturale, sono state individuate<br />
specifiche soluzioni di realtà virtuale.<br />
Queste ultime, ricorrendo anche al<br />
supporto di una apposita app (installabile<br />
sui device personali e/o forniti ai<br />
turisti), consentiranno di effettuare<br />
e gestire la visita virtuale, all’interno<br />
della quale saranno attivabili, in<br />
specifici punti di interesse del sito,<br />
elementi multimediali aggiuntivi (video,<br />
immagini, descrizioni e audio,<br />
ricostruzioni virtuali e oggetti 3D) con<br />
particolari focus su specifici aspetti<br />
storico/archeologici e sui risultati delle<br />
tecnologie diagnostiche impiegate.<br />
La Casa di Diana, non aperta al pubblico,<br />
è uno dei più importanti caseggiati<br />
ostiensi risalente alla prima metà del II<br />
secolo d.C. ed era adibita a residenza<br />
del ceto medio e ad attività commerciali.<br />
Per essa lo storytelling riguarderà<br />
i principali ambienti del piano terra,<br />
rappresentati dal tablinium, il mitreo<br />
con il suo vestibolo e i relativi connettivi<br />
necessari a dare continuità alla visita<br />
virtuale. Lo storytelling descriverà<br />
nei corridoi di ingresso le caratteristiche<br />
dell’edificio e della sua storia<br />
(fasi edilizie, restauri illustrati anche<br />
con foto d’epoca), nel tablinium i suoi<br />
affreschi con un focus sulle misure laser<br />
(RGB– ITR, LIF) per evidenziare i<br />
diversi interventi di restauro e i materiali<br />
utilizzati, nel vestibolo la sua<br />
funzione cerimoniale e le caratteristiche<br />
delle murature ottenute con<br />
tecniche laser, nel Mitreo la sua storia<br />
con un focus sugli altri mitrei di Ostia.<br />
La Fortezza del Pastiss, posta sotto il<br />
livello stradale (da -7 a -14 m) è visitabile<br />
solamente dietro appuntamento<br />
ed è caratterizzata da una accessibilità<br />
molto difficile; il Pastiss era una casamatta<br />
costruita tra il 1572 e il 1574<br />
posta a protezione ravvicinata di un<br />
bastione della Cittadella di Torino e<br />
avrebbe dovuto far parte di un più ampio<br />
progetto di opere di fortificazione<br />
che però non furono portate a termine.<br />
Il pubblico potrà fruire di una vista<br />
virtuale per le due grandi Sale di Combattimento<br />
del secondo livello che<br />
fornirà uno storytelling incentrato<br />
sulla storia del recupero del Pastiss<br />
e dell’assedio di Torino del 1706 non<br />
solo attraverso strati informativi liberamente<br />
attivabili, ma anche con la<br />
36 36 ArcheomaticA N°1 marzo <strong>2022</strong>
Tecnologie per i Beni Culturali<br />
37<br />
virtualizzazione dei dipinti custoditi<br />
nel Museo Micca che permetteranno<br />
di accedere a diversi focus di approfondimento<br />
(da quelli descrittivi, collegabili<br />
alle tecniche della guerra e<br />
ai personaggi riprodotti, a quelli più<br />
nascosti ricavati dalle analisi diagnostiche<br />
IR-ITR e LIF).<br />
L’Aula Isiaca, chiusa al pubblico, è un<br />
ambiente interrato situato al di sotto<br />
della Basilica della Domus Flavia che<br />
faceva parte della vasta residenza di<br />
Augusto. L’ambiente absidato era riccamente<br />
e affrescato da pitture, databili<br />
intorno al 30 a.C., che presentano<br />
numerosi richiami all’Egitto e alla dea<br />
Iside, come fiori di loto, serpenti, vasi<br />
rituali, ghirlande di rose, che ne giustificano<br />
l’attuale denominazione; tutti<br />
gli affreschi sono stati rimossi per ragioni<br />
conservative e sono conservati nel<br />
vicino Antiquarium. In questo la visita<br />
prevede il riposizionamento virtuale<br />
degli affreschi all’interno dell’Aula<br />
Isiaca per permettere una completa ricontestualizzazione<br />
degli ambienti con<br />
uno storytelling riguardante la storia<br />
del complesso e la presentazione dei<br />
risultati derivanti dalle misure laser<br />
(RGB– ITR, LIF).<br />
Il Progetto VADUS è cofinanziato da ESA<br />
(European Space Agency) nell’ambito<br />
della call ARTES 20 Applications integrating<br />
space asset(s) and 5G networks<br />
in L’Aquila /the Abruzzo region, Roma<br />
Capitale and Municipality of Torino<br />
(L’ART), con focus Cultural Heritage:<br />
Fruition & Diffusion. Il Consorzio esecutore<br />
è guidato da NEXT Ingegneria<br />
dei Sistemi e vede la partecipazione di<br />
TIM, ENEA, dell’Università di Roma La<br />
Sapienza, con il Centro interdipartimentale<br />
CITERA e il Dipartimento DIAG,<br />
e dei Parchi Archeologici del Colosseo<br />
e di Ostia Antica. In particolare, ENEA<br />
effettuerà i rilievi strumentali, mediante<br />
le suddette tecniche laser, di parti<br />
significative dei siti (i.e. affreschi,<br />
pitture, quadri) per fornire, dopo opportuna<br />
rielaborazione informazioni di<br />
natura scientifica e conservativa (i.e.<br />
spettri, immagini, 3D, report); Citera<br />
effettuerà mediante tecniche fotogrammetriche<br />
e di computer design<br />
l’implementazione di accurati modelli<br />
3D dei siti e di ricostruzione di eventuali<br />
parti mancanti, e si occuperà, con<br />
il contributo dei parchi archeologici<br />
di Ostia Antica e Colosseo, nonché di<br />
stakeholder istituzionali, della realizzazione<br />
degli storytelling con i relativi layer<br />
informativi di natura scientifica<br />
(provenienti principalmente da ENEA)<br />
e storico/archeologica. Next provvederà<br />
allo sviluppo della piattaforma<br />
e della sua componente applicativa<br />
verso i device dei turisti utilizzando<br />
sia l’infrastruttura 5G messa a disposizione<br />
da TIM, ottimizzata secondo<br />
le indicazioni fornite dal DIAG, sia i<br />
modelli 3D e gli storytelling sviluppati<br />
dagli altri partner. Attualmente il<br />
progetto è nella fase di preparazione<br />
all’esecuzione dei test preliminari di<br />
verifica in house del sistema proposto<br />
con il modello 3D e i materiali multimediali<br />
relativi alla Casa di Diana; a<br />
valle della validazione del sistema e<br />
delle relative analisi dei risultati ottenuti,<br />
si procederà alle necessarie<br />
calibrazioni e perfezionamento del<br />
servizio, che saranno seguite dalle<br />
attività di dimostrazione nei siti previsti<br />
con i turisti e gli stakeholders. Il<br />
sito ufficiale del progetto può essere<br />
raggiunto in:<br />
https://business.esa.int/projects/vadus<br />
Ultra-high acoustic remote sensing<br />
nel parco sommerso di Baia<br />
– Prosegue l’accordo operativo tra il<br />
Parco Archeologico dei Campi Flegrei<br />
(PAFLEG) e la sede CNR ISPC di Napoli<br />
che contempla l’utilizzo di tecniche<br />
non invasive di telerilevamento acustico<br />
subacqueo per il monitoraggio<br />
e la conservazione di beni culturali<br />
sommersi nell’Area Marina Protetta di<br />
Baia. Dopo la campagna in mare del<br />
2021 finalizzata all’esplorazione del<br />
patrimonio culturale sepolto dai sedimenti<br />
marini, la recente occasione di<br />
studio e analisi dei resti archeologici<br />
sommersi avvenuta grazie all’impiego<br />
di un sonar batimetrico di ultima generazione,<br />
ha permesso la mappatura<br />
ad altissima risoluzione della<br />
villa Pisoni nella cosiddetta<br />
“zona A” dell’Area Marina<br />
Protetta di Baia.<br />
I dati acquisiti hanno consentito<br />
di elaborare un modello<br />
digitale 3D a scala centimetrica<br />
del fondale con un dettaglio<br />
tale da permettere di<br />
ridisegnare parti della villa<br />
e di valutare e monitorare<br />
lo stato di conservazione dei<br />
resti archeologici sommersi.<br />
L’indagine con il sistema Norbit<br />
Winghead® i77h è stata coordinata<br />
da Crescenzo Violante, primo tecnologo<br />
del CNR ISPC di Napoli e responsabile<br />
scientifico dell’accordo operativo<br />
con PAFLEG. L’attività è stata svolta in<br />
collaborazione con la società norvegese<br />
Norbit subsea e la 2B Control di<br />
Bologna. Il fondale marino da cui affiorano<br />
i resti della villa è stato investigato<br />
con un ecoscandaglio multifascio<br />
compatto, il Norbit Winghead® i77h,<br />
che integra un sistema di posizionamento<br />
inerziale GNSS/INS. Fin dagli<br />
anni ‘60 il sito sommerso di Baia è<br />
stato un luogo simbolo per la ricerca e<br />
la sperimentazione di nuove tecniche<br />
dell’emergente archeologia subacquea<br />
italiana: mosaici, domus, porti<br />
di attracco sono al momento sommersi<br />
fino a profondità di circa 15 m.<br />
Le nuove indagini geofisiche effettuate<br />
nel presente studio forniscono<br />
ulteriori strumenti per la caratterizzazione,<br />
gestione e digitalizzazione<br />
dei beni culturali sommersi che ben<br />
si integrano con quelli derivati dalle<br />
tradizionali indagini subacquee. L’elaborazione<br />
e l’integrazione di dati rilevati<br />
da remoto (imbarcazioni e droni<br />
marini) permette di estrarre informazioni,<br />
sviluppare modelli per la ricerca<br />
archeologica e per la ricostruzione e<br />
la conservazione dei manufatti e dei<br />
paesaggi culturali sommersi. Il rilievo<br />
da remoto consente, inoltre, di preservare<br />
i beni culturali sommersi nel<br />
contesto in cui si trovano con significative<br />
implicazioni per la conservazione<br />
archeologica e l’uso consapevole ed<br />
efficiente delle risorse ambientali e<br />
culturali. Naturalmente ogni oggetto<br />
virtuale dovrà essere schedato con le<br />
caratteristiche della tecnologia e le<br />
specifiche di compatibilità alla banca<br />
dati nazionale di documentazione.
AGORÀ<br />
Meccanismo di Anticitera nuove ricerche<br />
sul “computer” ellenistico<br />
– Antikythera è un'isoletta rocciosa,<br />
situata tra Creta e la Grecia continentale:<br />
nei primi del 1900 un gruppo di<br />
subacquei greci dell’ isola del Mediterraneo<br />
orientale di Simy erano alla<br />
ricerca di spugne naturali, quando a<br />
causa di una tempesta persero la rotta<br />
e fortuitamente scoprirono il relitto di<br />
un'enorme nave che all'epoca trasportava<br />
statue in bronzo ed in marmo.<br />
Dopo la segnalazione alle autorità del<br />
ritrovamento, gli archeologi lavorarono<br />
sul relitto sino al settembre del 1901 e<br />
presso il Museo Archeologico Nazionale<br />
di Atene iniziarono i lavori di catalogazione<br />
e restauro (tra le sculture recuperate:<br />
l’Efebo di Anticitera che, con<br />
i suoi 1,96 metri di altezza, non corrisponde<br />
a modelli iconografici conosciuti<br />
e secondo alcuni studiosi potrebbe<br />
essere Perseo che tiene la testa della<br />
Gorgone uccisa o un giovane Eracle<br />
con il pomo delle Esperidi, per altri un<br />
Fig. 2 - La parte anteriore e posteriore della Macchina di Antikytera,<br />
credit: Tony Freeth, Scientific American, Gennaio <strong>2022</strong><br />
Hermes erudito che declama e che tiene<br />
in mano un caduceo. Attribuito allo<br />
scultore Euphranor, resta un brillante<br />
prodotto della scultura in bronzo del<br />
Peloponneso.)<br />
Tra i reperti che inizialmente erano<br />
sfuggiti all'attenzione, venne individuato<br />
un grumo delle dimensioni di un<br />
grande dizionario, uno strano oggetto<br />
che presentava tracce di corrosione ed<br />
era in buona parte inglobato in calcificazioni<br />
e sedimentazioni dovute ad animali<br />
marini. Inizialmente costituito da<br />
un unico blocco, si era poi frammentato<br />
in varie parti, rivelando ruote dentate<br />
di precisione in bronzo delle dimensioni<br />
di una moneta, molte delle quali<br />
con iscrizioni. Spyridon Stais nel 1902<br />
esaminò alcuni frammenti e comprese<br />
subito che si trattava di un meccanismo<br />
complesso.<br />
Era l’acme della tecnologia antica: la<br />
macchina di Anticitera, nota anche<br />
come il meccanismo di Antikythera -<br />
oggi conservata nel Museo Archeologico<br />
Nazionale di Atene, insieme ad una sua<br />
ricostruzione riprodotta in tempi moderni<br />
- è un oggetto composito, che<br />
ha sconcertato gli storici della scienza<br />
per più di centoventi anni, un vero e<br />
proprio computer analogico. Il relitto,<br />
a giudicare dalla ceramica facente<br />
parte del carico, fu fatto risalire alla<br />
cultura rodiota del I secolo a.C., secondo<br />
le conoscenze dell'epoca, poiché<br />
ingranaggi come questi non furono presenti<br />
nell'antica Grecia, o in qualsiasi<br />
altra parte del mondo, fino a molti secoli<br />
dopo il naufragio. Il ritrovamento<br />
generò un'interminabile controversia,<br />
molte furono le polemiche e le supposizioni:<br />
alcuni esperti sostenevano che<br />
i resti appartenessero ad un planetario,<br />
altri ad un astrolabio e<br />
nel corso dei decenni<br />
la massa originale fu<br />
divisa in 82 frammenti,<br />
lasciando ai ricercatori<br />
un puzzle diabolicamente<br />
difficile da ricostruire.<br />
Oggi si possiede<br />
una ragionevole comprensione<br />
di alcuni dei<br />
suoi meccanismi, ma ci<br />
sono ancora misteri irrisolti.<br />
<strong>Archeomatica</strong> nel<br />
Dicembre 2017, nella<br />
sezione International,<br />
ha dedicato un articolo<br />
al meccanismo di<br />
Antikythera: “The new<br />
findings from Antikythera<br />
mechanism” di<br />
Aristeidis Voulgaris, Andreas Vossinakis<br />
e Christophoros Mouratidis, uno studio<br />
che mira a indagare il calendario astronomico<br />
del quadrante della piastra<br />
frontale del suo meccanismo.<br />
Nel Marzo 2021 una nuova analisi della<br />
macchina dell’ UCL Antikythera Research<br />
Team - Tony Freeth (matematico<br />
e regista); Adam Wojcik (scienziato dei<br />
materiali); Lindsay MacDonald (scienziato<br />
delle immagini); Myrto Georgakopoulou<br />
(archeometallurgista); e due<br />
studenti laureati, David Higgon (orologiaio)<br />
e Aris Dacanalis (fisico) - ha proposto<br />
presso l'University College di Londra<br />
un nuovo modello di funzionamento<br />
degli ingranaggi sulla parte anteriore<br />
della macchina. Lo studio è stato di<br />
recente pubblicato - Gennaio <strong>2022</strong> - su<br />
Scientific American.<br />
I greci erano abili astronomi ad occhio<br />
nudo, guardavano il cielo notturno da<br />
una prospettiva geocentrica, ogni notte,<br />
mentre la Terra girava sul suo asse,<br />
vedevano la cupola di stelle che ruotava<br />
e le posizioni relative delle stelle<br />
rimanevano invariate, difatti vennero<br />
chiamate "stelle fisse". Si resero conto<br />
che corpi si muovevano sullo sfondo<br />
delle stelle e gli altri corpi in movimento,<br />
chiamati "erranti" a causa dei loro<br />
movimenti erratici, erano i pianeti.<br />
(Queste rotazioni sono chiamate cicli<br />
sinodici apparentemente anomale per<br />
gli scienziati dell’epoca e avvengono<br />
perché i pianeti orbitano intorno al sole<br />
e non come credevano gli antichi greci,<br />
alla Terra.)<br />
Tutti i corpi astronomici in movimento<br />
hanno orbite apparentemente vicine<br />
al piano del moto della Terra intorno<br />
al sole, la cosiddetta eclittica, il che<br />
significa che tutti seguono più o meno<br />
lo stesso percorso attraverso le stelle.<br />
Prevedere le posizioni dei pianeti lungo<br />
l'eclittica era molto difficile per i primi<br />
astronomi e questo compito molto<br />
probabilmente era una delle funzioni<br />
primarie del meccanismo di Antikythera,<br />
insieme a quella di tracciare le posizioni<br />
del sole e della luna, che hanno<br />
movimenti variabili rispetto alle stelle.<br />
Gran parte del design del meccanismo<br />
si basa sulla saggezza degli scienziati<br />
Babilonesi che registravano le posizioni<br />
quotidiane dei corpi astronomici su tavolette<br />
di argilla, rivelando che il sole,<br />
la luna e i pianeti si muovevano in cicli<br />
ripetuti. Il meccanismo di Antikythera<br />
infatti utilizza diverse relazioni di periodo,<br />
calcolo di origine babilonese.<br />
Il filologo tedesco Albert Rehm fu il primo<br />
a capire che 'Antikythera' era una<br />
38 ArcheomaticA N°1 marzo <strong>2022</strong>
Tecnologie per i Beni Culturali<br />
39<br />
macchina calcolatrice. Tra il 1905 e il<br />
1906 fece scoperte cruciali, che registrò<br />
nei suoi appunti di ricerca senza<br />
pubblicarle. Trovò Il numero 19 iscritto<br />
su uno dei frammenti di Antikythera: un<br />
chiaro riferimento alla relazione del periodo<br />
di 19 anni della luna nota come ciclo<br />
metonico, dal nome dell'astronomo<br />
greco Meton, ma scoperto molto prima<br />
dai Babilonesi. Sullo stesso frammento,<br />
Rehm trovò i numeri 76 - un perfezionamento<br />
greco del ciclo di 19 anni - e<br />
223, per il numero di mesi lunari, in un<br />
ciclo di previsione dell'eclissi babilonese<br />
chiamato ciclo di Saros. Erano i cicli<br />
astronomici ripetitivi che furono la forza<br />
trainante dell'astronomia predittiva<br />
babilonese.<br />
La seconda figura chiave nella storia<br />
della ricerca di Antikythera fu il fisico<br />
britannico, diventato storico della<br />
scienza, Derek J. de Solla Price. Nel<br />
1974, dopo 20 anni di ricerca, pubblicò<br />
un importante documento, "Gears from<br />
the Greeks", con riferimento a notevoli<br />
citazioni del giurista, oratore e politico<br />
romano Cicerone (106-43 a.C.). Una di<br />
questa citazioni descriveva una macchina<br />
realizzata dal matematico e inventore<br />
Archimede (circa 287-212 AEC), un<br />
dispositivo che captava i divergenti movimenti<br />
e le diverse velocità del sole,<br />
della luna e delle cinque stelle chiamate<br />
“vagabonde” (gli allora cinque<br />
pianeti). La macchina descritta ricorda<br />
proprio il meccanismo di Antikitera ed<br />
il passaggio suggerisce che Archimede,<br />
sebbene sia vissuto prima che il dispositivo<br />
fosse costruito, potrebbe aver<br />
fondato la tradizione che ha portato<br />
alla nascita del noto meccanismo. Vi è<br />
infatti la possibilità che il meccanismo<br />
di Antikythera fosse basato proprio su<br />
un progetto di Archimede. Nel De Re<br />
Publica, nelle Tusculanae Disputationes<br />
e nel De Natura Deorum, Cicerone aveva<br />
fatto quindi riferimento ai planetari<br />
in bronzo costruiti da Archimede che<br />
mostravano la Terra, la Luna, il Sole, il<br />
mese lunare e le eclissi, portati a Roma,<br />
dopo il saccheggio di Siracusa e la morte<br />
di Archimede nel 212 a.C., dal generale<br />
romano Marco Claudio Marcello.<br />
Per decenni i ricercatori hanno tentato<br />
di decifrare il funzionamento del dispositivo<br />
osservando la superficie dei suoi<br />
frammenti disintegrati, ma all'inizio<br />
degli anni '70 finalmente riuscirono ad<br />
esaminare l’interno del meccanismo.<br />
Price lavorò con il radiologo greco Charalambos<br />
Karakalos per ottenere radiografie<br />
dei frammenti, furono trovati 30<br />
ingranaggi distinti: 27 nel frammento<br />
Fig. 3 - Grafica di Tony Freeth e Jen Christiansen, Modello del UCL Antikythera Research Team.<br />
più grande e uno ciascuno negli altri<br />
tre. Karakalos, con sua moglie Emily,<br />
fu in grado di stimare per la prima volta<br />
il numero di denti degli ingranaggi,<br />
un passaggio fondamentale per capire<br />
cosa calcolasse il meccanismo.<br />
Le scansioni a raggi X erano bidimensionali,<br />
il che significava che la struttura<br />
degli ingranaggi appariva appiattita<br />
e in molti esiti rivelava solo immagini<br />
parziali degli ingranaggi, ma nonostante<br />
queste parziali deformazioni, Price,<br />
spinto da una caratteristica prominente<br />
sulla parte anteriore del meccanismo,<br />
chiamata ruota motrice principale,<br />
identificò un insieme di ingranaggi collegati:<br />
un treno di ingranaggi che iniziava<br />
con una ruota dentellata di 38 denti<br />
(due volte 19, poiché un ingranaggio<br />
con solo 19 denti sarebbe stato un po'<br />
troppo piccolo), che ne azionava (tramite<br />
altri ingranaggi) un altro da 127<br />
denti (metà di 254: il numero completo<br />
avrebbe richiesto un ingranaggio troppo<br />
grande).<br />
Come accennato in precedenza, sembra<br />
che il dispositivo fosse utilizzato<br />
per prevedere le posizioni del sole, della<br />
luna e dei pianeti in un giorno specifico<br />
nel passato o nel futuro. Un utente<br />
potrebbe quindi semplicemente girare<br />
una manovella sull'intervallo di tempo<br />
desiderato per vedere le previsioni<br />
astronomiche. Il meccanismo mostrava<br />
posizioni, ad esempio, su un "quadrante<br />
zodiacale" nella parte anteriore del<br />
meccanismo, dove l'eclittica era divisa<br />
in una dozzina di sezioni di 30 gradi che<br />
rappresentavano le costellazioni dello<br />
zodiaco. Price determinò correttamente<br />
le posizioni relative dei principali<br />
frammenti e definì l'architettura generale<br />
della macchina, con quadranti della<br />
data e dello zodiaco nella parte anteriore<br />
e due grandi sistemi di quadrante<br />
nella parte posteriore. I risultati di<br />
Price furono un passo significativo nella<br />
decodifica del mistero di Antikythera.<br />
Una terza figura chiave nella storia della<br />
ricerca di Antikythera è Michael Wright,<br />
ex curatore di ingegneria meccanica al<br />
Museo della Scienza di Londra. In collaborazione<br />
con il professore australiano<br />
di informatica Alan G. Bromley, Wright<br />
svolse nel 1990 un secondo studio utilizzando<br />
la tomografia assiale - prima<br />
tecnica a raggi X 3-D - ma Bromley morì<br />
prima che questo lavoro portasse i suoi<br />
frutti. Wright continuò il suo studio facendo<br />
importanti progressi: identificò il<br />
numero cruciale dei denti degli ingranaggi<br />
e comprese il quadrante superiore<br />
sul retro del dispositivo.<br />
Il terzo studio radiografico - pubblicato<br />
su Nature nel 2006 - completò la comprensione<br />
del retro del meccanismo e fu<br />
condotto nel 2005 da un gruppo di accademici<br />
inglesi e greci in collaborazione<br />
con il Museo Archeologico Nazionale di<br />
Atene. X-Tek Systems (ora di proprietà<br />
di Nikon) sviluppò un prototipo di macchina<br />
a raggi X per acquisire immagini a<br />
raggi X 3D ad alta risoluzione utilizzando<br />
la tomografia computerizzata a raggi<br />
X microfocus (TC a raggi X). Hewlett-<br />
Packard utilizzò una brillante tecnica di<br />
imaging digitale, chiamata mappatura<br />
della trama polinomiale, per migliorare<br />
i dettagli delle superfici: i nuovi dati<br />
furono sorprendenti. Il meccanismo<br />
prevedeva le eclissi oltre ai moti dei<br />
corpi astronomici; una scoperta collegata<br />
all'iscrizione che aveva trovato<br />
Rehm e che menzionava i 223 mesi del<br />
ciclo di eclissi di Saros. I nuovi raggi X<br />
rivelarono un grande ingranaggio di 223<br />
denti nella parte posteriore del meccanismo<br />
atto a far girare una lancetta<br />
intorno a un quadrante che si estende<br />
a spirale, compiendo quattro giri in to-
AGORÀ<br />
tale, divisi in 223 sezioni,<br />
per 223 mesi.<br />
Il quadrante Saros,<br />
chiamato così come<br />
il nome abituale del<br />
ciclo delle eclissi<br />
babilonesi predice<br />
quali mesi saranno<br />
caratterizzati da<br />
eclissi, insieme alle<br />
caratteristiche di<br />
ciascuna. La scoperta<br />
rilevò una nuova<br />
caratteristica del dispositivo,<br />
ma lasciò<br />
in sospeso un enorme<br />
problema: che<br />
funzione avevano un gruppo di quattro ingranaggi all'interno<br />
della circonferenza?<br />
Dopo mesi e mesi di studio questi ingranaggi risultarono calcolare<br />
il moto variabile della luna. La luna ha un moto variabile<br />
perché ha un'orbita ellittica: quando è più lontano dalla<br />
Terra, si muove più lentamente contro le stelle; quando è più<br />
vicino, si muove più velocemente. L'orbita della luna, però,<br />
non è fissa nello spazio: l'intera orbita ruota in poco meno di<br />
nove anni. Gli antichi greci non conoscevano le orbite ellittiche,<br />
ma spiegarono il sottile movimento della luna combinando<br />
due movimenti. Wright studiò due dei quattro misteriosi<br />
ingranaggi sul retro del meccanismo e notò che uno di<br />
essi aveva un perno sulla faccia che si agganciava con una<br />
fessura sull'altro ingranaggio e che gli ingranaggi ruotavano<br />
su assi diversi separati da poco più di un millimetro, il che<br />
significava che il sistema generava un movimento variabile.<br />
Gli assi degli ingranaggi non sono fissi, ma sono montati in<br />
modo epicicloidale sul grande ingranaggio da 223 denti.<br />
Wright scartò l'idea che questi ingranaggi calcolassero il moto<br />
variabile della luna perché nel suo modello, l'ingranaggio da<br />
223 denti girava troppo velocemente perché avesse un senso.<br />
Nel nuovo modello, realizzato da Tony Freeth e dal suo team,<br />
l'ingranaggio da 223 denti ruota molto lentamente per girare<br />
la lancetta del quadrante Saros. Calcolare la teoria epiciclica<br />
della luna con ingranaggi epiciclici a perni e scanalature<br />
era molto probabilmente una concezione straordinaria degli<br />
antichi greci e rafforzerebbe l’idea che la macchina fosse<br />
progettata da Archimede.<br />
Fig. 4 - Ruota motrice principale del meccanismo di<br />
Antikythera, foto scattata dal team di <strong>Archeomatica</strong><br />
LA PARTE ANTERIORE DEL MECCANISMO<br />
La caratteristica più evidente della parte anteriore del frammento<br />
più grande è la ruota motrice principale, progettata<br />
per ruotare una volta all'anno: non è un disco piatto come<br />
la maggior parte degli altri ingranaggi, ma ha quattro raggi<br />
che sostengono cuscinetti e fori circolari e che servivano per<br />
girare gli assi. Il bordo esterno dell'ingranaggio contiene un<br />
anello di pilastri, piccole dita che si alzano perpendicolarmente,<br />
con spalle ed estremità forate che erano chiaramente<br />
destinate a portare piastre. Quattro pilastri corti, invece,<br />
reggevano una piastra rettangolare e quattro pilastri lunghi<br />
ne reggevano una circolare.<br />
Seguendo Price, Wright propose un esteso sistema epicicloidale:<br />
l'idea che i due cerchi che i Greci usavano per spiegare<br />
gli strani moti inversi dei pianeti fosse stato montato sulla<br />
ruota motrice principale. Wright costruì un vero e proprio<br />
sistema di ingranaggi in ottone per mostrarne il funzionamento,<br />
nel 2002 pubblicò anche un modello di planetario<br />
innovativo per il meccanismo di Antikythera, che mostrava<br />
tutti e cinque i pianeti conosciuti nel mondo antico (la scoperta<br />
di Urano e Nettuno nel XVIII e XIX secolo, rispettivamente,<br />
richiese l'avvento dei telescopi). Mostrò che le teorie<br />
epicicliche potevano essere tradotte in treni di ingranaggi<br />
epiciclici con meccanismi a perni e fessure per visualizzare i<br />
movimenti variabili dei pianeti.<br />
Il modello di Wright presentava otto uscite coassiali - tubi<br />
tutti centrati su un singolo asse - che portavano informazioni<br />
al display frontale del dispositivo. Era davvero plausibile che<br />
gli antichi greci potessero costruire un sistema così avanzato?<br />
il suo sistema di ingranaggi non corrispondeva all'economia<br />
e all'ingegnosità dei noti treni di ingranaggi. La sfida che il<br />
team dell’ UCL ha dovuto affrontare è stata quella di riconciliare<br />
le uscite coassiali di Wright con le conoscenze che<br />
avevano a disposizione sul resto del dispositivo. Un indizio<br />
cruciale è apparso dallo studio TC a raggi X del 2005, che,<br />
oltre a mostrare gli ingranaggi in tre dimensioni, hanno rivelato<br />
migliaia di nuovi caratteri di testo nascosti all'interno<br />
dei frammenti. Nelle sue note di ricerca dal 1905 al 1906,<br />
Rehm aveva proposto che le posizioni del sole e dei pianeti<br />
fossero visualizzate in un sistema concentrico di anelli; il<br />
meccanismo originariamente aveva due coperchi, anteriore e<br />
posteriore, che proteggevano i display e includevano ampie<br />
iscrizioni. L'iscrizione sul retro, rivelata nelle scansioni del<br />
2005, era un vero e proprio manuale utente per il dispositivo.<br />
Nel 2016 Alexander Jones, professore di storia dell'astronomia<br />
alla New York University, scoprì che la prova definitiva<br />
dell'idea di Rehm era all'interno di questa iscrizione: una descrizione<br />
dettagliata di come il sole e i pianeti siano stati<br />
visualizzati in anelli, con perline di riferimento per mostrare<br />
le loro posizioni.<br />
Qualsiasi modello per il funzionamento del meccanismo dovrebbe<br />
corrispondere a questa descrizione, una spiegazione<br />
letteralmente iscritta sulla copertina posteriore del dispositivo<br />
che descrive come il sole e i pianeti sono stati visualizzati.<br />
Eppure i modelli precedenti non erano riusciti a incorporare<br />
questo sistema ad anello a causa di un problema tecnico.<br />
Wright aveva scoperto che il dispositivo utilizzava una sfera<br />
semilunare per mostrare la fase della luna, che calcolava<br />
meccanicamente sottraendo un input per il sole da un input<br />
per la luna, ma tale processo sembrava essere incompatibile<br />
con un sistema ad anello per la visualizzazione dei pianeti,<br />
perché le uscite per Mercurio e Venere impedivano al<br />
dispositivo per le fasi lunari di accedere all'input dal sistema<br />
di ingranaggi del sole. Nel 2018 Higgon, uno degli studenti<br />
laureati del team UCL, ebbe un'idea, risolse ordinatamente<br />
questo problema tecnico e spiegò un misterioso blocco forato<br />
su uno dei raggi della ruota motrice principale. Questo<br />
blocco probabilmente serviva a trasmettere la rotazione del<br />
"sole medio" (al contrario della rotazione variabile del "sole<br />
vero") direttamente al dispositivo per le fasi lunari. Questa<br />
configurazione - un sistema di anelli - rifletteva pienamente<br />
la descrizione nell'iscrizione sul retro della copertina.<br />
Nel tentativo di decifrare la parte anteriore del dispositivo<br />
bisognava identificare i cicli planetari incorporati nel meccanismo,<br />
importanti per definire come i treni di ingranaggi<br />
calcolassero le posizioni planetarie, e ricerche precedenti<br />
presumevano che si sarebbero basati sulle relazioni del periodo<br />
planetario derivate dai Babilonesi, ma nel 2016 Jones<br />
fece un'altra scoperta che costrinse a scartare questa ipotesi.<br />
La TAC a raggi X dell'iscrizione in copertina mostrava la divisione<br />
in sezioni per ciascuno dei cinque pianeti. Nella sezione<br />
Venere, Jones trovò il numero 462 e nella sezione di Saturno<br />
40 40 ArcheomaticA N°1 N°1 marzo marzo <strong>2022</strong> <strong>2022</strong>
Tecnologie per i i Beni Culturali<br />
41<br />
trovò il numero 442. Nessuna ricerca precedente aveva suggerito<br />
che gli antichi astronomi li conoscessero, in effetti essi<br />
rappresentavano relazioni periodiche più accurate di quelle<br />
trovate dai Babilonesi (289 cicli sinodici in 462 anni per Venere<br />
e 427 cicli sinodici in 442 anni per Saturno).<br />
Jones non capì subito come gli antichi greci derivassero entrambi<br />
questi periodi, ma Dacanalis, un altro studente laureato<br />
dell ‘UCL assemblò una lista completa delle relazioni<br />
dei periodi planetari e dei loro errori stimati dall'astronomia<br />
babilonese. Il ritrovamento di un processo, sviluppato dal filosofo<br />
Parmenide di Elea (dal sesto al quinto secolo a.C.) e<br />
riportato da Platone (dal quinto al quarto secolo a.C), servì<br />
per combinare le relazioni di periodo conosciute per ottenere<br />
quelle migliori.<br />
Con certezza qualsiasi metodo utilizzato dai creatori di Antikythera<br />
avrebbe richiesto tre criteri portanti: accuratezza,<br />
fattorizzabilità ed economia, il metodo doveva essere accurato<br />
per corrispondere alle relazioni di periodo conosciute per<br />
Venere e Saturno, e doveva essere fattorizzabile in modo che<br />
i pianeti potessero essere calcolati con ingranaggi abbastanza<br />
piccoli da entrare nel meccanismo. Per rendere il sistema<br />
economico, diversi pianeti avrebbero potuto condividere gli<br />
ingranaggi se le loro relazioni di periodo avessero condiviso<br />
fattori primi, riducendo il numero di ingranaggi necessari e<br />
tale economia era una caratteristica chiave dei treni di ingranaggi<br />
sopravvissuti. Sulla base di questi criteri, il Team<br />
ha derivato i periodi 462 e 442 utilizzando l'idea di Parmenide<br />
e ha impiegato gli stessi parametri per scoprire i periodi<br />
mancanti per gli altri pianeti, dove le iscrizioni sono andate<br />
perdute o danneggiate. Grazie alle relazioni dei periodi per<br />
i pianeti, hanno compreso come inserire i treni di ingranaggi<br />
per i pianeti negli stretti spazi disponibili. Per Mercurio e Venere,<br />
il Team ha teorizzato meccanismi economici a cinque<br />
ingranaggi con dispositivi pin-and-slot, simili ai meccanismi<br />
di Wright e la prova a sostegno della ricostruzione è stata<br />
fornita da un frammento di quattro centimetri di diametro.<br />
All'interno di questo pezzo, la TAC a raggi X ha mostrato un<br />
disco attaccato a un ingranaggio da 63 denti, che girava in<br />
una piastra a forma di D e il numero 63 condivide i fattori primi<br />
3 e 7 con 462 (il periodo di Venere). Un treno di ingranaggi<br />
che utilizzava l'ingranaggio a 63 denti potrebbe essere stato<br />
progettato per corrispondere a cuscinetto su uno dei raggi<br />
della ruota motrice principale. Un design simile per Mercurio<br />
corrispondeva alle caratteristiche sul raggio opposto.<br />
Per gli altri pianeti conosciuti - Marte, Giove e Saturno - il<br />
Team ha concepito sistemi molto compatti per adattarsi allo<br />
spazio disponibile. Christián C. Carman dell'Università Nazionale<br />
di Quilmes in Argentina, lavorando in modo indipendente,<br />
dimostrò come il sottile sistema di ingranaggi indiretti<br />
per il movimento variabile della luna poteva essere adattata<br />
anche ai pianeti.<br />
L’UCL Antikythera Research ha dimostrato che questi sistemi<br />
di ingranaggi possono essere estesi per incorporare le<br />
nuove relazioni d'epoca per i pianeti, inoltre questo sistema<br />
avrebbe permesso ai costruttori di Antikythera di montare<br />
diversi ingranaggi sulla stessa piastra e progettarli in modo<br />
che corrispondessero precisamente alle relazioni di periodo.<br />
Gli economici treni di sette ingranaggi potevano intrecciarsi<br />
tra le piastre sui pilastri della ruota motrice principale, in<br />
modo che le loro uscite fossero conformi al consueto ordine<br />
cosmologico dei corpi celesti - Luna, Mercurio, Venere, Sole,<br />
Marte, Giove e Saturno - che determinava la disposizione del<br />
sistema di anelli. Le dimensioni degli spazi disponibili tra le<br />
piastre erano esattamente giuste per ospitare questi sistemi,<br />
con una certa capacità di riserva e alcune prove ancora inspiegabili.<br />
Lo studio ha aggiunto un meccanismo per il moto variabile<br />
del sole e un meccanismo epiciclico per calcolare i "nodi"<br />
della luna - punti in cui l'orbita della luna taglia il piano dell'<br />
eclittica - rendendo possibile un'eclissi e le eclissi avvengono<br />
solo quando il sole è vicino a uno di questi nodi durante la<br />
luna piena o nuova. Gli astronomi medievali e rinascimentali<br />
chiamavano "mano di drago" un puntatore a doppia punta per<br />
i nodi della luna, inoltre, l'ingranaggio epicicloidale di questa<br />
mano di drago spiegava esattamente anche un cuscinetto<br />
prominente su uno dei raggi che prima sembrava non avere<br />
alcuna funzione.<br />
Lo studio in questione ha ulteriormente arricchito la comprensione<br />
del noto meccanismo: il display frontale corrispondeva<br />
alla descrizione nel manuale d'uso sul retro della<br />
copertina, con il sole e i pianeti mostrati da perline su anelli<br />
concentrici, la fase, la posizione e l'età della luna (il numero<br />
di giorni dalla luna nuova), e la lancetta del drago gli anni<br />
delle eclissi con le stagioni.<br />
Con gli anelli concentrici per i pianeti, gli studiosi hanno dato<br />
un senso anche all'iscrizione della copertina anteriore, che<br />
riporta una lista formulaica degli eventi sinodici di ogni pianeta<br />
(come le sue congiunzioni con il sole e i suoi punti stazionari)<br />
e gli intervalli in giorni tra essi: sulla piastra posteriore,<br />
le iscrizioni delle eclissi sono indicizzate alle marcature<br />
sul quadrante del Saros; sulla piastra anteriore, le iscrizioni<br />
relative alle alzate e ai tramonti delle stelle sono indicizzate<br />
al quadrante dello Zodiaco.<br />
L’ intuizione del Team è stata quella di verificare che le iscrizioni<br />
sulla parte anteriore potessero riferirsi alle lettere di<br />
indice sugli anelli planetari: se il puntatore del sole è ad una<br />
di queste lettere, quindi la voce corrispondente dell'iscrizione<br />
descrive il numero di giorni mancanti al prossimo evento<br />
sinodico. Poiché il lato sinistro dell'iscrizione, dove ci si<br />
aspetta di trovare queste lettere indice, è carente, non vi è<br />
possibilità di provare l'ipotesi, ma la spiegazione e la descrizione<br />
che il gruppo di ricerca ha generato potrebbe essere<br />
convincente.<br />
Il dispositivo è unico tra le scoperte del suo tempo e riscrive<br />
da solo la nostra conoscenza della tecnologia utilizzata degli<br />
antichi greci. Il primo meccanismo con ingranaggi di precisione<br />
conosciuto è una meridiana e un calendario di origine<br />
bizantina relativamente semplici, ma impressionanti per il<br />
tempo, risalenti a circa il 600 d.C. Il meccanismo di Antikythera,<br />
con i suoi ingranaggi di precisione con denti lunghi<br />
circa un millimetro, è completamente diverso da qualsiasi<br />
altro strumento del mondo antico. Perché ci sono voluti secoli<br />
prima che gli scienziati reinventassero qualcosa di così<br />
sofisticato come il dispositivo di Antikythera, e perché gli archeologi<br />
non hanno scoperto altri meccanismi simili? Si hanno<br />
forti ragioni per credere che questo oggetto non possa essere<br />
stato l'unico modello del suo genere e con certezza ci siano<br />
stati precursori del suo sviluppo. Il bronzo era un metallo<br />
molto prezioso, e quando un congegno come questo smetteva<br />
di funzionare, probabilmente veniva fuso per i suoi materiali,<br />
cosicché solo un naufragio potrebbe essere in prospettiva<br />
un'evenienza di trovarne di altri. Molte sono le lacune nella<br />
documentazione storica e scoperte future potrebbero sorprendere<br />
altrettanto, ma la ricerca di Antikythera dell'UCL è<br />
sicuramente un progresso significativo a fronte di un'enorme<br />
perdita di prove.<br />
Fonte: Scientific American
EVENTI<br />
6 GIUGNO <strong>2022</strong><br />
Electronic Imaging and Visual<br />
Arts<br />
Firenze<br />
www.archeomatica.it/3hcx<br />
8- 10 GIUGNO<br />
Salone Internazionale dei<br />
Beni Culturali<br />
Ferrara<br />
www.archeomatica.it/3q6u<br />
18 – 21 LUGLIO <strong>2022</strong><br />
XV Conferenza ICHAJ – Storia<br />
e Archeologia della Giordania<br />
www.archeomatica.it/3hq9<br />
25-27 OTTOBRE <strong>2022</strong><br />
TECHNOLOGY FOR ALL<br />
ROMA<br />
www.technologyforall.it<br />
27 – 30 OTTOBRE<br />
BMTA <strong>2022</strong><br />
Paestum – Salerno<br />
www.archeomatica.it/3q8q<br />
10-12 NOVEMBRE <strong>2022</strong><br />
Vienna, Austria<br />
CHNT27 - Conference on<br />
Cultural Heritage and New<br />
Technologies<br />
https://chnt.at<br />
<strong>2022</strong><br />
Roma 25-27 ottobre<br />
LEICA BLK360<br />
CATTURA IL MONDO CHE CI CIRCONDA CON<br />
IMMAGINI PANORAMICHE A COLORI SOVRAPPOSTE<br />
AD ACCURATE NUVOLE DI PUNTI.<br />
◗ Lo scanner più piccolo e leggero della sua categoria:<br />
165 mm di altezza x 100 mm di diametro.<br />
◗ Nuvole di punti ad alta precisione: 360.000 punti/sec.<br />
con risoluzione personalizzabile.<br />
◗ Semplice da utilizzare: si attiva con la pressione di un solo tasto.<br />
◗ Registra le scansioni e visualizza i dati sul campo in pochi istanti.<br />
◗ Rilevazione di immagini termiche con sensore FLIR®,<br />
in contemporanea con la scansione delle immagini.<br />
◗ I dati di realtà acquisita si connettono con le soluzioni di<br />
progettazione Autodesk.<br />
◗ Tramite l'app mobile ReCap Pro, BLK360 trasferisce immagini e<br />
dati di nuvole di punti su un tablet iPad, filtrando e registrando<br />
i dati di scansione in tempo reale per poi effettuarne<br />
il trasferimento a diverse applicazioni CAD, BIM, VR e AR.<br />
per maggiori<br />
informazioni<br />
Contattaci, scoprirai molto di più!<br />
Via A. Romilli, 20/8 - 20139 Milano • Tel. 02 5398739<br />
E-mail: teorema@geomatica.it<br />
42 www.geomatica.it • www.disto.it • www.termocamere.com<br />
ArcheomaticA N°1 marzo <strong>2022</strong>
Tecnologie per i Beni Culturali 43