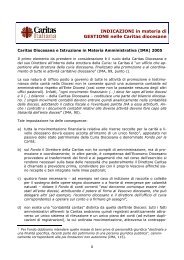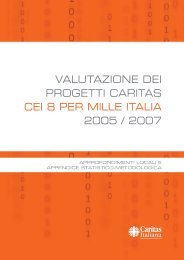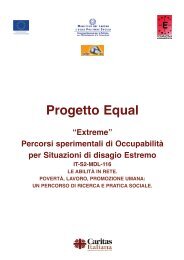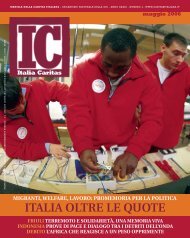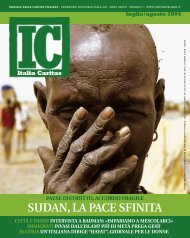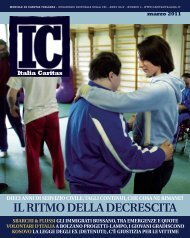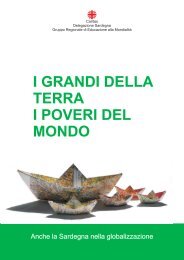Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
nazionale<br />
ruola quanti giustificano l’inerzia dolente e fatalista, attribuendola<br />
a fattori esterni.<br />
Arginare l’inclinazione alla lagna, stimolando e promuovendo<br />
iniziativa, creatività, scelte educative e culturali<br />
capaci di far emergere un pensiero aperto al Mediterraneo,<br />
all’Italia, all’Europa: è questa la leva strategica<br />
per poter parlare di sviluppo, non nelle intenzioni ma<br />
in azioni prive di ambiguità e di demagogia.<br />
Paninoteche, non librerie<br />
Gli ostacoli allo sviluppo sono insomma anzitutto culturali.<br />
Ma la Basilicata è culturalmente arretrata? Guardando<br />
alla fioritura delle idee e al fervore delle intelligenze,<br />
alle forme di espressione vitale costituite dalla<br />
cultura locale e dalla tradizione popolare e folcloristica,<br />
si può dire che la regione non è spenta. C’è vivacità, magari<br />
meno cultura civica, ma certo un vivo reticolo di solidarietà<br />
familiare e comunitaria, che deriva anche da<br />
20 ITALIA CARITAS | DICEMBRE 2007 / GENNAIO 2008<br />
viaggio al sud<br />
OLTRE LA GRANDE INDUSTRIA<br />
Interno degli stabilimenti Fiat a Melfi (Potenza).<br />
I grandi progetti industriali sono importanti,<br />
ma non bastano a garantire lo sviluppo della Basilicata,<br />
come delle altre regioni meridionali<br />
valori e radici cristiane. Si può dire che esista un familismo<br />
virtuoso, che consente di ammortizzare disoccupazione,<br />
miseria e squilibri sociali dove esistono. Permane<br />
inoltre una memoria condivisa, fatta di linguaggi,<br />
retaggi e paesaggi comuni.<br />
Se per cultura invece si intende l’elaborazione intellettuale<br />
dei dotti e l’azione di una classe dirigente, allora<br />
si notano le arretratezze. Invece di teatri, librerie, circoli<br />
culturali e sociali, quasi ovunque sono nate negli ultimi<br />
anni banche, gioiellerie, paninoteche. A riprova del fatto<br />
che i soldi (in Basilicata nelle banche sono depositate ingenti<br />
somme di denaro) dove ci sono non portano automaticamente<br />
cultura. Inoltre nel mezzogiorno d’Italia, e<br />
soprattutto in Basilicata, non esistono media (tv e giornali)<br />
di dimensione nazionale che parlino all’Italia; la Basilicata<br />
non è vista, non è letta. Come l’intero mezzogiorno<br />
d’Italia, è sottorappresentata; il baricentro della politica,<br />
dell’economia e dei media è spostato nel settentrione<br />
d’Italia, cuore d’Europa.<br />
Con altre parole, si può dire che in Basilicata si è seccato<br />
l’albero delle élite, la pianta che produce classe dirigente.<br />
In passato erano i notabili, il clero, gli agrari; poi è<br />
arrivata la borghesia statale, decorosa e rispettabile: la<br />
maestra, il maresciallo, il segretario comunale, l’impiegato<br />
alle poste o alle ferrovie. Oggi, declinate le precedenti classi<br />
dirigenti e tramontato il ceto cresciuto all’ombra dei<br />
partiti, chi emerge lo fa per proprio conto, indipendentemente<br />
e individualmente. Il tessuto delle relazioni sociali<br />
è sfilacciato, quello civico è debole, e all’orizzonte non si<br />
vede una classe dirigente in formazione, impiantata in un<br />
terreno culturale originale e meridionale.<br />
Parlare di sviluppo, in Basilicata oggi, significa dunque<br />
promuovere e favorire le connessioni (che mancano)<br />
tra soggetti (della cultura, della società, dell’imprenditoria)<br />
attivi e creativi; ovvero favorire e promuovere<br />
connessioni per dare vita a reti fatte non di rapporti subalterni,<br />
ma virtuosi. Fatte anche da una buona politica,<br />
oltre che da una libera mediazione culturale, da una sana<br />
e competente imprenditoria.<br />
In Basilicata, come nel resto del mezzogiorno, chi riuscirà<br />
a riconnettere questi rapporti virtuosi potrà guidare<br />
processi di sviluppo locale autentici, duraturi e rispettosi<br />
delle persone e delle comunità locali. Non c’è altra strada,<br />
per voltare la pagina della sudditanza e del lamento.<br />
nazionale<br />
Introduzione leggera. Leggerlo in francese fa un certo effetto.<br />
“Usure, racket, fraude: la mafia, première entreprise d'Italie”. Ma<br />
suscita un amaro compiacimento. Dopotutto è sempre esportazione<br />
d’immagine. Che parlino di noi, anche male, purché ne parlino.<br />
Non è la prima regola della comunicazione pubblicitaria?<br />
La recente inchiesta della Confesercenti, che segnala il volume<br />
degli affari mafiosi, è stata ampiamente divulgata in Italia. Ma pure<br />
all’estero, per esempio dal compassato Le Figaro, pronto a evidenziare<br />
che les italiens dopotutto non devono essere così pigri e fannulloni,<br />
se mettono in campo un volume annuo di più di 90 miliardi<br />
di euro di profitti, pari al 7% del Pil<br />
peninsulare (senza contare i proventi<br />
dei traffici di armi e droga), in un quadro<br />
di economia diffusa che coinvolge,<br />
secondo l’indagine, 160 mila commercianti,<br />
puntuali pagatori del pizzo,<br />
import mafieux corrisposto a Mafia<br />
Spa, impresa agile e capillare.<br />
Dopo l’introduzione leggera, intermezzo<br />
archeologico (in inglese).<br />
Quando si discute dei mali d’Italia,<br />
consulto un’altra inchiesta, L’Italia<br />
di oggi, datata 1904 e curata dai<br />
giornalisti inglesi Bolton King e<br />
Thomas Okey. Cosa si pensava un secolo fa del crimine<br />
organizzato in Italia? L’impressione è quella di un benevolo<br />
ottimismo. Intanto si parlava solo di camorra napoletana<br />
e mafia siciliana, senza citare la ‘ndrangheta<br />
calabrese. Inoltre ci si sbilanciava alquanto nel descrivere<br />
in negativo la camorra e nel concedere alla mafia<br />
(da intendersi persino come “forma degenerata di cavalleria”,<br />
“aristocrazia criminale”) addirittura un velato<br />
apprezzamento dei metodi praticati.<br />
Un punto di sovrapposizione tra camorra e mafia veniva<br />
comunque rintracciato nella comune propensione<br />
a usare la politica per proteggere traffici e affari illeciti. A<br />
Napoli e dintorni “il governo dà il suo tacito appoggio a<br />
un sistema che a sua volta gli assicura la maggioranza<br />
contrappunto<br />
MAFIA, IMPRESA ANTICA<br />
IL PIZZO È UN MALE INCURABILE?<br />
di Domenico Rosati<br />
Un sistema economico<br />
grandioso, una vicenda<br />
di intrecci perversi<br />
con la politica.<br />
Le notizie di oggi<br />
non si discostano dalle<br />
analisi di un secolo fa.<br />
Ma ci sono segni<br />
di evoluzione<br />
della cultura. Che<br />
alimentano la speranza<br />
dei collegi elettorali”. Pure in Sicilia<br />
“non è possibile a un candidato vincere<br />
un’elezione politica o amministrativa<br />
se (la mafia) non assicura la<br />
sua protezione”; vi sono “patroni”<br />
della mafia in parlamento e “il governo<br />
ha le sue bene intese relazioni<br />
coi grandi elettori mafiosi”.<br />
Rafforzamento delle strutture<br />
Vicenda immutabile? Priva di segni di<br />
speranza? Se il presente rivela non un<br />
indebolimento, ma un rafforzamento<br />
delle strutture mafiose e camorriste (e<br />
ciò rinvia anche alla connivenza<br />
esplicita o tacita con il potere di turno),<br />
vi sono tuttavia recenti episodi e<br />
testimonianze che, prima delle leggi e<br />
dopo le leggi, lasciano immaginare<br />
una possibile evoluzione, della cultura<br />
prima che delle abitudini. Il primo<br />
episodio è il gesto del vescovo (uscente)<br />
di Locri, Giancarlo Bregantini, che<br />
va a Duisburg a chiedere perdono per<br />
una sanguinaria vendetta di ‘ndrangheta<br />
e nel contempo invita al perdono<br />
reciproco, chiedendolo in primo luogo alle donne calabresi,<br />
delle quali, lui trentino, ha compreso il ruolo di custodi<br />
delle regole d’onore che includono la morte per chi<br />
abbia fatto sgarbo alla famiglia. Il secondo è l’annuncio degli<br />
industriali di Agrigento, che intendono espellere dall’associazione<br />
gli imprenditori che pagano il pizzo.<br />
Poca cosa, anche considerando i recenti arresti eccellenti<br />
in Sicilia, a fronte del “sistema economico” descritto<br />
e delle sue capacità di riproduzione in un contesto<br />
di disoccupazione e di precariato sovrabbondante; e<br />
anche di fronte al triste teatro dei conflitti tra figure istituzionali<br />
pagate per stroncare la criminalità organizzata.<br />
Ma i segni restano e, spesso, sostengono la pazienza,<br />
contrastano l’indifferenza e alimentano la speranza.<br />
ITALIA CARITAS | DICEMBRE 2007 / GENNAIO 2008 21