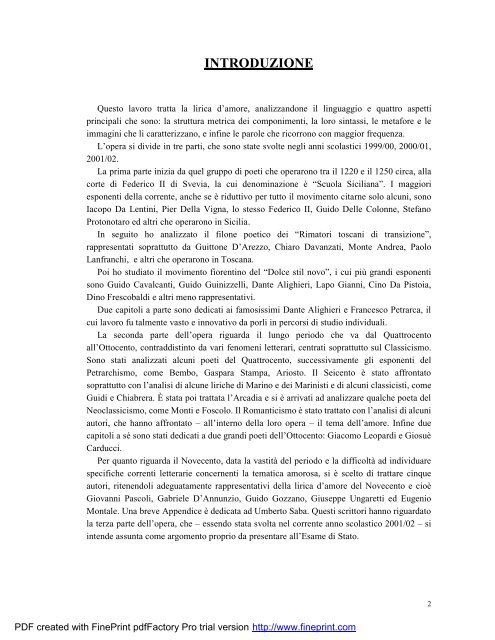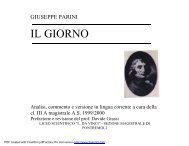IL LINGUAGGIO DELLA LIRICA D'AMORE - Liberta' Educazione ...
IL LINGUAGGIO DELLA LIRICA D'AMORE - Liberta' Educazione ...
IL LINGUAGGIO DELLA LIRICA D'AMORE - Liberta' Educazione ...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
INTRODUZIONE<br />
Questo lavoro tratta la lirica d’amore, analizzandone il linguaggio e quattro aspetti<br />
principali che sono: la struttura metrica dei componimenti, la loro sintassi, le metafore e le<br />
immagini che li caratterizzano, e infine le parole che ricorrono con maggior frequenza.<br />
L’opera si divide in tre parti, che sono state svolte negli anni scolastici 1999/00, 2000/01,<br />
2001/02.<br />
La prima parte inizia da quel gruppo di poeti che operarono tra il 1220 e il 1250 circa, alla<br />
corte di Federico II di Svevia, la cui denominazione è “Scuola Siciliana”. I maggiori<br />
esponenti della corrente, anche se è riduttivo per tutto il movimento citarne solo alcuni, sono<br />
Iacopo Da Lentini, Pier Della Vigna, lo stesso Federico II, Guido Delle Colonne, Stefano<br />
Protonotaro ed altri che operarono in Sicilia.<br />
In seguito ho analizzato il filone poetico dei “Rimatori toscani di transizione”,<br />
rappresentati soprattutto da Guittone D’Arezzo, Chiaro Davanzati, Monte Andrea, Paolo<br />
Lanfranchi, e altri che operarono in Toscana.<br />
Poi ho studiato il movimento fiorentino del “Dolce stil novo”, i cui più grandi esponenti<br />
sono Guido Cavalcanti, Guido Guinizzelli, Dante Alighieri, Lapo Gianni, Cino Da Pistoia,<br />
Dino Frescobaldi e altri meno rappresentativi.<br />
Due capitoli a parte sono dedicati ai famosissimi Dante Alighieri e Francesco Petrarca, il<br />
cui lavoro fu talmente vasto e innovativo da porli in percorsi di studio individuali.<br />
La seconda parte dell’opera riguarda il lungo periodo che va dal Quattrocento<br />
all’Ottocento, contraddistinto da vari fenomeni letterari, centrati soprattutto sul Classicismo.<br />
Sono stati analizzati alcuni poeti del Quattrocento, successivamente gli esponenti del<br />
Petrarchismo, come Bembo, Gaspara Stampa, Ariosto. Il Seicento è stato affrontato<br />
soprattutto con l’analisi di alcune liriche di Marino e dei Marinisti e di alcuni classicisti, come<br />
Guidi e Chiabrera. È stata poi trattata l’Arcadia e si è arrivati ad analizzare qualche poeta del<br />
Neoclassicismo, come Monti e Foscolo. Il Romanticismo è stato trattato con l’analisi di alcuni<br />
autori, che hanno affrontato – all’interno della loro opera – il tema dell’amore. Infine due<br />
capitoli a sé sono stati dedicati a due grandi poeti dell’Ottocento: Giacomo Leopardi e Giosuè<br />
Carducci.<br />
Per quanto riguarda il Novecento, data la vastità del periodo e la difficoltà ad individuare<br />
specifiche correnti letterarie concernenti la tematica amorosa, si è scelto di trattare cinque<br />
autori, ritenendoli adeguatamente rappresentativi della lirica d’amore del Novecento e cioè<br />
Giovanni Pascoli, Gabriele D’Annunzio, Guido Gozzano, Giuseppe Ungaretti ed Eugenio<br />
Montale. Una breve Appendice è dedicata ad Umberto Saba. Questi scrittori hanno riguardato<br />
la terza parte dell’opera, che – essendo stata svolta nel corrente anno scolastico 2001/02 – si<br />
intende assunta come argomento proprio da presentare all’Esame di Stato.<br />
PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com<br />
2