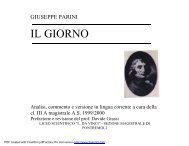IL LINGUAGGIO DELLA LIRICA D'AMORE - Liberta' Educazione ...
IL LINGUAGGIO DELLA LIRICA D'AMORE - Liberta' Educazione ...
IL LINGUAGGIO DELLA LIRICA D'AMORE - Liberta' Educazione ...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Il primo componimento è una ballata, o “canzone a ballo”, di endecasillabi, con rime<br />
ABABBX per la strofa, XX per la ripresa. L’ultima parola del componimento, giardino,<br />
coincide con l’ultima della ripresa.<br />
Vi sono pochi enjambements ( vv.1-3-6-7-13-14-17-30 ); da notare alcuni versi spezzati (<br />
vv.1-4-5-9-11-16-17-21-23-25-28-30 ).Oltre che da questi elementi, il ritmo è determinato<br />
anche dalla serie anaforica quando … quando … quando ai versi 24 e 25.<br />
Il secondo componimento è, anch’esso, una ballata ( destinata ad essere cantata con<br />
accompagnamento musicale ) di tutti settenari, con otto strofe di schema ababbx ( x sempre in<br />
maggio ), ripresa xx formata da un quinario e da un settenario.<br />
Sono presenti alcuni enjambements ( vv.1-3-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-33-36-37-<br />
39-47-49 ), ma in misura minore rispetto ai versi spezzati. Possiamo affermare che il ritmo di<br />
entrambe le poesie è piuttosto lento.<br />
6.2 TIPO DI <strong>LINGUAGGIO</strong> E DI SINTASSI<br />
Per comprendere che tipo di linguaggio usano i due poeti prenderemo spunto dall’ Epistola<br />
proemiale che fa capo a tutta una raccolta di testi poetici toscani che Lorenzo il Magnifico<br />
inviò a Federico di Aragona nel 1477. L’Epistola proemiale e probabilmente la stessa scelta<br />
dei testi della raccolta, si devono al Poliziano, che parla però in nome di Lorenzo.<br />
Questo testo è di grande importanza nell’ambito di quel processo di rivalutazione del<br />
volgare che caratterizza tutto il Quattrocento. Lorenzo Il Magnifico e Poliziano, assieme a<br />
tanti altri poeti loro contemporanei, operarono concretamente quella controtendenza che<br />
mirava a riconoscere dignità al volgare, a restituirgli campi d’uso non subalterni, a sostituirlo<br />
al Latino come lingua di cultura. Si possono apprezzare, grazie a loro, opere di qualità in<br />
volgare, sia in ambito poetico che prosastico. La ripresa del volgare, soprattutto, ma non solo,<br />
in ambito letterario, è guidata lungo le linee che avevano ispirato l’elaborazione linguistica e<br />
stilistica del Petrarca, anche se non con gli stessi risultati: il volgare degli umanisti cerca<br />
ispirazione nei classici latini, sia pur indirettamente, e cerca di competere con il Latino<br />
umanistico in dignità, eleganza e raffinatezza. Ecco perché vi è una forte frequenza di<br />
latinismi in ambito lessicale.<br />
Ritornando all’Epistola, Poliziano pone in rilievo i sommi Dante e Petrarca, ma anche tutti<br />
gli altri poeti che fanno parte dell’intera tradizione poetica.<br />
Possiamo asserire, quindi, che il linguaggio adoperato dagli umanisti, come Lorenzo il<br />
Magnifico e Poliziano, è assolutamente aderente a quello volgare della produzione del<br />
Petrarca.<br />
6.3 METAFORE ED IMMAGINI USATE<br />
Prendiamo in esame I’ mi trovai, fanciulle, un bel mattino. In questa lirica, che è fra le più<br />
belle e celebri del Poliziano e dell’intero Quattrocento, un giardino lussureggiante in<br />
primavera è metafora della giovinezza; il far ghirlande, il coglier la rosa mentre è più fiorita,<br />
significano goder la giovinezza; la sfioritura ( prima che sua bellezza sia fuggita v.27 ) evoca<br />
PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com<br />
36