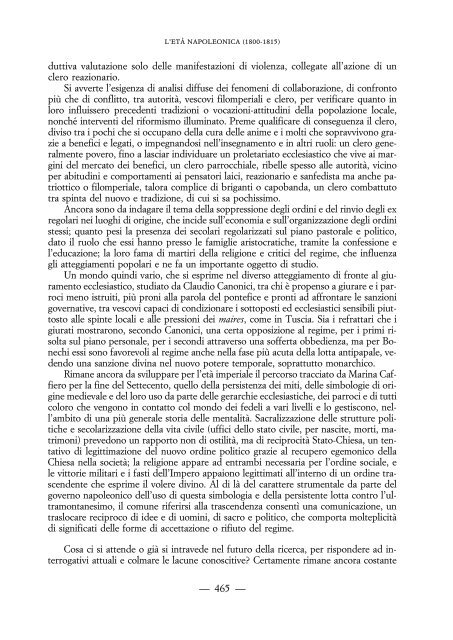R. De Lorenzo, L'età napoleonica (1800-1815) - Decennio ...
R. De Lorenzo, L'età napoleonica (1800-1815) - Decennio ...
R. De Lorenzo, L'età napoleonica (1800-1815) - Decennio ...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
L'ETA Á NAPOLEONICA (<strong>1800</strong>-<strong>1815</strong>)<br />
duttiva valutazione solo delle manifestazioni di violenza, collegate all'azione di un<br />
clero reazionario.<br />
Si avverte l'esigenza di analisi diffuse dei fenomeni di collaborazione, di confronto<br />
piuÁ che di conflitto, tra autoritaÁ, vescovi filomperiali e clero, per verificare quanto in<br />
loro influissero precedenti tradizioni o vocazioni-attitudini della popolazione locale,<br />
nonche interventi del riformismo illuminato. Preme qualificare di conseguenza il clero,<br />
diviso tra i pochi che si occupano della cura delle anime e i molti che sopravvivono grazie<br />
a benefici e legati, o impegnandosi nell'insegnamento e in altri ruoli: un clero generalmente<br />
povero, fino a lasciar individuare un proletariato ecclesiastico che vive ai margini<br />
del mercato dei benefici, un clero parrocchiale, ribelle spesso alle autoritaÁ, vicino<br />
per abitudini e comportamenti ai pensatori laici, reazionario e sanfedista ma anche patriottico<br />
o filomperiale, talora complice di briganti o capobanda, un clero combattuto<br />
tra spinta del nuovo e tradizione, di cui si sa pochissimo.<br />
Ancora sono da indagare il tema della soppressione degli ordini e del rinvio degli ex<br />
regolari nei luoghi di origine, che incide sull'economia e sull'organizzazione degli ordini<br />
stessi; quanto pesi la presenza dei secolari regolarizzati sul piano pastorale e politico,<br />
dato il ruolo che essi hanno presso le famiglie aristocratiche, tramite la confessione e<br />
l'educazione; la loro fama di martiri della religione e critici del regime, che influenza<br />
gli atteggiamenti popolari e ne fa un importante oggetto di studio.<br />
Un mondo quindi vario, che si esprime nel diverso atteggiamento di fronte al giuramento<br />
ecclesiastico, studiato da Claudio Canonici, tra chi eÁ propenso a giurare e i parroci<br />
meno istruiti, piuÁ proni alla parola del pontefice e pronti ad affrontare le sanzioni<br />
governative, tra vescovi capaci di condizionare i sottoposti ed ecclesiastici sensibili piuttosto<br />
alle spinte locali e alle pressioni dei maires, come in Tuscia. Sia i refrattari che i<br />
giurati mostrarono, secondo Canonici, una certa opposizione al regime, per i primi risolta<br />
sul piano personale, per i secondi attraverso una sofferta obbedienza, ma per Bonechi<br />
essi sono favorevoli al regime anche nella fase piuÁ acuta della lotta antipapale, vedendo<br />
una sanzione divina nel nuovo potere temporale, soprattutto monarchico.<br />
Rimane ancora da sviluppare per l'etaÁ imperiale il percorso tracciato da Marina Caffiero<br />
per la fine del Settecento, quello della persistenza dei miti, delle simbologie di origine<br />
medievale e del loro uso da parte delle gerarchie ecclesiastiche, dei parroci e di tutti<br />
coloro che vengono in contatto col mondo dei fedeli a vari livelli e lo gestiscono, nell'ambito<br />
di una piuÁ generale storia delle mentalitaÁ. Sacralizzazione delle strutture politiche<br />
e secolarizzazione della vita civile (uffici dello stato civile, per nascite, morti, matrimoni)<br />
prevedono un rapporto non di ostilitaÁ, ma di reciprocitaÁ Stato-Chiesa, un tentativo<br />
di legittimazione del nuovo ordine politico grazie al recupero egemonico della<br />
Chiesa nella societaÁ; la religione appare ad entrambi necessaria per l'ordine sociale, e<br />
le vittorie militari e i fasti dell'Impero appaiono legittimati all'interno di un ordine trascendente<br />
che esprime il volere divino. Al di laÁ del carattere strumentale da parte del<br />
governo napoleonico dell'uso di questa simbologia e della persistente lotta contro l'ultramontanesimo,<br />
il comune riferirsi alla trascendenza consentõÁ una comunicazione, un<br />
traslocare reciproco di idee e di uomini, di sacro e politico, che comporta molteplicitaÁ<br />
di significati delle forme di accettazione o rifiuto del regime.<br />
Cosa ci si attende o giaÁ si intravede nel futuro della ricerca, per rispondere ad interrogativi<br />
attuali e colmare le lacune conoscitive? Certamente rimane ancora costante<br />
Ð 465 Ð