01 Prel_trt:_v - Teatro del Giglio di Lucca
01 Prel_trt:_v - Teatro del Giglio di Lucca
01 Prel_trt:_v - Teatro del Giglio di Lucca
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
<strong>del</strong> Trittico. Un comporre per colori uniformi, nei quale in<strong>di</strong>vidui e cose si fondono,<br />
vi agisce infatti a tutti i livelli. È implicito nella scelta <strong>del</strong>le voci <strong>del</strong>la quin<strong>di</strong>cina<br />
<strong>di</strong> personaggi femminili, variate soltanto dalle gradazioni tra tessiture <strong>di</strong> soprano<br />
(Suor Angelica e le sue consorelle più giovani), mezzosoprano (per le suore<br />
<strong>di</strong> rango più elevato, la Badessa, la Zelatrice e la Maestra <strong>del</strong>le novizie) e contralto<br />
(la Zia Principessa). È frutto <strong>di</strong> una scelta intenzionale nel <strong>di</strong>panarsi <strong>del</strong>la partitura<br />
orchestrale su un fondo monocromo, tenuamente sfumato negli impasti dei<br />
legni, nelle liquescenze <strong>del</strong>l’arpa, nell’uso soffuso <strong>del</strong>le percussioni, entro una<br />
gamma <strong>di</strong> <strong>di</strong>namiche che per ampi tratti oscilla tra il pianissimo e il piano. Insomma,<br />
Suor Angelica è innanzi tutto l’espressione <strong>di</strong> un sentimento <strong>del</strong>icato, <strong>del</strong>la<br />
poesia <strong>del</strong>le piccole cose, che si connota nel profilo carezzevole e nei toni modali<br />
<strong>del</strong>l’intonazione vocale, nei proce<strong>di</strong>menti polifonici a mo’ <strong>di</strong> organum, negli<br />
ostinati che reiterano giri armonici semplificati, tipici <strong>di</strong> un Me<strong>di</strong>oevo d’in -<br />
venzione tanto in voga su scala europea nel secondo decennio <strong>del</strong> Novecento e applicato<br />
nel lavoro pucciniano malgrado l’esplicita ambientazione tardo seicentesca<br />
<strong>del</strong> soggetto.<br />
Forzano fu tra i primi a cogliere questo tratto <strong>del</strong>l’opera, allorché ne lodò gli<br />
«accenti così semplici, così nobili, così chiaramente… francescani» e così facendo<br />
– forse senza rendersene pienamente conto – la collocò nell’alveo dannunziano <strong>del</strong><br />
misticismo <strong>di</strong> maniera, decadente e sensuale, che in Italia all’epoca si qualificava<br />
appunto come ‘francescano’. L’episo<strong>di</strong>o d’esor<strong>di</strong>o con l’immancabile voce <strong>del</strong>le<br />
campane che fissa il profilo <strong>del</strong> primo ostinato (un modulo <strong>di</strong> quattro battute poi<br />
ripetuto per otto volte), il suono immateriale degli archi con l’aggiunta <strong>del</strong>l’arpa,<br />
il canto in latino <strong>del</strong>l’Ave Maria <strong>del</strong> coro femminile <strong>di</strong>etro la scena, l’aggiunta <strong>del</strong><br />
suono <strong>del</strong>l’organo leggermente in rilievo e il tocco naturalistico <strong>del</strong>l’imitazione <strong>del</strong><br />
canto degli uccelli («cinguettio che scende dai cipressi» con effluvio festoso e tenero)<br />
ne sono un compen<strong>di</strong>o quasi da manuale. In tale contesto, l’inserimento <strong>di</strong><br />
melo<strong>di</strong>e da chiesa (come la tipica intonazione <strong>del</strong>le litanie mariane), gli inni sacri,<br />
perfino certi spunti sonori <strong>di</strong> vita monastica, come lo scampanio che annuncia la<br />
visita <strong>del</strong>la Zia Principessa o il battito <strong>del</strong>le tavolette lignee che prescrive alle monache<br />
il grande silenzio notturno, <strong>di</strong>versamente dai suoni dal vero <strong>del</strong> Tabarro,<br />
non si percepiscono come citazioni, bensì come suoni d’atmosfera, che si <strong>di</strong>luiscono<br />
nei colori <strong>del</strong>la pittura d’ambiente (va detto che al fine <strong>di</strong> assimilare la giusta<br />
atmosfera, nella fase <strong>di</strong> gestazione <strong>del</strong>l’opera Puccini ebbe accesso straor<strong>di</strong>nario<br />
al convento <strong>di</strong> Vicopelago, dove viveva sua sorella Iginia, monaca agostiniana).<br />
In Suor Angelica, però, si rappresenta soprattutto il dramma potente <strong>di</strong> una<br />
maternità forzosamente occultata al mondo, privata <strong>del</strong>l’oggetto <strong>del</strong>le proprie speranze<br />
e indotta nel suici<strong>di</strong>o ad un gesto estremo <strong>di</strong> ricongiunzione col figlio mor-<br />
15


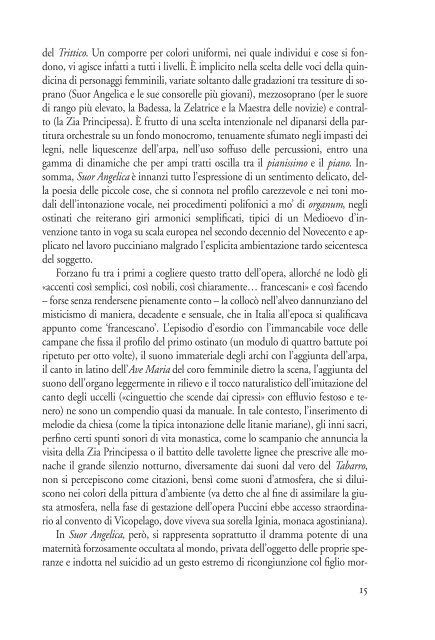


![La Bohème [file PDF 3,43 MB] - Teatro del Giglio di Lucca](https://img.yumpu.com/15811280/1/177x260/la-boheme-file-pdf-343-mb-teatro-del-giglio-di-lucca.jpg?quality=85)