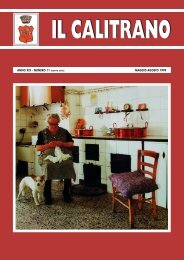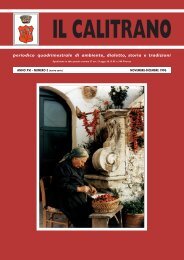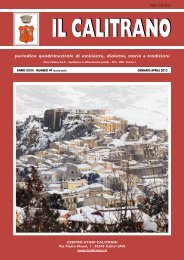You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
N. <strong>21</strong> n.s. – Settembre-Dicembre 2002 <strong>IL</strong> <strong>CALITRANO</strong><br />
come Donato Insengola, abitante “alla<br />
strata del Annunciata iuxta bona aliorum<br />
de Insengola” (cioè nelle case della sua<br />
famiglia, al centro di Calitri, nella parte<br />
migliore dell’abitato), che nel suo testamento<br />
chiedeva di essere sepolto “nella<br />
sepoltura di casa Insengola 7”. Giovanni<br />
Antonio Di Napoli, abitante sopra la chiesa<br />
di San Canio, aveva la tomba “di casa<br />
sua” nella chiesa di San Sebastiano. Dai<br />
testamenti si vede che nella chiesa del<br />
convento esistevano anche le sepolture<br />
utilizzate da alcune confraternite 8.<br />
Non sempre le offerte erano in denaro:<br />
nel 1608 Camilla Scoca, abitante alla<br />
“strata de la posterla”, destinava “vinti<br />
mezzetti di grano” ai frati e “dece mezzetti<br />
di grano 9” alle monache dell’Annunziata<br />
perché pregassero per l’anima sua.<br />
La maggior parte dei calitrani preferiva<br />
tuttavia farsi seppellire nella chiesa madre,<br />
intitolata all’Assunta e a San Canio.<br />
Sul sagrato della chiesa esisteva il cimitero<br />
per le sepolture comuni, tenuta in cattive<br />
condizioni, mentre l’interno ospitava<br />
cappelle private e sepolture confraternali<br />
10. Oltre alle spese per la sepoltura, i cittadini<br />
di solito lasciavano “alli preiti del<br />
ecclesia di Santo Canio maggiore di Calitro<br />
tutto quello loro tocca di messe, processione<br />
et altro secondo il solito”.<br />
Le cappelle private appartenevano alle<br />
famiglie più importanti del paese. La<br />
cappella dei Gesualdo, principi di Venosa,<br />
conti di Conza e feudatari di Calitri,<br />
intitolata ai Santi Filippo e Giacomo, era<br />
la seconda sul lato sinistro della navata;<br />
ma i principi mantenevano il patronato<br />
anche sulla chiesa di Santa Maria alla<br />
Ripa, vicinissima al castello, e sul convento<br />
di San Sebastiano dove, come ricorda<br />
Vito Acocella, era sepolta una nobildonna<br />
di casa Gesualdo 11; comunque<br />
la principale sepoltura dei Gesualdo era<br />
la cappella di Santa Maria delle Grazie,<br />
nella cattedrale di Conza, decorata di finissimi<br />
marmi e sculture, con l’altare privilegiato<br />
sul quale era collocato il quadro<br />
della Madonna delle Grazie commissionato<br />
dal cardinale Alfonso Gesualdo 12.<br />
In un testamento del 1611 Lucrezia<br />
Germano eleggeva a sua sepoltura nella<br />
chiesa madre la tomba “delli Balasci”<br />
(cioè della famiglia Balascio), lasciando<br />
un’offerta di 5 carlini alla chiesa della<br />
Madonna della Foresta e donando alla<br />
chiesa di San Canio “la tovaglia sua di<br />
seta negra che si metta alla croce 13”.<br />
Nel 1609 “Todescha Fruscio”, vedova<br />
del “quondam Donato de Anglesio” e<br />
appartenente a una famiglia molto ricca<br />
(sia i fratelli sia il suocero erano notai),<br />
disponeva nel suo testamento che “lo<br />
corpo suo sia sepellito dentro l’ecclesia<br />
di Santo Canio magiore di Calitro alla<br />
sepoltura della cappella de la casa di notare<br />
Giovanni Anglese suo socero 14”. All’atto<br />
notarile è allegato anche un “inventario<br />
delle robbe lasciate da Todescha<br />
Fruscio (…) fatto ad istantia de Cesare e<br />
Bartolomeo Fruscio”; evidentemente per<br />
i due ricchi fratelli Frucci (nel 1623 il<br />
notaio Bartolomeo Frucci fu sindaco di<br />
Calitri) nei patti matrimoniali della sorella<br />
defunta c’era ancora qualcosa da<br />
discutere 15.<br />
Germania, Freiburg i coniugi M. Antonia<br />
Rubino e Salvatore Zabatta ( Tor’Torr’ haland’)<br />
il 26 di ottobre hanno festeggiato il<br />
loro 50° anniversario di matrimonio. Gli<br />
auguri più sentiti e sinceri dal figlio Giovanni<br />
con la moglie e il nipote, degli amici e<br />
della Redazione del giornale.<br />
Mentre i più abbienti potevano programmare<br />
con cura il proprio funerale,<br />
stabilire dove essere sepolti e lasciare offerte<br />
per la celebrazione di messe in memoria,<br />
per i cittadini poveri la scelta era<br />
limitata; nel 1607 Domenico Cennarulo,<br />
che abitava a casa del cugino Luciano<br />
“ubi dicitur la strata di santo Petro seu lo<br />
puzzo”, sceglieva la chiesa madre, dichiarando<br />
di contentarsi di “quella sepoltura<br />
che piacerà a detto Luciano suo herede<br />
16”, mentre nello stesso anno “Giovanni<br />
de Angelo Torciano”, abitante “alla<br />
strata di piedi”, chiedeva di essere sepolto<br />
“alla sepoltura dello comune con tanta<br />
cura quanta piacerà ad Angelella sua moglie,<br />
che per essere povero detto testatore<br />
si remette a detta Angelella 17”.<br />
Nella chiesa di San Canio fu sepolto<br />
nel 1672 l’arcivescovo di Conza, Jacopo<br />
Lente (o Lenzio), morto mentre si trovava<br />
ospite dei principi Ludovisi nel castello<br />
di Calitri 18.<br />
7<br />
* * *<br />
L’uso di seppellire i defunti nelle<br />
chiese cominciò a essere abbandonato<br />
all’inizio del XIX secolo e durante il decennio<br />
francese (1806-1815) anche nel<br />
Regno di Napoli fu decretato che i cimiteri<br />
fossero costruiti lontano dall’abitato.<br />
Così, nei primi decenni dell’Ottocento,<br />
l’amministrazione comunale di Calitri<br />
deliberò la costruzione di un cimitero extraurbano<br />
e, dopo molte discussioni, individuò<br />
una zona a ovest del paese, a circa<br />
un chilometro di distanza dall’abitato.<br />
Nei tempi antichi questa località era<br />
chiamata Cicondella e, per la sua felice<br />
esposizione a sud, era ricca di vigneti e<br />
oliveti, come è ricordato anche in un’epigrafe<br />
che venne collocata nella cappella<br />
della congregazione del Purgatorio, all’interno<br />
del nuovo cimitero 19. L’epigrafe<br />
indica come data di apertura del cimitero<br />
l’anno 1850 e, secondo alcuni documenti<br />
qui riportati, nell’agosto del 1842 i lavori<br />
erano già incominciati.<br />
I terreni prescelti per la costruzione<br />
del cimitero, estesi per circa un ettaro<br />
(quasi tre moggia), appartenevano a<br />
Giuseppe Margotta (1 moggio e tre misure)<br />
e a Giambattista Cubelli (1 moggio<br />
e una misura), ai quali, come risarcimento<br />
dei suoli espropriati, fu offerto<br />
“un luogo nel Pascone dell’abitato, proprietà<br />
del Comune, vicino al cimitero<br />
dei colerosi 20”.<br />
I due proprietari, molto contrariati,<br />
ricorsero all’Intendenza di Avellino e al<br />
Ministero degli Interni contro la decisione<br />
dell’amministrazione, adducendo le<br />
ragioni più disparate e contraddittorie per<br />
dimostrare che il luogo indicato per il<br />
nuovo camposanto non era adatto; tra i<br />
motivi elencati c’erano “la natura cretacea<br />
del terreno, soggett’a crepolarsi nella<br />
stagione estiva, ed a scavarsi nello inverno”,<br />
“la lunga distanza dall’abitato” e il<br />
“sito accanto a una delle principale strade<br />
pubbliche, del continuo trafficata dalla<br />
popolazione <strong>21</strong>”.<br />
Giuseppe Margotta in particolare sosteneva<br />
che il suolo di sua proprietà non<br />
poteva essere utilizzato “per essere alla<br />
frana soggetto, perché rasente la strada<br />
pubblica che mena a una fontana, e perché<br />
posto in luogo assai vicino al paese<br />
22”; la decisione del sindaco, secondo<br />
Margotta, serviva solo a favorire alcuni<br />
cittadini, amici o parenti, proprietari di<br />
altri suoli che rischiavano l’esproprio. La<br />
vertenza durò alcuni anni ma, dopo una<br />
lunga serie di perizie, opposizioni e ricorsi,<br />
i funzionari del Ministero dell’Interno<br />
diedero torto ai proprietari dei suoli<br />
espropriati e Calitri ebbe il nuovo cimitero.