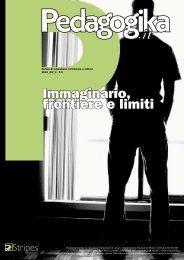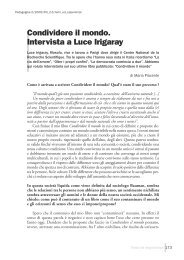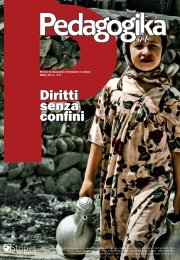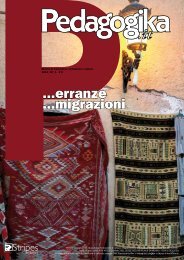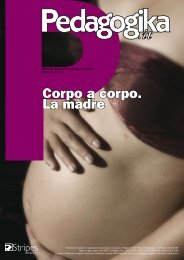(Il)legalità? - Pedagogika
(Il)legalità? - Pedagogika
(Il)legalità? - Pedagogika
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>Pedagogika</strong>.it/2011/XV_1/(<strong>Il</strong>)<strong>legalità</strong>?/Legalità_legittimità_cultura<br />
Mi concentro ora sulla differenza tra <strong>legalità</strong> e legittimità. Propongo di partire<br />
dalla imperitura lezione socratica così come Platone la narra nell’Apologia di Socrate.<br />
Comincio con il ricordare come la condanna a morte di Socrate fu decisa a<br />
seguito di un processo che lo vide imputato di empietà e di corruzione dei giovani.<br />
Ciò che di fatto Socrate fece, tale da attirargli il biasimo dei suoi concittadini,<br />
fu invitare i suoi interlocutori – chiunque essi fossero - all’esercizio della critica,<br />
all’assunzione di un atteggiamento di distacco dal sapere convenzionale, da quel<br />
plesso di tradizioni e abitudini fino ad allora incontroverso, onde sottoporlo al<br />
vaglio della razionalità. La vera guida di Socrate è appunto la ragione, il logos: non<br />
c’è alcuna condotta né alcuna legge che non possa essere sottoposta al giudizio della<br />
ragione anzi, potremmo dire, della filosofia. Non c’è nulla nell’esperienza umana<br />
cui la filosofia non si possa liberamente applicare 1 . Per via di queste e altre simili<br />
affermazioni Socrate viene accusato di empietà: è per i suoi concittadini empio, in<br />
quanto ha mostrato di non voler accettare passivamente l’ordine costituito, che è<br />
ordine naturale e divino insieme poiché naturali e divine insieme sono le leggi su<br />
cui si regge. L’accusa di empietà si affianca ad un’altra accusa, quella di corruzione<br />
dei giovani. Infatti, la libertà di filosofare, cioè di ricercare senza subire interferenze<br />
facendo uso soltanto della propria intelligenza e del proprio senso critico, è oggetto<br />
dell’insegnamento socratico; sono soprattutto i giovani ad avvicinarsi a Socrate e<br />
ad ascoltare le sue parole, essendo i più disposti ad apprendere, a farsi interpellare<br />
sul senso dell’esistenza, del vivere insieme, sul senso della politica e delle leggi. A<br />
loro Socrate si rivolge in particolare, insegnando a seguire il ragionamento fino<br />
in fondo, fino alle sue conseguenze più estreme, fino a respingere, se necessario,<br />
il sapere da sempre considerato verità senza che nessuno lo abbia mai indagato<br />
veramente. Ciò che ai giovani Socrate mostra è, in sintesi, l’esercizio della libertà<br />
del giudizio, l’autonomia del ragionamento ‘senza sponde’. Non è strano allora<br />
che i concittadini di Socrate, e in specie i più potenti, provassero preoccupazione:<br />
proprio i giovani, educati all’obbedienza, potevano ribellarsi, rifiutando ogni deferenza<br />
nei confronti di regole e convenzioni. Socrate è allora giudicato e condannato<br />
per empietà e corruzione; in realtà la sua colpa è mostrarsi del tutto indipendente,<br />
non deferente né sottomesso a potere e gerarchie.<br />
Mi sono soffermata sul caso di Socrate perché esso presenta spunti interessanti<br />
per comprendere in che senso la sua sfida sia una battaglia per la giustizia. Socrate<br />
invita i suoi ascoltatori a ripensare il senso del fare politica: bisogna – è questo in<br />
sostanza l’insegnamento di Socrate – accantonare gli interessi particolari e ridisegnare<br />
i confini stessi dell’agire politico, rinvigorire le regole costituzionali, gli<br />
standard immutabili della giustizia. La città cui Socrate si rivolge è una Atene resa<br />
fragile dalla guerra del Peloponneso, una Atene indebolita e corrotta. Ciò che So-<br />
1 “Ancor meno mi crederete se dico che il più grande bene dato all’uomo è proprio questa possibilità<br />
di ragionare quotidianamente sulla virtù e sui vari temi su cui mi avete sentito discutere o esaminare<br />
me stesso e altri, e che una vita senza ricerca non vale la pena di essere vissuta dall’uomo”<br />
(Apologia [38b], a cura di M. Sassi, Rizzoli, Milano, 2005, p. 165).<br />
Dossier 11