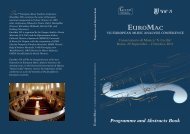Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
sviluppata da Cornelius Cardew di improvvisazione “etica”, in quanto assolutamente “democratica” dal<br />
punto di vista della performance ma al tempo stesso problematica nelle sue potenzialità comunicative, e<br />
quella di Jon Elster legata al concetto di limite nell’arte come generatore di valore artistico e della<br />
possibilità di un reale interscambio tra musicista e ascoltatori. The Diamond Sea, con la sua alternanza di<br />
sezioni riconducili alla forma canzone e lunghe parti improvvisative centrate sull’uso del rumore sembra<br />
voler conciliare queste due idee, nel tentativo di raggiungere un’espressione che concili l’etica<br />
individualista della free-improvisation con quella, etica anch’essa sotto il profilo della ricezione, della<br />
comunità degli ascoltatori. Si profila quindi in questa musica una convivenza tra principi apparentemente<br />
opposti che opera in maniera ambivalente, evitando di fare uso dei tratti più banali e triti della produzione<br />
della popular music anglo-americana ma senza per questo negare al proprio pubblico gli elementi minimi<br />
per una possibile condivisione del discorso portato avanti dalla canzone.<br />
A partire da un’analisi formale di The Diamond Sea e da una ricognizione dei meccanismi di ripetizione e<br />
variazione alla base del lungo sviluppo del brano, si tenterà infine di discutere tale tentativo nel quadro<br />
della contrapposizione tra individuo e collettività. La dimensione etica può infatti essere declinata sia<br />
come un’etica individuale, in quanto integrità e coerenza del soggetto rispetto ai propri principi (in linea<br />
con la visione di Cardew), sia come impegno alla comprensibilità collettiva del messaggio musicale. La<br />
sintesi dell’etica individuale espressiva e dell’esigenza di comprensibilità collettiva fornisce la cifra<br />
estetica dell’improvvisazione dei Sonic Youth. Dal punto di vista storiografico la posizione del gruppo,<br />
soprattutto per il suo tentativo di far convivere organicamente idee di avanguardia con sonorità e<br />
consuetudini compositive e d’ascolto tipiche della popular music, verrà definita sia sotto il profilo di una<br />
possibile ‘avanguardia popular’, sia della sua collocazione nel panorama musicale contemporaneo.<br />
Bibliografia essenziale<br />
Àlvarez Fernández, Miguel<br />
2007 Dissonance, Sex and Noise: (Re)Building (Hi)Stories of Electroacoustic Music, «Hz», 9,<br />
(consultato il 28 agosto 2010).<br />
Caporaletti, Vincenzo<br />
2005 I processi improvvisativi della musica. Un approccio globale, Lucca, LIM.<br />
2007 Out-Bloody-Rageous (Soft Machine, "Third",1970). La logica dialettica della musica audiotattile,<br />
“Philomusica on-line”, numero speciale (Atti del Convegno internazionale "Composizione e<br />
sperimentazione nel rock britannico 1966-1976", a cura di Gianmario Borio e Serena Facci),<br />
(consultato il 28 agosto 2010).<br />
Elster, Jon<br />
2004 Ulisse liberato: razionalità e vincoli, Bologna, Il Mulino.<br />
Cardew, Cornelius<br />
2006 Toward an Ethic of Improvisation, in Cornelius Cardew. A Reader, ed. by E. Prevòst, Harlow,<br />
Copula, pp.125-133.<br />
Hegarty, Paul<br />
2001 Full with Noise: Theory and Japanese Noise Music, «Ctheory.net»,<br />
(consultato il 28 agosto 2010).<br />
2002 General Ecology of Sound: Japanese Noise Music as Low Form,<br />