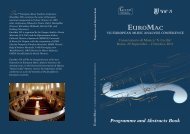Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
teorico in cui l’analisi musicale è concepita come il compito di ricondurre un testo musicale alla<br />
grammatica che lo ha generato, l’Ursatz schenkeriano può essere reinterpretato come lo stato<br />
rappresentazionale iniziale di un processo generativo, il cui stato finale è il brano in notazione musicale.<br />
Tale processo consiste nella applicazione di operatori (attinti da un repertorio finito) a livelli rappresentazionali<br />
(che possiamo chiamare “descrittori strutturali”). Schematicamente:<br />
dove s0 è l’Ursatz, sk è il testo rappresentabile in notazione musicale, di è un operatore che applicato al<br />
livello si produce il livello si+1 . Nella grammatica della tonalità l’Ursatz è il livello rappresentazionale s0<br />
da cui ha origine ogni processo generativo, processo che consiste in una sequenza s0Lsk di stati<br />
rappresentazionali, che chiamerò “derivazione”, il cui stato finale sk è il brano musicale. L’Ursatz è,<br />
dunque, innanzitutto un pattern che ha un ruolo “concettuale”, pertanto è un pattern proiettivo, secondo la<br />
distinzione introdotta. Definendo formalmente l’analisi di un brano come il processo volto ad individuare<br />
una derivazione s0Lsk tale che s0 è l’Ursatz e sk è il brano in partitura (processo di parsing), si sosterrà<br />
che se un livello è derivabile dal testo musicale attraverso un processo di “riduzione” esclusivamente<br />
basato sul dato empirico, tale livello è percettivamente rilevante ed è costituito da patterns<br />
percettivamente efficaci.<br />
Bibliografia essenziale<br />
Cadwallader A., Gagné D. (2007) Analysis of Tonal Music – A Schenkerian Approach, Oxford<br />
University Press.<br />
Hepokoski J., Darcy W. (2006) Elements of Sonata Theory, Oxford University Press.<br />
Novack S. (1990) Foregruond, Middlegruond, and background: their significance in the history of<br />
tonality, in Hedi Siegel, (a c. di),“Schenker Studies”, Cambridge University Press.<br />
Schenker H. (1935) Der freie Satz, Trans. and ed. by Ernst Oster (Free Composition), Pendragon<br />
Press, 2001.<br />
SARA DIECI – AURELIO BIANCO<br />
Una ‘ritrovata’ raccolta di Biagio Marini: Madrigali et Symfonie op. II (1618)<br />
Il compositore e violinista bresciano Biagio Marini è comunemente riconosciuto come una delle più<br />
singolari e interessanti personalità della tradizione strumentale barocca. Rappresentante modello del<br />
professionismo itinerante seicentesco, conobbe impieghi in prestigiose istituzioni musicali non solo in<br />
Italia ma anche a Nord delle Alpi. Si ricordano in primo luogo i due periodi passati nella cappella della<br />
basilica di S. Marco a Venezia e quello trascorso al servizio del duca Wolfgang Wilhelm a Neuburg e a<br />
Düsseldorf.<br />
Sin dalla primissima riscoperta dell’opera di Marini l’attenzione della critica si è essenzialmente<br />
indirizzata alla produzione strumentale del musicista lombardo. In sintesi, due sono i meriti che gli<br />
vengono riconosciuti: aver partecipato ad una prima definizione del genere della sonata a tre e aver<br />
contribuito in maniera determinante allo sviluppo della tecnica del proprio strumento tanto in area italiana<br />
quanto in area tedesca. Tre sono le antologie ancora oggi note di Marini interamente dedicate a generi<br />
strumentali: i celebri Affetti musicali opera I, le altrettanto famose Curiose et moderne invenzioni op. VIII<br />
e infine le Sonate da chiesa e da camera op. XXII. Nel catalogo a stampa di Marini la parte strumentale<br />
riveste dunque, perlomeno sotto il profilo quantitativo, un ruolo relativamente marginale. La produzione