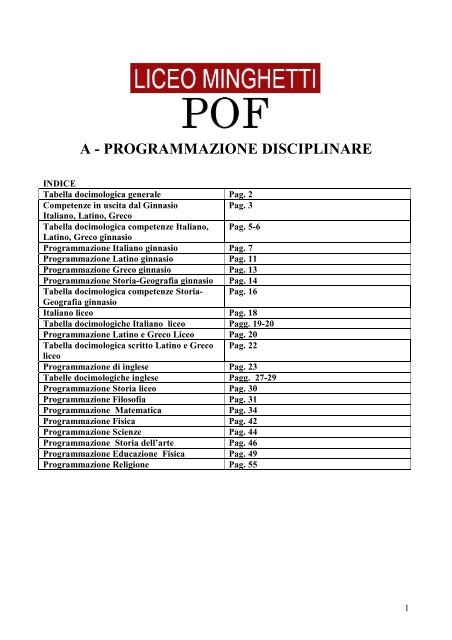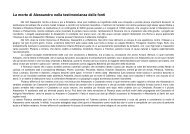Programmazioni disciplinari
Programmazioni disciplinari
Programmazioni disciplinari
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
A - PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE<br />
INDICE<br />
Tabella docimologica generale Pag. 2<br />
Competenze in uscita dal Ginnasio<br />
Italiano, Latino, Greco<br />
Pag. 3<br />
Tabella docimologica competenze Italiano,<br />
Latino, Greco ginnasio<br />
Pag. 5-6<br />
Programmazione Italiano ginnasio Pag. 7<br />
Programmazione Latino ginnasio Pag. 11<br />
Programmazione Greco ginnasio Pag. 13<br />
Programmazione Storia-Geografia ginnasio Pag. 14<br />
Tabella docimologica competenze Storia-<br />
Geografia ginnasio<br />
Pag. 16<br />
Italiano liceo Pag. 18<br />
Tabella docimologiche Italiano liceo Pagg. 19-20<br />
Programmazione Latino e Greco Liceo Pag. 20<br />
Tabella docimologica scritto Latino e Greco<br />
liceo<br />
Pag. 22<br />
Programmazione di inglese Pag. 23<br />
Tabelle docimologiche inglese Pagg. 27-29<br />
Programmazione Storia liceo Pag. 30<br />
Programmazione Filosofia Pag. 31<br />
Programmazione Matematica Pag. 34<br />
Programmazione Fisica Pag. 42<br />
Programmazione Scienze Pag. 44<br />
Programmazione Storia dell’arte Pag. 46<br />
Programmazione Educazione Fisica Pag. 49<br />
Programmazione Religione Pag. 55<br />
1
TABELLA DOCIMOLOGICA GENERALE A.S. 2012-13<br />
Voto Giudizio Metodo di studio Conoscenze<br />
<strong>disciplinari</strong><br />
1- 4 Insufficienza<br />
grave o molto<br />
grave<br />
5 Insufficienza<br />
non grave<br />
Studia in modo<br />
discontinuo e non<br />
consapevole<br />
Non è pertinente e<br />
puntuale nelle<br />
consegne<br />
Non utilizza in modo<br />
corretto gli strumenti<br />
di studio<br />
Organizza lo studio in<br />
modo<br />
complessivamente<br />
corretto<br />
Non è puntuale e/o<br />
completo nelle<br />
consegne<br />
Utilizza gli strumenti<br />
di studio in modo nel<br />
complesso adeguato<br />
6 Sufficiente Organizza lo studio in<br />
modo<br />
complessivamente<br />
autonomo<br />
E’ puntuale nelle<br />
consegne anche se<br />
non sempre preciso<br />
Utilizza gli strumenti<br />
di studio in modo<br />
complessivamente<br />
adeguato<br />
9-10 Ottimo/eccellente<br />
Organizza lo studio in<br />
modo autonomo e<br />
organico<br />
E’ puntuale e<br />
completo nelle<br />
consegne<br />
Utilizza gli strumenti<br />
di studio in modo<br />
competente<br />
E’ in possesso di<br />
conoscenze lacunose,<br />
frammentarie e non<br />
consapevolmente<br />
assimilate<br />
E’ in possesso di<br />
conoscenze poco<br />
consolidate, assimilate<br />
in modo<br />
prevalentemente<br />
mnemonico<br />
Conosce i contenuti<br />
essenziali della<br />
disciplina<br />
Ha conoscenze ampie<br />
e approfondite,<br />
puntualizzate in modo<br />
sicuro e competente.<br />
Capacità di<br />
individuare<br />
collegamenti e<br />
relazioni<br />
Non concettualizza i<br />
dati e non li classifica<br />
e/o seleziona in modo<br />
conforme alle<br />
richieste<br />
Non riesce a articolare<br />
collegamenti neppure<br />
se indirizzato<br />
Non è autonomo nelle<br />
operazioni di<br />
concettualizzazione,<br />
classificazione e<br />
selezione pertinente<br />
dei dati acquisiti<br />
Solo se indirizzato,<br />
articola<br />
esclusivamente i<br />
collegamenti più ovvi<br />
ed espliciti<br />
E’ in grado di<br />
compiere operazioni<br />
di<br />
concettualizzazione,<br />
classificazione e<br />
selezione pertinente<br />
dei dati acquisiti in<br />
modo<br />
complessivamente<br />
adeguato<br />
Riesce ad articolare i<br />
collegamenti<br />
fondamentali<br />
E’ in grado di<br />
compiere in modo<br />
autonomo e sicuro<br />
operazioni di<br />
sistematizzazione dei<br />
dati acquisiti<br />
Individua<br />
autonomamente le<br />
connessioni tra i temi<br />
e ne individua<br />
sviluppi originali<br />
Esprime giudizi<br />
criticamente<br />
argomentati<br />
Elaborazione ed<br />
esposizione delle<br />
conoscenze<br />
Utilizza le conoscenze<br />
in modo non<br />
pertinente alle<br />
richieste.<br />
Utilizza contenuti<br />
carenti e frammentari<br />
Li articola in modo<br />
scoordinato<br />
Espone in modo<br />
estremamente<br />
faticoso, formalmente<br />
scorretto e<br />
lessicalmente<br />
improprio<br />
Utilizza le conoscenze<br />
in modo parzialmente<br />
pertinente alle<br />
richieste, e/o utilizza<br />
contenuti banali.<br />
L’articolazione è in<br />
diversi passaggi<br />
disorganica<br />
L’esposizione è<br />
faticosa, non sempre<br />
corretta e<br />
lessicalmente<br />
impropria<br />
Utilizza le conoscenze<br />
in modo pertinente<br />
alle richieste,<br />
utilizzando contenuti<br />
essenziali.<br />
L’articolazione è<br />
coerente<br />
L’esposizione è nel<br />
complesso<br />
formalmente corretta<br />
e lessicalmente<br />
appropriata<br />
Utilizza le conoscenze<br />
in modo pertinente<br />
alle richieste,<br />
attraverso contenuti<br />
ampi e rielaborati in<br />
modo originale.<br />
L’articolazione è<br />
coerente e organica<br />
L’esposizione è fluida<br />
ed efficace,<br />
formalmente corretta<br />
e lessicalmente<br />
appropriata<br />
2
NUOVO OBBLIGO DELL’ISTRUZIONE<br />
COMPETENZE IN USCITA DAL GINNASIO<br />
ASSE DEI LINGUAGGI ITALIANO, LATINO, GRECO<br />
A conclusione del biennio l’allievo è in grado di:<br />
Competenze generali:<br />
Competenze di interazione:<br />
Collaborare e partecipare<br />
Agire in modo autonomo e responsabile<br />
Acquisire la consapevolezza di appartenere a un gruppo solidale, improntato alla collaborazione e al rispetto della<br />
persona.<br />
Percepire la scuola come ambiente primario in cui sperimentare la dimensione istituzionale del vivere civile, che si<br />
manifesta nel riconoscimento e nel rispetto di diritti e doveri consapevolmente condivisi come garanzia di libertà<br />
democratica.<br />
Partecipare attivamente alla vita della scuola, sia nelle relazioni quotidiane in classe, sia negli organi di rappresentanza<br />
democratica, a partire dalle assemblee e dal Consiglio di Classe, acquisendo l’abitudine all’esercizio corretto della<br />
libertà di parola e all’ascolto di posizioni differenti.<br />
Sperimentare nelle relazioni interpersonali e con gli insegnanti la trasparenza nella comunicazione.<br />
Competenze metodologiche:<br />
Imparare a imparare<br />
Analizzare le consegne, individuare le conoscenze ad esse pertinenti; elaborare una strategia efficace per svilupparle;<br />
articolarne lo sviluppo in modo pertinente, chiaro e coerente.<br />
Utilizzare in modo mirato gli strumenti di studio (libri di testo e dizionari).<br />
Organizzare mappe, tabelle, schemi funzionali ai contenuti ed alle finalità richiesti.<br />
Riordinare in modo efficace e sistematico gli appunti di lezione.<br />
Acquisire capacità di analisi degli errori e di autovalutazione sulla base di parametri dati.<br />
Elaborare e applicare di criteri di classificazione<br />
Attivare processi di deduzione: dalla “regola” alla sua applicazione<br />
Ambiti <strong>disciplinari</strong>:<br />
Lettura e comprensione dei testi<br />
Competenze:<br />
Acquisire e interpretare l’informazione<br />
Individuare collegamenti e relazioni<br />
Individuare il tema centrale del testo e la sua tipologia (manuale disciplinare, articolo di cronaca, articolo di opinione,<br />
saggio critico).<br />
Utilizzare i “segnali testuali” (paragrafazione, punteggiatura, connettivi logici, coesivi) come strumenti per la<br />
comprensione del testo.<br />
Individuare la struttura logica del testo, distinguendo le informazioni principali da quelle secondarie<br />
Riconoscere i rapporti e le relazioni fra le parti del testo<br />
Individuare le parole chiave.<br />
Compiere inferenze.<br />
Compiere operazioni di lettura selettiva:<br />
estrapolare dal testo dati in base a indicazioni fornite;<br />
classificare e selezionare dati<br />
operare generalizzazioni<br />
Produzione di testi orali e scritti<br />
Competenze:<br />
Comunicare<br />
Progettare<br />
Individuare collegamenti e relazioni<br />
3
Pianificare: ricercare, selezionare e ordinare dati pertinenti alle richieste attraverso operazioni predefinite (reperimento,<br />
classificazione e selezione dei dati, costruzione della scaletta)<br />
Sintetizzare e generalizzare i dati<br />
Costruire il testo scritto e orale conformemente alla tipologia richiesta (sintesi, recensione, analisi testuale di un testo<br />
letterario, relazione, esposizione, argomentazione)<br />
Utilizzare nella stesura i “segnali testuali” in modo competente (paragrafazione, punteggiatura, connettivi logici,<br />
coesivi).<br />
Utilizzare il registro linguistico adeguato al contesto comunicativo.<br />
Riflessione sulla lingua<br />
Competenze:<br />
Acquisire e interpretare l’informazione<br />
Individuare collegamenti e relazioni<br />
Riconoscere la pluralità di codici comunicativi<br />
Riconoscere la natura convenzionale della lingua come sistema di segni<br />
Utilizzare il lessico tecnico della disciplina<br />
Definire gli elementi fondamentali della lingua mediante un uso appropriato del lessico tecnico.<br />
Riconoscere e analizzare le parti del discorso, con particolare attenzione al sistema verbale.<br />
Riconoscere la natura fondamentale del sistema linguistico come rete di relazioni<br />
Riconoscere la relazione fondamentale tra forma e funzione<br />
Individuare la struttura gerarchica della frase semplice e della frase complessa e le relazioni logiche in essa attivate.<br />
Conoscere i fondamentali meccanismi di produzione lessicale (derivazione di nomi da verbi, da aggettivi ecc.).<br />
Conoscere le fondamentali relazioni tra parole (sinonimi, iponimi, iperonimi ecc.)<br />
Costruire mappe semantiche.<br />
Approccio al testo letterario<br />
Competenze:<br />
Acquisire e interpretare l’informazione<br />
Acquisire la consapevolezza dell’importanza delle manifestazioni dell’immaginario nell’esperienza individuale e<br />
collettiva.<br />
Conoscere gli aspetti caratterizzanti e le finalità della comunicazione letteraria.<br />
Conoscere il sistema dei generi letterari, con particolare riferimento all’epica, alla narrativa e alla poesia, e al teatro e<br />
riconoscere gli elementi caratterizzanti di ciascuno di essi, a livello sia tematico che stilistico.<br />
Conoscere elementi utili alla contestualizzazione di un testo e alla sua interpretazione alla luce di aspetti della cultura e<br />
della mentalità del periodo storico in cui è stato prodotto.<br />
Comprendere in modo analitico e globale i testi letterari oggetto di indagine e saperli riformulare, parafrasare e<br />
sintetizzare.<br />
Cogliere gli aspetti stilistici e retorici del testo.<br />
Utilizzare correttamente il lessico tecnico di base.<br />
Elaborare un’analisi testuale articolata e motivata di testi letterari, con un uso pertinente delle citazioni.<br />
4
Giudizio Imparare a<br />
imparare<br />
Insuf-<br />
ficienza<br />
grave o<br />
molto<br />
grave<br />
Insuf-<br />
ficienza<br />
non<br />
grave<br />
Sufficien<br />
-te<br />
Studia in modo<br />
discontinuo e/o<br />
puramente<br />
mnemonico<br />
Non è sempre<br />
puntuale e/o<br />
completo nelle<br />
consegne<br />
Non utilizza in<br />
modo corretto gli<br />
strumenti di studio<br />
Non riesce a<br />
correggere gli<br />
errori che gli<br />
vengono segnalati<br />
Organizza lo<br />
studio in modo<br />
non pienamente<br />
autonomo<br />
Non è puntuale e/o<br />
completo nelle<br />
consegne<br />
Utilizza gli<br />
strumenti di studio<br />
in modo non<br />
pienamente<br />
adeguato<br />
Solo guidato<br />
corregge gli errori<br />
che gli vengono<br />
segnalati<br />
Organizza lo<br />
studio in modo<br />
complessivamente<br />
autonomo<br />
E’ puntuale nelle<br />
consegne anche se<br />
non sempre<br />
preciso<br />
Utilizza gli<br />
strumenti di studio<br />
in modo<br />
complessivamente<br />
adeguato<br />
Riesce a<br />
correggere<br />
eventuali errori<br />
segnalati<br />
Individuare<br />
collegamenti e<br />
relazioni<br />
TABELLA DOCIMOLOGICA<br />
ITALIANO, LATINO E GRECO GINNASIO<br />
Non è autonomo<br />
nelle operazioni di<br />
concettualizzazione<br />
, classificazione e<br />
selezione pertinente<br />
dei dati acquisiti<br />
Compie operazioni<br />
di<br />
concettualizzazione<br />
, classificazione e<br />
selezione dei dati<br />
acquisiti in modo<br />
non completo e<br />
organico<br />
E’ in grado di<br />
compiere<br />
operazioni di<br />
concettualizzazion<br />
e, classificazione e<br />
selezione<br />
pertinente dei dati<br />
acquisiti in modo<br />
complessivamente<br />
adeguato<br />
Applica le<br />
conoscenze<br />
acquisite per<br />
analizzare dati<br />
nuovi<br />
strutturalmente<br />
simili a un<br />
modello dato<br />
Lettura e<br />
comprensione<br />
Non riconosce la<br />
coerenza interna<br />
del testo,<br />
fraintendendo<br />
diversi passaggi<br />
chiave<br />
Non è in grado di<br />
compiere<br />
inferenze e<br />
operazioni di<br />
lettura selettiva in<br />
modo conforme<br />
alle richieste<br />
Individua il tema<br />
centrale del testo e<br />
ne riconosce<br />
complessivamente<br />
la coerenza<br />
interna, ma<br />
fraintende diversi<br />
punti<br />
Compie inferenze<br />
e operazioni di<br />
lettura selettiva<br />
conformemente a<br />
richieste esplicite a<br />
livello poco<br />
approfondito<br />
Individua il tema<br />
centrale del testo e<br />
ne riconosce<br />
complessivamente<br />
la coerenza interna<br />
E’ in grado di<br />
compiere<br />
inferenze e<br />
operazioni di<br />
lettura selettiva in<br />
modo conforme a<br />
richieste esplicite<br />
Produzione orale<br />
e scritta<br />
Rispetta solo<br />
parzialmente le<br />
indicazioni fornite.<br />
Produce elaborati<br />
carenti nei<br />
contenuti.<br />
Articola il discorso<br />
in modo<br />
disorganico.<br />
La formulazione<br />
presenta diversi<br />
passaggi<br />
sintatticamente e/o<br />
morfologicamente<br />
scorretti<br />
Utilizza un lessico<br />
spesso improprio.<br />
Rispetta le<br />
indicazioni fornite,<br />
ma propone<br />
contenuti<br />
superficiali e<br />
generici o:propone<br />
contenuti<br />
pertinenti e<br />
diversificati ma in<br />
modo<br />
disarticolato.<br />
La formulazione è<br />
poco organica e<br />
coesa e a volte<br />
lessicalmente<br />
impropria.<br />
Rispetta le<br />
indicazioni fornite.<br />
I contenuti sono<br />
pertinenti, anche<br />
se essenziali.<br />
L’esposizione è<br />
nel complesso<br />
coerente e coesa e<br />
lessicalmente<br />
appropriata, anche<br />
se non ricca.<br />
Analisi<br />
metalinguistica<br />
Usa il lessico<br />
tecnico in modo<br />
notevolmente<br />
impreciso e non<br />
pienamente<br />
consapevole<br />
Non è autonomo<br />
nel riconoscere e<br />
analizzare gli<br />
elementi<br />
morfosintattici<br />
Usa il lessico<br />
tecnico in modo<br />
non sempre<br />
corretto<br />
Riconosce e<br />
analizza in modo<br />
non preciso gli<br />
elementi<br />
morfosintattici<br />
Usa il lessico<br />
tecnico in modo<br />
complessivamente<br />
corretto<br />
Riconosce e<br />
analizza in modo<br />
complessivamente<br />
corretto gli<br />
elementi<br />
morfosintattici<br />
Approccio al<br />
testo letterario<br />
Usa il lessico<br />
tecnico in modo<br />
notevolmente<br />
impreciso e non<br />
pienamente<br />
consapevole.<br />
Ha una<br />
conoscenza<br />
lacunosa e<br />
superficiale dei<br />
tratti<br />
caratterizzanti dei<br />
generi letterari e<br />
non è autonomo<br />
nel riconoscerli nei<br />
testi<br />
Usa il lessico<br />
tecnico in modo<br />
non preciso<br />
Ha una<br />
conoscenza<br />
complessivamente<br />
corretta ma<br />
superficiale dei<br />
tratti<br />
caratterizzanti dei<br />
generi letterari e li<br />
riconosce nei testi<br />
in modo non<br />
pienamente<br />
autonomo<br />
Usa il lessico<br />
tecnico in modo<br />
complessivamente<br />
corretto<br />
Ha una<br />
conoscenza<br />
corretta ed<br />
essenziale dei tratti<br />
caratterizzanti dei<br />
generi letterari e li<br />
riconosce nei testi.<br />
5
discreto Organizza lo<br />
studio in modo<br />
autonomo e<br />
E’ puntuale nelle<br />
consegne<br />
Utilizza gli<br />
strumenti di studio<br />
in modo adeguato<br />
E’ in grado di<br />
individuare e<br />
correggere<br />
eventuali errori.<br />
Buono Organizza lo<br />
studio in modo<br />
autonomo e<br />
organico<br />
E’ puntuale e<br />
completo nelle<br />
consegne<br />
Utilizza gli<br />
strumenti di studio<br />
in modo<br />
competente<br />
Ottimo<br />
o<br />
eccellente<br />
Organizza lo<br />
studio in modo<br />
autonomo e<br />
organico<br />
E’ puntuale e<br />
completo nelle<br />
consegne<br />
Utilizza gli<br />
strumenti di studio<br />
in modo<br />
competente<br />
E’ in grado di<br />
compiere<br />
operazioni di<br />
concettualizzazion<br />
e, classificazione e<br />
selezione<br />
pertinente dei dati<br />
acquisiti. Appli-<br />
ca le conoscenze<br />
acquisite per<br />
analizzare dati<br />
nuovi anche non<br />
esattamente<br />
coincidenti con la<br />
tipologia del<br />
modello dato<br />
E’ in grado di<br />
compiere<br />
operazioni di<br />
concettualizzazion<br />
e, classificazione,<br />
selezione e<br />
sistematizzazione<br />
dei dati acquisiti<br />
Applica le<br />
conoscenze<br />
acquisite per<br />
analizzare dati<br />
nuovi che<br />
presentano<br />
elementi<br />
problematici<br />
E’ in grado di<br />
compiere<br />
operazioni di<br />
concettualizzazion<br />
e, classificazione,<br />
selezione e<br />
sistematizzazione<br />
dei dati acquisiti<br />
Applica le<br />
conoscenze<br />
acquisite per<br />
analizzare dati<br />
nuovi che<br />
presentano elementi<br />
altamente<br />
problematici<br />
Individua il tema<br />
centrale del testo e<br />
ne riconosce la<br />
coerenza interna<br />
E’ in grado di<br />
compiere<br />
inferenze e<br />
operazioni di<br />
lettura selettiva in<br />
modo autonomo<br />
Effettua a partire<br />
dal testo<br />
collegamenti<br />
inter<strong>disciplinari</strong> in<br />
base a richieste<br />
precise<br />
Individua il tema<br />
centrale del testo e<br />
ne riconosce la<br />
coerenza interna<br />
E’ in grado di<br />
compiere<br />
inferenze e<br />
operazioni di<br />
lettura selettiva in<br />
modo autonomo e<br />
approfondito<br />
Coglie lo spessore<br />
culturale del testo<br />
analizzandone il<br />
tema e il lessico<br />
Effettua<br />
autonomamente<br />
collegamenti<br />
inter<strong>disciplinari</strong> a<br />
partire dal testo<br />
Individua il tema<br />
centrale del testo e<br />
ne riconosce la<br />
coerenza interna<br />
E’ in grado di<br />
compiere<br />
inferenze e operazioni<br />
di lettura<br />
selettiva in modo<br />
autonomo e<br />
approfondito<br />
Coglie lo spessore<br />
culturale del testo<br />
analizzandone il<br />
tema e il lessico<br />
Effettua autonomamente<br />
ampi<br />
collegamenti<br />
inter<strong>disciplinari</strong> a<br />
partire dal testo<br />
Esprime un giudizio<br />
criticamente<br />
motivato<br />
Segue in modo<br />
puntuale e<br />
completo le<br />
consegne.<br />
Pianifica e<br />
compone un testo<br />
pertinente nei<br />
contenuti e<br />
formalmente<br />
corretto.<br />
Utilizza un lessico<br />
adeguato sia<br />
nell’esposizione<br />
scritta che orale<br />
Segue in modo<br />
puntuale e<br />
completo le<br />
consegne.<br />
Selezione i<br />
contenuti in base a<br />
ricerca ed<br />
elaborazione<br />
personale<br />
Articola lo<br />
sviluppo del<br />
proprio testo in<br />
modo chiaro e<br />
coerente,<br />
argomentando in<br />
modo efficace le<br />
proprie opinioni.<br />
L’esposizione è<br />
chiara, corretta ed<br />
efficace e<br />
appropriata nel<br />
lessico.<br />
Segue in modo<br />
puntuale e<br />
completo le<br />
consegne.<br />
Stabilisce efficaci<br />
collegamenti e<br />
argomenta in<br />
modo originale<br />
Articola lo<br />
sviluppo del<br />
proprio testo in<br />
modo chiaro,<br />
efficace e<br />
coerente.<br />
Si esprime in<br />
modo fluido,<br />
utilizzando un<br />
lessico ampio e<br />
adeguato alle<br />
diverse situazione<br />
comunicative.<br />
Usa il lessico<br />
tecnico in modo<br />
corretto<br />
Riconosce e<br />
analizza in modo<br />
corretto e<br />
completo gli<br />
elementi<br />
morfosintattici<br />
Usa il lessico<br />
tecnico in modo<br />
corretto<br />
Riconosce e<br />
analizza in modo<br />
corretto e<br />
completo gli<br />
elementi<br />
morfosintattici<br />
Compie in modo<br />
autonomo confronti<br />
fra l’italiano e altre<br />
lingue.<br />
Usa il lessico<br />
tecnico in modo<br />
corretto<br />
Riconosce e<br />
analizza in modo<br />
corretto e<br />
completo gli<br />
elementi<br />
morfosintattici<br />
Compie in modo<br />
autonomo<br />
confronti fra<br />
l’italiano e altre<br />
lingue.<br />
E’ in grado di<br />
inferire<br />
autonomamente<br />
leggi linguistiche<br />
in base all’analisi<br />
di dati raccolti<br />
Usa il lessico<br />
tecnico in modo<br />
corretto e<br />
appropriato<br />
Ha una<br />
conoscenza<br />
corretta dei tratti<br />
caratterizzanti dei<br />
generi letterari e li<br />
riconosce nei testi.<br />
Usa il lessico<br />
tecnico in modo<br />
corretto e<br />
appropriato<br />
Ha una<br />
conoscenza<br />
corretta, esauriente<br />
e personalmente<br />
rielaborata dei<br />
tratti<br />
caratterizzanti dei<br />
generi letterari e li<br />
riconosce in modo<br />
autonomo e sicuro<br />
nei testi.<br />
.<br />
Usa il lessico<br />
tecnico in modo<br />
corretto e<br />
appropriato<br />
Ha una<br />
conoscenza<br />
corretta, esauriente<br />
e personalmente<br />
rielaborata dei<br />
tratti<br />
caratterizzanti dei<br />
generi letterari e li<br />
riconosce in modo<br />
autonomo e sicuro<br />
nei testi.<br />
Compie ricerche<br />
originali sui testi e<br />
argomenta in<br />
modo competente<br />
le proprie<br />
conclusioni.<br />
6
PROGRAMMAZIONE DIPARTIMENTALE DI ITALIANO (ginnasio)<br />
Unità 1: la comunicazione e i codici<br />
Conoscenze Abilità/capacità<br />
Gli elementi della comunicazione (il diagramma di Jakobson)<br />
Il codice come sistema di segni<br />
La struttura del segno: il rapporto tra significante e significato<br />
Classificazione dei segni: segni arbitrari e segni motivati<br />
Comunicazione verbale e non verbale<br />
I caratteri della comunicazione verbale: la nozione di lingua e le<br />
sue funzioni (Jakobson)<br />
La lingua adeguata al contesto: i registri linguistici e i linguaggi<br />
settoriali<br />
Unità 2: Riflessione sulla lingua: gli elementi costitutivi della lingua<br />
Definire con linguaggio specifico gli elementi<br />
fondamentali della comunicazione<br />
Dato un messaggio, ricostruire il diagramma di Jakobson<br />
ad esso relativo<br />
Dato un messaggio, riconoscere la funzione linguistica<br />
in esso prevalente<br />
Conoscenze Abilità/capacità<br />
Gli elementi minimi costitutivi della parola: radice, lessema e<br />
morfemi<br />
Le relazioni tra forma e significato<br />
Mappe semantiche<br />
Le parti del discorso e la loro funzione: definizione e<br />
classificazione<br />
Parti variabili e invariabili<br />
I parametri di variabilità delle forme verbali e nominali e la loro<br />
funzione:<br />
- modo<br />
- tempo<br />
- persona<br />
- numero<br />
- genere<br />
Il sistema verbale:<br />
- la coniugazione attiva e passiva e l’uso degli ausiliari<br />
- il sistema dei tempi e il loro uso testuale<br />
- il sistema dei modi finiti: differenze tra indicativo,<br />
congiuntivo, condizionale e imperativo<br />
- Le forme nominali del verbo (infinito, gerundio e<br />
participio) e la loro funzione<br />
Unità 3: Riflessione sulla lingua: sintassi della frase semplice<br />
Data una parola, scomporla negli elementi minimi<br />
Data una radice, costruire una mappa semantica<br />
Definire le parti del discorso e distinguerle all’interno<br />
della frase<br />
Analizzare forme linguistiche variabili e invariabili<br />
Conoscenze Abilità/capacità<br />
La sintassi:definizione<br />
Definire le componenti costitutive della frase<br />
La frase nucleare e.la centralità del verbo: la funzione logica e il<br />
concetto di dipendenza, il sintagma<br />
Riconoscere il nucleo all’interno di una frese semplice<br />
Elementi che dipendono dal verbo: i complementi necessari: gli<br />
argomenti; i complementi non necessari: le espansioni<br />
Distinguere argomenti da espansioni<br />
Elementi che non dipendono dal verbo: i complementi del nome<br />
e dell’aggettivo:<br />
Individuare gli elementi che dipendono dal verbo<br />
apposizione, complemento di specificazione, ecc.<br />
Tipologie della frase semplice:<br />
Individuare gli elementi che dipendono dal nome<br />
frasi nominali;<br />
frasi formate dal solo verbo;<br />
frasi con verbo ad un argomento: il soggetto;<br />
frasi formate con verbo a due argomenti: soggetto e<br />
complemento oggetto; copula + soggetto e parte nominale;<br />
verbi copulativi + soggetto e predicativo del soggetto; verbi<br />
Individuare il corretto rapporto di dipendenza fra gli<br />
elementi della frase semplice<br />
Formulare frasi nucleari e completarle con<br />
l’inserimento di argomenti ed espansioni secondo le<br />
indicazioni date<br />
7
passivi + soggetto e complemento d’agente e/o causa<br />
efficiente; verbi di stato + soggetto e complemento di stato in<br />
luogo; verbo essere con il significato di stare, esserci +<br />
soggetto e complemento di stato in luogo;<br />
frase formata con verbo a tre argomenti: soggetto, oggetto,<br />
termine; verbi appellativi, estimativi, elettivi + soggetto,<br />
oggetto e complemento predicativo dell’oggetto, verbi di<br />
moto + soggetto e complementi di luogo (moto a, moto da,<br />
moto per)<br />
Le espansioni<br />
complementi che dipendono dal verbo: tempo, fine, causa,<br />
mezzo,modo, compagnia e unione.<br />
I complementi del nome e dell’aggettivo<br />
complementi che dipendono dal nome o<br />
dall’aggettivo:partitivo, di qualità, materia ecc.<br />
Unità 4: Riflessione sulla lingua: sintassi della frase complessa<br />
Conoscenze Abilità/capacità<br />
La nozione di frase complessa<br />
Coordinazione e subordinazione; congiunzioni coordinanti e<br />
subordinanti<br />
La classificazione fondamentale delle subordinate:<br />
- completive<br />
o dichiarative/volitive<br />
o interrogative indirette<br />
- circostanziali<br />
o temporali<br />
o causali<br />
o finali<br />
o consecutive<br />
o concessive<br />
o ipotetiche<br />
o strumentali<br />
o modali<br />
- attributive<br />
Costrutti espliciti e impliciti<br />
I costrutti impliciti: i valori dell’infinito, del participio e del<br />
gerundio<br />
Definire e classificare le diverse tipologie di frase,<br />
individuandone gli elementi distintivi<br />
Individuare la struttura gerarchica della frase<br />
complessa e le relazioni logiche in essa attivate<br />
Valutare la coerenza di una frase in base alle relazioni<br />
logiche tra le diverse componenti<br />
Unità 5: Abilità di lettura<br />
Conoscenze Abilità/capacità<br />
Il testo e i suoi caratteri distintivi<br />
Dati messaggi diversi, riconoscere quelli che possono<br />
Testi orali e scritti.<br />
essere definiti testi<br />
I caratteri del testo scritto e le sue differenze dalla<br />
Leggere per imparare<br />
comunicazione orale.<br />
Orientarsi nell'indice del libro di testo<br />
Gli indici generali ed analitici dei testi; capitoli e paragrafi; Compiere operazioni di pre-lettura: crearsi aspettative;<br />
titoli, sottotitoli, titoli a margine; illustrazioni, didascalie; i trasformare in domande titoli, sottotitoli e titoli a<br />
caratteri di stampa.<br />
margine; cogliere le parole evidenziate.<br />
Punteggiatura e capoversi.<br />
Prevedere l’organizzazione logica di un testo.<br />
La coerenza testuale:<br />
Seguire il “filo del discorso” utilizzando la<br />
il tema centrale;<br />
punteggiatura e i nessi logici come “segnali linguistici”.<br />
<br />
<br />
<br />
l’ordine degli argomenti;<br />
sequenze e paragrafi; la frase tematica;<br />
tipi di paragrafo: che classifica; che definisce; che<br />
descrive; che narra; che enumera; che confronta; che<br />
istituisce rapporti di causa-effetto; che dimostra; che<br />
esemplifica; loro struttura abituale.<br />
Compiere inferenze.<br />
Estrapolare e classificare i dati informativi del testo<br />
Sintetizzare i dati fondamentali<br />
Spiegare e riformulare passaggi complessi<br />
8
La coesione testuale<br />
connettori e formule di raccordo;<br />
formule di richiamo: ripetizioni, sostituenti lessicali<br />
(sinonimi, iponimi, iperonimi), sostituenti pronominali,<br />
ellissi;<br />
l’uso testuale dei tempi verbali.<br />
Le tipologie testuali<br />
testo descrittivo<br />
testo espositivo<br />
testo argomentativi<br />
testo narrativo<br />
testo poetico<br />
Unità 6: Abilità di scrittura<br />
Conoscen<br />
ze<br />
Le regole<br />
dell’ortogr<br />
afia e<br />
della<br />
punteggiat<br />
ura.<br />
I caratteri<br />
del testo<br />
scritto<br />
(vedi<br />
Unità 5)<br />
Le<br />
tipologie<br />
testuali<br />
(vedi<br />
Unità 5)<br />
Scrittura<br />
funzionale<br />
e scrittura<br />
creativa<br />
Abilità/capacità<br />
Pianificare: ricercare e selezionare dati pertinenti alle richieste attraverso operazioni predefinite<br />
(reperimento, classificazione e selezione dei dati, costruzione della scaletta)<br />
Sintetizzare i dati, compiendo operazioni di generalizzazione e concettualizzazione<br />
Sviluppare il testo scritto e orale conformemente alla tipologia richiesta<br />
Utilizzare nella stesura i “segnali testuali” in modo competente (paragrafazione, punteggiatura,<br />
connettivi logici, coesivi).<br />
Utilizzare il registro linguistico adeguato al contesto comunicativo.<br />
Utilizzare correttamente il sistema dei tempi verbali.<br />
Correggere gli errori di stesura<br />
Produrre testi appartenenti alle seguenti tipologie:<br />
Relazioni (orali o scritte)<br />
Riassunti (da testi narrativi, espositivi e argomentativi) – abilità chiave: selezione e generalizzazione<br />
delle informazioni, ricostruzione delle sequenze<br />
Testi espositivi – abilità chiave: reperimento, classificazione e organizzazione dei dati informativi,<br />
riformulazione e spiegazione e interpretazione di informazioni complesse<br />
Testi argomentativi – abilità chiave: esporre una tesi, scegliere argomenti, classificarli e ordinarli in base<br />
all’efficacia, far dialogare più tesi<br />
Parafrasi (da testi letterari) – abilità chiave: riformulare passaggi complessi<br />
Analisi testuali (da testi letterari). – abilità chiave: individuare il tema centrale e lo sviluppo del testo;<br />
riconoscere in esso i tratti distintivi del genere letterario , gli aspetti retorici e stilistici, confrontare testi<br />
diversi;<br />
utilizzare correttamente il lessico tecnico; utilizzare correttamente le citazioni.<br />
Riscritture e parodie – abilità chiave: riconoscere e rielaborare gli aspetti tematici e stilistici di un testo<br />
letterario<br />
Recensioni – abilità chiave: cogliere una visione sintetica di un testo<br />
9
Unità 7: Approccio ai testi letterari – la narrativa<br />
Conoscenze Abilità/capacità<br />
Le manifestazioni dell’immaginario nell’esperienza individuale e<br />
collettiva.<br />
Gli aspetti caratterizzanti e le finalità della comunicazione<br />
letteraria.<br />
Il sistema dei generi letterari.<br />
La narrativa<br />
Il mito: origine e tipologia della narrazione mitica; il mito come<br />
forma di memoria delle civiltà senza scrittura.<br />
La fiaba: origine del genere; il sistema dei personaggi e lo<br />
sviluppo della storia.<br />
L’epica: o statuto del genere; i cicli epici, tra storia e leggenda; il<br />
processo di elaborazione dei poemi omerici; dall’oralità alla<br />
scrittura: il concetto di performance; aspetti stilistici: gli epiteti e<br />
le ricorrenze formulari, le similitudini, il proemio.<br />
L’Iliade: la società omerica e il suo sistema di valori l’ira e<br />
l’onore negato; la kalokagathìa e la tipologia dell’eroe; la “morte<br />
bella”; le donne e i valori del privato; la religione omerica e il<br />
concetto di destino.<br />
L’Odissea: la tipologia fiabesca del poema; novità e<br />
l’esemplarità del personaggio di Ulisse; il nostos e le peripezie;<br />
le donne e l’arte della tessitura; i segni e il riconoscimento.<br />
L’Eneide:<br />
Cenni sull’acquisizione dell’epos omerico da parte del mondo<br />
romano. La genesi della leggenda di fondazione.<br />
Il contesto storico della stesura dell’Eneide: il principato<br />
augusteo e la riproposizione del mito di Roma.<br />
La struttura dell’Eneide e i riferimenti omerici.<br />
Il doppio statuto di Enea.<br />
Il racconto:<br />
I caratteri del genere e i diversi sottogeneri;<br />
il livello della storia: esordio, Spannung, scioglimento;<br />
l’ambientazione spazio-temporale, il contesto sociale;<br />
il rapporto tra “fabula” e intreccio;<br />
il narratore e il punto di vista;<br />
i personaggi;<br />
lo stile.<br />
Il romanzo:<br />
l’origine del romanzo; i caratteri del genere e i diversi<br />
sottogeneri;<br />
il romanzo storico:<br />
I Promessi Sposi:<br />
la composizione del romanzo: dal Fermo ai Promessi Sposi; il<br />
romanzo come “contenitore polifunzionale”; la struttura del<br />
romanzo; i grandi temi del romanzo: la Storia e le storie, la<br />
società, la religione;il problema della lingua.<br />
I Promessi Sposi e il romanzo europeo.<br />
Unità 8: approccio ai testi letterari: la poesia<br />
Comprendere il testo in modo sintetico e analitico,<br />
utilizzando correttamente gli indicatori testuali<br />
Riconoscere le funzioni narrative utilizzandole come<br />
strumento per un’interpretazione globale<br />
Riconoscere i tratti distintivi del genere letterario<br />
Contestualizzare un testo interpretandolo alla luce di<br />
aspetti della cultura e della mentalità del periodo storico<br />
in cui è stato prodotto.<br />
Riconoscere i tratti distintivi di un autore attraverso<br />
l’analisi e il confronto di esempi diversi della sua<br />
produzione.<br />
Utilizzare il testo letterario come spunto per una<br />
riflessione sul presente<br />
Elaborare un’analisi articolata e motivata di testi<br />
narrativi, individuandone gli aspetti significativi<br />
attraverso l’analisi delle diverse funzioni e<br />
l’individuazione del genere letterario.<br />
Ri-scrivere brani reimpiegando tecniche compositive dei<br />
testi esaminati: similitudini, metafore ecc.<br />
Comporre testi narrativi contenenti le caratteristiche di<br />
genere studiate<br />
Conoscenze Abilità/capacità<br />
Il testo poetico e le sue caratteristiche:<br />
il processo di selezione e combinazione; il registro poetico; il<br />
significante e il significato.<br />
Il significato: la denotazione e la connotazione; i campi<br />
semantici; le figure di significato;le figure dell’ordine delle<br />
parole.<br />
Il significante:le caratteristiche metriche e ritmiche; le principali<br />
forme strofiche; le rime; le figure di suono; il rapporto tra poesia<br />
e musica.<br />
I generi poetici.<br />
-Definire e conoscere le caratteristiche di un testo poetico<br />
utilizzando correttamente il lessico tecnico. Dato un testo<br />
poetico: Parafrasarlo; Analizzarne la struttura;<br />
Commentarlo interpretandone il significato; Riconoscere<br />
i tratti distintivi di un autore attraverso il confronto di<br />
esempi diversi della sua produzione; Contestualizzare un<br />
testo poetico interpretandolo alla luce di aspetti della<br />
cultura del periodo in cui è stato prodotto.; Confrontare<br />
testi diversi di uno stesso autore e di autori diversi<br />
individuandone le specificità.<br />
10
Unità 9: approccio ai testi letterari: il teatro<br />
Conoscenze Abilità/capacità<br />
Il testo teatrale:<br />
Conoscere le caratteristiche del testo teatrale<br />
le origini del teatro;<br />
Riconoscere la specificità del testo e del linguaggio<br />
testo e testo drammatico; dal testo scritto al testo rappresentato: drammatico<br />
la messinscena; il teatro come mimesi; gli elementi costitutivi Leggere e segmentare il testo drammatico<br />
del testo drammatico e la specificità del linguaggio drammatico; Individuare lo sviluppo interno ad un testo teatrale, il<br />
la segmentazione del testo drammatico.<br />
sistema dei personaggi ed il messaggio veicolato<br />
I generi del testo drammatico:<br />
dall’autore<br />
la tragedia; la commedia; la drammaturgia moderna<br />
Conoscere le origini e lo sviluppo dei generi teatrali<br />
Conoscere le caratteristiche strutturali e tematiche dei<br />
generi teatrali<br />
Confrontare temi e scelte stilistico- strutturali in autori<br />
diversi ed in generi diversi<br />
Confrontare testo narrativo e testo drammatico per<br />
evidenziarne le peculiarità ed esprimere giudizi motivati su<br />
due differenti linguaggi.<br />
Riscrivere in forma drammatica testi narrativi.<br />
Utilizzare più testi appartenenti a diverse tipologie testuali<br />
per illustrare e discutere una tesi (approccio al saggio<br />
breve)<br />
N.B.: I contenuti elencati nelle varie unità non devono necessariamente essere trattati in modo esaustivo, ma si<br />
potrà operare tra essi una selezione in base alle esigenze delle classi<br />
QUARTA E QUINTA GINNASIO<br />
CONTENUTI DISCIPLINARI DI LATINO<br />
Gli ambiti di studio della lingua: fonetica, morfologia e sintassi<br />
La fonetica<br />
L’alfabeto e la pronuncia del latino<br />
Cenni su alcune fondamentali leggi fonetiche latine<br />
La morfologia<br />
La scomposizione di una forma flessiva: radice, tema e desinenza; eventuali prefissi e suffissi.<br />
Il verbo: il sistema verbale latino; la struttura della voce verbale; il paradigma; l'opposizione del sistema dell'infectum e<br />
del perfectum; il sistema dei modi; la coniugazione regolare; verbi deponenti e semideponenti; verbi irregolari e<br />
difettivi.<br />
La flessione nominale: il concetto di caso e di declinazione; le cinque declinazioni.<br />
Gli aggettivi della prima e della seconda classe; gli aggettivi con declinazione pronominale; i gradi di intensità:<br />
comparativi e superlativi.<br />
I pronomi: personali, riflessivi, possessivi, determinativi, dimostrativi, relativi, interrogativi., indefiniti.<br />
Gli avverbi; formazione degli avverbi di modo; gradi di intensità.<br />
La sintassi<br />
A. Gli elementi strutturali della frase semplice latina<br />
La funzione del verbo come elemento gerarchicamente strutturante della frase.<br />
Le funzioni dei casi.<br />
I rapporti di dipendenza all’interno della frase: le concordanze verbo-soggetto, nome-aggettivo; le reggenze del verbo e<br />
del nome.<br />
La posizione delle parole nella frase latina: la collocazione del verbo, l’iperbato, il parallelismo ecc.<br />
Le funzioni attributiva e predicativa.<br />
Le determinazioni di luogo e le principali espansioni introdotte da preposizione.<br />
La struttura sintattica della frase passiva.<br />
Il passivo impersonale.<br />
La funzione delle congiunzioni coordinanti nella frase semplice.<br />
La comparazione: i termini del paragone, la funzione dell’aggettivo e dell’avverbio in grado comparativo, il secondo<br />
termine di paragone. La funzione del partitivo.<br />
La funzione coesiva dei pronomi.<br />
11
B. La funzione sintattica dei modi verbali<br />
Usi del congiuntivo: congiuntivo esortativo, desiderativo, concessivo, potenziale, suppositivo, irreale.<br />
L’infinito nelle funzioni di soggetto e nome del predicato e in dipendenza da verbi transitivi; l’infinito passivo in<br />
dipendenza da verbo servile.<br />
Le costruzioni del gerundio e del gerundivo; la perifrastica passiva.<br />
Il participio: la sua duplice natura verbale e nominale e la sua collocazione nei rapporti gerarchici della frase; il valore<br />
temporale relativo; participio attributivo e congiunto; ablativo assoluto. La costruzione perifrastica attiva.<br />
Il supino.<br />
C. La frase complessa<br />
Le congiunzioni coordinanti e subordinanti e la loro funzione nella strutturazione gerarchica della frase.<br />
La classificazione delle subordinate: completive, circostanziali, attributive.<br />
Valore assoluto e valore relativo dei tempi verbali, la consecutio temporum dell’indicativo e del congiuntivo.<br />
– Le subordinate completive<br />
Classificazione e differenze tra italiano e latino<br />
L’uso del riflessivo nelle completive<br />
Le subordinate infinitive oggettive e soggettive<br />
La subordinata completiva interrogativa indiretta; interrogative proprie e retoriche; interrogative disgiuntive.<br />
– La subordinata completiva volitiva<br />
– La volitiva coi verba timendi<br />
Le subordinate completive dichiarative introdotte da ut e ut non<br />
Completive introdotte da quod<br />
Frasi epesegetiche<br />
Le subordinate circostanziali<br />
causali, temporali, finali, concessive, consecutive, introdotte da cum col verbo al congiuntivo; il periodo ipotetico<br />
indipendente; la comparazione tra frasi: ut in funzione comparativa.<br />
Le subordinate attributive<br />
La funzione subordinante del pronome relativo; prolessi, attrazione, uso aggettivale del relativo; relative all’indicativo e<br />
al congiuntivo.<br />
Il lessico<br />
Il latino come lingua “madre” dell’italiano<br />
Riconoscere permanenze di elementi lessicali latini in italiano, anche attraverso la conoscenza di elementari processi di<br />
trasformazione fonetica che consentano di verificare autonomamente l’entità del fenomeno della derivazione da una<br />
lingua all’altra. Derivazione diretta e derivazione colta: esempi significativi.<br />
Storie di parole<br />
La formazione delle parole<br />
conoscenza di strumenti di produzione lessicale come prefissi e suffissi,<br />
Famiglie lessicali (parole derivate da radicali “forti”, come fac-, spec,- cap- ecc.).<br />
Avvio alla comprensione del rapporto tra lingua e cultura latina<br />
Analizzare il significato di termini indicativi della mentalità e del sistema dei valori (es. fides, ratio, virtus ecc.) anche<br />
contrastivamente rispetto all’italiano.<br />
Avvio all’uso del dizionario:<br />
la struttura del lemma; analisi ragionata di termini ad alta frequenza e lessicalmente complessi come peto, ago, duco<br />
ecc. ; le reggenze dei termini, in particolare dei verbi.<br />
Strumenti alternativi al dizionario: dizionari etimologici, lessici frequenziali.<br />
Il contesto<br />
Attivare collegamenti inter<strong>disciplinari</strong> con storia, per ricostruire il tessuto socio-politico in cui si è sviluppata la<br />
produzione letteraria (prevalentemente in relazione alla storiografia, genere da cui viene tratta la maggior parte dei testi<br />
oggetto di studio).<br />
12
QUARTA E QUINTA GINNASIO<br />
CONTENUTI DISCIPLINARI DI GRECO<br />
Gli ambiti di studio della lingua: fonetica, morfologia e sintassi<br />
La fonetica<br />
L’alfabeto e la pronuncia del greco<br />
La classificazione dei suoni: vocali, dittonghi, semivocali, consonanti<br />
L’accentazione e le sue leggi<br />
I segni diacritici<br />
Principali fenomeni fonetici: apofonia,incontro di due consonanti, assimilazione e dissimilazione delle aspirate,<br />
scomparsa dello jod e del digamma, contrazione di vocali, crasi, legge di Grassmann, legge di Osthoff<br />
La morfologia<br />
La scomposizione di una forma flessiva: radice, tema, desinenza e terminazione; eventuali prefissi e suffissi.<br />
Il sistema verbale greco: la coniugazione tematica e atematica.<br />
Il concetto di diatesi: diatesi attiva e medio-passiva. La struttura della voce verbale; desinenze primarie e secondarie<br />
attive e medio-passive, desinenze dell’imperativo e dell’infinito attive e medio-passive.<br />
Il sistema del presente: la coniugazione del presente dei verbi con coniugazione tematica (non contratti e contratti) e<br />
atematica.<br />
Il valore dei modi:indicativo,congiuntivo, ottativo, imperativo, infinito, participio.<br />
Le classi verbali e i temi temporali.<br />
Il sistema dell’aoristo: la diatesi attiva e media; la diatesi passiva.<br />
Il sistema del futuro: la diatesi attiva e media; la diatesi passiva.<br />
Il sistema del perfetto: la diatesi attiva e medio-passiva.<br />
La flessione: il concetto di caso e di declinazione;<br />
La flessione dell’articolo.<br />
La prima e seconda declinazione e loro particolarità.<br />
Sostantivi contratti di prima e seconda declinazione.<br />
La terza declinazione e sue particolarità.<br />
La flessione del participio.<br />
La prima e seconda classe degli aggettivi. Aggettivi contratti di prima classe. Aggettivi irregolari.<br />
I gradi di intensità degli aggettivi:comparativi e superlativi.<br />
I pronomi: personali, riflessivi, possessivi, dimostrativi, relativi, interrogativi, indefiniti e relativi-indefiniti. Il pronome<br />
reciproco, i pronomi correlativi.<br />
Gli avverbi; formazione degli avverbi di modo; gradi di intensità.<br />
I numerali: cardinali, ordinali,avverbi numerali.<br />
La sintassi<br />
A. Gli elementi strutturali della frase semplice greca<br />
La funzione del verbo come elemento gerarchicamente strutturante della frase.<br />
Le funzioni dei casi.<br />
La posizione delle parole nella frase greca: la collocazione del verbo, la posizione attributiva e la funzione dell’articolo<br />
(l’articolo come pronome dimostrativo, la funzione sostantivante dell’articolo).<br />
La concordanza: soggetto-verbo, sostantivo-articolo, sostantivo-attributo, apposizione.<br />
I valori dell’aggettivo:posizione attributiva, predicativa, aggettivo sostantivato, neutro avverbiale.<br />
Sintassi della comparazione:il secondo termine di paragone e il complemento partitivo, il comparativo assoluto,la<br />
comparatio compendiaria, rafforzativi di comparativi e superlativi.<br />
Le determinazioni di luogo e le principali espansioni introdotte da preposizione.<br />
La struttura sintattica della frase passiva.<br />
La funzione delle congiunzioni coordinanti nella frase semplice.<br />
Usi di μέν e δέ<br />
La funzione coesiva dei pronomi.<br />
Le proposizioni interrogative dirette<br />
B. La sintassi dei modi finiti e non finiti<br />
Usi dei modi: indicativo,congiuntivo, ottativo, imperativo. Le negazioni ου e μή.<br />
Gli usi di ¥n<br />
L’uso nominale dell’infinito: l’infinito sostantivato.<br />
L’uso verbale dell’infinito: soggetto, nome del predicato, infinito in dipendenza da verbi transitivi.<br />
Il participio: uso nominale (participio sostantivato e attributivo), uso verbale(congiunto, genitivo assoluto, predicativo,<br />
accusativo assoluto, participio con ¥n.<br />
13
C. La frase complessa<br />
Le congiunzioni coordinanti e subordinanti e la loro funzione nella strutturazione gerarchica della frase.<br />
La classificazione delle subordinate: completive, circostanziali, attributive.<br />
L’uso dei tempi e dei modi nell’ipotassi greca:il valore aspettuale del tempo e la differenza rispetto alla consecutio<br />
temporum latina e italiana<br />
Le subordinate completive<br />
Le subordinate dichiarative (in forma esplicita e implicita)<br />
Le subordinate interrogative indirette (semplici e doppie)<br />
Le subordinate rette dai verba timendi<br />
Le subordinate rette dai verba curandi,<br />
Le subordinate rette dai verba affectuum<br />
Le subordinate circostanziali<br />
causali, temporali, finali, concessive, consecutive, ipotetiche, comparative.<br />
Le subordinate attributive<br />
La funzione subordinante del pronome relativo; prolessi, attrazione, omissione del dimostrativo; relative proprie e<br />
improprie<br />
Il lessico<br />
Il greco lingua indoeuropea<br />
Quale greco studiamo?Cenni di storia della lingua:<br />
il Miceneo; la Grecia antica e i suoi dialetti; la κοινή διάλεκτος, il greco bizantino e il greco moderno.<br />
La formazione delle parole<br />
conoscenza di strumenti di produzione lessicale come prefissi e suffissi,<br />
Famiglie lessicali (parole derivate da radicali “forti”, come qh-qe-; leg-log; arch-; gen,gon,gn-; ecc.).<br />
Avvio alla comprensione del rapporto tra lingua e cultura greca<br />
Analizzare il significato di termini indicativi della mentalità e del sistema dei valori, o della organizzazione sociale (es.<br />
nomos, physis, arethe ghenos, polis ecc.), anche in relazione allo sviluppo della storia del mondo<br />
greco<br />
Avvio all’uso del dizionario:<br />
la struttura del lemma; analisi ragionata di termini ad alta frequenza che assumono sfumature di significato differenti<br />
con il variare della diatesi: histemi, peitho, phaino, apollumi ecc.;le reggenze dei termini, in<br />
particolare dei verbi.<br />
Strumenti alternativi al dizionario: dizionari etimologici, lessici frequenziali.<br />
Il contesto<br />
Attivare collegamenti inter<strong>disciplinari</strong> con storia, per ricostruire il tessuto socio-politico in cui si è sviluppata la<br />
produzione letteraria (prevalentemente in relazione alla storiografia, genere da cui viene tratta la maggior parte dei testi<br />
oggetto di studio).<br />
CONTENUTI DISCIPLINARI DI GEO-STORIA<br />
CLASSI QUARTE E QUINTE GINNASIALI<br />
Premessa: la tabella che segue non è una scansione sinottica dei contenuti di Storia e Geografia del biennio, ma solo<br />
un riepilogo che per comodità viene illustrato in modo parallelo, lasciando ai singoli insegnanti la scelta dei<br />
collegamenti e la distribuzione nell’arco dell’anno scolastico delle singole unità didattiche.<br />
I percorsi di Educazione alla Legalità e cittadinanza attiva vengono invece illustrati nella sezione specifica del POF.<br />
STORIA GEOGRAFIA<br />
La preistoria<br />
Il concetto di preistoria<br />
l'origine dell'uomo e il processo di ominazione<br />
economia, società e arte del Paleolitico<br />
le caratteristiche dell’economia di caccia e raccolta<br />
La rivoluzione neolitica e la trasmissione delle tecniche<br />
Le differenze fra società nomadi e sedentarie<br />
Le civiltà del vicino Oriente<br />
- la civiltà mesopotamica e le prime città<br />
- la civiltà egizia<br />
-i primi Indoeuropei<br />
- gli Ebrei<br />
Il sistema uomo-ambiente<br />
Il concetto di paesaggio antropico<br />
L’ecologia; il processo e gli agenti di modifica<br />
dell’equilibrio ambientale; l’uso delle risorse naturali da<br />
parte dell’uomo; l’impronta ecologica; guerre per l'acqua.<br />
Le fonti di energia: definizione di fonte energetica; fonti<br />
primarie e secondarie, rinnovabili e non rinnovabili; la<br />
geografia delle fonti non rinnovabili e le prospettive del<br />
loro impiego; prospettive dell’impiego delle fonti<br />
rinnovabili; lo sfruttamento dell’energia nel tempo. Il<br />
problema energetico e gli equilibri politici internazionali;<br />
guerre per il petrolio. Le manifestazioni e le cause del<br />
surriscaldamento del pianeta.<br />
14
La civiltà greca<br />
La civiltà minoica<br />
I Micenei<br />
Il “Medioevo Ellenico” e l’origine della polis<br />
Le tirannidi<br />
La seconda colonizzazione<br />
Sparta e l’oligarchia<br />
Atene e la nascita della democrazia<br />
Le Guerre Persiane<br />
La Guerra del Peloponneso<br />
La crisi della polis<br />
Il grande progetto di Alessandro Magno<br />
L’Ellenismo<br />
La civiltà romana<br />
– Le origini di Roma;<br />
– Il passaggio dalla monarchia alla repubblica;<br />
– L’egemonia nel Mediterraneo: le guerre puniche<br />
– la crisi della repubblica<br />
– l’età dei Gracchi e di Silla.<br />
– L’età cesariana<br />
– la fine della repubblica e le guerre civili<br />
– La riforma augustea;<br />
– la società imperiale;<br />
– l’età giulio-claudia;<br />
– l’età flavia;<br />
– Il principato adottivo e l’apogeo dell’impero.<br />
– I Severi e la crisi del III secolo<br />
– Diocleziano e la Tetrarchia<br />
L’età tardo antica<br />
– L’età Costantiniana<br />
– Teodosio<br />
– Le grandi migrazioni e i regni romano-germanici<br />
– La fine dell’impero romano d’Occidente e l’inizio del<br />
Medioevo<br />
L’età altomedievale<br />
– I Longobardi<br />
– I Franchi<br />
– L’Islam e la conquista araba<br />
– Carlo Magno e il Sacro Romano Impero<br />
La popolazione mondiale e il fenomeno delle migrazioni<br />
La storia della popolazione mondiale; la “transizione<br />
demografica”; popolazione e ambiente; l’urbanizzazione.<br />
I movimenti migratori: cause e conseguenze<br />
Le colonizzazioni e il colonialismo moderno; i caratteri<br />
dell’economia coloniale; i problemi economici dei paesi di<br />
“nuova indipendenza”.<br />
La Globalizzazione<br />
Il concetto di globalizzazione: la dimensione mondiale<br />
della produzione; la finanziarizzazione dell’economia; le<br />
società multinazionali; la delocalizzazione; il ruolo degli<br />
organismi economici internazionali; l’omogeneizzazione<br />
culturale mondiale; il dibattito sulla globalizzazione.<br />
Sviluppo e sottosviluppo<br />
La ripartizione della ricchezza nel mondo; il rapporto<br />
Nord-Sud:definizione del concetto; le economie del Sud<br />
del mondo; le società del Sud del mondo; scambi ineguali e<br />
indebitamento; il problema sanitario<br />
Regioni e Stati del mondo<br />
Analisi delle caratteristiche fisiche e climatiche, nonché dei<br />
problemi economici e sociali presenti nelle diverse aree del<br />
mondo.<br />
L’emergere di nuovi colossi politico-economici, con<br />
particolare riferimento all’impatto della produzione cinese<br />
nel mercato internazionale.<br />
L’Europa e il Mediterraneo<br />
La regione mediterranea, la regione mediorientale; le tappe<br />
che hanno portato alla nascita dell’Unione Europea; le<br />
principali istituzioni europee, analogie e differenze fra i<br />
paesi che si affacciano sul Mediterraneo.<br />
Culture e identità dei popoli<br />
I grandi spazi di civiltà: Africa subsahariana, Cina, India.<br />
La riscoperta dell’identità etnico-religioso-culturale:<br />
l’integralismo islamico; il ruolo del terrorismo di matrice<br />
islamica nelle dinamiche economico-politiche<br />
internazionali.<br />
Geopolitica<br />
Si potranno approfondire tematiche geopolitiche utili alla<br />
comprensione dell’attualità, qui di seguito indicate a titolo<br />
esemplificativo:<br />
L’emergere di nuovi colossi politico-economici, con<br />
particolare riferimento all’impatto della produzione cinese<br />
nel mercato internazionale.<br />
La “guerra fredda” e il sistema dei due blocchi; il crollo<br />
dell’URSS e le sue conseguenze; il processo di definizione<br />
di un nuovo equilibrio.<br />
Il processo di pace in Medio Oriente.<br />
15
Giudii<br />
o<br />
TABELLA DOCIMOLOGICA GEO-STORIA<br />
Imparare a imparare Conoscenza<br />
argomenti<br />
GI Studia in modo discontinuo e/o<br />
puramente mnemonico<br />
Non è sempre puntuale e/o completo<br />
nelle consegne<br />
Non utilizza in modo corretto gli<br />
strumenti di studio<br />
Non riesce a prendere appunti.<br />
Non riesce a correggere gli errori che<br />
gli vengono segnalati<br />
I Organizza lo studio in modo non<br />
pienamente autonomo.<br />
Non è puntuale e/o completo nelle<br />
consegne.<br />
Utilizza gli strumenti di studio in<br />
modo non pienamente adeguato.<br />
Trascrive solo in modo meccanico i<br />
contenuti di una lezione.<br />
Riassume in modo parziale, senza<br />
strutturare mappe delle idee. Solo<br />
guidato corregge gli errori che gli<br />
vengono segnalati.<br />
S Organizza lo studio in modo<br />
complessivamente autonomo.<br />
E’ puntuale nelle consegne anche se<br />
non sempre preciso.<br />
Utilizza gli strumenti di studio in<br />
modo complessivamente adeguato.<br />
Prende appunti, anche se non sempre<br />
in modo preciso.<br />
Fornisce sintesi essenziali e produce<br />
elementari mappe delle idee.<br />
Riesce a correggere eventuali errori<br />
segnalati.<br />
D Organizza lo studio in modo<br />
autonomo ed è puntuale nelle<br />
consegne.<br />
Utilizza gli strumenti di studio in<br />
modo adeguato.<br />
Produce chiare mappe delle idee, si<br />
orienta nel proprio percorso.<br />
E’ in grado di individuare e<br />
correggere eventuali errori.<br />
B Organizza lo studio in modo<br />
autonomo e organico.<br />
E’ puntuale e completo nelle<br />
consegne.<br />
Utilizza gli strumenti di studio in<br />
modo competente.<br />
Produce autonomamente articolate<br />
mappe delle idee.<br />
Ha conoscenze<br />
molto lacunose.<br />
Ha conoscenze<br />
superficiali.<br />
Conosce gli<br />
elementi essenziali<br />
della disciplina.<br />
Possiede<br />
conoscenze<br />
complete, ma non<br />
dettagliate.<br />
Possiede<br />
conoscenze<br />
complete e<br />
dettagliate.<br />
Comunicare Acquisire e<br />
interpretare<br />
Non ascolta in classe,<br />
risponde in modo non<br />
chiaro, non conosce gli<br />
elementi essenziali del<br />
lessico tecnico, non fornisce<br />
definizioni né è in grado di<br />
sostenere argomentazioni.<br />
ascolta passivamente,<br />
risponde in forma poco<br />
chiara, usa linguaggio poco<br />
appropriato, comprende in<br />
modo intuitivo, ma non<br />
fornisce definizioni. Riesce<br />
solo in parte a sostenere<br />
argomentazioni, ma non<br />
risponde a obiezioni<br />
Ascolta in modo attivo,<br />
risponde adeguatamente,<br />
conosce il lessico specifico<br />
essenziale, fornisce<br />
definizioni. Sostiene tesi<br />
molto semplici, risponde a<br />
obiezioni molto circoscritte.<br />
Ascolta in modo attivo,<br />
interviene autonomamente,<br />
padroneggia lessico tecnico<br />
e definizioni. Riconosce il<br />
valore dei termini chiave e<br />
in quali contesti esso sia<br />
rilevante. Sostiene tesi<br />
articolate e risponde a<br />
obiezioni semplici<br />
ascolta in modo attivo,<br />
interviene autonomamente,<br />
padroneggia con sicurezza<br />
lessico tecnico e definizioni.<br />
Riconosce gli ambiti<br />
linguistici e si orienta negli<br />
spostamenti semantici.<br />
Sostiene organicamente una<br />
tesi e risponde a obiezioni<br />
l’informazione<br />
Non ricava<br />
informazioni da<br />
cartine, tabelle,<br />
schemi.<br />
Non coglie il<br />
significato<br />
fondamentale dai testi<br />
(libro di testo, articoli<br />
di approfondimento)<br />
Ricava informazioni<br />
frammentarie da<br />
cartine, tabelle,<br />
grafici, schemi.<br />
Coglie in modo<br />
impreciso e<br />
superficiale il<br />
significato dei testi<br />
(libro di testo, articoli<br />
di approfondimento)<br />
Fatica a distinguere<br />
informazione<br />
quantitativa,<br />
informazione<br />
discorsiva,<br />
valutazione critica<br />
Ricava informazioni<br />
basilari da cartine,<br />
schemi ecc.<br />
Coglie in modo<br />
essenziale il<br />
significato dei testi<br />
(libro di testo, articoli<br />
di approfondimento)<br />
Distingue in modo<br />
complessivamente<br />
pertinente<br />
informazione da<br />
interpretazione<br />
Ricava informazioni<br />
coerenti da cartine,<br />
schemi ecc.<br />
Distingue<br />
informazione e<br />
valutazione critica.<br />
Ascolta e valuta i<br />
giudizi dei compagni.<br />
Ricava informazioni<br />
dettagliate dagli<br />
strumenti a sua<br />
disposizione. Integra<br />
le proprie conoscenze<br />
ricorrendo a<br />
strumenti<br />
extrascolastici<br />
(internet,<br />
16
O Organizza lo studio in modo<br />
autonomo e organico.<br />
E’ puntuale e completo nelle<br />
consegne.<br />
Utilizza gli strumenti di studio in<br />
modo competente.<br />
Produce in modo autonomo e<br />
competente complesse mappe delle<br />
idee.<br />
Possiede<br />
conoscenze<br />
complete e<br />
approfondite.<br />
Ascolta in modo attivo,<br />
interviene in modo<br />
autonomo, padroneggia con<br />
sicurezza lessico tecnico e<br />
definizioni. Ha<br />
consapevolezza etimologica<br />
e si orienta negli spostamenti<br />
semantici. Muove obiezioni<br />
ed è in grado di addurre<br />
argomenti a sostegno di tesi<br />
originali.<br />
videodocumenti,<br />
altro).<br />
Distingue in modo<br />
coerente<br />
informazione<br />
quantitativa,<br />
informazione<br />
discorsiva e<br />
interpretazione.<br />
Ricava informazioni<br />
approfondite dagli<br />
strumenti specifici<br />
della disciplina.<br />
elabora proprie<br />
strategie di giudizio e<br />
costruzione di un<br />
sapere critico.<br />
Condivide in modo<br />
responsabile le<br />
proprie conoscenze e<br />
i propri strumenti di<br />
informazione.<br />
17
ITALIANO LICEO<br />
Proposte sugli obiettivi formativi e di contenuto il cui raggiungimento si ritiene essenziale per poter formulare una<br />
valutazione positiva.<br />
1) Consolidamento e affinamento della capacità linguistico-espressive nell’àmbito dell’esposizione sia scritta che<br />
orale.<br />
Requisiti fondamentali:<br />
correttezza grammaticale, sintattica e ortografica;<br />
proprietà lessicale nell’ambito di registri linguistici differenziati;<br />
capacità di strutturare organicamente e coerentemente il discorso;<br />
capacità di impostare (e sostenere) un discorso di tipo argomentativo.<br />
2) Acquisizione di abilità di analisi, interpretazione e comprensione di testi letterari, atte alla formazione di un lettore<br />
consapevole.<br />
Requisiti fondamentali:<br />
comprensione delle strutture linguistiche di un testo letterario tale da consentirne la corretta parafrasi e<br />
l’esposizione del significato a partire da quello letterale, come base necessaria per accedere a più approfonditi<br />
livelli di interpretazione;<br />
individuazione delle componenti specificamente letterarie del testo a partire dal riconoscimento delle forme<br />
metriche, delle strutture retoriche, dei caratteri propri dei diversi generi lirico, drammatico, narrativo;<br />
acquisizione e memorizzazione dei dati necessari alla contestualizzazione del testo, in rapporto alla<br />
collocazione storica e culturale di autori e opere.<br />
Il raggiungimento di tali obiettivi può considerarsi comune per le classi I e II, fermo restando che sarà legittimo<br />
attendersi dal discente che procede nello studio sistematico dei fenomeni letterari in prospettiva storica un progressivo<br />
accrescimento delle capacità di collegamento, di approfondimento, di rielaborazione personale dei dati, fino a pervenire<br />
a quella riflessione critica che costituirà l’obiettivo della classe finale.<br />
Al di là di questi parametri di riferimento si dovrà tenere conto del fatto che ogni classe si presenta con una diversa<br />
fisionomia e che ogni alunno si pone all’interno della classe con caratteristiche proprie e con una propria storia, che non<br />
dovranno essere trascurate nella valutazione. In particolare sarà opportuno valutare positivamente questi aspetti:<br />
l’abitudine alla lettura personale extrascolastica e l’interesse per le problematiche culturali, non esclusivamente<br />
letterarie;<br />
l’attitudine e l’interesse per la disciplina, l’assiduità e l’attenzione prestata alle lezioni;<br />
l’impegno di studio e la propensione al miglioramento e alla progressiva acquisizione di un metodo organico di<br />
lavoro personale.<br />
CANONE DEGLI AUTORI DELLA LETTERATURA ITALIANA LA CUI LETTURA È RITENUTA<br />
IMPRESCINDIBILE NEL TRIENNIO (cf. verbale n. 19 del 15/9/2000)<br />
Dante, Petrarca e Boccaccio;<br />
Machiavelli, Guicciardini, Ariosto, Tasso;<br />
Goldoni, Parini, Alfieri;<br />
Foscolo, Manzoni, Leopardi;<br />
Verga, Pascoli, D’Annunzio;<br />
Svevo, Pirandello;<br />
Saba, Ungaretti e Montale;<br />
Marino, Monti e Carducci, come altri, sono lasciati all’iniziativa dei singoli docenti.<br />
Per quanto concerne la Divina Commedia di Dante, per la lettura dei vari canti dell’Inferno e del Purgatorio, ci si atterrà<br />
ai programmi ministeriali; per il Paradiso si individuano come irrinunciabili i canti I, III, VI, XI, XVII e XXXIII.<br />
18
TABELLA DOCIMOLOGICA DELLE PROVE SCRITTE DI ITALIANO LICEO<br />
Analisi del testo<br />
Tipologia A<br />
a) Competenze linguistico-espressive<br />
Ortografia<br />
Morfosintassi<br />
Punteggiatura<br />
Lessico<br />
Registro<br />
b) Competenze di organizzazione testuale<br />
Coerenza<br />
Coesione<br />
c) Competenze relative al tipo testuale<br />
Comprensione globale<br />
Comprensione analitica<br />
Interpretazione<br />
Insuff. Mediocre Sufficiente Più che suff. Discr./Buono Buono/Ottimo<br />
Contestualizzazione<br />
Votazione 3-4 5 6 6,5 7-8 9-10<br />
Votazione 5-8 9 10 11 12-13 14-15<br />
Scrittura Documentata<br />
Tipologia B<br />
a) Competenze linguistico-espressive<br />
Ortografia<br />
Morfosintassi<br />
Punteggiatura<br />
Lessico<br />
Registro<br />
Insuff. Mediocre Sufficiente Più che suff. Discr./Buono Buono/Ottimo<br />
b) Competenze di organizzazione testuale<br />
Coerenza<br />
Coesione<br />
c) Competenze relative al tipo testuale<br />
Rispetto dei vincoli comunicativi<br />
(destinatario, scopo, collocaz., estens.)<br />
Utilizzo della documentazione<br />
(comprens., selezione, interpretaz.)<br />
Eventuale integrazione dei dati con<br />
informazioni congruenti<br />
Votazione 3-4 5 6 6,5 7-8 9-10<br />
Votazione 5-8 9 10 11 12-13 14-15<br />
Tema<br />
Insuff. Mediocre Sufficiente Più che suff. Discr./Buono Buono/Ottimo<br />
Tipologia C e D<br />
a) Competenze linguistico-espressive<br />
Ortografia<br />
Morfosintassi<br />
Punteggiatura<br />
Lessico<br />
Registro<br />
b) Competenze di organizzazione testuale<br />
Coerenza<br />
Coesione<br />
c) Competenze relative al tipo testuale<br />
Pertinenza rispetto alla traccia<br />
Efficacia delle argomentazioni<br />
Votazione 3-4 5-8 5 9 6 10 6,5 11 7-8 12-13 9-10 14-15<br />
Votazione<br />
5-8 9 10 11 12-13 14-15<br />
19
TABELLA DOCIMOLOGICA DELLE PROVE ORALI DI ITALIANO LICEO<br />
Livello di<br />
apprendimento<br />
Insuff. Mediocre Sufficiente Discreto Buono Ottimo Eccellente<br />
voto in decimi 3-4 5 6 7 8 9 10<br />
voto in<br />
trentesimi<br />
PARAMETRI<br />
Conoscenze<br />
Rielaborazione<br />
critica<br />
Capacità di<br />
collegamento<br />
Abilità<br />
espressive<br />
12-15 16-19 20 21-23 24-25 26-28 29-30<br />
LATINO E GRECO: CLASSI LICEALI<br />
OBIETTIVI<br />
L’insegnamento del latino e del greco nel triennio si basa su due piani, quello storico-letterario e quello linguistico; il<br />
primo, incentrato sulla lettura di testi in lingua originale, è la finalità principale<br />
e attraverso un lavoro multidisciplinare (filologia, storia antica, critica letteraria, antropologia, storia<br />
dell’arte) diventa studio della cultura classica, il secondo è lo strumento indispensabile per una conoscenza autentica di<br />
essa; questa distinzione condiziona in modo significativo le scelte metodologiche e la valutazione dei risultati finali.<br />
Gli obiettivi <strong>disciplinari</strong>, quelli che hanno la funzione di organizzare in modo coerente gli<br />
argomenti di storia letteraria e i testi (o tradotti o letti in traduzione) e avviare ad uno studio della<br />
cultura interdisciplinare, sono i seguenti:<br />
ricostruzione dell’ambiente storico-culturale;<br />
studio dei generi letterari e dei loro statuti;<br />
analisi di temi significativi all’interno dei prodotti letterari;<br />
studio della lingua come strumento per la lettura dei testi.<br />
Gli obiettivi formativi sono i seguenti.<br />
(la differenza nei diversi anni è data dalla progressiva complessità degli argomenti su cui si esercitano)<br />
Obiettivi massimi<br />
Capacità di analizzare e tradurre dal greco e dal latino un testo non noto, rendendolo in una forma italiana appropriata e<br />
consapevole degli aspetti stilistici e tematici legati all'autore e al periodo storico;<br />
capacità di analizzare ed interpretare i testi, di cogliere relazioni con altri testi o col contesto, di cogliere le specificità<br />
del genere letterario e il rapporto con la sua tradizione;<br />
capacità di sintetizzare e rielaborare conoscenze di storia letteraria, con collegamenti di tipo sincronico e diacronico, di<br />
organizzarle in chiare esposizioni o di utilizzarle per argomentazioni coerenti<br />
capacità di esprimere un proprio giudizio critico argomentato sui testi letti;<br />
capacità di esprimersi in modo corretto, specifico nel linguaggio, coerentemente col quesito proposto, documentando i<br />
propri giudizi.<br />
Obiettivi minimi<br />
Capacità di orientarsi in un testo non noto e di cogliere anche parzialmente il senso del brano, dimostrando conoscenza<br />
teorica dei fenomeni grammaticali, anche se non necessariamente autonomia di traduzione; capacità di istituire relazioni<br />
tra il testo da tradurre e le conoscenze di storia letteraria attraverso il riconoscimento di parole-chiave significative;<br />
consapevolezza delle analisi, interpretazioni, relazioni proposte dall'insegnante;<br />
conoscenza degli argomenti di storia letteraria trattati e capacità di utilizzo a livello espositivo;<br />
capacità di esprimersi in modo corretto, specifico nel linguaggio, coerentemente col quesito proposto, documentando i<br />
propri giudizi<br />
CONTENUTI<br />
Ambito linguistico<br />
Nel corso del triennio si affrontano il ripasso, il consolidamento e l’approfondimento della morfosintassi trattata nel<br />
biennio; una uniforme definizione dei contenuti per tutte le sezioni è impossibile, perché la distribuzione della materia è<br />
diversa, a seconda dei libri di testo adottati; comunque considerati requisiti ineludibili alla fine del biennio un bagaglio<br />
20
minimo di conoscenze teoriche (v. coordinamento ginnasio-liceo) e la capacità di tradurre brani di tipo narrativo<br />
attraverso l’analisi delle strutture e il riconoscimento del lessico fondamentale.<br />
Ambito storico-letterario<br />
Lo studio storico-letterario si basa soprattutto sulla lettura diretta dei testi, sia in lingua originale, sia<br />
in traduzione; rispetta a grandi linee la scansione cronologica di tipo tradizionale, ma non<br />
necessariamente è di tipo sistematico e può svilupparsi intorno a nuclei tematici di tipo sincronico o<br />
diacronico.<br />
La quantità dei brani di prosa o dei versi da leggere e commentare è determinata dal livello di apprendimento delle<br />
singole classi o dalle scelte di approfondimento, quindi variabile.<br />
Ad livello esemplificativo, nelle classe terza si prevede per il latino la lettura per la poesia di un minimo di 150 versi e<br />
per la prosa,di una scelta antologica di brani Tacito e di Seneca; in greco si leggeranno un minimo di 350 versi di una<br />
tragedia e una scelta antologica di passi filosofici. La quantità dei testi in prosa dovrà attenersi a criteri di esaustività,<br />
ma non è determinabile secondo parametri rigidamente numerici.<br />
Possono variare anche il rapporto in termini quantitativi fra poesia e prosa o la scelta degli autori in relazione alle<br />
decisioni del docente, tenendo conto di quanto previsto dalle indicazioni nazionali.<br />
METODI, STRUMENTI, ATTIVITÀ DI RECUPERO<br />
Metodi: lezione frontale per introdurre e raccordare le diverse unità didattiche, per guidare alla lettura-traduzione dei<br />
testi e alla comprensione dei diversi aspetti testuali; lavoro individuale da parte degli studenti di lettura di testi e di saggi<br />
critici e discussioni collettive condotte in classe;<br />
attività di ricerca individuale o di gruppo.<br />
Strumenti di uso quotidiano sono manuali scolastici, saggi critici, classici anche in edizione economica, strumenti di<br />
consultazione per lo studio delle lingue classiche; si utilizzano anche sussidi audiovisivi e informatici; indispensabile,<br />
comunque, l’uso di fotocopie.<br />
L’attività di recupero viene programmata nel corso dell’anno a seconda delle esigenze delle diverse<br />
classi; generalmente orientata al recupero di lacune di tipo grammaticale e difficoltà nella traduzione, può essere<br />
affrontata sia all’interno delle lezioni curricolari con attività differenziate o<br />
di ripasso collettivo sia con corsi di recupero pomeridiani o per gruppi o sotto forma di sportello;<br />
sarebbero auspicabili attività di recupero trasversali, per gruppi di studenti di sezioni diverse o anche di classi diverse,<br />
individuati da comuni difficoltà.<br />
Strumenti di verifica e criteri di valutazione<br />
Gli strumenti di verifica sono di diverso tipo, e non rigidamente distinti per la misurazione finale<br />
del voto scritto e orale, ma diversamente valutati a seconda delle diverse abilità e competenze che<br />
intendono registrare.<br />
I tipi di verifica sono i seguenti:<br />
traduzioni di brani d’autore non noti, ma preferibilmente collegati al discorso letterario in atto, ed eventualmente<br />
corredati di note-guida alla traduzione e di quesiti di critica testuale o letteraria; devono essere in numero non inferiore a<br />
due nel trimestre e non inferiore a tre nel pentamestre; possono variare nell’ultimo anno, a seconda delle esigenze<br />
richieste dall’imminenza dell’esame;<br />
test sul tipo della tipologia A o B della terza prova dell’esame di stato, per verificare l’acquisizione dei contenuti di<br />
storia letteraria e il grado di riutilizzo per l’analisi dei testi oppure la conoscenza dei brani d’autore programmati, con<br />
relative tematiche; i quesiti possono proporre o quesiti di storia letteraria o brani da tradurre e commentare, partendo<br />
dalle parole-chiave significative, o testi di critica da spiegare e documentare e possono essere scanditi secondo percorsi<br />
ben delineati, attraverso domande di contenuto e di interpretazione;<br />
colloqui per verificare le conoscenze di storia letteraria e la lettura critica dei testi.<br />
I criteri di valutazione sono diversi a seconda delle prove e delle abilità che queste comportano: nelle prove di<br />
traduzione il grado di sufficienza viene determinato a posteriori, sulla base della risposta complessiva della classe ai<br />
singoli compiti, e non secondo criteri quantitativi, quali il numero di errori di grammatica; è legato alla capacità di<br />
cogliere una certa coerenza nel testo ed eventuali relazioni fra questo e il discorso storico-letterario, anche se non<br />
attraverso la totale comprensione del brano e la sua resa in italiano;<br />
i test misurano, con un sistema di punteggio differenziato:<br />
1- l’acquisizione dei contenuti;<br />
2- la capacità di analisi, interpretazione e rielaborazione;<br />
3- la proprietà linguistica;<br />
il grado di sufficienza è calcolato sui contenuti se utilizzati in modo coerente col quesito, anche se non reinterpretati<br />
criticamente;<br />
nelle interrogazioni orali la sufficienza è calcolata sulla correttezza delle informazioni, sulla consapevolezza delle<br />
analisi condotte dall’insegnante, sulla conoscenza degli argomenti trattati e la capacità di utilizzo a livello espositivo,<br />
sulla proprietà di linguaggio.<br />
21
TABELLA DOCIMOLOGICA DELLE PROVE SCRITTE DI LATINO E GRECO LICEO<br />
A- Comprensione delle strutture:<br />
1- sintassi;<br />
2- morfologia<br />
B- Comprensione del significato:<br />
1- comprensione del significato dei singoli periodi;<br />
2- comprensione del legame logico tra i diversi periodi e del significato complessivo del brano<br />
C- Resa in lingua italiana :<br />
1- traduzione in un testo italiano coeso, formalmente corretto ed appropriato nel lessico<br />
Griglia in quindicesimi<br />
indicatori descrittori Punti<br />
A- Comprensione delle strutture Ottima (6)<br />
(tot. 6)<br />
Buona (5,5)<br />
Errori anche gravi, ma scarsi (5/4,5)<br />
Errori anche numerosi, ma isolati (4/3,5)<br />
Errori concatenati (3/2,5)<br />
Gravi errori e diffusi (2/1,5)<br />
Errori molto gravi e lacune (1/0,5)<br />
………..<br />
B- Comprensione del significato Ottima (6)<br />
(tot. 6)<br />
Buona (5,5)<br />
Con fraintendimenti isolati (5/4,5)<br />
Complessivamente coerente, nonostante fraintendimenti (4/3,5)<br />
Disorganica (3/2,5)<br />
Compromessa, incoerente (2/1,5)<br />
Gravemente incoerente (1/0,5)<br />
…………..<br />
C- Resa in lingua italiana Fluida e personale, lessico appropriato (3/2,5)<br />
(tot. 3)<br />
Sostanzialmente corretta (2)<br />
Scorretta (1)<br />
………….<br />
votoxxx<br />
Griglia in decimi<br />
indicatori descrittori Punti<br />
A- Comprensione delle strutture Ottima (4)<br />
(tot. 4)<br />
Buona (3,5)<br />
Errori anche gravi, ma scarsi (3)<br />
Errori anche numerosi, ma isolati (2,5)<br />
Errori concatenati (2)<br />
Gravi errori e diffusi (1,5)<br />
Errori molto gravi e lacune (1)<br />
………..<br />
B- Comprensione del significato Ottima (4)<br />
(tot.4)<br />
Buona (3,5)<br />
Con fraintendimenti isolati (3)<br />
Complessivamente coerente, nonostante fraintendimenti (2,5)<br />
Disorganica (2)<br />
Compromessa, incoerente (1,5)<br />
Gravemente incoerente (1/0,5)<br />
…………..<br />
C- Resa in lingua italiana Fluida e personale, lessico appropriato (2/1,5)<br />
(tot. 2)<br />
Sostanzialmente corretta (1)<br />
Scorretta (0,5)<br />
………….<br />
votox<br />
22
A PARTE PRIMA<br />
PRIMO BIENNIO<br />
OBIETTIVI SPECIFICI<br />
PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE DI INGLESE<br />
Lo studente dovrà acquisire competenze linguistico-comunicative corrispondenti al livello B1 del Quadro Comune<br />
Europeo di Riferimento per le lingue. In particolare dovrà:<br />
comprendere in modo globale e selettivo testi orali e scritti su argomenti noti inerenti alla sfera personale e<br />
sociale;<br />
analizzare semplici testi orali, scritti, iconico-grafici ecc. su argomenti di attualità, letteratura, cinema, arte,<br />
ecc.<br />
Sarà curata la competenza trasversale della comprensione dei testi scritti, di tipologia e livello adeguato<br />
a ogni ordine di classi ( A2 e B1). Si assumeranno come riferimento i seguenti quattro indicatori da verificare<br />
trasversalmente con i colleghi di altre materie : 1. comprendere e rispettare esattamente le consegne<br />
2. fare deduzioni e inferenze logiche ( lavorando sulle<br />
informazioni implicite, facendo ipotesi sul significato di una<br />
parola a partire dal contesto logico-sintattico )<br />
3. riconoscere l’argomento centrale del testo e dei singoli<br />
paragrafi<br />
4. raccogliere dati e generalizzare/definire<br />
riferire fatti e descrivere situazioni con pertinenza lessicale in testi orali e scritti, lineari e coesi;<br />
partecipare a conversazioni e interagire nella discussione in maniera adeguata al contesto;<br />
riflettere sugli elementi linguistici con riferimento a fonologia, morfologia, sintassi e lessico, anche in<br />
un’ottica comparativa con la lingua italiana;<br />
analizzare e mettere a confronto aspetti della propria cultura con aspetti relativi alla cultura dei paesi in cui la<br />
lingua è parlata.<br />
CLASSE IV GINNASIO<br />
COMPRENSIONE ORALE E SCRITTA<br />
Saper comprendere informazioni dirette e concrete su argomenti quotidiani (famiglia, acquisti, lavoro,<br />
ambiente circostante, cinema, musica, TV, attualità).<br />
Saper comprendere e seguire istruzioni brevi e semplici.<br />
Saper comprendere il senso generale di un testo breve di argomento conosciuto, letto ad alta voce.<br />
Capire ed estrarre informazioni essenziali da brevi dialoghi su argomenti di vita quotidiana.<br />
PRODUZIONE ORALE E SCRITTA<br />
Saper interagire durante una conversazione su argomenti familiari (famiglia, routine quotidiana, interessi,<br />
tempo libero, esperienze personali).<br />
Saper stabilire e mantenere contatti sociali (saluti, presentazioni, ringraziamenti, scuse, inviti ecc.)<br />
Saper fornire semplici descrizioni su una varietà di argomenti familiari che rientrano nel proprio campo di<br />
interesse.<br />
Saper raccontare un evento, un’esperienza personale, una storia.<br />
Saper descrivere immagini (disegni, foto)<br />
Saper utilizzare in modo adeguato le strutture grammaticali.<br />
23
CLASSE V GINNASIO<br />
COMPRENSIONE ORALE E SCRITTA<br />
Capire istruzioni pratiche su semplici procedure da seguire o indicazioni precise espresse chiaramente.<br />
Saper comprendere i punti principali di una conversazione di una certa lunghezza su argomenti familiari,<br />
relativi a: scuola, tempo libero, lavoro, vacanze, differenze culturali, shopping, moda, cronaca, a condizione<br />
che il discorso sia articolato in modo chiaro e avvenga nella lingua standard.<br />
Saper comprendere brevi narrazioni e saper capire i punti essenziali di una storia.<br />
Saper leggere velocemente brevi testi (es. notizie in breve) e trovare fatti e informazioni importanti.<br />
PRODUZIONE ORALE E SCRITTA<br />
Saper sostenere una conversazione semplice su argomenti familiari o di interesse personale.<br />
Saper interagire in situazioni di vita quotidiana (viaggio, negozi, alberghi).<br />
Saper chiedere e seguire indicazioni.<br />
Saper interagire nei contatti sociali esprimendo la propria opinione, il proprio accordo o disaccordo con<br />
semplici motivazioni.<br />
Saper raccontare i punti essenziali di una storia o di un’esperienza vissuta.<br />
Saper scrivere lettere informali e semplici lettere formali.<br />
Descrivere persone e luoghi conosciuti e scrivere semplici storie.<br />
Saper utilizzare in modo adeguato le strutture grammaticali.<br />
La metodologia di lavoro comprenderà strategie, diversificate in base alle caratteristiche dei gruppi classe, tali da<br />
favorire lo sviluppo di competenze comunicative e sociali; fra queste, gli insegnanti hanno individuato come efficace e<br />
produttiva quella del co-operative learning: gli alunni lavorano alla realizzazione di compiti assegnati a piccoli gruppi<br />
con incarichi specifici e sono impegnati nella restituzione all’intera classe del lavoro all’interno del loro gruppo di<br />
lavoro.<br />
SECONDO BIENNIO<br />
OBIETTIVI SPECIFICI<br />
Lo studente dovrà acquisire competenze linguistico-comunicative corrispondenti al livello B2 del Quadro Comune<br />
Europeo di Riferimento. In particolare dovrà:<br />
comprendere in modo globale, selettivo e dettagliato testi orali/scritti riguardanti la sfera personale e sociale,<br />
l’attualità e la letteratura;<br />
Sarà curata la competenza trasversale della comprensione dei testi scritti, di tipologia e livello adeguato<br />
a ogni ordine di classi ( B1 e B2). Si assumeranno come riferimento i seguenti quattro indicatori da verificare<br />
trasversalmente con i colleghi di altre materie : 1. comprendere e rispettare esattamente le consegne<br />
2. fare deduzioni e inferenze logiche (lavorando sulle<br />
informazioni implicite, facendo ipotesi sul significato di<br />
una parola a partire dal contesto logico-sintattico)<br />
3. riconoscere una tesi o l’argomento centrale del testo e<br />
dei singoli paragrafi<br />
4. raccogliere dati e generalizzare/definire<br />
riferire fatti, descrivere situazioni e sostenere opinioni con le opportune argomentazioni in testi orali articolati<br />
e testi scritti strutturati e coesi;<br />
partecipare a conversazioni e interagire nella discussione, anche con parlanti nativi, in maniera adeguata sia<br />
agli interlocutori sia al contesto;<br />
riflettere sul sistema e sugli usi linguistici della lingua straniera, anche al fine di acquisire una consapevolezza<br />
delle analogie e differenze con la lingua italiana;<br />
utilizzare adeguatamente la lingua straniera per lo studio e l’apprendimento di altre discipline;<br />
analizzare e approfondire aspetti relativi alla cultura dei paesi in cui si parla la lingua;<br />
leggere, analizzare e interpretare testi letterari, di epoche diverse<br />
24
CLASSE PRIMA LICEO<br />
COMPRENSIONE ORALE E SCRITTA<br />
Saper comprendere i punti principali di un discorso su argomenti familiari e di attualità, relativi alla scuola, al<br />
tempo libero, alla vita familiare e sociale, a condizione che il discorso sia articolato in modo chiaro e avvenga<br />
nella lingua standard.<br />
Saper capire nella loro globalità i messaggi orali contenuti in un film, in una rappresentazione teatrale, in<br />
un’intervista radiofonica in lingua standard.<br />
Saper comprendere nella loro globalità articoli e resoconti su temi di attualità, nonché testi letterari.<br />
Saper comprendere le parti fondamentali di un testo di letteratura non conosciuto.<br />
PRODUZIONE ORALE E SCRITTA<br />
Saper utilizzare in modo adeguato le strutture grammaticali.<br />
Saper partecipare a una conversazione di una certa lunghezza su argomenti familiari o di interesse personale e<br />
su temi di attualità.<br />
Saper esporre il proprio punto di vista, motivandolo mediante semplici spiegazioni.<br />
Saper raccontare in modo abbastanza chiaro una storia, un’esperienza o un avvenimento collegando<br />
logicamente i concetti.<br />
Saper scrivere in maniera comprensibile su temi relativi ai propri interessi personali, saper descrivere<br />
esperienze, avvenimenti.<br />
Saper descrivere persone, luoghi e immagini.<br />
Saper scrivere semplici storie, racconti, articoli.<br />
Saper scrivere lettere informali e formali.<br />
Saper rispondere a domande relative alle parti fondamentali di un testo di letteratura o attualità già noto.<br />
Saper rispondere a semplici domande relative alle parti fondamentali di un testo di letteratura non conosciuto.<br />
CLASSE SECONDA LICEO<br />
COMPRENSIONE ORALE E SCRITTA<br />
Saper comprendere i punti principali di un discorso su argomenti familiari e di attualità, relativi alla scuola, al<br />
tempo libero, alla vita familiare e sociale, a condizione che il discorso sia articolato in modo chiaro e avvenga<br />
nella lingua standard.<br />
Saper capire i punti essenziali dei messaggi orali contenuti in un film, in una rappresentazione teatrale, in<br />
un’intervista dal vivo a condizione che il discorso avvenga nella lingua standard.<br />
Saper comprendere i nuclei essenziali di articoli e resoconti su temi di attualità.<br />
Saper comprendere e fare semplici analisi di testi letterari.<br />
Saper comprendere le parti fondamentali di un testo di letteratura non conosciuto.<br />
PRODUZIONE ORALE E SCRITTA<br />
Saper utilizzare in modo adeguato le strutture grammaticali.<br />
Saper partecipare a una conversazione di una certa lunghezza su argomenti familiari o di interesse personale e<br />
su temi di attualità.<br />
Saper esporre chiaramente il proprio punto di vista, motivandolo mediante spiegazioni e commenti.<br />
Saper riassumere testi orali e scritti (d’uso e letterari) e fornire informazioni a riguardo.<br />
Saper raccontare una storia, un’esperienza o un avvenimento collegando logicamente i concetti e le sequenze.<br />
Saper scrivere in maniera sostanzialmente corretta su temi relativi all’attualità, letteratura, film e concerti.<br />
Saper scrivere brevi storie, racconti, articoli.<br />
Saper scrivere lettere informali e formali.<br />
Saper rispondere a semplici domande relative alle parti fondamentali di un testo di letteratura non conosciuto.<br />
La metodologia di lavoro comprenderà strategie, diversificate in base alle caratteristiche dei gruppi classe, tali da<br />
favorire lo sviluppo di competenze comunicative e sociali; fra queste, gli insegnanti hanno individuato come efficace e<br />
produttiva quella del co-operative learning: gli alunni lavorano alla realizzazione di compiti assegnati a piccoli gruppi<br />
con incarichi specifici e sono impegnati nella restituzione all’intera classe del lavoro all’interno del loro gruppo di<br />
lavoro.<br />
25
QUINTO ANNO<br />
OBIETTIVI SPECIFICI<br />
Lo studente, in possesso di abilità e competenze linguistico-comunicative corrispondenti al livello B2 del Quadro<br />
Comune Europeo di Riferimento, dovrà consolidare il proprio metodo di studio nell’uso della lingua straniera per<br />
l’apprendimento di contenuti non linguistici.<br />
Si porrà attenzione allo studio di testi relativi ad ambiti <strong>disciplinari</strong> diversi (ambiti storico sociale,artistico e letterario).<br />
CLASSE TERZA LICEO<br />
COMPRENSIONE ORALE E SCRITTA<br />
Saper comprendere nella loro globalità saggi, documenti e testi letterari svolti in programma.<br />
Saper comprendere con l’aiuto del dizionario monolingue testi non conosciuti, relativi al programma svolto.<br />
PRODUZIONE ORALE E SCRITTA<br />
Saper scrivere una trattazione sintetica di argomenti relativi al programma svolto, in maniera sostanzialmente<br />
corretta, utilizzando in modo adeguato le strutture grammaticali<br />
Saper riassumere testi letterari, saggi e documenti.<br />
Saper collocare un testo e un autore nel contesto storico, sociale e letterario.<br />
Saper tracciare le caratteristiche di un’epoca.<br />
PROFILO IN USCITA<br />
Alla fine del corso di studi gli alunni sono in grado di:<br />
a. padroneggiare la lingua inglese a livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento relativamente ai<br />
seguenti ambiti:<br />
- contesti di interazione che implicano comunicazioni orali e scritte<br />
- comprensione e analisi di testi di varia tipologia<br />
- analisi e critica di testi letterari che vengono compresi in relazione al contesto storico-<br />
culturale<br />
b. stabilire nessi con culture europee ed extra-europee e operare confronti fra la lingua inglese ed altre lingue<br />
moderne e antiche.<br />
c. utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare e comunicare.<br />
26
Griglia di valutazione delle produzioni scritte di biennio e triennio<br />
TABELLA di VALUTAZIONE : WRITING A LETTER<br />
CONTENT 3: caratteristiche di originalità<br />
2: contenuto adeguato<br />
1.5: contenuto parziale<br />
1: contenuto scarso<br />
ACCURACY 5: ottimo<br />
4: buono<br />
3: sufficiente<br />
2.5: scarso<br />
2-1: gravemente insufficiente<br />
RANGE OF VOCABULARY 3: lessico specifico e ricco<br />
2: lessico adeguato<br />
1: errori lessicali (2 errori)<br />
ORGANIZATION and COHESION 1: organizzazione corretta<br />
1: adeguato uso dei connettivi (dare 0<br />
se non è stato usato neanche un<br />
APPROPRIATENESS of<br />
REGISTER and FORMAT<br />
connettivo)<br />
1: divisione in paragrafi<br />
1: registro linguistico adeguato (il<br />
punto si attribuisce solo se non c’è<br />
neanche un errore di registro)<br />
POINTS /15<br />
TABELLA di VALUTAZIONE : WRITING A STORY<br />
CONTENT 3: contenuto esauriente e ricco<br />
/caratteristiche di originalità<br />
2: contenuto adeguato<br />
1.5 : contenuto parziale<br />
1: contenuto scarso<br />
ACCURACY 5: ottimo<br />
4: buono<br />
3: sufficiente<br />
2.5: scarso<br />
2-1: gravemente insufficiente<br />
RANGE OF VOCABULARY 3: lessico specifico e ricco<br />
2: lessico adeguato e qualche errore<br />
1: lessico non adeguato e /o molti<br />
errori<br />
ORGANIZATION and COHESION 1: organizzazione corretta e<br />
affermazioni pertinenti<br />
1: adeguato uso dei connettivi (dare 0<br />
se non è stato usato neanche un<br />
APPROPRIATENESS of<br />
REGISTER and FORMAT<br />
connettivo)<br />
0.5: divisione in paragrafi e registro<br />
linguistico adeguato<br />
0.5: rispetto del numero di parole<br />
POINTS /15<br />
/3<br />
/5<br />
/3<br />
/2<br />
/2<br />
/3<br />
/5<br />
/3<br />
/3<br />
/1<br />
27
TABELLA di VALUTAZIONE : WRITING AN ARTICLE / AN ESSAY<br />
CONTENT 3: contenuto esauriente e ricco<br />
/caratteristiche di originalità<br />
2: contenuto adeguato<br />
1.5 : contenuto parziale<br />
TABELLA di VALUTAZIONE : WRITING A REPORT<br />
CONTENT 3 : contenuto esauriente e ricco<br />
2: contenuto adeguato<br />
1.5 : contenuto parziale<br />
1: contenuto scarso<br />
ACCURACY 5: ottimo<br />
4: buono<br />
3: sufficiente<br />
2.5: scarso<br />
2-1: gravemente insufficiente<br />
RANGE OF VOCABULARY 3: lessico specifico e ricco<br />
2: lessico adeguato e qualche errore<br />
1: lessico non adeguato e /o molti errori<br />
ORGANIZATION and COHESION 1: organizzazione corretta e affermazioni<br />
pertinenti<br />
1: adeguato uso di connettivi<br />
APPROPRIATENESS OF REGISTER<br />
AND FORMAT<br />
1: contenuto scarso<br />
ACCURACY 5: ottimo<br />
4: buono<br />
3: sufficiente<br />
2.5: scarso<br />
2-1: gravemente insufficiente<br />
RANGE OF VOCABULARY 3: lessico specifico e ricco<br />
2: lessico adeguato e qualche errore<br />
1: lessico non adeguato e /o molti<br />
errori<br />
ORGANIZATION and COHESION 1: organizzazione corretta e<br />
affermazioni pertinenti<br />
1: adeguato uso dei connettivi (dare 0<br />
se non è stato usato neanche un<br />
APPROPRIATENESS of<br />
REGISTER and FORMAT<br />
connettivo)<br />
0.5: divisione in paragrafi<br />
0: inadeguatezza o omissione<br />
0.5: rispetto del numero di parole<br />
1: registro linguistico adeguato (il<br />
punto si attribuisce solo se non c’è<br />
neanche un errore di registro)<br />
0: 1 o più errori di registro<br />
POINTS /15<br />
1: divisione in paragrafi titolati<br />
0: inadeguatezza o omissione<br />
1: registro linguistico adeguato<br />
0: 1 o più errori di registro<br />
POINTS /15<br />
/3<br />
/5<br />
/3<br />
/2<br />
/2<br />
/3<br />
/ 5<br />
/3<br />
/2<br />
/2<br />
28
INDICATORI<br />
1.Comprensione<br />
del testo<br />
2. Conoscenza<br />
dei contenuti<br />
3. Correttezza<br />
grammaticale e<br />
sintattica<br />
4. Correttezza<br />
lessicale<br />
5. Capacità di<br />
analisi, sintesi e<br />
rielaborazione<br />
Esame di Stato<br />
Griglia di valutazione della terza prova scritta<br />
( punteggio massimo 15/15 ; sufficienza 10/15 )<br />
PUNTEGGIO<br />
MASSIMO<br />
1<br />
3<br />
5<br />
3<br />
3<br />
LIVELLI DI<br />
VALUTAZIONE<br />
scarsa<br />
adeguata<br />
completa<br />
scarsa<br />
adeguata<br />
completa<br />
scarsa<br />
mediocre<br />
sufficiente<br />
discreta<br />
buona<br />
ottima<br />
scarsa<br />
adeguata<br />
completa<br />
scarsa<br />
adeguata<br />
completa<br />
PUNTEGGIO<br />
CORRISPONDENTE AI<br />
LIVELLI<br />
0<br />
0.5<br />
1<br />
1<br />
2<br />
3<br />
1<br />
1.5-3<br />
3.5<br />
4<br />
4.5<br />
5<br />
1<br />
2<br />
3<br />
1<br />
2<br />
3<br />
PUNTEGGIO<br />
ATTRIBUITO<br />
ALL’INDICA<br />
TORE<br />
/1<br />
/3<br />
/5<br />
/3<br />
/3<br />
29
OBIETTIVI COMUNI STORIA TRIENNIO<br />
PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE DI STORIA TRIENNIO<br />
PRIMA LICEO<br />
A - Acquisizione di competenze lessicali relative al grado di sviluppo cognitivo della disciplina.<br />
B - Acquisizione di abilità di lettura e comprensione dì testi storici, a partire dal manuale.<br />
C - Acquisizione di consapevolezza critica del significato della storia.<br />
D - Acquisizione di un metodo adeguato a schematizzare, memorizzare e sintetizzare i dati.<br />
E - Acquisizione di capacità espositive e argomentative.<br />
SECONDA LICEO<br />
A - Consolidamento delle competenze lessicali relative al grado di sviluppo cognitivo della disciplina.<br />
B - Consolidamento delle abilità di lettura e comprensione di testi storici.<br />
C- Consolidamento della consapevolezza critica del significato della storia e dei rapporti tra passato e presente.<br />
D - Acquisizione della capacità di collocare le fonti, i documenti e i testi storiografici nel loro contesto di riferimento e<br />
di individuare gli elementi essenziali per la loro interpretazione.<br />
E - Acquisizione di capacità di ricostruire percorsi logici complessi.<br />
F - Consolidamento delle capacità espositive e argomentative.<br />
TERZA LICEO<br />
A - Consolidamento della capacità di usare in termini appropriati e critici il lessico storiografico.<br />
B - Consolidamento delle abilità di lettura e comprensione di testi storici e storiografici.<br />
C- Consolidamento della consapevolezza critica del significato della storia e dei rapporti tra passato e presente.<br />
D - Consolidamento della capacità di collocare le fonti, i documenti e i testi storiografici nel loro contesto di riferimento<br />
e di individuare gli elementi essenziali per la loro interpretazione.<br />
E - Consolidamento della capacità di ricostruire percorsi logici complessi.<br />
F - Acquisizione di competenze di problematizzazione e attualizzazione della storia.<br />
G - Consolidamento delle capacità espositive e argomentative.<br />
CONTENUTI DELL’INSEGNAMENTO DI STORIA (TRIENNIO)<br />
Le indicazioni che seguono sono base di orientamento per la programmazione dei singoli insegnanti<br />
Prima liceo<br />
In coerenza con le Indicazioni nazionali la prima liceo è dedicata, in continuità con il biennio precedente, allo studio del<br />
processo di formazione dell’Europa e del suo aprirsi ad una dimensione globale tra medioevo ed età moderna, nell’arco<br />
cronologico che va dall’XI secolo fino alla metà del Seicento.<br />
È prevista la trattazione dei seguenti temi caratterizzanti:<br />
i diversi aspetti della rinascita dell’XI secolo;<br />
i poteri universali (Papato e Impero), comuni e monarchie;<br />
la Chiesa e i movimenti religiosi;<br />
società ed economia nell’Europa basso medievale;<br />
la crisi dei poteri universali e l’avvento delle monarchie territoriali e delle Signorie;<br />
le scoperte geografiche e le loro conseguenze;<br />
la definitiva crisi dell’unità religiosa dell’Europa;<br />
la costruzione degli stati moderni e l’assolutismo.<br />
In questo ambito l’insegnante sviluppa percorsi di approfondimento anche inter<strong>disciplinari</strong> con analisi di fonti e testi<br />
storiografici.<br />
Seconda liceo<br />
La seconda liceo è dedicata allo studio della seconda età moderna in un arco cronologico che va dalla metà del Seicento<br />
a fine Ottocento.<br />
È prevista la trattazione dei seguenti temi caratterizzanti:<br />
lo sviluppo dell’economia fino alla rivoluzione industriale;<br />
le rivoluzioni politiche del Sei-Settecento (inglese, americana, francese);<br />
l’età napoleonica e la Restaurazione;<br />
il problema della nazionalità nell’Ottocento, il Risorgimento italiano e l’Italia unita;<br />
l’Occidente degli Stati-Nazione;<br />
la questione sociale e il movimento operaio;<br />
la seconda rivoluzione industriale;<br />
30
l’imperialismo e il nazionalismo;<br />
lo sviluppo dello Stato italiano fino alla fine dell’Ottocento.<br />
In questo ambito l’insegnante sviluppa percorsi di approfondimento anche inter<strong>disciplinari</strong> con analisi di fonti e testi<br />
storiografici.<br />
Terza liceo<br />
L’ultimo anno è dedicato allo studio dell’epoca contemporanea, dall’analisi delle premesse della I guerra mondiale fino<br />
ai giorni nostri.<br />
È prevista la trattazione dei seguenti temi caratterizzanti del primo Novecento:<br />
l’inizio della società di massa in Occidente;<br />
l’età giolittiana;<br />
la prima guerra mondiale;<br />
la rivoluzione russa e l’URSS da Lenin a Stalin;<br />
la crisi del dopoguerra;<br />
il fascismo;<br />
la crisi del ’29 e le sue conseguenze negli Stati Uniti e nel mondo;<br />
il nazismo;<br />
la shoah e gli altri genocidi del XX secolo;<br />
la seconda guerra mondiale;<br />
l’Italia dal Fascismo alla Resistenza e le tappe di costruzione della democrazia repubblicana.<br />
Per il secondo Novecento la trattazione verte su tre fondamentali blocchi tematici:<br />
dalla “guerra fredda” alle svolte di fine Novecento;<br />
decolonizzazione e lotta per lo sviluppo in Asia, Africa e America latina;<br />
la storia d’Italia nel secondo dopoguerra.<br />
In questo ambito l’insegnante sviluppa percorsi di approfondimento anche inter<strong>disciplinari</strong> con analisi di fonti e testi<br />
storiografici.<br />
VALUTAZIONE STORIA LICEO<br />
Al termine del triennio lo studente<br />
1. conosce le linee principali dello sviluppo economico, politico e culturale della storia dell’Europa e dell’Italia nel<br />
quadro della storia globale del mondo,<br />
2. usa in maniera appropriata il lessico e le categorie interpretative proprie della disciplina,<br />
3. sa argomentare una tesi in forma scritta e/o orale,<br />
4. sa leggere e valutare fonti e testi storiografici,<br />
5. sa riflettere criticamente sul valore della storia in quanto radice del presente e della propria identità.<br />
Si considera sufficiente il raggiungimento dei punti 1, 2, 3.<br />
Per quanto riguarda i criteri di valutazione dal 2 al 10 si rimanda alla tabella docimologica generale.<br />
OBIETTIVI COMUNI FILOSOFIA<br />
PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE DI FILOSOFIA<br />
PRIMA LICEO<br />
A - Acquisizione di competenze lessicali relative al grado di sviluppo cognitivo della disciplina.<br />
B - Acquisizione di abilità di lettura e comprensione diretta dei testi antologici o integrali, quando non particolarmente<br />
complessi, per individuare le idee centrali e le strategie argomentative scelte dall’autore.<br />
C - Acquisizione di capacità di ricostruzione di percorsi logici complessi, con particolare riferimento alla capacità di<br />
costruire schemi, mappe e riassunti.<br />
D - Acquisizione di capacità di contestualizzazione storica delle problematiche trattate.<br />
E - Acquisizione di capacità espositive e argomentative adeguate allo sviluppo della disciplina.<br />
SECONDA LICEO<br />
A - Consolidamento della competenza lessicale relativa al grado di sviluppo cognitivo della disciplina.<br />
B - Consolidamento delle abilità di lettura, analisi e comprensione diretta dei testi antologici o integrali.<br />
C - Consolidamento delle capacità di ricostruzione di percorsi logici complessi.<br />
D - Consolidamento delle capacità di contestualizzazione storica delle problematiche trattate.<br />
E - Acquisizione di capacità di costruire confronti <strong>disciplinari</strong> fra autori e fra concetti.<br />
F - Consolidamento delle capacità espositive e argomentative<br />
31
TERZA LICEO<br />
A - Acquisizione della capacità di usare in termini appropriati e critici il lessico filosofico.<br />
B - Acquisizione della capacità di analizzare criticamente testi filosofici.<br />
C - Consolidamento della capacità di ricostruire percorsi logici complessi.<br />
D - Consolidamento della capacità di contestualizzare le problematiche trattate e di elaborare relazioni tra il passato e il<br />
presente.<br />
E - Consolidamento della capacità di costruire confronti fra autori e fra concetti.<br />
F - Consolidamento delle capacità espositive e argomentative.<br />
G - Capacità di intervenire in termini congrui e con autonomia di critica in discussioni generali.<br />
CONTENUTI DELL’INSEGNAMENTO DI FILOSOFIA<br />
Le indicazioni che seguono sono base di orientamento per la programmazione dei singoli insegnanti<br />
Prima liceo<br />
In coerenza con le Indicazioni nazionali durante la prima liceo lo studente acquisisce familiarità con la specificità del<br />
sapere filosofico, apprendendone il lessico fondamentale, imparando a comprendere e ad esporre in modo organico le<br />
idee e i sistemi di pensiero oggetto di studio.<br />
Gli autori esaminati e i percorsi didattici afferiscono a un ambito cronologico che va dalle origini della filosofia greca<br />
(VI-V secolo a.C.) all’esaurimento della filosofia scolastica e medievale (XIV secolo).<br />
Nell’ambito della filosofia antica è prevista la trattazione dei seguenti argomenti e/o autori:<br />
le filosofie presocratiche e i sofisti;<br />
Socrate e Platone;<br />
Aristotele;<br />
le filosofie ellenistico-romane;<br />
il neoplatonismo.<br />
Nell’ambito della filosofia tardo-antica e medievale:<br />
il rapporto fede-ragione (religione cristiana e filosofia greca);<br />
la patristica e Agostino;<br />
la scolastica;<br />
Tommaso e l’aristotelismo;<br />
la crisi della scolastica.<br />
In questo ambito l’insegnante sceglie percorsi di approfondimento che permettano anche un primo contatto diretto degli<br />
studenti con i grandi testi della tradizione filosofica.<br />
Seconda liceo<br />
In seconda liceo lo studente utilizza il lessico e le categorie specifiche della filosofia per comprendere e contestualizzare<br />
gli sviluppi del pensiero dal XV al XIX secolo.<br />
È prevista la trattazione dei seguenti argomenti e autori:<br />
le filosofie dell’Umanesimo-Rinascimento;<br />
la rivoluzione scientifica in Bacone e Galilei;<br />
il pensiero politico moderno da Hobbes a Rousseau;<br />
le metafisiche razionaliste di Cartesio, Spinoza e Leibniz;<br />
religione e storia in Vico e Pascal;<br />
l’empirismo e Hume;<br />
l’Illuminismo e Kant;<br />
il romanticismo, l’idealismo tedesco e Hegel.<br />
In questo ambito l’insegnante sceglie percorsi di approfondimento basati anche sulla lettura diretta dei grandi testi della<br />
tradizione filosofica. Si sottolinea che l’ultimo punto viene spesso, di necessità, posticipato all’anno successivo.<br />
Terza liceo<br />
L’ultimo anno è dedicato principalmente alla filosofia contemporanea, tra XIX e XX secolo. Lo studente apprende<br />
l’utilizzo delle categorie filosofiche per l’analisi critica dei problemi della vita e della società contemporanee.<br />
In molti casi la programmazione inizia con il romanticismo, l’idealismo tedesco e Hegel.<br />
È poi prevista la trattazione dei seguenti argomenti e autori dell’Ottocento:<br />
la reazione all’idealismo in Schopenhauer, Kierkegaard, Marx;<br />
il positivismo e i suoi sviluppi;<br />
Nietzsche.<br />
Per quanto riguarda il Novecento le Indicazioni nazionali suggeriscono una scelta tra i seguenti temi e autori:<br />
Husserl e la fenomenologia;<br />
32
Freud e la psicanalisi;<br />
Heidegger e l’esistenzialismo;<br />
il neoidealismo italiano;<br />
Wittgenstein e la filosofia analitica;<br />
vitalismo e pragmatismo;<br />
la filosofia d'ispirazione cristiana e la nuova teologia;<br />
interpretazioni e sviluppi del marxismo, in particolare di quello italiano;<br />
temi e problemi di filosofia politica;<br />
gli sviluppi della riflessione epistemologica;<br />
la filosofia del linguaggio;<br />
l'ermeneutica filosofica.<br />
VALUTAZIONE FILOSOFIA<br />
Al termine del triennio lo studente<br />
1. conosce i punti nodali dello sviluppo del pensiero occidentale,<br />
2. utilizza correttamente il lessico e le categorie specifiche della disciplina,<br />
3. sa argomentare una tesi in forma scritta e/o orale,<br />
4. ha gli strumenti per leggere e interpretare un testo,<br />
5. sa riflettere criticamente sulle grandi domande della filosofia anche in riferimento alla propria esperienza di vita.<br />
Si considera sufficiente il raggiungimento dei punti 1, 2, 3.<br />
Per quanto riguarda i criteri di valutazione dal 2 al 10 si rimanda alla tabella docimologica generale.<br />
33
Classe IV<br />
PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE DI MATEMATICA<br />
PROGRAMMA COMUNE DI DIPARTIMENTO: CONTENUTI E OBIETTIVI MINIMI<br />
I numeri naturali Giustificare l’affermazione che N è ordinato.<br />
Rappresentare numeri naturali sulla retta.<br />
Le quattro operazioni Distinguere operatori, operandi, risultato.<br />
Distinguere le operazioni interne dalle altre.<br />
Riconoscere l’impossibilità di dividere per 0.<br />
I multipli e i divisori Definire “multiplo” e “divisore”.<br />
Ricordare i criteri di divisibilità per 2, 5, 3, 9.<br />
Definire il concetto di numero primo .<br />
Scomporre numeri naturali in fattori primi .<br />
Le potenze Definire l’operazione di elevamento a potenza.<br />
Riconoscere i casi particolari a 1 e a 0 .<br />
Le proprietà delle operazioni Riconoscere l’ordine di priorità delle operazioni.<br />
Svolgere semplici espressioni in N.<br />
Enunciare le proprietà algebriche in forma simbolica e<br />
verbale.<br />
Riconoscere il raccoglimento a fattore comune come<br />
conseguenza della proprietà distributiva.<br />
Le proprietà delle potenze Enunciare le proprietà delle potenze.<br />
Applicare le proprietà delle potenze in semplici espressioni.<br />
Il MCD e il mcm Determinare MCD e mcm di due numeri naturali.<br />
I sistemi di numerazione Interpretare un numero in notazione decimale come<br />
polinomio nelle potenze di 10.<br />
I numeri interi Riconoscere numeri concordi e discordi.<br />
Determinare l’opposto e il valore assoluto di un numero.<br />
Rappresentare numeri interi sulla retta.<br />
Confrontare numeri interi.<br />
Le operazioni con i numeri interi Enunciare le regole per l’esecuzione delle quattro operazioni<br />
in Z.<br />
Svolgere semplici espressioni in Z.<br />
Determinare il segno di una potenza con esponente naturale.<br />
Le leggi di monotonia Enunciare le leggi di monotonia.<br />
Scrivere uguaglianze o disuguaglianze a partire da una<br />
uguaglianza o disuguaglianza data.<br />
Applicare le leggi di cancellazione.<br />
Le frazioni e i numeri razionali Classificare frazioni.<br />
Distinguere frazioni equivalenti.<br />
Ridurre una frazione ai minimi termini.<br />
Ridurre più frazioni a mcd.<br />
Riconoscere un numero razionale.<br />
Confrontare due frazioni.<br />
Rappresentare numeri razionali sulla retta.<br />
Le operazioni con i numeri razionali Eseguire operazioni tra frazioni.<br />
Elevare una frazione a esponente naturale.<br />
Svolgere semplici espressioni in Q.<br />
Le potenze con esponente intero Interpretare potenze con esponente intero.<br />
Svolgere semplici espressioni in Q in cui compaiano potenze<br />
con esponente intero.<br />
34
Le percentuali e le proporzioni Determinare la percentuale assegnata di una quantità data.<br />
Applicare la proprietà fondamentale delle proporzioni.<br />
I numeri decimali Determinare il numero decimale corrispondente a una<br />
frazione assegnata.<br />
Interpretare numeri decimali periodici.<br />
Determinare la frazione corrispondente a un numero<br />
decimale finito.<br />
I monomi Definire un monomio.<br />
Riconoscere un monomio.<br />
Ridurre un monomio in forma normale.<br />
Individuare il coefficiente, la parte letterale e il grado di un<br />
monomio.<br />
Le operazioni con i monomi Eseguire somme e prodotti di monomi.<br />
Determinare la divisibilità di un monomio per un altro.<br />
I polinomi Definire un polinomio.<br />
Ridurre un polinomio in forma normale.<br />
Individuare il grado di un polinomio.<br />
Le operazioni con i polinomi Semplificare somme algebriche di polinomi.<br />
Moltiplicare un monomio per un polinomio.<br />
Moltiplicare due polinomi fra loro.<br />
I prodotti notevoli Ricordare lo sviluppo dei prodotti notevoli “somma per<br />
differenza” e “quadrato di un binomio”.<br />
Svolgere lo sviluppo dei prodotti notevoli “somma per<br />
differenza” e “quadrato di un binomio”.<br />
Svolgere semplici espressioni sull’insieme dei polinomi, nelle<br />
quali compaiano anche i più semplici prodotti notevoli.<br />
Le funzioni polinomiali Riconoscere una funzione polinomiale in una variabile.<br />
Verificare gli zeri di una funzione polinomiale.<br />
Gli enti geometrici e i postulati Riconoscere definizioni, enti primitivi, postulati, teoremi.<br />
Enunciare i postulati di appartenenza e di ordinamento della<br />
retta.<br />
Definire i termini “semiretta”, “segmento”, “angolo”,<br />
“figure congruenti”, “segmenti consecutivi”, “segmenti<br />
adiacenti”, “angoli consecutivi”, “angoli adiacenti”.<br />
Classificare angoli.<br />
Le operazioni su segmenti e angoli Determinare la somma di due segmenti e un multiplo<br />
assegnato di un segmento.<br />
Determinare la somma di due angoli.<br />
I teoremi e le dimostrazioni Distinguere ipotesi e tesi in teorema.<br />
Distinguere enunciato e dimostrazione di un teorema.<br />
I triangoli e le loro proprietà Individuare gli elementi di un triangolo.<br />
Definire e individuare bisettrici, mediane, altezze.<br />
Classificare triangoli.<br />
I primi due criteri di congruenza Enunciare i primi due criteri di congruenza.<br />
Applicare i primi due criteri di congruenza in casi semplici.<br />
Il triangolo isoscele Enunciare il teorema del triangolo isoscele e il suo inverso.<br />
Enunciare e dimostrare il teorema della bisettrice nel<br />
triangolo isoscele.<br />
Il terzo criterio di congruenza Enunciare (e dimostrare) il terzo criterio di congruenza.<br />
Applicare il terzo criterio di congruenza in casi semplici.<br />
Le disuguaglianze triangolari Enunciare il primo teorema dell’angolo esterno.<br />
Enunciare le disuguaglianze triangolari.<br />
35
Le rette perpendicolari Definire i termini “rette perpendicolari”, “distanza di un<br />
punto da una retta”, “asse di un segmento”.<br />
Le rette parallele Definire il termine “rette parallele”.<br />
I teoremi delle parallele Enunciare il teorema delle parallele con il suo inverso.<br />
Gli angoli interni nei triangoli Enunciare e dimostrare il teorema sulla somma degli angoli<br />
interni di un triangolo.<br />
Enunciare i criteri di congruenza dei triangoli rettangoli.<br />
Le proprietà dei parallelogrammi Enunciare le condizioni necessarie e sufficienti perché un<br />
quadrilatero sia un parallelogramma.<br />
Applicare le proprietà dei parallelogrammi alla<br />
dimostrazione di semplici teoremi.<br />
I quadrilateri Enunciare le proprietà fondamentali del rettangolo, del<br />
rombo, del quadrato e del trapezio.<br />
Il piano cartesiano Distinguere gli elementi di un piano cartesiano.<br />
I segmenti nel piano cartesiano Determinare analiticamente lunghezza e punto medio di un<br />
segmento di estremi dati.<br />
L’equazione della retta Tracciare il grafico di una equazione lineare.<br />
Il coefficiente angolare Interpretare coefficiente angolare e termine noto.<br />
Gli insiemi e le loro rappresentazioni (Definire il termine “insieme”)<br />
Interpretare i simboli ∅ e ∈.<br />
Interpretare la rappresentazione di un insieme in forma<br />
grafica, per elencazione e per proprietà caratteristica (casi<br />
semplici).<br />
Tradurre la rappresentazione di un insieme da una forma<br />
all’altra.<br />
Verificare l’inclusione di un insieme in un altro.<br />
Interpretare il simbolo ⊂.<br />
Le operazioni con gli insiemi Determinare l’intersezione e l’unione di due insiemi.<br />
Determinare il prodotto cartesiano di due insiemi.<br />
La partizione di un insieme Definire il termine “partizione”.<br />
Le relazioni binarie Interpretare la rappresentazione di una relazione.<br />
Le relazioni sugli insiemi Definire le proprietà riflessiva, simmetrica, transitiva,<br />
antiriflessiva e antisimmetrica.<br />
Le relazioni di equivalenza e di ordine Definire il termine “relazione di equivalenza”.<br />
Le funzioni Definire il termine “funzione”, “dominio”, “codominio”.<br />
Individuare dalle rappresentazioni grafiche dominio,<br />
codominio, immagini di una funzione.<br />
Individuare funzioni biunivoche, iniettive, suriettive.<br />
Le funzioni numeriche Riconoscere esempi di funzioni numeriche.<br />
Particolari funzioni numeriche Definire le funzioni di proporzionalità diretta, inversa,<br />
quadratica e la funzione lineare.<br />
Determinare valori particolari di una funzione numerica<br />
elementare.<br />
Tracciare il grafico di una funzione numerica elementare.<br />
Le identità e le equazioni Definire i termini “identità” e “equazione”.<br />
Verificare la soluzione di un’equazione.<br />
Classificare equazioni.<br />
I principi di equivalenza Enunciare i principi di equivalenza delle equazioni.<br />
36
Le equazioni numeriche intere Risolvere semplici equazioni numeriche intere di primo<br />
grado.<br />
Distinguere equazioni determinate, indeterminate e<br />
impossibili.<br />
Le equazioni letterali intere Determinare la soluzione di semplici equazioni lineari intere.<br />
Le diseguaglianze numeriche Enunciare le proprietà delle diseguaglianze.<br />
Le disequazioni numeriche intere Determinare l’insieme delle soluzioni di semplici<br />
disequazioni numeriche intere di primo grado.<br />
I sistemi di disequazioni Determinare l’insieme delle soluzioni di un sistema di due<br />
disequazioni numeriche intere di primo grado (in forma<br />
normale.)<br />
La risoluzione di problemi lineari Tradurre un semplice problema lineare in un’equazione e<br />
determinarne la soluzione.<br />
Il campione e la popolazione Distinguere campione e popolazione in un esempio.<br />
I caratteri qualitativi e quantitativi Distinguere caratteri qualitativi e quantitativi.<br />
La frequenza, le classi e le tabelle Determinare frequenza e frequenza relativa di un valore in<br />
una popolazione di dati.<br />
Organizzare una popolazione di dati in classi di frequenza<br />
secondo le indicazioni assegnate.<br />
Gli istogrammi e gli aerogrammi Rappresentare una popolazione di dati con un istogramma.<br />
Interpretare un istogramma.<br />
I diagrammi a dispersione Interpretare un diagramma a dispersione.<br />
La media aritmetica e ponderata Calcolare la media aritmetica di un gruppo di dati.<br />
Calcolare una semplice media ponderata.<br />
La mediana e la moda Determinare la mediana e la moda di piccole popolazioni di<br />
dati.<br />
Il foglio elettronico Creare, compilare e salvare un foglio elettronico con soli<br />
dati numerici.<br />
I software di geometria dinamica Eseguire e salvare semplici costruzioni geometriche.<br />
Classe V<br />
L’estrazione di radice Definire l’operazione di radice ennesima.<br />
L’irrazionalità di √2 Enunciare il teorema dell’irrazionalità di √2.<br />
Rappresentare sulla retta il punto di ascissa √2.<br />
Le successioni approssimanti Distinguere valori approssimati per difetto e per eccesso di<br />
un numero irrazionale.<br />
I numeri decimali illimitati non periodici Distinguere numeri decimali illimitati non periodici da<br />
numeri periodici o finiti.<br />
Definire i termini “numero irrazionale” e “numero reale”.<br />
I radicali in R0 +<br />
Interpretare le parti di un radicale.<br />
Enunciare le condizioni di esistenza dei radicali.<br />
Controllare le condizioni di esistenza di un radicale.<br />
Enunciare la proprietà invariantiva.<br />
Semplificare un radicale.<br />
Ridurre più radicali allo stesso indice.<br />
Confrontare radicali.<br />
Le operazioni con i radicali Calcolare il prodotto e il quoziente di radicali.<br />
Trasportare un fattore fuori del segno di radice.<br />
Determinare la potenza di un radicale.<br />
Eseguire la somma algebrica di radicali simili.<br />
37
La razionalizzazione Razionalizzare una frazione il cui denominatore sia un<br />
radicale quadratico semplice.<br />
Le potenze con esponente razionale Interpretare potenze con esponente razionale come radicali e<br />
viceversa.<br />
L’estensione e l’equivalenza Definire la relazione di equivalenza fra superfici.<br />
Definire l’equiscomponibilità.<br />
Le equivalenze nei parallelogrammi Enunciare e dimostrare il teorema sull’equivalenza nei<br />
parallelogrammi.<br />
Enunciare il corollario del rettangolo.<br />
Enunciare e dimostrare il teorema sull’equivalenza del<br />
triangolo e del parallelogramma.<br />
Enunciare e dimostrare il teorema sull’equivalenza del<br />
triangolo e del trapezio.<br />
I teoremi di Euclide Enunciare i teoremi di Euclide.<br />
Riconoscere in un triangolo rettangolo le equivalenze date<br />
dai teoremi di Euclide.<br />
Il teorema di Pitagora Enunciare e dimostrare il teorema di Pitagora.<br />
Le classi di grandezze Definire il concetto di classe di grandezze omogenee.<br />
Le grandezze commensurabili e non Definire i termini “grandezze commensurabili” e “grandezze<br />
incommensurabili”.<br />
Individuare la misura di una grandezza in funzione di<br />
un’altra.<br />
Enunciare il teorema di incommensurabilità di lato e<br />
diagonale nel quadrato.<br />
I rapporti fra grandezze Definire il rapporto e la proporzione fra grandezze<br />
omogenee.<br />
Il teorema di Talete Definire gli insiemi di grandezze direttamente proporzionali.<br />
Enunciare il teorema di Talete.<br />
Enunciare e dimostrare il teorema della retta parallela a un<br />
lato di un triangolo.<br />
Le trasformazioni e gli invarianti Definire i termini “trasformazione geometrica”, “identità”,<br />
“trasformazione inversa”, “invariante”.<br />
La traslazione Descrivere le proprietà di un vettore.<br />
Definire la traslazione di vettore assegnato.<br />
Applicare una traslazione di vettore assegnato.<br />
Comporre due traslazioni.<br />
La rotazione Definire la rotazione.<br />
Applicare una rotazione di angolo assegnato.<br />
La simmetria centrale Definire la simmetria centrale.<br />
Applicare una simmetria di dato centro.<br />
La simmetria assiale Definire la simmetria assiale.<br />
Applicare una simmetria di dato asse.<br />
Le trasformazioni e la congruenza Definire le isometrie.<br />
L’omotetia Definire l’omotetia.<br />
Applicare un’omotetia di centro e rapporto assegnato.<br />
Le figure simili Definire la similitudine.<br />
Individuare gli elementi omologhi in figure simili.<br />
I criteri di similitudine nei triangoli Enunciare i criteri di similitudine.<br />
Applicare i criteri di similitudine a casi semplici.<br />
38
L’equazione della retta. Ricavare la forma esplicita dalla forma implicita.<br />
Tracciare il grafico di una retta di data equazione.<br />
Determinare il coefficiente angolare di una retta passante<br />
per due punti.<br />
La condizione di parallelismo Enunciare la condizione di parallelismo di due rette.<br />
Distinguere rette parallele.<br />
La condizione di perpendicolarità Enunciare la condizione di perpendicolarità.<br />
Controllare la perpendicolarità di due rette.<br />
I fasci di rette parallele Scrivere l’equazione del fascio di rette parallele a una retta<br />
data.<br />
Scrivere l’equazione della parallela a una retta data per un<br />
punto esterno ad essa.<br />
I fasci di rette centrati in un punto Scrivere l’equazione del fascio di rette di dato centro.<br />
Scrivere l’equazione della retta di inclinazione assegnata<br />
passante per un punto dato.<br />
La retta passante per due punti Determinare l’equazione di una retta passante per due punti.<br />
I sistemi lineari numerici 2×2 Scrivere un sistema di equazioni in forma normale.<br />
Distinguere coefficienti e termini noti.<br />
I sistemi determinati e non Definire i termini “sistema determinato”, “sistema<br />
indeterminato” e “sistema impossibile”<br />
Stabilire se un sistema è determinato o meno.<br />
L’interpretazione grafica dei sistemi Interpretare geometricamente un sistema 2×2.<br />
Il determinante di un sistema 2×2 Calcolare il determinante di un sistema.<br />
I metodi algebrici di risoluzione Risolvere un sistema 2×2 numerico con il metodo della<br />
sostituzione, del confronto o della riduzione.<br />
I sistemi numerici n×n Risolvere un sistema numerico 3×3 in forma semplice.<br />
I sistemi letterali Discutere il determinante di un sistema letterale 2×2<br />
semplice in forma normale.<br />
Problemi con sistemi lineari Tradurre un semplice problema lineare in un sistema e<br />
determinarne la soluzione.<br />
Gli eventi e la probabilità a priori Distinguere eventi certi, impossibili e aleatori.<br />
Definire la probabilità di un evento.<br />
Discutere i valori possibili della probabilità di un evento.<br />
Determinare la probabilità di un evento in casi semplici.<br />
La somma logica di eventi Definire il termine “evento unione”.<br />
Determinare la probabilità dell’evento unione di due eventi<br />
incompatibili.<br />
Il prodotto logico di eventi Definire il termine “evento intersezione”.<br />
La probabilità condizionata Definire la probabilità condizionata.<br />
Determinare la probabilità condizionata di due eventi<br />
indipendenti.<br />
Le distribuzioni di probabilità Definire una distribuzione di probabilità.<br />
La legge dei grandi numeri Enunciare la legge dei grandi numeri.<br />
La probabilità statistica Determinare la probabilità statistica su una popolazione di<br />
dati.<br />
39
Classe I<br />
Scomposizione dei polinomi in fattori. Eseguire la scomposizione di un polinomio mediante<br />
l’applicazione immediata di uno dei seguenti procedimenti:<br />
– raccoglimento a fattor comune totale;<br />
– raccoglimento a fattor comune parziale;<br />
– riconoscimento dei prodotti notevoli:<br />
◦ somma per differenza di due monomi;<br />
◦ quadrato di un binomio;<br />
◦ cubo di un binomio;<br />
◦ somma o differenza di cubi;<br />
– riconoscimento del trinomio particolare di secondo<br />
grado;<br />
– applicazione del teorema di Ruffini.<br />
Frazioni algebriche. Eseguire le quattro operazioni e le potenze ad esponente<br />
intero su frazioni algebriche anche all’interno di espressioni<br />
molto semplici.<br />
Equazioni di secondo grado. Comprendere la terminologia relativa alle equazioni di 2°<br />
grado.<br />
Risolvere equazioni di 2° grado pure.<br />
Risolvere equazioni di 2° grado spurie.<br />
Ricordare la formula risolutiva delle equazioni di 2° grado.<br />
Classificare il tipo di soluzioni di un’equazione di 2° grado<br />
in base al segno del discriminante.<br />
Risolvere equazioni di 2° grado complete semplici.<br />
Geometria analitica della retta. Interpretare le coordinate di un punto nel piano.<br />
Determinare analiticamente la lunghezza di un segmento e le<br />
coordinate del suo punto medio.<br />
Riconoscere l’equazione di una retta e il significato dei suoi<br />
parametri. Convertire l’equazione di una retta dalla forma<br />
esplicita a quella implicita e viceversa.<br />
Tracciare una retta di equazione data.<br />
Enunciare la condizione di parallelismo di due rette.<br />
Studiare la posizione reciproca di due rette.<br />
Scrivere l’equazione della retta passante per due punti.<br />
Geometria analitica della parabola. Riconoscere l’equazione della parabola nella forma y = ax 2<br />
e interpretare a.<br />
Riconoscere l’equazione della parabola nella forma y -<br />
y´ = a(x - x´) 2 e interpretare a, x´ e y´.<br />
Riconoscere l’equazione della parabola nella forma<br />
y = ax 2 + bx + c e tracciarla per punti.<br />
Studiare la posizione reciproca di una parabola e una retta.<br />
Geometria:<br />
– La circonferenza<br />
– Il cerchio<br />
– I vettori<br />
Classe II (vecchio ordinamento)<br />
Ricavare dal testo di un teorema le ipotesi e la tesi.<br />
Costruire la figura in base alla descrizione verbale<br />
Ripetere dimostrazioni già incontrate in classe.<br />
Rappresentare un vettore in termini geometrici o cartesiani.<br />
Eseguire operazioni sui vettori.<br />
Geometria analitica della retta. Interpretare le coordinate di un punto nel piano.<br />
Determinare analiticamente la lunghezza di un segmento e le<br />
coordinate del suo punto medio.<br />
Riconoscere l’equazione di una retta e il significato dei suoi<br />
parametri. Convertire l’equazione di una retta dalla forma<br />
esplicita a quella implicita e viceversa. Tracciare una retta<br />
di equazione data.<br />
Enunciare la condizione di parallelismo di due rette.<br />
Studiare la posizione reciproca di due rette.<br />
Scrivere l’equazione della retta passante per due punti.<br />
40
Geometria analitica della parabola. Riconoscere l’equazione della parabola nella forma y = ax 2<br />
e interpretare a.<br />
Riconoscere l’equazione della parabola nella forma y -<br />
y´ = a(x - x´) 2 e interpretare a, x´ e y´.<br />
Riconoscere l’equazione della parabola nella forma<br />
y = ax 2 + bx + c e tracciarla per punti.<br />
Studiare la posizione reciproca di una parabola e una retta.<br />
Geometria analitica della circonferenza. Riconoscere l’equazione della circonferenza nella forma<br />
x 2 + y 2 = r 2 e interpretare r.<br />
Riconoscere l’equazione della circonferenza nella forma (x -<br />
x´) 2 + (y - y´) 2 = r 2 e interpretare a, x´ e y´.<br />
Tracciare per punti una circonferenza di equazione<br />
x 2 + y 2 + ax + by + c = 0.<br />
Studiare la posizione reciproca di una circonferenza e una<br />
retta.<br />
Funzione esponenziale. Definire le potenze con esponente razionale o reale e la<br />
funzione esponenziale y = a x .<br />
Prevedere l’andamento della funzione esponenziale in base<br />
al segno di a.<br />
Confrontare un andamento lineare e un andamento<br />
esponenziale.<br />
Logaritmi. Definire il logaritmo di b in base a.<br />
Ripetere le proprietà dei logaritmi.<br />
Riconoscere le condizioni di esistenza di un logaritmo.<br />
Calcolare logaritmi elementari.<br />
Equazioni esponenziali e logaritmiche elementari. Interpretare equazioni esponenziali elementari.<br />
Risolvere equazioni esponenziali della forma a x = b, dove b<br />
può scriversi come potenza intera o razionale di a.<br />
Interpretare equazioni logaritmiche elementari.<br />
Risolvere equazioni logaritmiche elementari.<br />
Risolvere equazioni esponenziali elementari mediante<br />
logaritmi.<br />
Classe III (vecchio ordinamento)<br />
Definizione delle funzioni goniometriche e loro grafico. Definire la misura degli angoli in radianti e la circonferenza<br />
goniometrica. Definire seno, coseno e tangente sulla<br />
circonferenza goniometrica. Descrivere l’andamento delle<br />
funzioni goniometriche, il loro grafico e il loro periodo.<br />
Applicare le relazioni fondamentali.<br />
Ricordare il valore delle funzioni goniometriche degli angoli<br />
di 0°, 30°, 45°, 60°, 90°.<br />
Applicare le relazioni fra gli angoli associati.<br />
Formule di addizione e sottrazione, duplicazione, bisezione. Ricordare le formule di addizione e sottrazione di seno e<br />
coseno. Ricordare le formula di duplicazione di seno e<br />
coseno. Ricordare le formula di bisezione di seno e coseno.<br />
Identità ed equazioni goniometriche. Definire identità ed equazioni goniometriche.<br />
Risolvere equazioni goniometriche elementari.<br />
Risolvere equazioni goniometriche della forma<br />
asinx + bcosx = 0. Risolvere equazioni goniometriche di<br />
secondo grado in una sola funzione.<br />
Risoluzione dei triangoli rettangoli e dei triangoli qualunque. Definire seno, coseno e tangente nel triangolo rettangolo.<br />
Ricordare le relazioni trigonometriche nel triangolo<br />
rettangolo. Risolvere triangoli rettangoli di cui sono dati due<br />
elementi. Enunciare i teoremi dei seni e del coseno.<br />
Risolvere triangoli qualunque noti tre elementi di base (fra<br />
cui almeno un lato).<br />
41
Classe I<br />
PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE DI FISICA<br />
Grandezze e misure. Definire il concetto di grandezza.<br />
Interpretare una definizione operativa.<br />
Ripetere gli elementi fondamentali del Sistema<br />
Internazionale di Unità.<br />
Interpretare l’indicazione dell’incertezza in una misura.<br />
Cinematica rettilinea del punto materiale. Definire il concetto di sistema di riferimento.<br />
Schematizzare il sistema di riferimento relativo a un moto<br />
rettilineo con un asse di coordinate.<br />
Definire le grandezze istante, posizione, intervallo e<br />
distanza. Definire la velocità media.<br />
Determinare velocità media, distanza percorsa o intervallo<br />
impiegato in un moto rettilineo, note due di tali grandezze.<br />
Interpretare un grafico s–t.<br />
Definire il moto rettilineo uniforme.<br />
Ripetere e interpretare la legge oraria del moto uniforme.<br />
Applicare la legge del moto uniforme a problemi semplici.<br />
Definire la velocità istantanea come pendenza della retta<br />
tangente al grafico s–t.<br />
Interpretare un grafico v–t.<br />
Definire l’accelerazione media.Determinare accelerazione<br />
media, variazione di velocità o intervallo impiegato in un<br />
moto rettilineo, note due di tali grandezze.<br />
Definire il moto uniformemente accelerato.<br />
Ripetere e interpretare le leggi orarie del moto<br />
uniformemente accelerato.<br />
Applicare le leggi del moto uniformemente accelerato a<br />
problemi semplici.<br />
Cinematica del punto in due dimensioni. Definire un vettore sul modello degli spostamenti.<br />
Determinare la somma di due vettori.<br />
Distinguere un vettore da uno scalare.<br />
Definire i vettori posizione, velocità e accelerazione.<br />
Definire il moto circolare uniforme e le grandezze relative.<br />
Applicare le relazioni cinematiche fra raggio, velocità e<br />
accelerazione centripeta in un moto circolare uniforme.<br />
Forze e movimento. Descrivere la natura vettoriale delle forze e la loro misura<br />
statica.<br />
Enunciare le leggi di Newton.<br />
Enunciare il principio di relatività.<br />
Applicare le leggi di Newton allo studio dei casi più<br />
semplici: la caduta libera, il moto circolare uniforme.<br />
Enunciare le caratteristiche fondamentali del moto dei<br />
proiettili.<br />
Gravitazione. Enunciare le leggi di Kepler.<br />
Enunciare e interpretare la legge di Newton di gravitazione<br />
universale.<br />
Applicare la legge di gravitazione al caso di un singolo<br />
satellite su un’orbita circolare.<br />
Energia meccanica. Definire il lavoro di una forza costante.<br />
Enunciare il teorema delle forze vive.<br />
Definire l’energia cinetica.<br />
Definire l’energia potenziale della forza peso.<br />
Enunciare il teorema di conservazione dell’energia<br />
meccanica.<br />
Applicare il teorema di conservazione dell’energia<br />
meccanica a problemi semplici.<br />
42
Classe II (vecchio ordinamento)<br />
Grandezze e misure. Definire il concetto di grandezza.<br />
Interpretare una definizione operativa.<br />
Ripetere gli elementi fondamentali del Sistema<br />
Internazionale di Unità.<br />
Interpretare l’indicazione dell’incertezza in una misura.<br />
Cinematica rettilinea del punto materiale. Definire il concetto di sistema di riferimento.<br />
Schematizzare il sistema di riferimento relativo a un moto<br />
rettilineo con un asse di coordinate.<br />
Definire le grandezze istante, posizione, intervallo e<br />
distanza.<br />
Definire la velocità media.<br />
Determinare velocità media, distanza percorsa o intervallo<br />
impiegato in un moto rettilineo, note due di tali grandezze.<br />
Interpretare un grafico s–t.<br />
Definire il moto rettilineo uniforme.<br />
Ripetere e interpretare la legge oraria del moto uniforme.<br />
Applicare la legge del moto uniforme a problemi semplici.<br />
Definire la velocità istantanea come pendenza della retta<br />
tangente al grafico s–t.<br />
Interpretare un grafico v–t.<br />
Definire l’accelerazione media.<br />
Determinare accelerazione media, variazione di velocità o<br />
intervallo impiegato in un moto rettilineo, note due di tali<br />
grandezze.<br />
Definire il moto uniformemente accelerato.<br />
Ripetere e interpretare le leggi orarie del moto<br />
uniformemente accelerato.<br />
Applicare le leggi del moto uniformemente accelerato a<br />
problemi semplici.<br />
Cinematica del punto in due dimensioni. Definire un vettore sul modello degli spostamenti.<br />
Determinare la somma di due vettori.<br />
Distinguere un vettore da uno scalare.<br />
Definire i vettori posizione, velocità e accelerazione.<br />
Definire il moto circolare uniforme e le grandezze relative.<br />
Applicare le relazioni cinematiche fra raggio, velocità e<br />
accelerazione centripeta in un moto circolare uniforme.<br />
Forze e movimento. Descrivere la natura vettoriale delle forze e la loro misura<br />
statica.<br />
Enunciare le leggi di Newton.<br />
Enunciare il principio di relatività.<br />
Applicare le leggi di Newton allo studio dei casi più<br />
semplici: la caduta libera, il moto circolare uniforme.<br />
Enunciare le caratteristiche fondamentali del moto dei<br />
proiettili.<br />
Gravitazione. Enunciare le leggi di Kepler.<br />
Enunciare e interpretare la legge di Newton di gravitazione<br />
universale.<br />
Applicare la legge di gravitazione al caso di un singolo<br />
satellite su un’orbita circolare.<br />
Energia meccanica. Definire il lavoro di una forza costante.<br />
Enunciare il teorema delle forze vive.<br />
Definire l’energia cinetica.<br />
Definire l’energia potenziale della forza peso.<br />
Enunciare il teorema di conservazione dell’energia<br />
meccanica.<br />
Applicare il teorema di conservazione dell’energia<br />
meccanica a problemi semplici.<br />
43
Classe III (vecchio ordinamento)<br />
Temperatura e calore. Descrivere l’equilibrio termico.<br />
Definire il concetto di temperatura.<br />
Descrivere le scale termometriche Celsius e Kelvin.<br />
Definire calore e lavoro come processi di<br />
trasferimento/trasformazione di energia.<br />
Discutere la distinzione fra calore e temperatura.<br />
Ripetere le relazioni calorimetriche fondamentali.<br />
Applicare le relazioni calorimetriche a casi semplici.<br />
Termodinamica. Introdurre il concetto di energia interna di un sistema fisico.<br />
Enunciare il primo principio della termodinamica.<br />
Definire le macchine termiche come trasformazioni cicliche.<br />
Discutere la necessità di un refrigeratore e il concetto di<br />
rendimento.<br />
Enunciare il secondo principio della termodinamica.<br />
Elettrostatica. Descrivere semplici esperienze di elettrostatica.<br />
Enunciare la legge di Coulomb.<br />
Definire il campo elettrico.<br />
Descrivere il campo elettrico in situazioni particolari.<br />
Definire la differenza di potenziale.<br />
Collegare il campo elettrico in una regione dello spazio al<br />
moto delle cariche puntiformi presenti.<br />
Corrente elettrica continua e circuiti elementari. Definire l’intensità di corrente elettrica.<br />
Interpretare descrizioni di circuiti elettrici.<br />
Enunciare la legge di Ohm.<br />
Applicare la legge di Ohm a circuiti elementari.<br />
Determinare la resistenza equivalente di una connessione di<br />
resistenze in serie o in parallelo.<br />
Magnetismo. Descrivere fenomeni magnetici particolari.<br />
Descrivere gli effetti magnetici della corrente elettrica.<br />
Definire il campo magnetico.<br />
Enunciare la legge della forza di Lorentz.<br />
Descrivere il moto di una carica in un campo magnetico<br />
uniforme.<br />
Induzione elettromagnetica. Descrivere il fenomeno delle correnti indotte.<br />
Definire il flusso del campo magnetico attraverso un<br />
circuito.<br />
Enunciare la legge di Faraday–Neumann–Lenz.<br />
Descrivere alcune conseguenze del fenomeno dell’induzione<br />
elettromagnetica.<br />
PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE DI SCIENZE<br />
Gli insegnanti, concordemente, ritengono opportuno segnalare la necessità, nei confronti degli studenti che intendono<br />
frequentare il penultimo anno all’estero, di far sostenere agli studenti in questione, una volta rientrati, una prova di<br />
accertamento delle conoscenze e delle competenze relative al programma previsto nel POF per la specifica classe di<br />
pertinenza.<br />
PROGRAMMAZIONE CURRICOLARE PER L’A.S. 2012-2013<br />
Classi QUARTE GINNASIALI<br />
Obiettivi specifici di apprendimento<br />
Nella quarta ginnasiale prevale un approccio di tipo fenomenologico basato su osservazione e descrizione,<br />
con particolare attenzione ai criteri per la raccolta e registrazione dei dati.<br />
Competenze <strong>disciplinari</strong><br />
– Osservare , descrivere e analizzare i fenomeni legati alla realtà e alla trasformazione della materia e<br />
dell’energia a partire dall’esperienza.<br />
– Individuare correlazioni tra i fenomeni osservati..<br />
– Saper rappresentare anche con un grafico o con un disegno schematico il fenomeno studiato.<br />
44
Nuclei tematici<br />
Scienze della terra<br />
– Generalità relative al Sistema Solare. Leggi di Keplero .Legge di Gravitazione Universale.<br />
– Moti della Terra. La Luna..<br />
– Le sfere della Terra.<br />
– Minerali e rocce. Vulcani e terremoti. La tettonica delle placche;<br />
– La superficie della Terra dal punto di vista geomorfologico e geodinamico.<br />
Classi QUINTE GINNASIALI<br />
Obiettivi specifici di apprendimento<br />
Anche nella quinta ginnasiale prevale un approccio di tipo fenomenologico basato su osservazione<br />
descrizione, con particolare attenzione all’uso dell’unità di misura e ai criteri per la raccolta e registrazione<br />
dei dati.<br />
Competenze <strong>disciplinari</strong><br />
–Osservare , descrivere e analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alla realtà e alla<br />
trasformazione della materia e dell’energia a partire dall’esperienza.<br />
–Individuare correlazioni tra le grandezze e tra le relative unità di misura.<br />
–Saper rappresentare anche con un grafico o con un disegno schematico il fenomeno studiato.<br />
Nuclei tematici<br />
a) Chimica<br />
- Teoria atomica di Dalton – Modelli atomici –Sistema periodico – Legami –Formule chimiche.<br />
b) Biologia<br />
- Cellula e Biodiversità<br />
Competenze <strong>disciplinari</strong> al termine del primo biennio<br />
a) Organizzare in modo autonomo lo studio<br />
b) Portare a termine in modo autonomo un lavoro intrapreso<br />
c) Avere competenze linguistiche<br />
- conoscere la terminologia specifica della disciplina<br />
- esprimersi oralmente e per iscritto in modo corretto e appropriato, chiaro, consequenziale, sintetico e<br />
completo<br />
- essere in grado di leggere e comprendere un testo scientifico<br />
d) Acquisire il metodo scientifico come metodo razionale di conoscenza<br />
- sapere osservare e descrivere un fenomeno<br />
- sapere usare le unità di misura, sapere raccogliere e registrare dati<br />
e) Avere consapevolezza dell’evoluzione del pensiero scientifico<br />
-contestualizzare storicamente teorie, leggi e principi<br />
Da ciò derivano le seguenti abilità:<br />
–Osservare , descrivere e analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alla realtà e alla<br />
trasformazione della materia e dell’energia a partire dall’esperienza.<br />
–Individuare correlazioni tra le grandezze e tra le relative unità di misura.<br />
–Saper rappresentare anche con un grafico o con un disegno schematico il fenomeno studiato.<br />
Classi PRIME LICEO<br />
Obiettivi specifici di apprendimento<br />
Acquisire le conoscenze necessarie per comprendere correttamente i fenomeni naturali e i processi di cambiamento ad<br />
essi collegati per riuscire a valutarne l’importanza, rapportando quanto studiato alle situazioni reali di cui si può avere<br />
esperienza diretta o indiretta (ad esempio attraverso quanto perviene da organi di informazione).<br />
Comprendere le interdipendenze tra i fenomeni studiati e, grazie e ciò, essere in grado di collegarli tra loro,<br />
acquisendo una visione globale della natura con le sue componenti e i suoi fenomeni principali.<br />
Competenze <strong>disciplinari</strong><br />
Saper descrivere ed interpretare correttamente i fenomeni oggetto di studio, con le principali interconnessioni,<br />
utilizzando la terminologia specifica.<br />
Saper utilizzare quanto appreso per la risoluzione dei problemi tipici della disciplina.<br />
Nuclei tematici<br />
a) Chimica<br />
Nomenclatura dei composti, tradizionale e IUPAC. Principali tipi di reazioni chimiche.<br />
Chimica quantitativa: bilanciamento delle equazioni chimiche, mole e calcoli stechiometrici.<br />
Le soluzioni, concentrazione delle soluzionie metodi di misura di essa,. Cenni fondamentali sull’equilibrio<br />
chimico; ionizzazione dell’acqua, acidi e basi di Arrhenius e di Bronsted , pH delle soluzioni.<br />
Elementi di termodinamica: entalpia ed entropia. Elettrochimica.<br />
b) Scienze della Terra<br />
Minerali e rocce con relativa classificazione e processi di formazione; modellamento della litosfera:<br />
processi endogeni ed esogeni. Tettonica delle placche.<br />
45
Classi SECONDE LICEO<br />
Obiettivi specifici di apprendimento<br />
Acquisire le conoscenze di base necessarie per comprendere correttamente i fenomeni chimici e biologici e i processi<br />
di cambiamento ad essi collegati, rapportando quanto studiato alle situazioni reali di cui si può avere esperienza diretta<br />
o indiretta (ad esempio attraverso quanto perviene da organi di informazione).<br />
Acquisire le conoscenze di base necessarie relative alla composizione, alla struttura e all’evoluzione dell’Universo e dei<br />
corpi celesti che lo popolano.<br />
Competenze <strong>disciplinari</strong><br />
Saper descrivere ed interpretare correttamente i fenomeni oggetto di studio, individuando le principali<br />
interconnessioni e utilizzando la terminologia specifica.<br />
Saper utilizzare quanto appreso per la risoluzione dei problemi tipici della disciplina.<br />
Nuclei tematici<br />
a) Chimica<br />
Chimica generale ed inorganica: il pH delle soluzioni, elementi di termodinamica, ossidoriduzioni ed elettrochimica.<br />
Chimica organica: gli idrocarburi, i gruppi funzionali e le relative categorie di composti organici.<br />
b) Astronomia e geografia Astronomica<br />
Elementi di Astronomia: Cenni relativi alla Sfera Celeste, origine dell’Universo, distanze astronomiche, stelle e la loro<br />
evoluzione.<br />
Elementi di geografia astronomica: Sistema solare, leggi di Keplero e legge di gravitazione universale, la Terra e i suoi<br />
moti e relative conseguenze.<br />
c) Biologia<br />
Le molecole biologiche; Studio dei microrganismi e della cellula, procarioti ed eucarioti, organizzazione cellulare;<br />
metabolismo, respirazione e cenni sulla fotosintesi. Membrane cellulari, struttura, funzioni e modalità di trasporto.<br />
DNA e RNA, sintesi delle proteine, mutazioni.<br />
Le basi cellulari della riproduzione e dell’ereditarietà.<br />
Classi TERZE LICEO<br />
Obiettivi specifici di apprendimento<br />
Acquisire le conoscenze di base relative alla ereditarietà, all’evoluzionismo.<br />
Conoscere la struttura e la fisiologia del corpo umano per comprendere quali siano i comportamenti più<br />
idonei al mantenimento o al raggiungimento dello stato di salute.<br />
Comprendere le interdipendenze tra fenomeni studiati e, grazie e ciò, essere in grado di collegarli tra loro.<br />
Saper riconoscere e riprodurre consapevolmente percorsi argomentativi con adeguata correttezza terminologica.<br />
Competenze <strong>disciplinari</strong><br />
Saper osservare, descrivere analiticamente ed interpretare le strutture e i fenomeni studiati ed essere in grado di<br />
sintetizzare le conoscenze acquisite.<br />
Nuclei tematici<br />
Biologia<br />
a) Ereditarietà.<br />
b) Concetti fondamentali relativi al tema dell’evoluzionismo.<br />
c) Anatomia e fisiologia umana: struttura e funzioni dei principali organi e sistemi e loro interconnessioni e<br />
integrazioni nella funzione globale dell’organismo umano: tessuti; sistema digerente, respiratorio, circolatorio e<br />
linfatico, immunitario, escretore, endocrino, riproduttore, nervoso.<br />
FINALITA’<br />
PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE DI STORIA DELL’ARTE<br />
Le finalità dell’insegnamento della Storia dell’Arte sono:<br />
1) Formare un fruitore dei prodotti artistici che sia in grado di riconoscere, analizzare, capire il significato e il<br />
valore dell’opera d’arte, secondo conoscenze, competenze e abilità proprie della disciplina;<br />
2) Educare a una visione complessa e sfaccettata delle civiltà studiate attraverso il collegamento delle arti<br />
figurative col processo storico-sociale e culturale delle civiltà,<br />
3) Favorire una chiara coscienza dell'importanza dei beni artistici e culturali, particolarmente complessi e<br />
stratificati nel territorio italiano, e della necessità di riconoscerli e rispettarli.<br />
4) Formare interessi, atteggiamenti, comportamenti civici che contribuiscano a creare un rapporto responsabile<br />
con la società;<br />
46
PROGRAMMA<br />
Le competenze verranno raggiunte attraverso la trattazione dei seguenti contenuti:<br />
biennio: nelle classi prime e seconde liceali saranno affrontati le nozioni e i concetti fondamentali relativi all’arte antica,<br />
in particolare greca e romana,( in considerazione dell’indirizzo di studi) e della grande cultura figurativa dell’Europa<br />
medievale e moderna. Si accoglie l’indicazione di trattare i contenuti del biennio liceale senza precise cesure tra la<br />
prima e la seconda classe.<br />
Terzo anno: l’ultimo anno verrà dedicato alla fine dell’arte moderna e all’arte contemporanea tra Ottocento e<br />
Novecento.<br />
I docenti potranno e dovranno operare delle scelte, tenendo conto, tra l’altro:<br />
delle occasioni offerte dal territorio, dalle visite e dai viaggi di istruzione, nonché dai progetti realizzati dalla<br />
scuola;<br />
degli spunti inter<strong>disciplinari</strong>, in particolare per il terzo anno;<br />
della necessità di approfondire gli aspetti metodologici e storiografici più formativi.<br />
I docenti di storia dell’arte desiderano inoltre, essendo la disciplina una delle poche insegnate nel nostro istituto ad<br />
avere una concreta presenza nella contemporaneità, valorizzare il contributo delle nuove tecnologie, anche per<br />
recuperare (e non svilire) le competenze informatiche degli studenti, orientandoli verso un uso creativo della<br />
multimedialità.<br />
VALUTAZIONE<br />
Giudizio Metodo di studio Conoscenze <strong>disciplinari</strong> Capacità di individuare<br />
collegamenti e relazioni<br />
Insufficienz<br />
a grave o<br />
molto grave<br />
Insufficienza<br />
non<br />
grave<br />
sufficiente<br />
Studia in modo<br />
discontinuo<br />
Non è puntuale e/o<br />
completo nelle consegne<br />
Non è consapevole delle<br />
proprie operazioni di<br />
lavoro<br />
Organizza lo studio in<br />
modo non sempre<br />
autonomo<br />
Non sempre è puntuale e/o<br />
completo nelle consegne<br />
Utilizza gli strumenti di<br />
studio in modo nel<br />
complesso adeguato ma<br />
modesto<br />
Organizza lo studio in<br />
modo autonomo<br />
E’ puntuale nelle<br />
consegne anche se non<br />
sempre preciso<br />
Utilizza gli strumenti di<br />
studio in modo<br />
complessivamente<br />
adeguato<br />
Ha una conoscenza<br />
lessicale di base limitata e<br />
una conoscenza del lessico<br />
tecnico lacunosa Non<br />
memorizza, se non in<br />
modo saltuario e<br />
frammentario, gli elementi<br />
di base della disciplina<br />
Non riconosce e utilizza<br />
correttamente le categorie<br />
della descrizione<br />
dell’immagine<br />
Conosce il lessico di base<br />
ma in modo impreciso e<br />
usa il lessico tecnico in<br />
modo non sempre corretto<br />
Memorizza in modo<br />
meccanico e poco<br />
consapevole gli elementi<br />
di base della disciplina<br />
Riconosce e utilizza, solo<br />
se opportunamente<br />
guidato, gli elementi della<br />
descrizione<br />
Ha una conoscenza<br />
lessicale di base corretta e<br />
una conoscenza del lessico<br />
tecnico adeguata<br />
Conosce gli elementi di<br />
base della disciplina<br />
Riconosce e utilizza<br />
correttamente le categorie<br />
della descrizione<br />
dell’immagine<br />
Non concettualizza i dati e<br />
non li classifica e/o<br />
seleziona in modo<br />
conforme alle richieste<br />
Non è in grado di operare<br />
confronti tra opere della<br />
stessa epoca o di epoche<br />
differenti<br />
E’ parzialmente in grado<br />
di compiere, se guidato,<br />
operazioni di<br />
concettualizzazione,<br />
classificazione e selezione<br />
dei dati acquisiti<br />
Solo se indirizzato, è in<br />
grado di operare confronti<br />
tra opere in modo ovvio<br />
ed esplicito<br />
E’ in grado di compiere<br />
operazioni di<br />
concettualizzazione,<br />
classificazione e selezione<br />
pertinente dei dati<br />
acquisiti in modo<br />
complessivamente<br />
adeguato<br />
Riesce a operare confronti<br />
tra opere in modo<br />
semplice ed essenziale<br />
Applica, se indirizzato, le<br />
conoscenze acquisite per<br />
analizzare dati nuovi<br />
strutturalmente simili al<br />
modello dato<br />
Elaborazione ed<br />
esposizione delle<br />
conoscenze<br />
Utilizza le conoscenze in<br />
modo non pertinente alle<br />
richieste<br />
Espone i contenuti in<br />
modo faticoso,<br />
formalmente scorretto e<br />
concettualmente<br />
scoordinato<br />
Utilizza le conoscenze in<br />
modo parzialmente<br />
pertinente alle richieste<br />
Espone i contenuti in<br />
modo faticoso, non<br />
sempre corretto e talvolta<br />
concettualmente<br />
scoordinato<br />
Utilizza le conoscenze in<br />
modo pertinente alle<br />
richieste, utilizzando<br />
contenuti essenziali<br />
Espone i contenuti in<br />
modo adeguato,<br />
complessivamente corretto<br />
e concettualmente logico<br />
Analizza in modo corretto<br />
gli elementi strutturali<br />
della descrizione<br />
47
discreto<br />
Buono<br />
Ottimo/ecce<br />
llente<br />
Organizza lo studio in<br />
modo autonomo<br />
E’ puntuale nelle<br />
consegne<br />
Utilizza gli strumenti di<br />
studio in modo adeguato<br />
Organizza lo studio in<br />
modo autonomo e<br />
organico<br />
E’ puntuale e completo<br />
nelle consegne<br />
Utilizza gli strumenti di<br />
studio in modo<br />
competente<br />
Organizza lo studio in<br />
modo autonomo e<br />
organico<br />
E’ puntuale e completo<br />
nelle consegne<br />
Utilizza gli strumenti di<br />
studio in modo<br />
competente<br />
Ha una conoscenza<br />
lessicale di base corretta e<br />
una conoscenza del lessico<br />
tecnico completa<br />
Conosce in modo organico<br />
gli elementi di base della<br />
disciplina Riconosce e<br />
utilizza correttamente e<br />
autonomamente le<br />
categorie della descrizione<br />
dell’immagine<br />
Ha una conoscenza<br />
lessicale ampia e organica<br />
e una conoscenza del<br />
lessico tecnico completa<br />
Conosce in modo<br />
organico, completo e<br />
competente gli elementi<br />
della disciplina<br />
Riconosce e utilizza<br />
correttamente e<br />
autonomamente le<br />
categorie della descrizione<br />
dell’immagine con<br />
sicurezza<br />
Ha una conoscenza<br />
lessicale ampia e organica<br />
e una conoscenza del<br />
lessico tecnico completa<br />
Conosce in modo<br />
organico, completo e<br />
approfondito gli elementi<br />
della disciplina.<br />
Riconosce e analizza<br />
correttamente e<br />
autonomamente le<br />
categorie della descrizione<br />
dell’immagine con<br />
sicurezza<br />
E’ in grado di compiere<br />
operazioni di<br />
concettualizzazione,<br />
classificazione e selezione<br />
pertinente dei dati<br />
acquisiti. E’ in grado di<br />
operare confronti tra opere<br />
in modo corretto e<br />
coerente. Applica le<br />
conoscenze acquisite per<br />
analizzare dati nuovi<br />
anche non esattamente<br />
coincidenti con la<br />
tipologia del modello dato<br />
E’ in grado di compiere<br />
operazioni di<br />
concettualizzazione,<br />
classificazione, selezione<br />
e sistematizzazione dei<br />
dati acquisiti<br />
Affronta in modo<br />
spontaneo operazioni di<br />
confronto tra opere in<br />
modo corretto e coerente e<br />
le sa sviluppare<br />
Applica le conoscenze<br />
acquisite per analizzare<br />
dati nuovi che presentano<br />
elementi problematici<br />
E’ in grado di compiere<br />
operazioni di<br />
concettualizzazione,<br />
classificazione, selezione<br />
e sistematizzazione dei<br />
dati acquisiti<br />
Affronta in modo<br />
spontaneo operazioni di<br />
confronto tra opere in<br />
modo corretto e coerente e<br />
le sa sviluppare in modo<br />
originale<br />
Applica le conoscenze<br />
acquisite per analizzare<br />
dati nuovi che presentano<br />
elementi altamente<br />
problematici<br />
Esprime giudizi<br />
criticamente argomentati<br />
Utilizza le conoscenze in<br />
modo pertinente alle<br />
richieste, utilizzando<br />
contenuti diversificati<br />
Espone i contenuti in<br />
modo complessivamente<br />
scorrevole e corretto e<br />
concettualmente logico<br />
Analizza in modo corretto<br />
gli elementi strutturali<br />
della descrizione con<br />
qualche spunto critico<br />
Utilizza le conoscenze in<br />
modo pertinente alle<br />
richieste, utilizzando<br />
contenuti ampi e<br />
coerentemente rielaborati<br />
Espone i contenuti in<br />
modo scorrevole, coerente<br />
e organico<br />
Analizza in modo corretto<br />
gli elementi strutturali<br />
della descrizione e li<br />
utilizza come strumenti<br />
per la comprensione e<br />
l’interpretazione<br />
Utilizza le conoscenze in<br />
modo pertinente alle<br />
richieste, utilizzando<br />
contenuti ampi e<br />
rielaborati in modo<br />
originale<br />
Espone i contenuti in<br />
modo scorrevole, coerente<br />
e organico<br />
Analizza in modo corretto<br />
gli elementi strutturali<br />
della descrizione e li<br />
utilizza come strumenti<br />
per la comprensione e<br />
l’interpretazione<br />
Coglie lo spessore<br />
culturale dell’opera d’arte<br />
48
PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE DI EDUCAZIONE FISICA<br />
FINALITÀ E OBIETTIVI DELL’ED. FISICA<br />
L’educazione fisica concorre, assieme alle altre materie, alla formazione e istruzione di ciascun alunno. Nell’insieme<br />
delle discipline scolastiche, essa ha la particolarità di mettere al centro dell’apprendimento il corpo e il movimento,<br />
ponendosi così come luogo di esperienza concreta, complementare agli altri insegnamenti.<br />
Le finalità dell’ed. fisica al liceo Minghetti sono lo sviluppo dell’individuo, l’educazione alla salute e lo sviluppo della<br />
cultura del movimento, ossia, in coerenza col quadro europeo delle “competenze chiave per l’apprendimento<br />
permanente ”, la formazione di un cittadino consapevole, autonomo, responsabile della gestione della sua vita fisica<br />
durante il tempo della scolarità e lungo tutta la vita.<br />
Obiettivi generali della materia:<br />
1. sviluppo delle capacità fisiche e arricchimento del bagaglio motorio di ognuno<br />
2. conoscenza delle attività fisiche, sportive e artistiche<br />
3. autonomia nella gestione dell’attività fisica oltre l’età scolare e per tutto l’arco della vita.<br />
Attraverso le varie attività proposte nell’intero percorso scolastico, gli alunni fanno esperienza di sé, nel confronto con<br />
la realtà esterna e con gli altri, realizzano prestazioni fisiche e movimenti complessi, compiono azioni di adattamento<br />
specifiche a ciascuna situazione proposta; acquisiscono dei saperi nell’agire: nel confronto con le regole e i codici<br />
costitutivi di ciascuna attività fisica, sportiva o artistica, gli alunni acquisiscono la dimensione culturale dell’ed. fisica.<br />
LE CONOSCENZE<br />
Ogni attività ha la sua specificità e ciascuna situazione comporta l’acquisizione di conoscenze; le conoscenze<br />
caratteristiche dell’ed. fisica sono di quattro tipi:<br />
Le informazioni: riguardano l’attività fisica affrontata, quali per es. le regole di un gioco o di una condotta in sicurezza,<br />
ma riguardano anche il soggetto in azione relativamente alle sollecitazioni fisiche che riceve da un movimento, o ad una<br />
situazione di gioco nel momento in cui cerca di reperire informazioni dalla lettura di un gioco. Altre informazioni<br />
provengono dalle conoscenze scientifiche relativamente alla possibilità di gestire in autonomia la pratica fisica<br />
Le tecniche e le tattiche; sono conoscenze specifiche di ciascuna disciplina sportiva o artistica e corrispondono ai<br />
principi esecutivi dei gesti e alla scelta pertinente dell’azione, fra quelle possibili.<br />
Le conoscenze di sé: derivano dall’agire, si acquisiscono con l’esperienza e corrispondono agli insegnamenti che<br />
ciascuno deve trarre dalla pratica. Richiedono una riflessione sulla propria esecuzione, sui risultati, una mobilizzazione<br />
dei sensi (visivo, propriocettivo, cinestetico), un’attenzione agli effetti dell’attività e costituiscono progressivamente un<br />
repertorio di sensazioni, emozioni, consapevolezze.<br />
Il sapersi relazionare con gli altri<br />
Queste conoscenze concernono il modo di comportarsi in gruppo. Per es. gli alunni si aiutano l’un l’altro, partecipano<br />
all’organizzazione del materiale, prevengono i problemi di sicurezza degli altri, assumano ruoli diversi nelle attività<br />
praticate.<br />
LE COMPETENZE<br />
L’insieme delle conoscenze, mescolate fra loro e in interazione con gli apprendimenti pratici (il saper fare) permette<br />
agli alunni di costruire delle competenze, ossia la capacità di far fronte in modo adeguato a una situazione particolare o<br />
a un insieme di situazioni proposte dall’insegnante.<br />
Nell’insieme le competenze generali (dimensione culturale) dell’ed. fisica possono tradursi nella capacità di:<br />
1. realizzare una prestazione misurabile<br />
2. saper adattare gli spostamenti in ambienti molteplici, diversi o nuovi<br />
3. guidare il proprio corpo in azioni di tipo ginnico o artistico<br />
4. saper affrontare un’attività di opposizione individuale o collettiva<br />
5. orientare e sviluppare gli effetti dell’ed. fisica in vista del mantenimento personale della forma fisica<br />
Quando ci si confronta con l’attività fisica e sportiva sono sollecitate anche competenze di tipo metodologico; gli alunni<br />
devono infatti impegnarsi nell’attività, assumere dei rischi, procedere in maniera riflessiva, acquisire una migliore<br />
conoscenza di sé, imparare a lavorare insieme, ecc.<br />
Le competenze di ed. fisica di tipo metodologico possono essere generalizzate nel:<br />
1. impegnarsi con consapevolezza<br />
2. concepire dei progetti di apprendimento o allenamento<br />
3. apprezzare gli effetti dell’attività fisica<br />
4. confrontarsi con le regole della vita collettiva<br />
L’insieme delle competenze di tipo culturale e metodologico interagiscono costantemente durante la pratica e<br />
costituiscono il significato dell’ed. fisica scolastica: all’uscita del percorso liceale esse consentiranno agli studenti di<br />
accedere ai saperi utili all’elaborazione di un progetto personale di benessere e mantenimento della salute. Questi saperi<br />
sono utili durante il periodo scolastico e più generalmente lungo tutta la vita.<br />
49
L CONTRIBUTO DELL’ED. FISICA ALL’ACQUISIZIONE DELLE COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA<br />
L’ed. fisica partecipa all’acquisizione delle competenze chiave di cittadinanza attraverso l’esperienza concreta. E’ un<br />
esercizio di cittadinanza vissuta nell’agire, nell’apprendere, nel lavorare in gruppo, attraverso il quale l’alunno impara<br />
ad essere più autonomo, responsabile, capace di stare con gli altri, di prendere iniziative e concepire progetti.<br />
PROGRAMMAZIONE CURRICULARE DI ED. FISICA<br />
Per garantire una formazione equilibrata e il raggiungimento degli obiettivi della materia, i contenuti dell’insegnamento<br />
si organizzano intorno alle competenze culturali e metodologiche dell’ed. fisica e coerentemente con le Indicazioni<br />
Nazionali.<br />
I contenuti dell’ed. fisica attingono dal patrimonio culturale e sociale dell’esercizio fisico e delle discipline sportive;<br />
sono in funzione delle possibilità offerte dalla scuola in termini di spazi e attrezzatura e delle scelte dei singoli<br />
insegnanti. Al fine di assicurare una certa omogeneità di insegnamento il dipartimento adotta un insieme comune di<br />
attività, lasciando alla scelta individuale un insieme di altre attività.<br />
L’insieme comune è costituito da attività diversificate tra loro, con caratteristiche diverse dal punto di vista dei saperi e<br />
delle competenze sollecitate; esso è costituito da: la corsa di lunga durata, la ginnastica artistica e/o l’atletica, i giochi di<br />
squadra del basket e della pallavolo, l’educazione respiratoria e posturale, la teoria dell’esercizio fisico.<br />
Fra le attività scelte da singoli docenti ci sono attività sportive come il calcetto, il goback e il pattinaggio in linea,<br />
oppure attività artistiche come la danza, la giocoleria e l’acrosport.<br />
Le caratteristiche di ciascuna attività proposta formano le competenze specifiche da acquisire da parte dell’alunno.<br />
Sebbene ciascuna attività che si programmi chiami in causa fondamentalmente una competenza specifica, spesso le<br />
competenze sono presenti in forma combinata, si articolano e interagiscono costantemente durante la pratica, cosicché il<br />
conseguimento di una specifica competenza porta con sé anche competenze di tipo metodologico e sociale.<br />
Di seguito è riportata la programmazione delle attività comuni al dipartimento per ciascuna delle cinque classi, con i<br />
relativi obiettivi specifici di apprendimento e competenze attese, precisando che i programmi di ciascuna classe sono<br />
presentati dai singoli docenti all’avvio dell’ anno scolastico secondo le indicazioni di: situazione iniziale della classe,<br />
obiettivi specifici di apprendimento, contenuti, competenze attese, aspetti metodologici, criteri di valutazione e<br />
strumenti di verifica<br />
IL GINNASIO<br />
IV ginnasio<br />
La corsa<br />
L’appoggio corretto del piede<br />
Corsa continua ad un ritmo blando (10 min.)<br />
Pallavolo<br />
la tecnica dei gesti fondamentali di palleggio, bagher e battuta dal basso<br />
il gioco 1vs1 e 2 vs 2<br />
Basket<br />
la tecnica dei gesti fondamentali di palleggio e tiro libero<br />
il gioco 1 vs 1<br />
Ginnastica artistica<br />
La capovolta a braccia tese<br />
La postura<br />
Corretto assetto del dorso e della colonna vertebrale, il corretto appoggio degli arti inferiori.<br />
Esercizi posturali e di tonificazione dei muscoli posturali.<br />
V ginnasio<br />
La corsa<br />
2 km di corsa continua a 8 km/h e 9 km/h<br />
La respirazione<br />
La respirazione nell’esercizio fisico, rilevazione del numero dei battiti cardiaci a riposo, sotto sforzo e relativo<br />
tempo di recupero.<br />
Pallavolo<br />
il controllo della palla nel palleggio, nel bagher e nella battuta dal basso<br />
gioco 2 c 2<br />
Basket :<br />
il passaggio<br />
il palleggio con l’indipendenza dello sguardo, il palleggio in superamento di un D (difensore)<br />
la situazione dell’1 c 1 nel palleggio e nel tiro<br />
la situazione del 2 c 1 (imparare a smarcarsi e a passare)<br />
50
Il salto in alto<br />
La tecnica del Fosbury<br />
La ginnastica artistica<br />
Posizioni in atteggiamento rovesciato del corpo (la propedeutica della verticale al muro)<br />
COMPETENZE ATTESE ALLA FINE DELL’OBBLIGO SCOLASTICO<br />
Rappresentano un livello minimo di competenze e conoscenze richiesto alla fine delle classi ginnasiali nelle attività<br />
comuni al dipartimento; esse consentono un primo livello di autonomia nella pratica delle attività fisico-sportive<br />
Attività aerobica<br />
Produrre uno sforzo in relazione a un carico di lavoro prestabilito<br />
Modulare l’intensità dello sforzo in relazione alla situazione personale.<br />
Impegnarsi in un progetto personalizzato di miglioramento di sé.<br />
Pallavolo<br />
In situazione di gioco ridotto, cercare di ottenere punti attraverso un rinvio corretto della palla, da solo o con<br />
l’aiuto di un compagno, sfruttando tutto lo spazio del campo avversario.<br />
Impegnarsi in un progetto di gioco semplice legato al rinvio della palla.<br />
Rispettare i compagni, gli avversari e le decisioni dell’arbitro.<br />
Basket<br />
In una situazione di gioco ridotto a squadre di due o tre giocatori, cercare di far avanzare la palla verso la zona<br />
di attacco attraverso scelte pertinenti di azioni di passaggio o palleggio, contro una difesa che cerca di<br />
recuperare la palla, nel rispetto della regola del non contatto.<br />
Inserirsi in un progetto di gioco semplice legato alla progressione della palla.<br />
Rispettare i compagni, gli avversari e le decisioni dell’arbitro.<br />
Ginnastica artistica<br />
Realizzare almeno due figure in atteggiamento di corpo rovesciato, da solo, o con aiuto, nel rispetto delle<br />
regole di sicurezza.<br />
IL LICEO<br />
1^ liceo<br />
Corsa<br />
2 km di corsa continua a 8km/h, 9km/h, 10 km/h, 11 km/h<br />
test VMA (Velocità Max Aerobica)<br />
Pallavolo<br />
la propedeutica delle azioni di attacco di schiacciata, pallonetto e battuta dall’alto<br />
la ricezione e il passaggio all’alzatore<br />
gioco 3 c 3<br />
Basket<br />
i principi tattici<br />
la situazione 2 c 1 e 3 c 2 e il gioco 3 c 3<br />
il tiro in 3^ tempo<br />
La ginnastica artistica<br />
la verticale al muro<br />
2^ liceo<br />
Corsa<br />
2, 4 o 6 km di corsa continua<br />
Pallavolo<br />
La schiacciata, il pallonetto e la battuta dall’alto<br />
Il gioco 3 c 3 e 6 c 6<br />
Basket<br />
Il tiro in entrata<br />
Il gioco 3 c 3<br />
La ginnastica artistica<br />
L’acrosport (“piramidi umane”)<br />
3^ liceo<br />
Corsa<br />
2, 4 o 6 km di corsa continua<br />
51
Teoria<br />
conoscenze scientifiche relative a: l’apparato locomotorio, la biomeccanica del movimento, i gruppi muscolari<br />
dell’arto inferiore e del busto, la postura, l’allungamento muscolare, la tonificazione muscolare, l’attività<br />
aerobica e il consumo energetico.<br />
Pallavolo<br />
La schiacciata e la battuta dall’alto<br />
Il gioco 6 c 6<br />
Fitness<br />
La tonificazione e l’allungamento muscolare<br />
COMPETENZE ATTESE ALLA FINE DEL CICLO SCOLASTICO<br />
Esse favoriscono un ulteriore livello di autonomia nella pratica motoria di ciascun alunno; rappresentano gli strumenti<br />
effettivi di una cittadinanza responsabile, basata su una condotta corretta della propria vita fisica, attraverso la<br />
partecipazione a pratiche sociali o la capacità di progettare in proprio un allenamento.<br />
Attività aerobica<br />
Elaborare e realizzare un progetto di allenamento personale di miglioramento delle capacità aerobiche con una<br />
prospettiva di effetti a medio/lungo termine.<br />
Tonificazione muscolare<br />
Elaborare e realizzare un progetto di allenamento personale riguardante la capacità di forza muscolare, in relazione a<br />
effetti attesi nel medio/lungo periodo, salvaguardando l’integrità fisica.<br />
Allungamento muscolare (stretching)<br />
Individuare e realizzare una batteria di es. di allungamento di mantenimento o miglioramento della propria elasticità in<br />
funzione delle condizioni personali e del proprio progetto di allenamento (riduzione delle tensioni, aumento<br />
dell’escursione articolare).<br />
Pallavolo<br />
Ottenere la vittoria in una partita attraverso la messa in pratica di un’organizzazione collettiva in grado di costruisce il<br />
gioco per favorire le possibilità di attacco, attraverso palle veloci o piazzate.<br />
Impegnarsi in un progetto di gioco legato all’efficacia dell’attacco.<br />
Rispettare i compagni, gli avversari e le decisioni dell’arbitro.<br />
Essere in grado di arbitrare.<br />
Basket<br />
In una situazione di gioco a squadre di quattro/cinque giocatori, cercare la vittoria attraverso l’organizzazione di azioni<br />
di attacco per arrivare a tirare in posizione favorevole, con una difesa che cerca di disturbare la progressione della palla<br />
nel rispetto delle principali regole del gioco.<br />
Inserirsi in un progetto di gioco semplice legato alla progressione della palla.<br />
Rispettare i compagni, gli avversari e le decisioni dell’arbitro.<br />
Essere in grado di arbitrare.<br />
LA VALUTAZIONE IN EDUCAZIONE FISICA<br />
La valutazione in ed. fisica riguarda fondamentalmente il saper fare degli alunni di fronte a situazioni particolari,<br />
caratterizzanti una competenza specifica.<br />
Precisato che le competenze sono identificabili alla fine di un periodo sufficientemente lungo di apprendimento e che le<br />
conoscenze insite nell’apprendimento non sono valutabili di per sé, separatamente dalla competenza, si presentano le<br />
tabelle docimologiche significative del livello di apprendimento degli alunni, relativamente agli obiettivi specifici di<br />
apprendimento (il saper fare) comuni al dipartimento, premesso che la valutazione in ed. fisica si avvale di quattro<br />
differenti tipologie di verifica.<br />
Rilevazione di misure:<br />
rilevazione della riuscita nella corsa in un percorso di 2 Km alla velocità min. di 8km/h;<br />
rilevazione della VMA (velocità massima aerobica)<br />
Osservazione delle abilità motorie:<br />
correttezza dell’esecuzione in compiti motori di tipo prescrittivo, quali per es. :<br />
osservazione dell'esecuzione del salto in alto<br />
osservazione dell’esecuzione dei fondamentali di un gioco sportivo<br />
osservazione dell'esecuzione della verticale<br />
osservazione della riuscita di alcune figure dell’acrosport<br />
Osservazione della capacità di problem-solving quali per es.:<br />
saper scegliere la giusta azione in una esercitazione di tipo finalizzato (es. 2 vs 1, 2 vs 2 dei giochi sportivi)<br />
saper giocare il 3 vs 3 applicando principi tattici<br />
52
saper occupare la giusta posizione in campo in situazioni di gioco<br />
saper affrontare in modo creativo, attraverso gli elementi forniti dall’insegnante, situazioni aperte di tipo<br />
espressivo o sportivo.<br />
Verifica scritta su contenuti teorici-scientidici<br />
Griglie di valutazione disciplinare<br />
Competenza : saper affrontare un’attività di opposizione individuale o collettiva<br />
Attività: pallavolo<br />
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO: palleggio, bagher e battuta dal basso<br />
CLASSI 4^ - 5^ ginnasio<br />
Non applica i principi esecutivi del gesto voto 5<br />
Tenta di applicare i principi esecutivi del gesto voto 6<br />
Esegue correttamente il gesto tecnico voto 7-8<br />
Controlla la palla in una situazione semplice e ripetitiva voto 8-9<br />
CLASSI LICEALI<br />
Non applica i principi esecutivi del gesto voto 5<br />
Tenta di applicare i principi esecutivi del gesto voto 6<br />
Esegue correttamente il gesto tecnico solo in situazione semplice voto 7<br />
Controlla la palla nei fondamentali in esercitazioni di tipo finalizzata voto 8<br />
Controlla la palla nei fondamentali in situazione di gioco voto 9<br />
Esegue azioni di attacco in situazione di gioco voto 10<br />
Competenza: saper affrontare un’attività di opposizione individuale o collettiva<br />
Attività: il gioco del basket<br />
OBIETTIVO SPECIFICO DI APPRENDIMENTO: il palleggio<br />
CLASSI 4^ e 5^ ginnasio<br />
Non sa palleggiare voto 5<br />
Palleggia con entrambe le mani con il controllo dello sguardo voto 6<br />
Sa eseguire il palleggio con il cambio di mano voto 7<br />
Sa palleggiare con l’indipendenza dello sguardo voto 8<br />
Sa superare il D (difensore) in palleggio col cambio di mano voto 9<br />
CLASSI LICEALI<br />
Non sa eseguire il palleggio e non sa eseguire il cambio di mano voto 5<br />
Esegue il palleggio con il cambio di mano voto 6<br />
Esegue il palleggio in esercitazioni di superamento di un D voto 7<br />
Esegue il palleggio di attesa in esercitazioni di tipo finalizzato voto 8<br />
Utilizza il palleggio di attesa e in avanzamento in situazione di gioco voto 9<br />
Utilizza il palleggio in situazione di gioco per superare un avversario voto 10<br />
OBIETTIVO SPECIFICO DI APPRENDIMENTO: il tiro<br />
CLASSI 4^ - 5^ ginnasio<br />
Non applica i principi esecutivi del gesto voto 5<br />
Tenta di applicare i principi esecutivi del gesto voto 6-7<br />
Esegue correttamente il gesto voto 8<br />
Controlla la palla in una situazione semplice e ripetitiva voto 9<br />
53
CLASSI LICEALI<br />
Non applica i principi esecutivi né del “tiro libero” né “in entrata “ voto 5<br />
Tenta di applicare i principi esecutivi del gesto voto 6<br />
Esegue correttamente solo un tipo di tiro voto 7<br />
Esegue correttamente entrambi i tiri voto 8<br />
Esegue correttamente il gesto in esercitazioni di tipo finalizzato voto 9<br />
Applica il gesto in situazione di gioco voto 10<br />
Competenza: realizzare una prestazione misurabile<br />
Attività aerobica della corsa di lunga durata<br />
OBIETTIVO SPECIFICO DI APPRENDIMENTO: corsa continua di 2 km<br />
CLASSI 5^ GINNASIO<br />
Femmine<br />
Corre fino a 700 m (5 min.) voto 4<br />
Corre 700-1400 m (5-10 min) voto 5<br />
Corre 1400-1900 (10-14 min) voto 6<br />
Corre 2 km a 8 km/h voto 7<br />
Corre 2 km a 9 km/h voto 8<br />
Corre 2 km a 10 km/h voto 9<br />
Corre 2 km a 11 km/h voto 10<br />
CLASSI 1^ LICEO<br />
Femmine<br />
Corre fino a 700 m (5 min.) voto 3<br />
Corre 700-1400 m (5-10 min) voto 4<br />
Corre 1400-1900 (10-14 min) voto 5<br />
Corre 2 km a 8 km/h voto 6<br />
Corre 2 km a 9 km/h voto 7<br />
Corre 2 km a 10 km/h voto 8<br />
Corre 2 km a 11 km/h voto 9<br />
Corre 3 km a 11 km/h voto 10<br />
Maschi<br />
Corre 700-1400 mt (5-10 min voto 4<br />
Corre 1400-1900 (10-14 min) voto 5<br />
Corre 2 km a 8 km/h voto 6<br />
Corre 2 km a 9 km/h voto 7<br />
Corre 2 km a 10 km/h voto 8<br />
Corre 2 km a 11 km/h voto 9<br />
Corre 3 km a 11 km/h voto 10<br />
Maschi<br />
Corre 700-1400 mt (5-10 min voto 3<br />
Corre 1400-1900 (10-14 min) voto 4<br />
Corre 2 km a 8 km/h voto 5<br />
Corre 2 km a 9 km/h voto 6<br />
Corre 2 km a 10 km/h voto 7<br />
Corre 2 km a 11 km/h voto 8<br />
Corre 3 km a 11 km/h voto 9<br />
Corre oltre 3 km a 11 km/h voto 10<br />
54
PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE DI RELIGIONE<br />
OBIETTIVI SPECIFICI DELLA PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE<br />
Assi portanti della programmazione disciplinare sono la mediazione del la cultura cristiana , il suo aprirsi al confronto<br />
con altre fedi religiose e credi filosofici, l’attenzione alle domande esistenziali dell’alunno, secondo le forme proprie<br />
della sua età e condizione , quali sono ad esempio le domande sul senso religioso,<br />
sulla ricerca del bene e del vero, sulla costruzione di relazioni interpersonali, sulla scelta di valori di riferimento per la<br />
propria realizzazione di persona libera e responsabile.<br />
Considerata in generale la peculiarità culturale degli studi affrontati dagli alunni nel corso dell’intero quinquennio, la<br />
programmazione disciplinare cerca quanto più possibile di creare intersezioni con le le discipline affini - storia,<br />
filosofia, letteratura italiana e straniera, storia dell’arte.<br />
Coerentemente con quanto è indicato dalla normativa vigente sull’insegnamento della religione nella scuola italiana, la<br />
programmazione propone la cultura religiosa quale valore fondamentale dell’uomo;<br />
tiene conto del fatto che la religione cattolica è parte del patrimonio storico del popolo italiano e la propone in<br />
prospettiva culturale, nel rispetto della coscienza degli alunni e tenendo conto delle finalità generali della scuola;<br />
afferma che si tratta di una disciplina a tutti gli effetti scolastica, che mira alla formazione integrale della persona.<br />
La programmazione disciplinare cerca quanto più possibile di creare occasioni per gli alunni di interagire con<br />
l’insegnante, offrendo opportunità d’intervento durante la lezione svolta in classe, nella consapevolezza che, portando<br />
l’alunno ad una più attiva riflessione, esso utilizzerà le nuove conoscenze come strumenti efficaci per l’esercizio delle<br />
competenze adeguate all’età e al contenuto.<br />
Considerata in generale la peculiarità culturale degli studi affrontati dagli alunni nel corso dell’intero Quinquennio, In<br />
accordo con il POF della Scuola, la lezione è concepita come dialogo educativo , in cui l’insegnante offre opportunità di<br />
conoscenze adeguate all’età dello scolaro e allo sviluppo della disciplina, facendo leva sull’interesse o suscitandolo<br />
oppure ancora rispondendo a domande poste dagli alunni sul tema proposto.<br />
NUCLEI TEMATICI<br />
Le aree contenutistiche sono organizzate per macrotemi didattici: il Fenomeno religioso; la Storia della Salvezza nel<br />
testo biblico; Gesù e l’annuncio del Regno; la Morale; Chiesa e Mondo.<br />
COMPETENZE DISCIPLINARI<br />
Nello svolgimento dei macrotemi, ci si propone di offrire almeno le informazioni essenziali e di coinvolgere gli alunni a<br />
dichiarare le loro conoscenze in materia, formulando inoltre domande di chiarimento e/o approfondimento unitamente a<br />
osservazioni personali e metodologiche. Lo scopo è formare attraverso l’informazione e motivare attraverso la<br />
partecipazione. Ci si propone di favorire l’acquisizione, da parte degli alunni, di una strumentazione fondamentale che<br />
consenta loro di arrivare a esprimersi e a prendere posizione, con conoscenze idee giudizi domande, sulla problematica<br />
religiosa. Per il concreto perseguimento di tale scopo, si sollecitano gli alunni a esprimere con correttezza e precisione il<br />
proprio pensiero.<br />
CRITERI DI VALUTAZIONE<br />
Ai fini della Valutazione sono utilizzati i seguenti criteri:<br />
Interesse (curiosità e attenzione);<br />
Partecipazione ( collaborazione al dialogo educativo);<br />
Raggiungimento degli Obiettivi desumibile dalla qualità degli interventi e delle risposte (frammentarie,<br />
superficiali, mnemoniche, adeguate, pertinenti, povere, argomentate sulla base di conoscenze, di riflessioni e<br />
di collegamenti ).<br />
La Valutazione è articolata con i seguenti Giudizi : INSUFFICENTE, SCARSO, SUFFICIENTE, DISCRETO,<br />
MOLTO e MOLTISSIMO.<br />
55