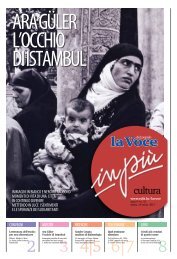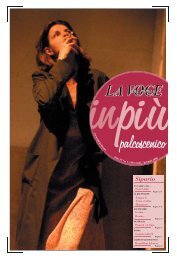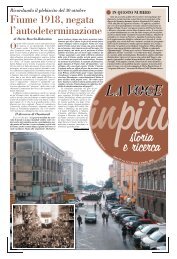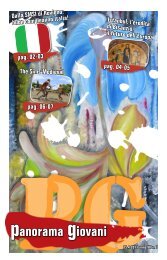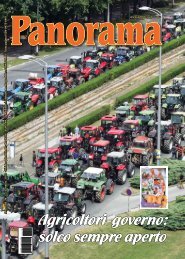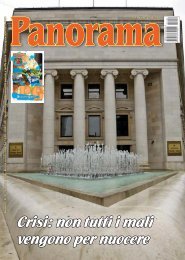Centro di Ricerche Storiche di Rovigno quarant'anni fa i primi ... - Edit
Centro di Ricerche Storiche di Rovigno quarant'anni fa i primi ... - Edit
Centro di Ricerche Storiche di Rovigno quarant'anni fa i primi ... - Edit
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
2 storia e ricerca<br />
CONTRIBUTI<br />
<strong>di</strong> Kristjan Knez<br />
Il 3 novembre 1918, con la fi rma<br />
dell’armistizio a Villa Giusti<br />
presso Padova e la successiva<br />
entrata del regio esercito a<br />
Trento e Trieste, si pose fi ne alla<br />
carnefi cina che per tre anni e mezzo<br />
aveva sconvolto i territori compresi<br />
tra le Alpi e il mare Adriatico.<br />
Il venir meno delle ostilità aveva<br />
rappresentato la conclusione <strong>di</strong><br />
quella mattanza ma al contempo<br />
aperse nuove questioni <strong>di</strong> non irrilevante<br />
portata. E non poteva<br />
andare <strong>di</strong>versamente. La guerra<br />
che scoppiò tra il Regno d’Italia e<br />
l’Impero austro-ungarico non era<br />
solo un nuovo fronte che si aperse<br />
nel già ferito vecchio continente,<br />
essa incarnava <strong>di</strong>ssi<strong>di</strong> molto profon<strong>di</strong><br />
che si protraevano, in forma<br />
acuta, da almeno un quarantennio,<br />
in primo luogo per la questione<br />
delle “terre irredente”. Pertanto,<br />
accanto ai tuoni delle cannonate<br />
che sconvolsero il nuovo teatro<br />
bellico, è utile tenere presente<br />
anche le altre <strong>di</strong>mensioni che confl<br />
uirono in quello scontro.<br />
Per gli italiani<br />
fu la «redenzione»<br />
Per l’Italia si trattava <strong>di</strong> una<br />
guerra <strong>di</strong> “liberazione” e <strong>di</strong> “re-<br />
denzione” che avrebbe fi nalmente<br />
portato alla defi nitiva unità nazionale<br />
e grazie alla quale si sarebbe<br />
concluso quel percorso iniziato<br />
nei <strong>primi</strong> decenni dell’Ottocento<br />
con il Risorgimento, in<strong>fa</strong>tti<br />
si parlava della “quarta guerra<br />
d’in<strong>di</strong>pendenza”. Per la duplice<br />
monarchia, invece, la <strong>di</strong>chiarazione<br />
delle ostilità era il risultato del<br />
tra<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> un alleato – l’Italia<br />
nel 1882 era entrata nella Triplice<br />
Alleanza – la cui mira era l’occupazione<br />
<strong>di</strong> parte del suo territorio,<br />
compresa Trieste, centro economico-commerciale<br />
<strong>di</strong> rilievo, il<br />
cui porto era defi nito il “polmone”<br />
dell’Impero. La posizione<br />
<strong>di</strong> Vienna non era errata. La monarchia<br />
sabauda, corteggiata dalle<br />
potenze della Triplice Intesa,<br />
alla fi ne fi rmò il patto segreto <strong>di</strong><br />
Londra (26 aprile 1915) in cui,<br />
in caso <strong>di</strong> vittoria, le veniva promesso<br />
una serie <strong>di</strong> territori appartenenti<br />
alla monarchia danubiana<br />
e che coincidevano, in buona<br />
parte, a quegli stessi che avevano<br />
prodotto le controversie tra le due<br />
parti fra Otto e Nocevento. Perciò<br />
se nel “maggio ra<strong>di</strong>oso” le armate<br />
italiane si mossero lungo la frontiera<br />
orientale, lo fecero in primo<br />
luogo per acquisire quelle porzioni<br />
<strong>di</strong> territorio, defi nite anche<br />
“l’Italia d’oltre confi ne”.<br />
Antagonismi<br />
e appetiti<br />
Per il comando austriaco si<br />
trattava <strong>di</strong> una guerra <strong>di</strong> conquista,<br />
imperialista, e per fronteggiarla<br />
non <strong>di</strong>sdegnò <strong>di</strong> utilizzare<br />
gli antagonismi nazionali, che da<br />
decenni stavano caratterizzando<br />
la vita nelle regioni af<strong>fa</strong>cciate<br />
sull’Adriatico orientale. Nel luglio<br />
del 1915 lo Stato Maggiore<br />
dell’Impero tentò <strong>di</strong> motivare gli<br />
Sloveni alla <strong>di</strong>fesa <strong>di</strong> fronte ad<br />
una possibile avanzata italiana<br />
in profon<strong>di</strong>tà. Quin<strong>di</strong> si fece leva<br />
sul patriottismo e sull’avversità<br />
nei confronti dell’Italia e dei suoi<br />
“appetiti”. E nello scontro con il<br />
vicino l’Isonzo si tinse <strong>di</strong> rosso,<br />
proprio come aveva funestamente<br />
congetturato il sacerdote e poeta<br />
<strong>di</strong> Tolmino, Simon Gregorčič,<br />
nella sua celeberrima poesia de<strong>di</strong>ca<br />
a quel fi ume.<br />
Sul fronte dell’Isonzo e sul<br />
Carso buona parte dei soldati era-<br />
Mostre, <strong>di</strong>battiti, letture, spettacoli, fi lm e documentari d’autore<br />
Venerdì, 7 novembre 2008<br />
no Slavi (Sloveni, Croati, Serbi<br />
della Krajina e della Bosnia,<br />
ecc.). Per i medesimi si trattava<br />
in primo luogo <strong>di</strong> <strong>di</strong>fendere il<br />
suolo natio e l’orgoglio, e <strong>di</strong> conseguenza<br />
erano fortemente motivati<br />
a combattere, malgrado le<br />
<strong>di</strong>ffi cili con<strong>di</strong>zioni orografi che e<br />
climatiche <strong>di</strong> quel settore, a <strong>di</strong>fferenza<br />
dei <strong>fa</strong>nti italiani, specie<br />
quelli del <strong>Centro</strong> e del Sud, che<br />
erano giunti in territori lontani,<br />
ove pure i toponimi avevano un<br />
suono “aspro”.<br />
Lo spazio slavo<br />
Benché essi si battessero per<br />
la “redenzione” dei connazionali<br />
della sponda opposta adriatica, la<br />
linea del fronte correva e si incuneava<br />
nello spazio etnico e culturale<br />
sloveno – non venne toccata<br />
né l’Istria né Trieste –, la cui popolazione,<br />
grazie all’azione del<br />
clero, aveva sviluppato un forte<br />
senso <strong>di</strong> appartenenza nazionale.<br />
Questo aspetto era stato rammentato<br />
da Attilio Tamaro già nel<br />
1919; ma il primo ad affrontarlo,<br />
inserendolo nel contesto della<br />
Grande guerra, è stato lo storico<br />
militare Antonio Sema, che, con<br />
la competenza che lo contrad<strong>di</strong>stingueva,<br />
è stato tra i <strong>primi</strong> – se<br />
non il primo in Italia – a scriverne<br />
in termini scientifi ci, analizzandone<br />
il problema (ricor<strong>di</strong>amo in primo<br />
luogo i tre tomi “La Grande<br />
guerra sul fronte dell’Isonzo”, Libreria<br />
E<strong>di</strong>trice Goriziana, Gorizia<br />
1995-1997). Lo stu<strong>di</strong>oso evidenzia<br />
altresì che molte delle questioni<br />
verifi catesi nella Venezia Giulia<br />
sul fi nire della seconda guerra<br />
mon<strong>di</strong>ale o nell’imme<strong>di</strong>ato dopoguerra<br />
(il concetto <strong>di</strong> spazio etni-<br />
Trieste ricorda il novantesimo della redenzione<br />
Cinque mostre, una <strong>di</strong>visa in sei<br />
sezioni, <strong>di</strong>battiti, letture, spettacoli,<br />
fi lm e documentari d’autore<br />
animeranno i prossimi due mesi gli<br />
spazi culturali più rappresentativi <strong>di</strong><br />
Trieste, a cura dell’Assessorato alla<br />
Cultura del Comune <strong>di</strong> Trieste, Direzione<br />
Area Cultura e Civici Musei<br />
<strong>di</strong> Storia ed Arte, in occasione del<br />
90.esimo anniversario della Prima<br />
redenzione <strong>di</strong> Trieste e della fi ne della<br />
Prima guerra mon<strong>di</strong>ale. I contenuti<br />
della manifestazione sono emersi da<br />
un serrato lavoro <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>osi e docenti<br />
<strong>di</strong> varie università italiane, componenti<br />
<strong>di</strong> un comitato scientifi co che<br />
ha a lungo <strong>di</strong>scusso e approfon<strong>di</strong>to<br />
temi e argomenti defi nendo un percorso<br />
a tappe che narra il racconto<br />
della Grande Guerra osservandolo<br />
da più angolazioni. La prima mostra<br />
curata da Lorenza Resciniti, conservatore<br />
presso i Civici Musei <strong>di</strong> Storia<br />
ed Arte <strong>di</strong> Trieste, è stata inaugurata<br />
il 30 ottobre scorso presso la Sala Attilio<br />
Selva <strong>di</strong> Palazzo Gopcevich con<br />
il titolo “Il tesoro riscoperto”, la storia<br />
<strong>di</strong> una scoperta clamorosa: per la<br />
prima volta viene esposto un “tesoro<br />
segreto”, custo<strong>di</strong>to nelle casseforti<br />
dell’Archivio <strong>di</strong> Stato <strong>di</strong> Trieste,<br />
quale ere<strong>di</strong>tà del governo austriaco.<br />
Si tratta <strong>di</strong> tremila preziosi, custo<strong>di</strong>ti<br />
in 384 sacchetti <strong>di</strong> stof<strong>fa</strong> bianca che<br />
racchiudono spille, bracciali, collane,<br />
orecchini, anelli d’oro e d’argento,<br />
accanto a monete, bancono-<br />
Le <strong>di</strong>mensioni <strong>di</strong> uno scontro che si accese sulle ferite della Grande G<br />
1918: il crollo dell’Austria-Ung<br />
<strong>di</strong> Francesco Cenetiempo<br />
La popolazione <strong>di</strong> Lissa attende le forze militari italiane<br />
te, posate, candelabri <strong>fa</strong>centi parte<br />
della serie dei “depositi giu<strong>di</strong>ziali”,<br />
consegnata fi n dal ‘700 al Tribunale<br />
<strong>di</strong> Trieste. Il ricco materiale deriva<br />
da sequestri, recupero <strong>di</strong> refurtiva,<br />
spese legali e cauzioni, patrimonio<br />
<strong>di</strong> defunti in presenza <strong>di</strong> fi gli minori,<br />
<strong>di</strong> soggetti sottoposti a tutela, <strong>di</strong><br />
ere<strong>di</strong> irreperibili e <strong>fa</strong>llimenti. Con il<br />
passaggio dall’amministrazione austriaca<br />
a quella italiana tutti i preziosi<br />
passarono in custo<strong>di</strong>a dell’Intendenza<br />
<strong>di</strong> Finanza e da questa (decreto 28<br />
<strong>di</strong>cembre 2000 n.1390) all’Archivio<br />
<strong>di</strong> Stato <strong>di</strong> Trieste. Il corpus che ne è<br />
derivato, offre una visione peculiare<br />
della società triestina nel momento<br />
in cui la città si evolve da periferia<br />
dell’Impero austroungarico a porto<br />
commerciale <strong>di</strong> primaria importanza.<br />
I gioielli, commissionati e indossati<br />
dai ceti borghesi, testimoniano<br />
una nuova ricchezza, da godere e<br />
mostrare, alle volte ricercata e rara,<br />
grazie alle possibilità <strong>di</strong> interscambio<br />
con i paesi lontani raggiunti dalle<br />
navi mercantili.<br />
Nelle immagini<br />
l’entusiasmo popolare<br />
Nella stessa giornata ha preso il<br />
via presso la Sala Umberto Veruda<br />
<strong>di</strong> Palazzo Costanzi la Mostra “Trieste<br />
liberata”. La cronaca nelle immagini<br />
della Fototeca dei Civici Musei<br />
<strong>di</strong> Storia ed Arte a cura <strong>di</strong> Francesco<br />
Fait e Clau<strong>di</strong>a Morgan degli stessi<br />
Civici Musei triestini. Le giornate<br />
<strong>di</strong> fi ne ottobre e inizio novembre<br />
del 1918, giornate <strong>di</strong> entusiasmo popolare<br />
per il passaggio <strong>di</strong> Trieste all’Italia,<br />
giornate <strong>di</strong> manifestazioni e<br />
<strong>di</strong> atti simbolici, come la rimozione<br />
dell’aquila bicipite dal palazzo della<br />
Luogotenenza, sono documentate<br />
dal corpus <strong>di</strong> immagini fotografi che<br />
selezionato tra il consistente patrimonio<br />
<strong>di</strong> fon<strong>di</strong> fotografi ci, fi rmati<br />
dai più noti fotografi <strong>di</strong> fi ne Ottocento<br />
operanti a Trieste. Nella Camera<br />
chiara, ancora oggi opera fondamentale<br />
<strong>di</strong> critica fotografi ca, Roland<br />
Barthes racconta un aneddoto:<br />
osservando una foto del 1852 raffi -<br />
gurante l’ultimo fratello <strong>di</strong> Napoleone<br />
stupito pensò: “Questi occhi hanno<br />
visto l’imperatore!”, rendendosi<br />
conto che la fotografi a “riproduce<br />
all’infi nito ciò che ha avuto luogo<br />
una sola volta”, ciò che non potrà<br />
mai più ripetersi. Ecco dunque l’essenza<br />
e il <strong>fa</strong>scino della fotografi a:<br />
ciò che è stato fotogra<strong>fa</strong>to è esistito.<br />
Essa non inventa, ha il potere <strong>di</strong><br />
<strong>fa</strong>r rivivere ciò che è stato. Dunque<br />
che cosa meglio <strong>di</strong> una mostra fotografi<br />
ca per documentare quei cinque<br />
giorni intensi ed esaltanti, vissuti da<br />
Trieste dal 30 ottobre al 3 novembre<br />
del 1918? Questo periodo è stato un<br />
banco <strong>di</strong> prova per i fotografi triestini:<br />
osservando la totalità delle opere<br />
in mostra ci si rende conto <strong>di</strong> quanto<br />
le immagini dei fratelli Avanzo,<br />
<strong>di</strong> Umberto Morterra, <strong>di</strong> Arnaldo<br />
Polacco si inseriscano a pieno titolo<br />
nel fi lone della fotografi a documentaria<br />
internazionale e anticipino<br />
le moment décisif <strong>di</strong> cui parlerà decenni<br />
dopo Cartier-Bresson: immortalare<br />
il momento, ma non un attimo<br />
qualsiasi, il momento decisivo che<br />
condensa l’essenza della situazione.<br />
Dall’altro lato Giuseppe Furlani,<br />
insegnante, pittore e fotografo,<br />
con le sue raffi nate immagini è un<br />
degno rappresentante del pittorialismo,<br />
il movimento nato alla fi ne del<br />
XIX secolo per nobilitare la fotografi<br />
a, dandole le qualità <strong>di</strong> una grande<br />
arte pur senza nulla sacrifi care alla<br />
verità.<br />
La posta<br />
degli irredenti<br />
Dalla Trieste austriaca in guerra,<br />
da una città come la defi nì Eugenio<br />
Montale “intensamente europea eppure<br />
inconfon<strong>di</strong>bilmente legata ad<br />
un ceppo ben <strong>di</strong>stinto per linguaggio,<br />
sangue e tra<strong>di</strong>zioni” (dal <strong>di</strong>scorso<br />
pronunciato da Eugenio Montale<br />
al Circolo della Cultura e delle Arti<br />
<strong>di</strong> Trieste nella ricorrenza del centenario<br />
della nascita <strong>di</strong> Italo Svevo),<br />
tra il maggio del 1915 e l’ottobre<br />
del 1918, partono per il fronte italiano<br />
1047 volontari (2107 da tutte<br />
le terre giuliane dalmate e fi umane).<br />
Uomini e ragazzi che si arruolano<br />
nelle fi le dell’esercito italiano<br />
per realizzare un loro ideale, anche<br />
a costo dell’estremo sacrifi cio del-<br />
la loro vita; do<strong>di</strong>ci saranno insigniti<br />
della massima onorifi cenza, la medaglia<br />
d’oro al valore militare. Sono<br />
Guido Brunner, Guido Corsi, Fabio<br />
Filzi, Ugo Pizzarello, Ugo Polonio,<br />
Francesco Rismondo, Nazario<br />
Sauro, Guido Slataper, Giani e Carlo<br />
Stuparich, Spiro Tipaldo Xi<strong>di</strong>as,<br />
Giacomo Venezian. Nel Museo Postale<br />
e Telegrafi co della Mitteleuropa<br />
si è aperta il 31 ottobre, con la curatela<br />
della sua <strong>di</strong>rettrice Chiara Simon,<br />
“La posta degli irredenti. Documenti<br />
dei volontari giuliani e dalmati”: qui<br />
sono raccontate le loro storie attraverso<br />
la corrispondenza dal fronte e<br />
i ritagli <strong>di</strong> giornali dell’epoca. Un’ulteriore<br />
sezione è de<strong>di</strong>cata alle cartoline<br />
del 1918, inneggianti alla “Trieste<br />
liberata” con l’arrivo degli italiani.<br />
È raccontato, inoltre, lo sviluppo<br />
del servizio <strong>di</strong> posta militare italiano,<br />
inesistente prima del 1915, che viene<br />
completamente riorganizzato proprio<br />
allo scoppio della Prima guerra<br />
mon<strong>di</strong>ale dall’Amministrazione delle<br />
Poste e dei Telegrafi del Regno<br />
d’Italia.<br />
Eroi in <strong>di</strong>visa<br />
Segue l’esposizione curata da<br />
Antonella Cosenzi, archivista dei<br />
Civici Musei <strong>di</strong> Storia ed Arte, “Eroi<br />
in <strong>di</strong>visa. Uniformi dalle collezioni<br />
civiche”. Una decina <strong>di</strong> giacche<br />
da uniforme e copricapo del Regio<br />
Esercito Italiano, relative alla prima<br />
guerra mon<strong>di</strong>ale sono esposte per la<br />
prima volta nella signifi cativa cor