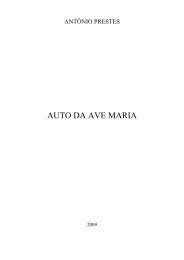Serenella Pelaggi* PER UNA REVISIONE DELL'AREA DELL ...
Serenella Pelaggi* PER UNA REVISIONE DELL'AREA DELL ...
Serenella Pelaggi* PER UNA REVISIONE DELL'AREA DELL ...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
La nozione di complemento ha una sua utilità didattica, ma è molto<br />
discussa nella linguistica moderna; si rivolgono critiche, in particolare,<br />
all’inesauribile moltiplicazione dei complementi “minori”, che creano<br />
spesso divisioni artificiose e arbitrarie.<br />
Gli autori si limitano dunque ad enunciare 31 complementi in tutto,<br />
tra principali e minori, molti dei quali con varie suddivisioni (ibidem: 72-<br />
-79).<br />
Concordando indubbiamente sulla opinabilità dei criteri di classificazione<br />
dei complementi indiretti, qui però ne mettiamo anche in discussione<br />
l’ utilità pratica, tanto più ai fini della didattica. Questo è confermato<br />
dall’analisi dei testi per l’insegnamento dell’italiano come LS, che<br />
a stento introducono complementi indiretti minori o peraltro principali in<br />
quanto tali; privilegiano piuttosto la presentazione dei verbi intransitivi<br />
con le eventuali preposizioni da cui sono comunemente accompagnati,<br />
e assimilano i cosiddetti complementi minori alla nozione più ampia di<br />
uso della lingua, nell’ambito delle funzioni, o in spazi denominati<br />
Come si dice?. Prendiamo ad esempio (ibidem: 76):<br />
a. la presunzione deriva spesso dall’ignoranza;<br />
b. un articolo ricco di spunti critici;<br />
c. discutere della situazione politica;<br />
nella prassi didattica si presenteranno i gruppi fraseologici: derivare<br />
da, (essere) ricco di, e discutere di, ovviando del tutto<br />
all’introduzione dei complementi rispettivamente di<br />
a. allontanamento /origine /separazione /provenienza;<br />
b. abbondanza /privazione;<br />
c. argomento.<br />
Il Sensini (1994: 222), a riguardo della definizione di verbi transitivi<br />
e intransitivi, rileva:<br />
«Il verbo intransitivo vede esaurirsi nel soggetto l’azione che esprime e,<br />
quindi, non ammette un complemento oggetto diretto dopo di sé. Ciò, però,<br />
non significa che l’azione che esso indica non possa aver bisogno di un<br />
completamento in un altro elemento della frase e, quindi, passare su<br />
qualche altro elemento della frase, costituito da un complemento indiretto,<br />
cioè da un complemento introdotto da una preposizione: “Elena ride di<br />
tutto”. Nel caso di verbi intransitivi come ubbidire, giocare, aderire,<br />
rinunciare, ecc., il completamento dell’azione che indicano è talmente<br />
necessario, perché essi abbiano un senso, che tali verbi hanno per lo più<br />
un “oggetto” su cui “passa” l’azione, anche se risulta espresso da un<br />
complemento indiretto, cioè introdotto da una preposizione: “Ubbidisci<br />
alla mamma”; “Tutti aderiscono alla tua iniziativa”. Per questa loro<br />
caratteristica, questi verbi sono chiamati transitivi indiretti.»<br />
Questo passo del Sensini contempla in sintesi tutta la problematica<br />
del rapporto tra verbo, oggetto diretto e indiretto, preposizioni e