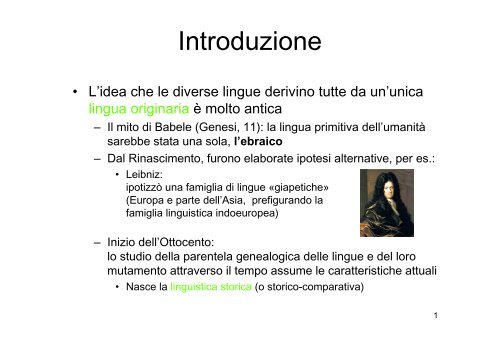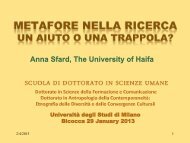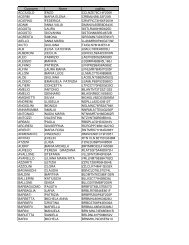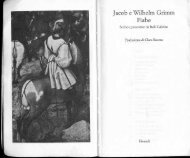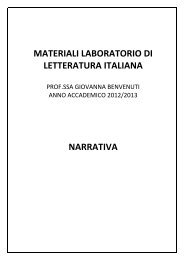lingua originaria - Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione
lingua originaria - Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione
lingua originaria - Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Introduzione<br />
• L’idea che le <strong>di</strong>verse lingue derivino tutte da un’unica<br />
<strong>lingua</strong> <strong>originaria</strong> è molto antica<br />
– Il mito <strong>di</strong> Babele (Genesi, 11): <strong>la</strong> <strong>lingua</strong> primitiva dell’umanità<br />
sarebbe stata una so<strong>la</strong>, l’ebraico<br />
– Dal Rinascimento, furono e<strong>la</strong>borate ipotesi alternative, <strong>per</strong> es.:<br />
• Leibniz:<br />
ipotizzò una famiglia <strong>di</strong> lingue «giapetiche»<br />
(Europa e parte dell’Asia, prefigurando <strong>la</strong><br />
famiglia linguistica indoeuropea)<br />
– Inizio dell’Ottocento:<br />
lo stu<strong>di</strong>o del<strong>la</strong> parente<strong>la</strong> genealogica delle lingue e del loro<br />
mutamento attraverso il tempo assume le caratteristiche attuali<br />
• Nasce <strong>la</strong> linguistica storica (o storico-comparativa)<br />
1
1. Il metodo comparativo e <strong>la</strong><br />
ricostruzione delle lingue originarie<br />
• Lo scopo è scoprire se due o più lingue sono<br />
genealogicamente apparentate oppure no<br />
• ossia se esse derivano da una stessa <strong>lingua</strong> <strong>originaria</strong><br />
• Il fenomeno del prestito linguistico può <strong>di</strong>sturbare <strong>la</strong> comparazione<br />
– Si confrontano le parti del vocabo<strong>la</strong>rio meno esposte al prestito:<br />
es. numerali, nomi <strong>di</strong> parente<strong>la</strong><br />
– Si cercano corrispondenze sistematiche tra fonemi e morfemi in<br />
lingue <strong>di</strong>verse (<strong>la</strong> semplice somiglianza tra le parole non basta)<br />
• Italiano e tedesco sono<br />
imparentate fra loro, ma<br />
• Italiano e turco no<br />
• Tedesco e turco neanche<br />
2
1. Il metodo comparativo e <strong>la</strong><br />
ricostruzione delle lingue originarie<br />
• Sul<strong>la</strong> base delle corrispondenze sistematiche in<strong>di</strong>viduate<br />
si ricostruisce <strong>la</strong> <strong>lingua</strong> <strong>originaria</strong> dal<strong>la</strong> quale il campione<br />
<strong>di</strong>scende<br />
– Cfr. <strong>la</strong>tino<br />
factum<br />
<strong>la</strong>ctem<br />
noctem<br />
– L’<strong>originaria</strong> sequenza <strong>la</strong>tina -ct- si è mutata in -tt- in italiano,<br />
-ch- [ʧ] in spagnolo, -it- in francese e -pt- in romeno<br />
3
1. Il metodo comparativo e <strong>la</strong><br />
ricostruzione delle lingue originarie<br />
– Si può ipotizzare che all’origine dei suoni corrispondenti in<br />
ciascuna delle quattro lingue, ci fosse un unico suono<br />
(asterisco = forma ricostruita):<br />
*[u:] proto-germanico ><br />
[aw] inglese/tedesco<br />
[øy] o<strong>la</strong>ndese<br />
[u:ʔ] danese<br />
4
1.2. L’«albero genealogico»<br />
delle lingue indoeuropee<br />
• Confrontando un gruppo <strong>di</strong> lingue strettamente<br />
apparentate si ricostruisce una <strong>lingua</strong> <strong>originaria</strong><br />
– Per es. proto-germanico, proto-s<strong>la</strong>vo ecc.<br />
• Confrontando vari gruppi linguistici si ricostruisce <strong>la</strong><br />
<strong>lingua</strong> <strong>originaria</strong> dell’intera famiglia (l'immagine<br />
risultante è un albero genealogico)<br />
– Il modello dell’albero genealogico non è <strong>per</strong>fetto:<br />
• non rappresenta le complesse re<strong>la</strong>zioni e sovrapposizioni parziali<br />
che sussistono fra i membri dei gruppi linguistici stu<strong>di</strong>ati<br />
5
1.3. Un esempio <strong>di</strong> ricostruzione<br />
• Molte delle corrispondenze sistematiche osservate sono<br />
casi partico<strong>la</strong>ri <strong>di</strong> corrispondenze più generali<br />
– /p/ del sanscrito, del greco e del <strong>la</strong>tino<br />
– /f/ del gotico<br />
– Si tratta <strong>di</strong> un caso partico<strong>la</strong>re del<strong>la</strong> corrispondenza sistematica<br />
che esiste tra le occlusive delle lingue germaniche e quelle <strong>di</strong><br />
altri gruppi <strong>di</strong> lingue indoeuropee:<br />
• mutazione/rotazione consonantica germanica (legge <strong>di</strong> Grimm)<br />
7
1.3. Un esempio <strong>di</strong> ricostruzione:<br />
<strong>la</strong> Legge <strong>di</strong> Grimm<br />
1. Alle occlusive sorde del sanscrito,<br />
del greco e del <strong>la</strong>tino corrispondono<br />
fricative sorde nelle lingue<br />
germaniche<br />
2. Alle occlusive sonore del<br />
sanscrito, del greco e del <strong>la</strong>tino<br />
corrispondono occlusive sorde<br />
nelle lingue germaniche<br />
3. Ai fonemi che sono in sanscrito<br />
occlusive sonore aspirate, in<br />
greco occlusive sorde aspirate, in<br />
<strong>la</strong>tino fricative sorde,<br />
corrispondono nelle lingue<br />
germaniche occlusive sonore<br />
Mutazione consonantica<br />
dall’indoeuropeo al germanico<br />
8
1.3. Un esempio <strong>di</strong> ricostruzione:<br />
<strong>la</strong> seconda Legge <strong>di</strong> Grimm<br />
• Un’apparente eccezione al<strong>la</strong> «legge <strong>di</strong> Grimm»:<br />
– a */t/ in IE non corrisponde in tedesco /θ/, bensì /d/<br />
(cfr. ingl. three vs. ted. drei)<br />
– a */d/ in IE non corrisponde /t/, bensì /ts/<br />
(cfr. ingl. tooth vs. Zahn [tsa:n])<br />
• Si ipotizza che il tedesco abbia subito un ulteriore<br />
mutamento consonantico:<br />
– «seconda mutazione consonantica germanica»,<br />
o «seconda legge <strong>di</strong> Grimm»:<br />
• Indoeuropeo */t/ e */d/ ><br />
germanico comune */θ/ e */t/ ><br />
tedesco /d/ e /ts/<br />
– Nelle altre lingue germaniche sono rimasti /θ/ e /t/<br />
9
2. Il mutamento fonetico e<br />
le «leggi fonetiche»<br />
• Il sistema fonologico dell’italiano contiene sette fonemi vocalici in<br />
sil<strong>la</strong>ba accentata, <strong>di</strong>stinti da:<br />
– posizione verticale del<strong>la</strong> <strong>lingua</strong><br />
• alti, me<strong>di</strong>o-alti, me<strong>di</strong>o-bassi e bassi<br />
– posizione orizzontale del<strong>la</strong> <strong>lingua</strong><br />
• anteriori, centrali e posteriori<br />
• In <strong>la</strong>tino le vocali si <strong>di</strong>stinguevano anche <strong>per</strong> il tratto del<strong>la</strong><br />
lunghezza:<br />
– nominativo rosă ['rosa] vs. ab<strong>la</strong>tivo rosā ['rosa:]<br />
10
2. Il mutamento fonetico e<br />
le «leggi fonetiche»<br />
• Nel passaggio dal <strong>la</strong>tino all’italiano<br />
– sono andate <strong>per</strong>dute le <strong>di</strong>stinzioni <strong>di</strong> lunghezza, che si sono<br />
trasformate in<br />
– <strong>di</strong>stinzioni <strong>di</strong> posizione verticale del<strong>la</strong> <strong>lingua</strong><br />
11
2. Il mutamento fonetico e<br />
le «leggi fonetiche»<br />
• I mutamenti fonetici sembrano o<strong>per</strong>are con assoluta<br />
rego<strong>la</strong>rità: sono «leggi fonetiche»<br />
• Però ogni legge fonetica presenta delle eccezioni:<br />
– Eccezione nel mutamento fonologico dal <strong>la</strong>tino all’italiano:<br />
• i breve <strong>la</strong>tina in posizione accentata <strong>di</strong>venta /e/ in italiano, ma:<br />
<strong>la</strong>t. vínco língua(m) família(m)<br />
it. vinco <strong>lingua</strong> famiglia<br />
*venco *lengua *famelia<br />
– La scuo<strong>la</strong> dei Neogrammatici sosteneva che il mutamento<br />
fonetico era «privo <strong>di</strong> eccezioni» (soggetto a «leggi») solo «nel<strong>la</strong><br />
misura in cui procede meccanicamente»<br />
• questo processo meccanico può interferire con altri fattori<br />
• si tratta <strong>di</strong> in<strong>di</strong>viduare e definire in modo adeguato i motivi che<br />
hanno causato queste «eccezioni» alle leggi fonetiche<br />
12
2.1. Leggi fonetiche concorrenti<br />
Sanscrito: bhrátar pitár<br />
Gotico: bróþar fádar (invece <strong>di</strong> *fáþar)<br />
– Eccezione al<strong>la</strong> Legge <strong>di</strong> Grimm???<br />
– Differenze <strong>di</strong> accento<br />
ipotesi: l'indoeuropeo aveva <strong>la</strong> <strong>di</strong>stribuzione accentuale del<br />
sanscrito e tale <strong>di</strong>stribuzione è stata determinante nel<br />
mutamento delle occlusive dall’indoeuropeo al germanico<br />
• Legge <strong>di</strong> Verner (1876):<br />
– Nel passaggio dall’indoeuropeo al germanico,<br />
le occlusive sorde <strong>di</strong>ventano dapprima fricative sorde;<br />
– queste <strong>di</strong>ventano poi fricative sonore se l’accento le segue<br />
– mentre rimangono sorde se l’accento le precede<br />
– L’eccezione al<strong>la</strong> legge <strong>di</strong> Grimm è spiegabile come effetto<br />
dell’intervento <strong>di</strong> un’altra legge<br />
13
2.2. Analogia<br />
• Meccanismo che crea forme nuove sul modello <strong>di</strong> forme esistenti<br />
• Si tratta <strong>di</strong> un fenomeno morfologico i cui effetti sono tali da<br />
produrre apparenti eccezioni alle leggi fonetiche<br />
– In generale, si rappresenta l’analogia come risultato dell’applicazione<br />
<strong>di</strong> una proporzione aritmetica ( a:b = c:d )<br />
– Inglese antico ‘mucca’:<br />
cu [ku:] singo<strong>la</strong>re > cow [kaw]<br />
cy [ky:] plurale > *[kaj] (cfr. cows [kaws])<br />
– La mancanza <strong>di</strong> [kaj] e <strong>la</strong> presenza <strong>di</strong> cows è dovuta all’analogia sul<br />
modello <strong>di</strong> altre parole che formano il plurale rego<strong>la</strong>re in -s:<br />
stone : stones = cow : x => x = cows<br />
– La forza dell’analogia sta nel<strong>la</strong> rego<strong>la</strong>rità che impone al<strong>la</strong> <strong>lingua</strong>:<br />
• <strong>la</strong> forma «rego<strong>la</strong>re» tende a sostituire quel<strong>la</strong> «irrego<strong>la</strong>re» (nel caso sopra,<br />
il plurale con flessione interna)<br />
14
3. Il mutamento morfologico<br />
• Uno dei meccanismi fondamentali <strong>di</strong> mutamento<br />
morfologico <strong>per</strong> quanto riguarda <strong>la</strong> nascita <strong>di</strong> forme e<br />
<strong>di</strong> parole nuove è l’analogia<br />
• Altri meccanismi:<br />
– Retroformazione:<br />
parole nuove create «togliendo» morfemi a una paro<strong>la</strong> già<br />
suffissata (spesso un prestito)<br />
• ingl. afflict derivata da affliction (e non viceversa)<br />
• ingl. act derivata da action (e non viceversa)<br />
• ingl. e<strong>di</strong>t derivata da e<strong>di</strong>tor (e non viceversa)<br />
• it. arrivo derivata da arrivare<br />
• it. rinvio derivata da rinviare<br />
15
3. Il mutamento morfologico<br />
– Grammaticalizzazione:<br />
un lessema (morfema libero) <strong>di</strong>venta un morfema legato<br />
• it. il suffisso avverbiale -mente<br />
derivato etimologicamente dall’ab<strong>la</strong>tivo <strong>di</strong> <strong>la</strong>t. mens ‘mente’<br />
it. sinceramente < <strong>la</strong>t sincera mente<br />
‘con sincera <strong>di</strong>sposizione <strong>di</strong> spirito’<br />
– Ricategorizzazione:<br />
il <strong>la</strong>tino aveva tre generi (maschile, femminile e neutro)<br />
l’italiano ne ha solo due (maschile e femminile)<br />
• Il neutro <strong>la</strong>tino si è ricategorizzato nel maschile italiano<br />
(somnium > sogno, venenum > veleno, folium > foglio)<br />
• A volte, il neutro plurale ha generato nomi femminili in italiano<br />
(folia > foglia)<br />
16
4. Il mutamento sintattico<br />
• Si confonde spesso con il mutamento morfologico<br />
(almeno <strong>per</strong> il passaggio dal <strong>la</strong>tino all'italiano)<br />
– In <strong>la</strong>tino, un unico tempo verbale, il <strong>per</strong>fetto, esprimeva<br />
quello che noi esprimiamo con due tempi: passato prossimo<br />
e passato remoto<br />
• litteras scripsi = ‘scrissi una lettera’ ‘ho scritto una lettera’<br />
– Il passato prossimo italiano si è sviluppato da una<br />
costruzione tardo-<strong>la</strong>tina<br />
• litteras scriptum habeo (VI sec. d.C.)<br />
– Il <strong>la</strong>tino non possedeva <strong>la</strong> categoria degli articoli:<br />
gli articoli in italiano si sono sviluppati da parole <strong>la</strong>tine che<br />
appartenevano ad altre categorie grammaticali<br />
• il - lo - <strong>la</strong> < illu(m) il<strong>la</strong>(m) (pronomi <strong>di</strong>mostrativi)<br />
• un - uno - una < unu(m) una(m) (numerali)<br />
17
4. Il mutamento sintattico<br />
• Il passaggio dal <strong>la</strong>tino alle lingue romanze ha anche<br />
determinato un ra<strong>di</strong>cale cambiamento tipologico:<br />
– il <strong>la</strong>tino era una <strong>lingua</strong> principalmente OV<br />
(posposizionale, or<strong>di</strong>ne AN/NA e GN, ausiliare segue il verbo)<br />
– l'italiano è una <strong>lingua</strong> principalmente VO<br />
(preposizionale, or<strong>di</strong>ne NA e NG, ausiliare precede il verbo)<br />
– litteras scriptum habeo vs. ho scritto una lettera<br />
18
5. Il mutamento lessicale e<br />
semantico<br />
• Mutamento semantico:<br />
mutamento nel «modo <strong>di</strong> in<strong>di</strong>care <strong>la</strong> realtà» da parte<br />
<strong>di</strong> una data paro<strong>la</strong> in una data <strong>lingua</strong><br />
• <strong>la</strong>t. plebs-plebe(m) ‘popo<strong>la</strong>zione’ ><br />
• it. pieve 1. ‘gruppo <strong>di</strong> fedeli’ > 2. ‘chiesa’<br />
• Tipi <strong>di</strong> mutamento semantico:<br />
– Restringimento:<br />
• <strong>la</strong>t. fortuna ‘sorte (in gen.)’ > ‘buona sorte’<br />
• ingl. meat ‘cibo (in gen.)’ > ‘carne’<br />
– Ampliamento:<br />
• <strong>la</strong>t. virtus ‘qualità proprie dell’uomo maschio (vir)'<br />
> ‘qualità positiva (in generale)’<br />
• <strong>la</strong>t. caballus ‘cavallo da <strong>la</strong>voro’<br />
> ‘cavallo (in generale)’<br />
19
5. Il mutamento lessicale e<br />
– Metafora:<br />
semantico<br />
<strong>la</strong>t ca<strong>per</strong>e ‘afferrare (con le mani)’ ><br />
it. capire ‘afferrare in senso astratto (con <strong>la</strong> mente)’<br />
– Metonimia: creazione <strong>di</strong> un nuovo significato <strong>per</strong> contiguità<br />
con quello precedente<br />
<strong>la</strong>t. BUCCA(M) ‘guancia’ > 'bocca'<br />
– Sineddoche: «una parte <strong>per</strong> il tutto»<br />
ingl. stove ‘stanza riscaldata’ > ‘stufa’<br />
– I<strong>per</strong>bole: passaggio da un significato più forte a un<br />
significato più debole<br />
<strong>la</strong>t. *extonare ‘colpire con il tuono’ > fr. étonner ‘stupire’<br />
20
5. Il mutamento lessicale e<br />
semantico<br />
– Litote: il passaggio da un significato più debole a uno più forte<br />
<strong>la</strong>t. eliminare ‘allontanare <strong>di</strong> casa’ > it. ‘uccidere’<br />
– Degenerazione:<br />
arabo faqïh ‘giureconsulto’ > ‘funzionario <strong>di</strong> dogana’ ><br />
it. facchino ‘portatore <strong>di</strong> pesi’<br />
– Innalzamento:<br />
<strong>la</strong>t. minister ‘servo’ > ‘servo dell’im<strong>per</strong>atore’ ><br />
it. ministro ‘capo <strong>di</strong> un ministero’<br />
– Trasformazione <strong>di</strong> nomi propri in nomi comuni:<br />
<strong>la</strong>t. Caesar ‘Giulio Cesare’ ><br />
ted. Kaiser ‘im<strong>per</strong>atore’<br />
russo zar ‘im<strong>per</strong>atore’<br />
21