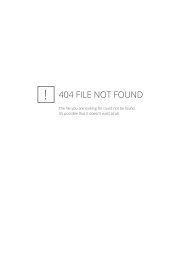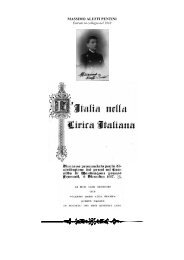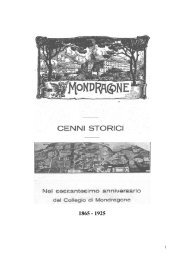Edizione 11 - Giugno 2006 - Nobile Collegio Mondragone
Edizione 11 - Giugno 2006 - Nobile Collegio Mondragone
Edizione 11 - Giugno 2006 - Nobile Collegio Mondragone
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Associazione ex Alunni <strong>Nobile</strong> <strong>Collegio</strong> <strong>Mondragone</strong><br />
Fondata il 2 febbraio 1922<br />
_______________________________________________________________________________________________________________________<br />
N° <strong>11</strong> GIUGNO <strong>2006</strong><br />
Il Molto Reverendo Padre Peter-Hans Kolvenbach S.I. Generale della Compagnia di Gesù con<br />
il Presidente Ferdinando Massimo, i vicepresidenti Enrico Corsetti Antonini ed Enrico Fiorelli,<br />
il segretario Vittorio Spadorcia ed i consiglieri Giuseppe Moroni Fiori e Fabio Valerj ,<br />
alla Curia Generalizia a Borgo Santo Spirito in Roma.<br />
25 Febbraio <strong>2006</strong><br />
_____________________________________________________________________________________________<br />
Nuova edizione semestrale dal 2001<br />
Primo numero 14 luglio 1866 - Oggi on-line sul sito www.collegiomendragone.com
Il <strong>Mondragone</strong><br />
_______________________________________________________________________________________________<br />
INDICE DEGLI ARTICOLI<br />
Lettera di ringraziamento del M.R.P. Peter-Hans Kolvenbach S.I. pag. 3<br />
Chi è Peter-Hans Kolvenback di Gianni Valente dal sito www.30giorni.it pag. 4<br />
Il Padre Provinciale d’Italia estratto dal sito www.gesuiti.it pag. 5<br />
Antiche Terre Pontificie di Ugo De Angelis pag. 6-7<br />
Padre Luigi Parisi S.I. In memoria pag. 8<br />
Nomina nuovi Padri Assistenti Spirituali della nostra Associazione pag. 8<br />
Il <strong>Collegio</strong> Romano notizie da Internet pag. 9<br />
Una stampa per la nostra Associazione - Dono di G. Bertelè pag .10<br />
Istituto Massimo di Andrea Monda pag. <strong>11</strong><br />
“lamerica” di Manfredi Pio di Savoia pag. 12-13<br />
Davanti a <strong>Mondragone</strong> di Carlo Scalera ( da Il <strong>Mondragone</strong> del 1948 ) pag. 13<br />
I quadri, dono di Gianni Salaroli per la nostra sala a <strong>Mondragone</strong> pag. 14<br />
I primi cinque Convittori e i Presidenti della Associazione Ex Alunni pag. 15<br />
I Gesuiti Missionari estratto dal sito www.gesuiti.it pag. 16<br />
I Gesuiti e le missioni di Piero Gheddo pag. 16÷18<br />
I Gesuiti in America Latina di Francesco Capece Galeota pag. 19-20<br />
Alcune vicende della Cappella Maggiore di Rodolfo Maria Strollo pag. 21÷24<br />
Una passeggiata in relax di Rolando Tonarelli pag. 25-26<br />
Le strutture archeologiche nella villa <strong>Mondragone</strong> di Luigi Devoti pag. 27÷29<br />
Le sorprese dei mercatini di Massimo Carafa Jacobini pag. 30<br />
Alcune lettere di ringraziamento di amici” Soci Onorari” pag. 31<br />
* * * * * * * * * *<br />
_____________________________________________________________________________________________<br />
N° <strong>11</strong> – <strong>Giugno</strong> <strong>2006</strong> pag.2 di 32
Il <strong>Mondragone</strong><br />
_______________________________________________________________________________________________<br />
LETTERA DI RINGRAZIAMENTO DEL<br />
M.R. PADRE PETER-HANS KOLVENBACH S.I. AL NOSTRO<br />
PRESIDENTE FERDINANDO MASSIMO<br />
_____________________________________________________________________________________________<br />
N° <strong>11</strong> – <strong>Giugno</strong> <strong>2006</strong> pag.3 di 32
Il <strong>Mondragone</strong><br />
_______________________________________________________________________________________________<br />
Chi è Peter-Hans Kolvenbach<br />
di Gianni Valente (tratto da internet: http://www.30giorni.it/it/articolo.asp?id=439 )<br />
Padre Peter-Hans Kolvenbach in visita alla missione di<br />
Nagaland, in India, nel 1995<br />
Un padre commerciante di Nimega e una madre<br />
dalle antiche origini italiane (si chiamava Jacoba<br />
Johanna Petronella Domesino) sono stati i genitori<br />
di Peter-Hans Kolvenbach, che nasce a Druten,<br />
nei Paesi Bassi, il 30 novembre del 1928.<br />
La formazione giovanile, al collegio Pietro<br />
Canisio di Nimega, si svolge negli anni terribili<br />
della guerra mondiale, con il Paese sotto<br />
occupazione nazista.<br />
L’entrata nella Compagnia di Gesù avviene nel<br />
’48. Dieci anni dopo, nel settembre del ’58, Peter-<br />
Hans lascia la sua terra col primo gruppo di<br />
gesuiti olandesi assegnati al Libano, dove studia<br />
teologia all’Università Saint-Joseph di Beirut e<br />
viene ordinato sacerdote nel ’61.<br />
Nel Paese levantino il gesuita venuto dal nord<br />
passa gli anni centrali della sua vita imbevendosi<br />
delle lingue e delle tradizioni ecclesiali e<br />
liturgiche del Vicino Oriente.<br />
mensile internazionale diretto da Giulio Andreotti<br />
I suoi studi si concentrano sull’armeno. Insegna<br />
prima filosofia, poi linguistica generale e armeno<br />
presso l’Università Saint-Joseph di Beirut.<br />
Nel ’74 è eletto provinciale della viceprovincia<br />
del Vicino Oriente, che include le comunità<br />
gesuite di Libano, Siria ed Egitto.<br />
Sono gli anni in cui il Paese dei cedri inizia ad<br />
essere dilaniato dalla guerra civile.<br />
Kolvenbach vi rimane fino all’81, quando padre<br />
Arrupe lo chiama a Roma come rettore del<br />
Pontificio Istituto Orientale.<br />
Dopo la tormentata fase finale del ministero di<br />
padre Arrupe, colpito da ictus nell’agosto del<br />
1981, il Pontefice affida in via straordinaria la<br />
guida della Compagnia ai gesuiti italiani Paolo<br />
Dezza e Giuseppe Pittau.<br />
I due delegati pontifici “traghettano” la<br />
Compagnia fino allo svolgimento della<br />
trentatreesima Congregazione generale, che il 13<br />
settembre ’83 elegge Kolvenbach preposito<br />
generale.<br />
Pur essendo chiamato a gestire la delicata fase<br />
successiva alla gestione “carismatica” di Arrupe,<br />
che con le sue scelte aveva finito per polarizzare<br />
anche all’interno della Compagnia entusiasmi e<br />
insofferenze, non si può dire che il suo mandato<br />
abbia avuto l’impronta della “normalizzazione”.<br />
Di indole ascetica e spirituale, padre Kolvenbach<br />
ha mantenuto anche nella guida dell’Ordine un<br />
profilo riservato e dialogante, cercando soluzioni<br />
non traumatiche alle controversie, come si è visto<br />
nel ruolo assunto nel “caso Dupuis”, scoppiato per<br />
le riserve manifestate nel ’98 dalla Congregazione<br />
per la dottrina della fede nei confronti delle opere<br />
teologiche del gesuita. Professore alla Pontificia<br />
Università. Gregoriana.<br />
Padre Kolvenbach è membro di due<br />
Congregazioni vaticane (Evangelizzazio-ne dei<br />
popoli e Istituti di vita consacrata) e consultore<br />
della Congregazione per le Chiese orientali.<br />
_____________________________________________________________________________________________<br />
N° <strong>11</strong> – <strong>Giugno</strong> <strong>2006</strong> pag.4 di 32
Il <strong>Mondragone</strong><br />
_______________________________________________________________________________________________<br />
Il Padre Provinciale d’Italia<br />
P. Francesco Tata S. I. (Franz)<br />
Nasce a Roma il 21 maggio 1944. Frequenta<br />
qui l'istituto Pio IX e dopo il liceo classico si<br />
iscrive alla facoltà di Fisica.<br />
Nel 1963 entra nel noviziato di Lonigo (VI) e<br />
Dopo gli studi filosofico-teologici viene<br />
ordinato presbitero il 17 giugno 1972 e lavora<br />
alla Cappella Universitaria di Roma-Sapienza<br />
ove resta fino al 1976.<br />
Termina la sua formazione con la licenza in<br />
Psicologia, alla Pontificia Università<br />
Gregoriana. Nel 1978 diviene socio (vice<br />
padre maestro) nel noviziato di Genova.<br />
Pronuncia gli ultimi voti il 31 maggio 1979.<br />
In seguito, p. Franz diventa padre maestro dei<br />
novizi, carica che ha ricoperto per 17 anni.<br />
Al termine del suo mandato come maestro,<br />
diviene rettore del <strong>Collegio</strong> Antonianum a<br />
Padova e poi rettore del Filosofato nazionale e<br />
nel 2002 viene nominato provinciale d'Italia.<br />
Il suo mandato scadrà nel 2008.<br />
Attualmente, si avvale della collaborazione<br />
dei pp. Alberto Remondini (Viceprovinciale<br />
per il Centro-Nord) e Carlo Aquino<br />
(Viceprovinciale per il Centro-Sud).<br />
E' inoltre delegato del Padre Generale per la<br />
Civiltà Cattolica, è presidente del Magis e<br />
moderatore dell'Assistenza dell'Europa<br />
meridionale.<br />
Vive a Roma e ha il suo ufficio presso la<br />
Residenza del Gesù.<br />
(Tratto dal sito : www.gesuiti.it )<br />
_____________________________________________________________________________________________<br />
N° <strong>11</strong> – <strong>Giugno</strong> <strong>2006</strong> pag.5 di 32
Il <strong>Mondragone</strong><br />
_______________________________________________________________________________________________<br />
ANTICHE TERRE PONTIFICIE<br />
Sant’Uffizio. LA TENUTA DI CONCA<br />
DALLE FONDERIE PONTIFICIE ALLA FABBRICA DELLA CARTA PAGLIA<br />
1568-1978<br />
Questo contributo si inserisce nell’ambito delle<br />
diverse annose ricerche condotte dallo scrivente e<br />
oggi inserite in un più vasto programma di<br />
promozione storico-culturale, condiviso con<br />
l’Archivio Vaticano della Congregazione per la<br />
Dottrina della Fede.<br />
In questa memoria si accennano alcune notizie su<br />
vicende e personaggi che hanno contribuito a vario<br />
titolo, alla crescita e valorizzazione di un vasto<br />
territorio ricadente ai margini dell’allora<br />
Campagna Romana, in un contesto storicotemporale<br />
pre e post unitario del nostro paese.<br />
Questa vasta area in tempi più antichi è stata<br />
interessata da una gloriosa attività metallurgica<br />
gestita dall’allora Stato Pontificio XVI-XIX secolo<br />
( in questo settore si inseriscono anche le vicende<br />
di Marcantonio Colonna, dei Doria Panphilj etc).<br />
E altresì, gli imponenti interventi di bonifica e<br />
regimentazione delle acque del fiume Astura<br />
necessari al movimento degli impianti idraulici<br />
delle Ferriere, nochè le politiche di salvaguardia e<br />
tutela del patrimoinio boschivo da parte del<br />
Sant’Uffizio.<br />
L’autore accanto all’allora Prefetto Joseph<br />
Cardinale Ratzinger, ora Papa Benedetto XVI,<br />
presso l’edificio ex Ferriere di Conca in occasione<br />
della visita nei “luoghi della memoria” del 4<br />
Maggio 2004.<br />
Inoltre il consolidamento della Cupola di San<br />
Pietro voluto da Papa Benedetto XIV nel 1743 (<br />
Poleni-Vanvitelli) dove furono utilizzati i<br />
cerchioni in ferro prodotti nelle Ferriere Pontificie<br />
di Conca.<br />
Nel 1867 il Conte Achille Gori Mazzoleni, prende<br />
in affitto dal Sant’Uffizio la Tenuta di Conca, che<br />
acquisterà qualche anno dopo dalla Giunta<br />
liquidatrice dei beni ecclesiastici .<br />
Il Conte Achille fece parte della Giunta<br />
provvisoria di Governo istituita dal Cadorna il 23<br />
Settembre del 1870.<br />
Il figlio Attilio Gori Mazzoleni all’età di 8 anni fu<br />
uno dei convittori iscritti nel primo anno di<br />
apertura del <strong>Nobile</strong> <strong>Collegio</strong> di <strong>Mondragone</strong><br />
istituito il 2 febbraio del 1865 dal Principe Don<br />
Marcantonio Borghese unitamente ai P.P.della<br />
Compagnia di Gesù di Frascati.<br />
(Fonte :Associazione Ex Alunni <strong>Nobile</strong> <strong>Collegio</strong><br />
<strong>Mondragone</strong> 1865-1953)<br />
Attilio Gori Mazzoleni entrato in collegio nel 1865,<br />
anno di apertura.<br />
(foto archivio dell’Associazione Ex Alunni <strong>Nobile</strong> <strong>Collegio</strong><br />
<strong>Mondragone</strong>)<br />
_____________________________________________________________________________________________<br />
N° <strong>11</strong> – <strong>Giugno</strong> <strong>2006</strong> pag.6 di 32
Il <strong>Mondragone</strong><br />
_______________________________________________________________________________________________<br />
Nel 1891 il Conte Attilio eredita la Tenuta di<br />
Conca ed è lì che nel 1902 presso la Cascina<br />
Vecchia si consumò il triste omicidio della povera<br />
fanciulla Santa Maria Goretti.<br />
Il luogo del martirio eletto a Santuario, oggi è una<br />
delle pricipali mete di pellegrinaggio nel contesto<br />
degli itinerari religiosi del nostro paese.<br />
Di questo territorio riecheggiano ancora i versi<br />
D’Annunziani composti nel 1900, all’amico poeta<br />
Augusto Sindici, autore di alcune “Leggende della<br />
Campagna Romana”.. (intanto passavano anche<br />
per la spiaggia latina, come nelle tue rime, le<br />
giumente cariche di carbone in lunghe file<br />
andando dalle carbonere di Conca agli imposti di<br />
Anzio, mentre tu evocavi la fiamma e il fumo nelle<br />
macchie devastate e il rumore delle accette...e li<br />
servaggi canti der tajatore...)<br />
Qualche anno dopo il Conte Gori Mazzoleni dà<br />
inizio ai lavori di trasformazione dell’edificio<br />
industriale ex Ferriere di Conca per far posto alla<br />
nuova Cartiera per la produzione di Carta Paglia.<br />
E in periodi più recenti, questo territorio è stato<br />
caratterizzato anche da una pioneristica industria<br />
della pescicoltura creata tra gli anni venti e trenta<br />
dal Cavalier Gustavo Dominici, altro illuminato<br />
mercante di campagna, di origini umbre ma<br />
romano di adozione.<br />
Nel successivo periodo, spiccano le diverse e<br />
innovative attività della Tenuta di Conca, dalla<br />
produzione silvicola, ai semi di ricino da cui si<br />
ricavava l’olio per i motori degli aerei, al<br />
formaggio esportato nel nuovo continente, e per<br />
finire alle copiose quantità degli apprezzatissimi<br />
prodotti ittici (cefali) di Conca, venduti ai mercati<br />
generali di Via Ostiense che allietavano le tavole<br />
dei romani soprattutto in occasione del<br />
tradizionale cenone natalizio.(1930-34)<br />
Nel 1934, con la successiva bonifica integrale<br />
legata ai piani di trasformazione fondiaria, l’allora<br />
governo fascista attraverso l’O.N.C. mise fine a<br />
questa florida e innovativa attività.<br />
Tali notizie, frutto di una annosa attività di ricerca,<br />
sono state ripagate dall’interesse suscitato nella<br />
Curia Vaticana e suggellate lo scorso 4 maggio<br />
2004 dalla prestigiosa visita nei “Luoghi della<br />
memoria” del Cardinale Ratzinger oggi Papa<br />
Benedetto XVI.<br />
Ugo De Angelis<br />
Questa è l’e-mail che abbiamo ricevuto con<br />
allegato l’articolo dell’architetto De Angelis<br />
sopra pubblicato<br />
Gentile Presidente<br />
Dott.Ferdinando Massimo,<br />
nel consultare le diverse importanti notizie<br />
storiche riportate nel vostro pregevole sito web,<br />
abbiamo appreso che il <strong>Nobile</strong> <strong>Collegio</strong> di<br />
<strong>Mondragone</strong> nell’anno 1865 ha, tra l’altro,<br />
annoverato nelle proprie fila l’allora fanciullo<br />
Gori Mazzoleni Attilio ( il padre Conte Achille<br />
nel 1870 fu membro della Giunta Provvisoria di<br />
Governo e successivamente deputato al Senato<br />
per Subiaco). Come sappiamo il Conte Attilio<br />
Gori Mazzoleni è soprattutto ricordato per aver<br />
assunto a mezzadria nel proprio tenimento le due<br />
famiglie marchigiane Goretti e Serenelli che<br />
dimoravano nella Cascina Vecchia di Conca<br />
dove nel 1902 avvenne il martirio della Santa<br />
Maria Goretti.<br />
Inoltre si porta a conoscenza della S/V che da<br />
diversi anni si è avviato e condotto numerosi<br />
studi e ricerche sulla Tenuta di Conca, un vasto<br />
territorio posto ai margini della Campagna<br />
Romana, in un contesto storico- temporale<br />
compreso tra 1568 e il 1978 riguardante gli<br />
aspetti meglio specificati nell’allegata memoria.<br />
Quanto sopra quindi si chiede di valutare<br />
l’opportunità di verificare se l’Archivio del<br />
<strong>Nobile</strong> <strong>Collegio</strong> di <strong>Mondragone</strong> contenga ancora<br />
materiale documentario e o fotografico<br />
finalizzato ad implementare i pochi dati in nostro<br />
possesso, sulla vita del Conte Attilio Gori<br />
Mazzoleni.<br />
Nell’auspicare un gradito riscontro della<br />
presente si coglie l’occasione per inviare i più<br />
cordiali saluti.<br />
Ugo De Angelis, architetto.<br />
_____________________________________________________________________________________________<br />
N° <strong>11</strong> – <strong>Giugno</strong> <strong>2006</strong> pag.7 di 32
Il <strong>Mondragone</strong><br />
_______________________________________________________________________________________________<br />
Il P. Luigi Parisi S.I. nacque a Roma il 5 aprile<br />
1922 ed entrò in Compagnia ad Ariccia-Galloro a<br />
20 anni dopo la maturità classica. Frequentò le<br />
classi di filosofia (1945-1947) e teologia (1950-<br />
1954) alla PUG. Il magistero lo fece al <strong>Collegio</strong><br />
di <strong>Mondragone</strong> (Frascati 1947-1950). A Firenze<br />
fece il terzanno di probazione (1954-1955). Il suo<br />
primo impegno fu l’ufficio di Ministro al <strong>Collegio</strong><br />
Massimo di Roma (1955-1957 e 1960-1962) e al<br />
<strong>Collegio</strong> <strong>Mondragone</strong> (1957-1960). Dal 1962 al<br />
1998 ebbe vari incarichi al "Foyer Catholique<br />
Européen" di Bruxelles, con una breve parentesi<br />
(1971-1973) in cui fece il Parroco a Roma S.<br />
Saba. A Bruxelles il suo ministero principale fu<br />
l’assistenza spirituale alle famiglie degli Italiani<br />
impegnati negli organismi europei; per un certo<br />
periodo è stato anche Superiore della comunità.<br />
Rientrato in Italia, aiutò nella Chiesa di Roma S.<br />
Andrea al Quirinale, soprattutto nell’anno del<br />
giubileo. Nel 2001 fu trasferito nella Parrocchia<br />
di Roma S. Roberto Bellarmino come aiuto al<br />
Parroco e vi rimase anche dopo che la<br />
Parrocchia è passata alla Diocesi di Roma 2003).<br />
Negli ultimi anni è stato l’Assistente Spirituale<br />
della nostra Associazione.<br />
Padre Luigi Parisi S.I.<br />
(Assistente Spirituale della nostra Associazione)<br />
Roma 05 Aprile 1922<br />
† Roma 13 Febbraio <strong>2006</strong><br />
Caro Gigi,<br />
ci hai lasciati!<br />
Ci sei stato vicino lungo tutta la tua intensa vita<br />
sempre illuminata da una incrollabile fede che hai<br />
sempre trasmesso a noi con semplicità scanzonata<br />
ma con fermezza incrollabile.<br />
Ti abbiamo incontrato giovane e brillante<br />
“prefetto” di camerata del nostro <strong>Collegio</strong>, e lungo<br />
il cammino della nostra vita hai guadagnato un<br />
posto speciale nei nostri cuori, sicuri di trovare in<br />
te un riferimento fermo e sempre disponibile.<br />
In questi ultimi anni ci sei stato vicino come<br />
Assistente Spirituale della nostra Associazione,<br />
dopo mezzo secolo dalla chiusura del <strong>Collegio</strong>.<br />
Ora sei meritatamente vicino al Signore, alla<br />
cui chiamata avevi risposto, e continuerai a<br />
guidarci ed aiutarci nel nostro passaggio terreno.<br />
Ciao Gigi!<br />
Quando Dio vorrà ci ritroveremo ancora.<br />
Arrivederci Gigi!<br />
********<br />
IL CONSIGLIO DIRETTIVO dell'ASSOCIAZIONE EX ALUNNI<br />
NOBILE COLLEGIO MONDRAGONE<br />
ha nominato, nella riunione del Consiglio del 20 marzo <strong>2006</strong>, i seguenti<br />
Padri Assistenti Spirituali dell'Associazione:<br />
Padre Cesare Jori S.I. residente in Via degli Astalli, 16 00186 ROMA tel.: 06.697001<br />
Padre Sauro De Luca S.I. residente in Via Silvio Spaventa, 4 50129 FIRENZE tel.: 055.579801<br />
_____________________________________________________________________________________________<br />
N° <strong>11</strong> – <strong>Giugno</strong> <strong>2006</strong> pag.8 di 32
Il <strong>Mondragone</strong><br />
_______________________________________________________________________________________________<br />
Fu istituito da Sant'Ignazio di Loyola (1491 -<br />
1556) dopo la fondazione della Compagnia di<br />
Gesù (1550), per coprire tutto l'arco scolastico,<br />
dagli studi elementari a quelli universitari. Per<br />
volontà di Gregorio XIII fu costruita, dal 1582 al<br />
1584, la sede definitiva del <strong>Collegio</strong> Romano nei<br />
cui locali è ospitata oggi.la.scuola.del.Visconti. .<br />
Gli insegnanti dell'antico <strong>Collegio</strong> sono stati<br />
personalità eminenti della cultura, basti pensare a<br />
Cristoforo Clavio, astronomo e matematico,<br />
altissimo esempio di umanista, scienziato<br />
stimatissimo da Galileo, oppure a Christoph<br />
Grienberger, che dal 1591 fu professore di<br />
matematica e scienze. Insegnante e rettore del<br />
<strong>Collegio</strong> fu anche Roberto.Bellarmino<br />
Il <strong>Collegio</strong> Romano fu inoltre teatro dei dotti<br />
dibattiti tra Galileo e Segneri (1624 - 1694),<br />
maestro di oratoria, Giuseppe Calandrelli (1747 -<br />
1827) fondatore dell'Osservatorio astronomico<br />
(1787) del <strong>Collegio</strong>, Angelo Secchi (1818 - 1878),<br />
celebre astronomo e direttore dell'Osservatorio dal<br />
1850.<br />
Nel 1551 S. Ignazio di Loyola, fondatore della<br />
Compagnia di Gesù, fondò in un palazzo romano<br />
(ora scomparso) situato alle falde del<br />
Campidoglio, nella "Via Capitolina" (oggi Piazza<br />
d'Aracoeli) la prima scuola dei padri gesuiti con<br />
annessa la prima biblioteca e fu chiamata <strong>Collegio</strong><br />
Romano.<br />
La riuscita fu ottima, tanto che a seguito del<br />
continuo aumento del numero degli studenti si<br />
dovette procedere ad un cambio di sede.<br />
Nel 1584, infatti Papa Gregorio XIII inaugurò la<br />
nuova sede del <strong>Collegio</strong> Romano in un Palazzo<br />
Il <strong>Collegio</strong> Romano<br />
in Roma sito nell'omonima piazza tutt'ora esistente, e<br />
da tale Papa che fu detto "Fondatore e<br />
Protettore"prese il nome di "Gregoriana".<br />
Nel 1773, in seguito alla soppressione della<br />
Compagnia di Gesù, il <strong>Collegio</strong> fu affidato alla<br />
custodia del clero secolare romano, per essere<br />
riconsegnato poi alla rifondata Compagnia il 17<br />
maggio 1824 dal Papa Leone XII.<br />
Nel 1873 il <strong>Collegio</strong> Romano subì un'altro<br />
trasferimento, questa volta la nuova sede fu<br />
individuata in Palazzo Borromeo, sempre a Roma in<br />
via del Seminario, oggi sede del <strong>Collegio</strong><br />
Bellarmino, e fu in questo anno che il Papa Pio IX<br />
con Rescritto del 4 dicembre 1873, permise al<br />
<strong>Collegio</strong> di assumere il titolo di "Pontificia<br />
Università del <strong>Collegio</strong> Romano"; inoltre conferì al<br />
Rettore del <strong>Collegio</strong> il diritto di sottoscriversi<br />
"Rettore della Pontificia Università Gregoriana".<br />
(notizie da internet)<br />
_____________________________________________________________________________________________<br />
N° <strong>11</strong> – <strong>Giugno</strong> <strong>2006</strong> pag.9 di 32
Il <strong>Mondragone</strong><br />
_______________________________________________________________________________________________<br />
Milano, 5 dicembre 2005<br />
UNA STAMPA ANTICA PER LA NOSTRA ASSOCIAZIONE<br />
Dono dell’Ex Alunno Giovanni Bertelè<br />
Caro Spadorcia,<br />
come ti ho detto nel nostro colloquio telefonico<br />
della scorsa settimana, è mia intenzione donare<br />
all’Associazione ex Alunni di <strong>Mondragone</strong> una<br />
antica stampa in mio possesso che riproduce la<br />
villa - non una fotocopia come pensato in un<br />
primo momento, ma l’originale - sperando che<br />
possa trovare una collocazione nella nuova sala<br />
dedicata alla storia del <strong>Collegio</strong>.<br />
Lo faccio nel ricordo di un periodo felice della<br />
mia vita trascorso nel <strong>Collegio</strong> e come<br />
ringraziamento a quanti lo determinarono: i Padri<br />
che furono degli amici prima che degli insegnanti<br />
e sempre rispettosi della mia persona e delle mie<br />
idee, i compagni che ricordo vivissimamente<br />
ancora oggi dopo 65 anni con molto affetto e coi<br />
quali i rapporti sono sempre stati di grande<br />
affiatamento e camerateria.<br />
Ti prego di farla incorniciare di semplice<br />
legno color noce e di applicare una discreta<br />
targhetta in ottone con la scritta<br />
Dono di Giovanni Bertelè in <strong>Collegio</strong> dal 1938 al<br />
1941.<br />
Mi farai sapere poi la spesa, per il rimborso.<br />
Avremo occasione di risentirci, ma intanto mando<br />
a te, e a tutti gli amici, i più vivi auguri di Buone<br />
Feste !<br />
Giovanni Bertelè<br />
(in collegio dal 1938 al 1941)<br />
Bertelè Scrive:<br />
05.12.02<br />
Messaggio per Spadorcia.<br />
Domani spedisco per posta prioritaria la<br />
stampa con una lettera di cui in allegato una<br />
copia.<br />
Prego assicurarmi del ricevimento.<br />
Carissimi saluti<br />
Bertelè<br />
Spadorcia risponde:<br />
Caro.Giovanni,<br />
ho ricevuto il tuo messaggio e ho comunicato al<br />
nostro Presidente Ferdinando Massimo e al<br />
nostro Vice-Presidente Enrico Corsetti Antonini<br />
quello che stai facendo per l'Associazione.<br />
Appena riceveremo il plico sarà anche mia<br />
premura comunicare il ricevimento.<br />
Da parte di tutti noi, per ora, un enorme grazie e<br />
prendo l'occasione per inviare i migliori auguri a<br />
te e famiglia per le prossime feste.<br />
Vittorio Spadorcia<br />
Giovanni Bertelè da convittore<br />
_____________________________________________________________________________________________<br />
N° <strong>11</strong> – <strong>Giugno</strong> <strong>2006</strong> pag.10 di 32
Il <strong>Mondragone</strong><br />
_______________________________________________________________________________________________<br />
Pochi giorni dopo la presa di Porta Pia del 1870, il<br />
<strong>Collegio</strong> Romano, dalla metà del ‘500 proprietà<br />
della Compagnia di Gesù, fu requisito per dare<br />
ospitalità temporanea ad uno dei contingenti<br />
militari piemontesi affluiti nella città. Era la fine<br />
di settembre e le scuole avrebbero dovuto riaprire<br />
da lì a pochi giorni. La scuola riaprirà solo il 3<br />
dicembre col nuovo nome di Regio Liceo<br />
Visconti.<br />
I Gesuiti non rimasero con le mani in mano. Nove<br />
anni dopo, il 9 novembre del 1879, venne<br />
inaugurato l’Istituto dell’Immacolata nella sede di<br />
Villa Peretti, edificio di proprietà del trentenne<br />
Padre Massimiliano Massimo sito nei pressi delle<br />
Terme di Diocleziano (di fronte all’attuale<br />
Stazione Termini). L’inaugurazione consistette in<br />
una funzione religiosa nella cappella domestica<br />
della villa cui parteciparono tutti i 7 insegnanti e<br />
tutti i 25 alunni .<br />
La scuola ben presto prese piede e cambiò, di<br />
fatto, anche il nome diventando, per tutti, la<br />
scuola del Padre Massimo e poi, senz’altro, Il<br />
Massimo.<br />
Nell’archivio storico dei gesuiti, a pochi metri da<br />
piazza San Pietro, abbiamo trovato queste foto di<br />
classe datate 1881. Sono scattate nei giardini di<br />
Villa Peretti, prima sede dell’Istituto voluto da<br />
P.Massimo e fondato grazie anche ad un<br />
contributo di 2.400 ducati di.Leone.XIII.<br />
Nel 1887, a causa del nuovo piano regolatore<br />
della città, l’edificio fu demolito e, proprio in quei<br />
giardini, venne costruito il grande palazzo<br />
Massimo che fino al 1960 ospiterà il liceo classico<br />
e che oggi, dopo il trasferimento della scuola al<br />
più moderno complesso dell’EUR, ospita il<br />
Museo Nazionale Romano.<br />
Istituto Massimo Roma, 1881 Archivio Storico della<br />
Compagnia del Gesù<br />
Istituto Massimo<br />
a cura di Andrea Monda<br />
Tra i volti che vediamo ci saranno di sicuro alcuni di<br />
quei 7 insegnanti e di quei 25 alunni che avevano<br />
dato vita nemmeno due anni prima ad uno degli<br />
istituto scolastici più prestigiosi della Capitale. “Con<br />
un po’ di esperienza si può dedurre un’intera<br />
biografia dall’osservazione di un volto”, afferma Alan<br />
Finkielkraut ne “L’umanità perduta”. L’esperienza<br />
qui richiesta è alla portata di tutti; è quella della<br />
scuola con i suoi riti, più o meno assurdi, ordinari (la<br />
campanella, la ricreazione, la giustificazione…) e<br />
straordinari come appunto una foto di classe.<br />
Con questo bagaglio di nostalgico sgomento<br />
osserviamo questi volti intuendone il mistero della<br />
biografia. Cosa sono diventati quei ragazzi? Il legame<br />
tra il Massimo e la città di Roma è sempre stato molto<br />
forte: lo dimostra, tra l’altro, la sfilza di ben 7 exalunni<br />
diventati sindaci, da Ludovico Spada<br />
Potenziani a Francesco Rutelli, passando per<br />
Salvatore Rebecchini e Amerigo Petrucci.<br />
Colpisce anche l’abbigliamento dei ragazzi, più<br />
“moderno”, pur nella goffaggine con cui sono<br />
indossate giacche e cravatte, rispetto a quello dei<br />
professori che, grazie anche al loro truce volto<br />
ottocentesco ( che forse cela un’anima burbera o<br />
bonaria? ) ci ricordano i personaggi della scuola di<br />
Amarcord di Fellini.<br />
Viene da pensare a quando è stata scattata la foto, a<br />
pochi anni dalla fine del potere temporale della<br />
Chiesa, al “punto di valico” tra due mondi. 1881: in<br />
Italia viene utilizzata per la prima volta, in modo<br />
massiccio, la dinamite mentre ad Alpignano viene<br />
fondata una società per la fabbricazione di lampadine<br />
elettriche. In Russia viene ucciso lo zar Alessandro II<br />
e i rapporti tra Francia e Italia si incrinano a causa del<br />
protettorato francese su Tunisi. Escono I malavoglia,<br />
Malombra, Ritratto di signora. L’anno dopo l’Italia<br />
avrà l’allargamento del suffragio elettorale e da<br />
600.000 elettori si passa a 2 milioni. Andrea Costa è<br />
il primo deputato socialista e a Milano viene fondato<br />
il primo partito operaio. Viene scoperto il bacillo<br />
della tubercolosi.<br />
Il 2 giugno muore Garibaldi…<br />
Cosa è arrivato di tutto questo ai ragazzi immortalati<br />
nei giardini di Villa Peretti?<br />
E cosa, della cronaca e della storia, è arrivato a noi<br />
ex-alunni di altre scuole di altre classi?<br />
_____________________________________________________________________________________________<br />
N° <strong>11</strong> – <strong>Giugno</strong> <strong>2006</strong> pag.<strong>11</strong> di 32
Il <strong>Mondragone</strong><br />
_______________________________________________________________________________________________<br />
“lamerica”<br />
Lettera di Michele (semialfabeta(sic) di campagna) alla sua mamma.<br />
A Mà, commo tesuditto te ascrivo pena<br />
rivato a nuiorc.<br />
Er viagio co 'lali Talia nun poli sapè<br />
commo che fù e io mo telo dico; cuannoche’<br />
peppe me lassò ar larioporto uno che vidde<br />
cuante falicie e facotti tenevo me fa dice<br />
"pijate er carelletto" e mallunca'na specie de<br />
cariola de fero co le rotine epperò senza ir<br />
ciesto ma cor freno ammano anniscosto che se<br />
tira si lo trovi, sinno' nun se move, che io ce<br />
caricai falicie e facotti e ntrai nel rioporto che<br />
è na sala lunca lunca co tutti che spettano<br />
infila in tiana er turno devanti ar posto<br />
ndovechè ce sta 'na signiora cor vistitino verte<br />
e ‘n cappelletto buffo assede tietro ar banco<br />
co'no spazietto affianco.<br />
Pianno pianno rivo devanti a essa che me fa<br />
dice : "bijetto" commo che sur tramve e je do<br />
er malloppo de robba che me tiede la genzia;<br />
issa cuarda eppoi ricuarda e me fa dice "ndo<br />
vai?" je dico nuiorc e essa fa ah e me dice<br />
"baccai? Je fò "no nun baccaio, solo che devo<br />
da anna’ a nuiorc", i essa me fa, tutta<br />
ncavolata "dicooo...c'ai falicie?" dicodesì.<br />
"Mettele cuà" ndicanno lo spazietto li’<br />
mbasso e io ce le metto; issa trafica collo<br />
sgrittoio, prenne du cose collose che escheno<br />
da la machinetta e le picica ai manijoni dele<br />
falicie eppoi picica artre tichettine sur cartame,<br />
spince cuarcosa e la falicie schizzeno via e je<br />
dico "e mo ndo vanno esse?" me fa"cuelle le<br />
ripiji a nuiorc, tiette er baccajo ammano" e me<br />
ridà tutti i cosi de la genzia e dice "vadi dellà ar<br />
controllo pulizia poi ir ghet vintuno.”<br />
Boh, je faccio e vado ndove che affatto<br />
segnio co la testa, ellì 'nartra fila deggente che<br />
mano mano vanza verzo no strettoio comeche’<br />
c'avemo noi pe le pecura che ce passeno una pe’<br />
una pe’ la tosata o pe’ latte oppuro pe falle<br />
servi’ dar montone; li ce sta 'na gappietta<br />
invetrata co ‘n puliziotto che te chiete<br />
documenta, je do ir malloppo de la genzia, sceje<br />
er pasaporto, me cuarda, lo cuardo, timpra ir<br />
pasaporto e ristituisce tutto dopodichè vai<br />
traverso 'n archetto che cuanno passi fa bippe<br />
bippe e te fermano dicheno “se levi tutto er<br />
metallo”, metto ir reccichiavi drento er cestetto<br />
che me da’ e che va drento a na gallerietta,<br />
aripasso, bippe bippe, “levete puro loro locio”<br />
levo, cestetto, aripasso, nun bippa gnente e<br />
"bene vadi" dice e me ridà ir reccichiavi e loro<br />
locio.<br />
_____________________________________________________________________________________________<br />
N° <strong>11</strong> – <strong>Giugno</strong> <strong>2006</strong> pag.12 di 32
Il <strong>Mondragone</strong><br />
_______________________________________________________________________________________________<br />
Secuo laggente e rivo a cuello che deve<br />
da esse er ghet vintuno pecche’ ce stanno tanti<br />
che parleno puro lincue incumprensibbili che<br />
penso so merecani de nuiorc che ce ritorneno.<br />
Spetta chette spetta tuttandratto na vocie<br />
incuprensibbile parla e tutti s'arzeno, se<br />
metteno infila devanti n'artra signiora cor<br />
vistitino verte e ir cappelleto buffo, je danno<br />
ir cartame che te ne strappa ‘n pezzetto eppoi<br />
vai ar corridoio stretto stretto e arfonno ciè la<br />
porta del rioplano che entri e te dicheno vadi<br />
nfonno e ce stanno tante portroncine piccule<br />
piccule tutte messe a faccia avanti che sempra<br />
er cinema der paese ma più fitto fitto che sestà<br />
uno taccato a lartro che si respiri forte<br />
antruppi er vicino.<br />
Dopodeche’ me metto assede e, spetta che<br />
te spetta ‘na voce parla che n’se capisce, tutti<br />
a senti’, poi sona ‘n dindarolo, se scureno le<br />
luci e io m’addormo che so’ stanco e ir<br />
secuito telo dico nartra vorta.<br />
Tu fijo fezionato Micchele<br />
(Manfredi Pio di Savoia,<br />
in collegio dal 1948 al 1951)<br />
(Carlo Scalera in collegio dal 1944 al 1948)<br />
_____________________________________________________________________________________________<br />
N° <strong>11</strong> – <strong>Giugno</strong> <strong>2006</strong> pag.13 di 32
Il <strong>Mondragone</strong><br />
_______________________________________________________________________________________________<br />
I QUADRI, DONO DI GIANNI SALAROLI PER LA NOSTRA SALA<br />
A MONDRAGONE<br />
Gianni Salaroli<br />
(in collegio dal 1941 al 1945)<br />
Gianni Salaroli ha risposto alla richiesta della<br />
nostra Associazione e ha donato i quadri sopra<br />
riprodotti.<br />
La Associazione è molto grata e i quadri faranno<br />
bella mostra, insieme ad altri, nella sala a noi<br />
dedicata che è in corso di restauro a <strong>Mondragone</strong>.<br />
Con l’occasione si fa appello a tutti gli Ex di buona<br />
volontà a donare eventuali “memorabilia”<br />
riguardanti il <strong>Nobile</strong> <strong>Collegio</strong> <strong>Mondragone</strong>.<br />
_____________________________________________________________________________________________<br />
N° <strong>11</strong> – <strong>Giugno</strong> <strong>2006</strong> pag.14 di 32
Il <strong>Mondragone</strong><br />
_______________________________________________________________________________________________<br />
1865 I PRIMI 5 CONVITTORI:<br />
1° febbraio 1865 Giancarlo dei Duchi Scotti Gallarati<br />
1° febbraio 1865 Carlo Rocchi<br />
2 febbraio 1865 Felice dei Principi Borghese<br />
2 febbraio 1865 Camillo dei Principi Borghese<br />
2 febbraio 1865 Gianbattista dei Principi Borghese<br />
PRESIDENTI DELL’ASSOCIAZIONE EX ALUNNI DEL<br />
NOBILE COLLEGIO MONDRAGONE DAL 1922<br />
1922 Primo Presidente della F.A.C. Federazione Antichi Convittori:.<br />
Principe don Camillo Francesco Massimo Principe d’Arsoli.<br />
Entrato in <strong>Collegio</strong> nel 1874<br />
1927 Diego Calcagno Presidente Circolo Giovanile . Entrato in <strong>Collegio</strong> nel 1926<br />
1929 Principe don Prospero Colonna. Entrato in <strong>Collegio</strong> nel 1866<br />
1937 Principe don Fabrizio Massimo. Entrato in <strong>Collegio</strong> nel 1877<br />
1949 Principe don Leone Enrico Massimo. Entrato in <strong>Collegio</strong> nel 1907<br />
1960 Com.te don Marcello Sanfelice dei M.si di Monteforte.<br />
Entrato in <strong>Collegio</strong> nel 1918<br />
1991 Principe don Camillo Borghese. Entrato in <strong>Collegio</strong> nel 1935<br />
2004 Principe don Ferdinando Massimo. Entrato in <strong>Collegio</strong> nel 1949<br />
_____________________________________________________________________________________________<br />
N° <strong>11</strong> – <strong>Giugno</strong> <strong>2006</strong> pag.15 di 32
ll <strong>Mondragone</strong><br />
_____________________________________________________________________________________________<br />
L'epopea missionaria della Compagnia di Gesù fu<br />
iniziata il 7 aprile 1541 da San Francesco<br />
Saverio: partito da Lisbona con la qualifica di<br />
nunzio apostolico, dopo avere circumnavigato<br />
l'Africa, raggiunse Goa, in India nel 1542, dopo<br />
13 mesi di navigazione, e per due anni lavorò<br />
infaticabilmente per la conversione degli indiani<br />
della Pescheria; nel 1544 si spinse nella penisola<br />
di Malacca, di là raggiunse le Molucche (l'attuale<br />
Indonesia) e poi nel 1549 approdò nel Giappone,<br />
dove rimase oltre due anni. Nel 1552 volle partire<br />
per la Cina per aprire al Vangelo l'"impero di<br />
mezzo", ma morì il 3 dicembre 1552 alle porte<br />
della Cina, nell'isola di Sancian. Con le sue lettere<br />
inviate dall'Oriente egli creò tra i giovani gesuiti<br />
dell'Europa un incredibile entusiasmo per le<br />
missioni in Asia. Per oltre due secoli un gran<br />
numero di gesuiti si sparse per tutti i Paesi del<br />
continente asiatico: ricordiamo soltanto i nomi di<br />
Alessandro Valignano, Roberto de' Nobili,<br />
Rodolfo Acquaviva, Matteo Ricci, Alessandro de<br />
Rhodes, Adamo Schall, Ferdinando Verbiest,<br />
Costanzo.Beschi.<br />
Se ora dall'Asia passiamo all'America, rileviamo<br />
che lo stesso ardore missionario spinse i gesuiti a<br />
evangelizzare quasi tutti i Paesi di quel continente,<br />
cominciando dal Brasile col padre Emmanuele<br />
I gesuiti "missionari"<br />
da: www.gesuiti.it<br />
***<br />
Nobrega nel 1549, per giungere nella Florida<br />
(1566), passando per il Perù (1568), il Messico<br />
(1572), il Tucumàn (1586), il Paraguay (1588), il<br />
Cile (1592), l'Ecuador (1592). L'opera più nota dei<br />
gesuiti nell'America Latina fu la costituzione delle<br />
"Riduzioni" (Reducciones), le quali consistevano<br />
nel raccogliere gli indigeni, in particolare i guaraní<br />
(abitanti nelle foreste come nomadi) in villaggi nei<br />
quali i gesuiti insegnavano loro sia le verità della<br />
fede cristiana, sia le norme di una vita più civile, sia<br />
la coltivazione di piante più produttive. Erano<br />
perciò centri di civilizzazione e anche di difesa<br />
contro le razzie dei coloni spagnoli e portoghesi. Le<br />
Reducciones si svilupparono in tale maniera da<br />
suscitare l'invidia e la sordida cupidigia dei coloni e<br />
poi delle autorità politiche spagnole e portoghesi,<br />
tanto da essere una delle cause della soppressione<br />
della Compagnia di Gesù, avvenuta nel 1773, con<br />
l'accusa che i gesuiti avevano formato una specie di<br />
regno nel Paraguay, nemico dei regni della Spagna<br />
e del Portogallo, e dalle Reducciones avevano<br />
ricavato grandi ricchezze, sfruttando i fedeli sudditi<br />
dei Re cattolici. In realtà, i gesuiti erano colpevoli<br />
soltanto di aver portato la fede e la civiltà a tribù<br />
poverissime e sfruttate e di averle difese dalla<br />
crudeltà dei coloni europei, talvolta anche con l'uso<br />
delle armi.<br />
I Gesuiti e le Missioni<br />
Articolo tratto da MONDO E MISSIONE di<br />
Piero Gheddo Il Pime ( Pontificio Istituto Missioni Estere)<br />
Nel novembre dell'anno 1609, sei gesuiti partono<br />
da Asunciòn, dividendosi in tre gruppi e<br />
dirigendosi verso la regione abitata dagli indios<br />
Guaranì, le foreste di cui era circondato il Rio<br />
Paranà, vera spina dorsale del Sud America.<br />
Dieci anni prima, altri missionari avevano portato<br />
ad Asunciòn la notizia di una straordinaria<br />
scoperta: nelle selve tra il Rio Paranà e il Rio<br />
Uruguay viveva una razza di indios valorosi, fieri<br />
della loro lingua e cultura, i Guaranì, un<br />
materiale umano ben più prezioso, per i<br />
missionari, che gli abbaglianti sogni delle miniere<br />
d'oro e di pietre preziose che stimolavano i<br />
"conquistadores" spagnoli.<br />
Studiata l'impresa, la Compagnia di Gesù aveva<br />
chiesto alla Corona di Spagna il permesso di<br />
lavorare fra quegli indios, riservandoli alle loro<br />
cure, per farne cittadini dell'Impero spagnolo e<br />
buoni cristiani. Il 26 novembre 1609, data che è<br />
considerata l'inizio di questa esperienza, il<br />
luogotenente generale del governatore del<br />
Paraguay e del Rio de la Plata, emanò un'ordinanza<br />
con la quale proibiva agli spagnoli di entrare nella<br />
zona del Rio Paranapanema (in lingua Guaranì)<br />
per reclutarvi indios per il servizio personale; gli<br />
indigeni erano affidati alla sola Compagnia di<br />
Gesù.<br />
Lo stesso Re di Spagna pubblica numerose leggi e<br />
decreti per condannare la schiavitù e i cattivi<br />
trattamenti a cui gli indios erano sottoposti. Ma i<br />
pregiudizi sono duri a morire, specie quando c'è<br />
sotto un grosso interesse economico.<br />
Nel diritto coloniale spagnolo (e portoghese) gli<br />
indios erano equiparati a minori bisognosi di<br />
_____________________________________________________________________________________________<br />
N° <strong>11</strong> – <strong>Giugno</strong> <strong>2006</strong> pag.16 di 32
ll <strong>Mondragone</strong><br />
_____________________________________________________________________________________________<br />
protezione, di stimolo al lavoro organizzato, di<br />
organizzazione della loro vita sociale secondo<br />
schemi europei. Non si concepiva altra "civiltà"<br />
che quella europea, cui anche gli indios dovevano<br />
accedere: ma, essendo primitivi e selvatici,<br />
bisogna condurveli con metodi paternamente<br />
costrittivi, come si fa con i ragazzi, mentre li si<br />
istruisce nel cristianesimo e quindi si civilizzano i<br />
loro costumi.<br />
Partendo da questi presupposti, la Corona di<br />
Spagna affida gli indios ai colonizzatori (assistiti<br />
dai missionari per la parte religiosa), affinché li<br />
inquadrino nel lavoro, insegnando loro a lavorare<br />
la terra, istruendoli nella dottrina cristiana e<br />
avviandoli alla "civiltà". Nasce così l'istituto della<br />
"encomienda", per cui ad un colono viene affidato<br />
un vasto territorio da colonizzare: gli indios che vi<br />
sono dentro sono sotto la sua autorità e<br />
protezione. Naturalmente l'"encomienda" ha delle<br />
regole ben precise (proibito ridurre gli indios in<br />
schiavitù, chi non vuole starci può andarsene,<br />
proibito l'uso della frusta o altri maltrattamenti,<br />
ecc.) e si conoscono anche casi di coloni spagnoli<br />
condannati dai tribunali spagnoli per abusi sugli<br />
indios (quasi sempre in seguito a denunzie di<br />
missionari). Però, in pratica, nell'immenso<br />
continente quasi spopolato e senza strade, nella<br />
sua "encomienda" il colono era re e signore<br />
assoluto.<br />
Nell'America spagnola, le navi e le armate dei<br />
"conquistadores" erano sempre accompagnate dai<br />
missionari, anch'essi inviati dalla Corona<br />
spagnola, che concepiva la colonizzazione come<br />
un'opera di fede e di civiltà. È noto il travagliato<br />
rapporto fra missionari e colonizzatori spagnoli (e<br />
portoghesi in Brasile). Soprattutto sono note le<br />
proteste di non pochi missionari contro i metodi<br />
schiavisti dei coloni (Bartolomeo de las Casas è<br />
solo uno fra i tanti) e l'azione dei Papi (bolle e<br />
scomuniche contro chi praticava la schiavitù) per<br />
mitigare i metodi della colonizzazione. Com'è noto<br />
il grande lavoro teologico e giuridico della Chiesa<br />
per scalzare alla base le teorie razziste che<br />
guidavano i coloni: Francesco de Vitoria sostiene,<br />
nella prima metà del 1500 (prima ancora di Las<br />
Casas), la tesi secondo cui gli indios (anche se<br />
infedeli e primitivi) sono uomini come i bianchi,<br />
hanno i diritti dei bianchi e devono essere<br />
rispettati da tutti, soprattutto dai cristiani.<br />
Meno nota è l'epopea delle "Riduzioni" che ha<br />
rappresentato il tentativo riuscito di creare un<br />
altro tipo di colonizzazione, rispettosa dell'uomo e<br />
delle culture, in alternativa a quella praticata da<br />
spagnoli e portoghesi nelle Americhe. Stranamente,<br />
questo capitolo glorioso delle missioni è<br />
dimenticato, mentre, credo, rappresenta bene lo<br />
spirito, gli scopi, i metodi dei missionari del<br />
passato, quando si incontravano con popoli diversi<br />
e di civiltà orale (o "primitivi").<br />
Riprendiamo il racconto dei sei Gesuiti che, partiti<br />
da Asunciòn nel novembre 1609, arrivano nelle<br />
foreste del Rio Paranà dove vivono i Guaranì. Due<br />
di questi (Marziale Lorenzana e Francisco di San<br />
Martìn), con l'aiuto di alcuni Guaranì già<br />
convertiti, entrano in contatto con un clan della<br />
tribù e spiegano loro i vantaggi di una volontaria<br />
sottomissione alla Corona di Spagna attraverso i<br />
Gesuiti, evitando così la "encomienda" che li<br />
avrebbe messi nelle mani dei coloni spagnoli. Il 29<br />
dicembre 1609 si fonda la prima "Riduzione" 200<br />
chilometri a sud di Asunciòn, intitolata a S. Ignazio<br />
Guazù (maggiore, oggi in Paraguay), per<br />
distinguerla dall'altra Riduzione intitolata a S.<br />
Ignazio Mini (minore, oggi in Argentina) fondata<br />
nel 1610 da due altri Gesuiti (Simone Mascetti e<br />
Giuseppe Cataldini).<br />
L'anno seguente (16<strong>11</strong>), visti i buoni risultati delle<br />
prime due Riduzioni, le autorità spagnole emanano<br />
vari decreti che esentano dall'"encomienda" gli<br />
indios sottomessi ai Gesuiti, vietano l'accesso di<br />
spagnoli e meticci ai territori affidati ai Gesuiti; e<br />
fissano norme precise per le "encomiendas"<br />
spagnole (ad esempio, gli indios hanno diritto ad un<br />
salario fissato dalla legge), proibendo ancora la<br />
schiavitù, anche con schiavi comperati legalmente<br />
(le tribù Guaycurùs e Tupì catturavano indiani di<br />
altri gruppi tribali e li vendevano agli spagnoli).<br />
Interessante notare che ci fu, nella regione del<br />
Paraguay, una levata di scudi da parte dei coloni<br />
spagnoli ed i Gesuiti, accusati di essere all'origine<br />
di queste norme troppo garantiste per gli indios,<br />
reagirono proclamando peccato mortale la non<br />
osservanza di quei decreti del governatore<br />
spagnolo!<br />
Così incomincia l'esperienza delle "Riduzioni".<br />
Rimandando alla seconda parte del nostro servizio<br />
la descrizione dell'organizzazione interna di queste<br />
comunità, vediamo come cresce e si afferma il<br />
sistema dello "Stato gesuita", tra pericoli da parte<br />
degli indios e dei portoghesi. I primi attacchi<br />
vengono da parte degli stessi indios Guaranì delle<br />
foreste. Il "cacicco" (capo) Carupé e lo stregone<br />
Nezù, invidiosi dell'ascendente dei nuovi capi e<br />
stregoni bianchi, nel novembre 1628 fanno uccidere<br />
_____________________________________________________________________________________________<br />
N° <strong>11</strong> – <strong>Giugno</strong> <strong>2006</strong> pag.17 di 32
ll <strong>Mondragone</strong><br />
_____________________________________________________________________________________________<br />
tre Gesuiti a Candelaria (la Riduzione centrale in<br />
cui vivevano i missionari a capo di tutto il<br />
sistema) e scatenano una vera guerra contro la<br />
missione: circa 1.500 indios chiamati da gruppi<br />
nell'interno della foresta si avvicinano al<br />
villaggio, seminando morte e distruzione. I Gesuiti<br />
organizzano la difesa e mandano messaggeri per<br />
chiedere aiuto: ottengono dieci archibugieri<br />
spagnoli e oltre mille guerrieri indios provenienti<br />
da altre Riduzioni dei Gesuiti e dei Francescani.<br />
La guerriglia dura circa un mese e si conclude<br />
con lo scontro decisivo del 20 dicembre 1628,<br />
vittorioso per la difesa di Candelaria. Le centinaia<br />
di prigionieri sono quasi tutti liberati e ritornano<br />
ai loro clan magnificando la potenza dei Gesuiti e<br />
il loro perdono. Solo dodici vengono impiccati dal<br />
"braccio secolare", non senza essere prima<br />
convinti dai missionari a pentirsi ed a farsi<br />
battezzare!<br />
Acquarello del gesuita Floriàn Paucke (1749-1767)<br />
raffigurante una missione gesuitica<br />
Molto più grave il pericolo degli assalti<br />
portoghesi, provenienti da San Paolo, città<br />
fondata nel 1554 da due Gesuiti portoghesi, José<br />
Anchieta e Manuel da Nobrega, proprio come<br />
"Riduzione" per l'istruzione e la conversione degli<br />
indiani, ma presto affermatasi come centro<br />
propulsore della conquista portoghese verso<br />
l'interno del continente e come crogiolo di razze<br />
dove nasce la nazionalità brasiliana. La<br />
popolazione paulista si è formata fin dall'inizio<br />
con un meticciato tra portoghesi, indios e altri<br />
gruppi di immigrati europei. Nel 1600 i paulisti<br />
(chiamati "mamaluchi" cioè meticci) erano un<br />
popolo forte e numeroso che, pur sottomesso alla<br />
Corona di Lisbona, avevano una loro autonomia e<br />
dimostravano una potente vitalità espansionistica<br />
verso ovest. Alleatisi con gli indios Tupì, nemici<br />
tradizionali dei Guaran ì, estendono il dominio<br />
portoghese con delle spedizioni armate chiamate<br />
"bandeiras" (di qui il nome di "bandeirantes" dato<br />
ancora oggi ai paulisti) che avevano due scopi:<br />
esplorare il territorio scoprendo eventuali ricchezze<br />
minerarie (soprattutto oro!), affermando il possesso<br />
dei portoghesi sulle terre scoperte; e trovare indios<br />
da portare a San Paolo come schiavi. Queste<br />
spedizioni fanno indietreggiare a poco a poco, a<br />
favore del Portogallo, i confini stabiliti dal Trattato<br />
di Tordesillas (1493) fra i domini spagnoli e<br />
portoghesi in America.<br />
A partire dal 1612-1615, i paulisti incominciano ad<br />
assaltare le Riduzioni dei Gesuiti del Guayrà. La<br />
Spagna aveva proibito agli indios di usare le armi.<br />
Le Riduzioni non potevano difendersi ed essendo<br />
ben stabilite sul territorio in una regione<br />
abbastanza ristretta, rappresentavano per i<br />
mamaluchi una preda ambita (gli altri indios da<br />
catturare erano dispersi nelle foreste!). Secondo<br />
notizie del tempo, i paulisti avevano catturato, dal<br />
1612 al 1639, ben 300.000 indios nei territori<br />
spagnoli; secondo un'altra relazione, dal 1628 al<br />
1630 i Gesuiti perdevano 60.000 neofiti per opera<br />
dei "bandeirantes"; nel 1635-1637, ben trenta<br />
Riduzioni erano saccheggiate e distrutte dai<br />
paulisti: decine di migliaia di indios dispersi, uccisi<br />
o catturati come schiavi. Gli spagnoli del Paraguay<br />
non intervenivano, per la lontananza dei posti, per<br />
l'insufficienza delle loro forze armate e anche per<br />
l'antipatia verso l'esperienza dei Gesuiti che molti si<br />
auguravano venisse interrotta.<br />
Acquarello di Lèonie Matthis, raffigurante la piazza di San<br />
Ignacio Mini (1940).<br />
I missionari decidono di reagire nell'unico modo<br />
possibile, cioè rendendo autonome anche nella<br />
difesa le loro Riduzioni, come già lo erano in campo<br />
produttivo, amministrativo, commerciale, ecc.<br />
_____________________________________________________________________________________________<br />
N° <strong>11</strong> – <strong>Giugno</strong> <strong>2006</strong> pag.18 di 32
ll <strong>Mondragone</strong><br />
_____________________________________________________________________________________________<br />
Nel 1638 il gesuita Ruiz de Montoya, il<br />
missionario più importante nella storia delle<br />
Riduzioni, viene mandato in Spagna per ottenere il<br />
permesso di armare gli indios.<br />
La Corte rimanda la decisione al Viceré di Lima<br />
(sensibile alle ragioni dei Gesuiti perché<br />
difendono i possedimenti spagnoli dai paulisti): Le<br />
Riduzioni si armano e gli indios vengono<br />
addestrati all'uso delle armi moderne. Nel 1639<br />
per la prima volta gli indios Guaranì si difendono<br />
e volgono in fuga gli assedianti paulisti a Caapaza<br />
Guazù.<br />
La sconfitta brucia ai paulisti che preparano una<br />
maxi spedizione per finirla con i Gesuiti spagnoli<br />
e i loro Guaranì. Nel 1641, 500 mamalucos con<br />
2.500 Tupì, su 900 canoe e un poderoso<br />
armamento, scendono il corso del Rio Uruguay.<br />
Ma non sanno di essere attesi e che le Riduzioni<br />
hanno organizzato bene l'avvistamento e la difesa.<br />
4.000 guerrieri guaranì, organizzati dal fratello<br />
gesuita Domingo Torres, veterano dell'esercito<br />
spagnolo, sono pronti ad accorrere al primo<br />
cenno. L'<strong>11</strong> marzo 1641 i paulisti subiscono un<br />
imprevisto attacco a fuoco sul Rio Uruguay: i<br />
Guaranì, con 300 fucili e persino un rudimentale<br />
cannone, sbaragliano gli attaccanti. Un massacro.<br />
Dispersi nelle foreste circostanti, i paulisti<br />
chiedono una tregua che è loro rifiutata. La<br />
battaglia prosegue in acqua e per terra: alla fine,<br />
si contano circa duemila morti fra i Tupì e i<br />
mamalucos, che abbandonano ai Guaranì 600<br />
canoe e 300 fucili e archibugi.<br />
* * * * * * * *<br />
Questa battaglia sull'alto Rio Uruguay ha cambiato<br />
la mappa politica del Sud America: se avessero<br />
vinto i paulisti, non solo l'esperimento<br />
delle "Reducciones" sarebbe finito 127 anni prima<br />
di quanto poi è successo, ma il dominio portoghese<br />
si sarebbe esteso fino a tutto il Paraguay attuale,<br />
tagliando le comunicazioni fra i possedimenti<br />
spagnoli sul Rio de la Plata (Buenos Aires), il Perù<br />
e la Bolivia.<br />
La battaglia segna l'inizio, per le Riduzioni<br />
gesuitiche, di una pace che dura più di un secolo.<br />
Incomincia la fase di espansione e di<br />
consolidamento della missione gesuitica.<br />
Piero Gheddo<br />
Acquarello di Lèonie Matthis (1882-1952) raffigurante.una<br />
cerimonia davanti il portale della Chiesa di San Ignacio Mini.<br />
Collezione Museo Històrico Nacional (Buenos Aires).<br />
I gesuiti in America Latina<br />
di Francesco Capece Galeota<br />
Ministro Plenipotenziario Consulente dell’Istituto Italo-Latino Americano<br />
Fatto scarsamente conosciuto e che meriterebbe<br />
essere approfondito, riguarda il ruolo avuto dalla<br />
Compagnia di Gesù in America Latina,<br />
precisamente in Argentina, Brasile, Bolivia e<br />
soprattutto Paraguay con le loro “misiones” o<br />
“riduzioni”.<br />
La loro creazione ai primi del seicento trova un<br />
solo precedente nella storia del diritto coloniale<br />
tramite la Compagnia delle Indie, da parte<br />
britannica nel mercantile.<br />
Le reducciones dei gesuiti rispondono al desiderio<br />
della Corona di Spagna di delegare i poteri<br />
centrali in zone coloniali “critiche” e molto<br />
lontane ad elementi altamente affidabili per la<br />
gestione della Monarchia Cattolica di Madrid e la<br />
tutela (o meglio gestione) delle popolazioni indigene.<br />
Nei Paesi indicati i gesuiti si insediarono presso<br />
limitati gruppi, preservando le lingue tradizionali<br />
locali e diffondendo il Verbo Evangelico affiancato<br />
da un’opera di elevazione sociale impensabile per<br />
quei tempi.<br />
Particolarmente notevole è l’insegnamento che essi<br />
conducono nel campo dello sviluppo artistico di uno<br />
specifico barocco coloniale e nell’insegnamento<br />
della musica.<br />
L’autogestione conferita dal governo di Madrid per il<br />
taglio comunitario e sociale si può accostare come<br />
esempio moderno ai kibbutz israeliani, pur tenendo<br />
conto della differenza di epoca e di culture.<br />
_____________________________________________________________________________________________<br />
N° <strong>11</strong> – <strong>Giugno</strong> <strong>2006</strong> pag.19 di 32
ll <strong>Mondragone</strong><br />
_____________________________________________________________________________________________<br />
Si è parlato di gestione teocratica autonoma con<br />
mezzi largamente assimilabili ai poteri statuali<br />
come l’esistenza di mezzi di difesa come<br />
minuscoli eserciti.<br />
Oltre l’emancipazione sociale, lo scopo di<br />
creazione delle reducciones dei gesuiti è stato<br />
anche quello di profonda difesa dei diritti umani<br />
degli indios, particolarmente i guaranti, del<br />
Paraguay situati a ridosso dei confini con l’Impero<br />
del Brasile, rapiti, secondo la storia, dai cosiddetti<br />
banderantes brasiliani per avviarli in condizioni di<br />
servaggio al lavoro delle loro terre.<br />
Come in tutti gli avvenimenti storici, l’incrocio di<br />
interesse tra Spagna e Portogallo vede cadere in<br />
disgrazia tale ruolo storico ed anomalo della<br />
Compagnia di Gesù e troncato con l’editto di<br />
Carlo III di espulsione dei Gesuiti dalle terre del<br />
regno.<br />
Questo fenomeno unico nella storia delle religioni<br />
e delle Nazioni ha lasciato in eredità un<br />
patrimonio monumentale di rilevanza come chiese,<br />
conventi ed edifici che riflettono gioielli di uno<br />
splendido barocco coloniale trasmesso anche in<br />
oggetti lignei di pregevole fattura.<br />
Per valorizzare tale patrimonio monumentale poco<br />
conosciuto, l’Istituto Italiano Latino-Americano<br />
(IILA),Organismo internazionale avente sede a<br />
Roma, di cui fanno parte oltre all’Italia i 20 Paesi<br />
dell’America Latina, ha stipulato nel 2004 accordi<br />
con i Governi di Buenos Aires e di Asunsion ,<br />
che mirano a rivalorizzare patrimoni nazionali di<br />
immenso valore e che ricomprende Fondi<br />
Archivistici e Biblioteche.<br />
L’IILA propone corsi di formazione per restauro, in<br />
particolare di matrice italiana, anche nei Paesi<br />
dell’area andina, culminati in un seminario a<br />
Cartagena dei responsabili di Governo e di<br />
Università di tali Paesi.<br />
Da tale simposio sono sorte proposte di allestimento<br />
di scuole-cnatiere di restauro che vedono in molti<br />
Paesi come controparti le Facoltà di Architettura<br />
delle Università Gesuitiche di tali Paesi, come<br />
l’Università Javeriana di Bogotà.<br />
Francesco Capece Galeota<br />
(in collegio dal 1950 al 1951)<br />
Giubileo.ignaziano-saveriano-favriano<br />
Il 7 aprile di <strong>2006</strong> si compiono 500 anni dalla<br />
nascita, nel Castello di Javier, Navarra-Spagna, di<br />
Francisco di Javier, professore della Sorbona,<br />
cofondatore, con la direzione di Ignazio di Loyola,<br />
della Compagnia di Gesù, missionario nelle Indie<br />
Orientali e Giappone e figura universale che tracciò<br />
forti legami di collaborazione e comprensione tra<br />
Oriente ed Occidente. Il Governo gesuiti in Italia,<br />
la Chiesa del SS. Nome di Gesù in Roma e il<br />
Vicariato di Roma promuovono la celebrazione di<br />
un ampio programma di atti culturali, religiosi e di<br />
incontro sociale per commemorare nell'arco di un<br />
anno - dal 3 di dicembre di 2005 fino alla stessa<br />
data del <strong>2006</strong> - questo giubileo aperto alle<br />
iniziative di altre istituzioni ed entità ed<br />
all'interesse generale di tutte le persone.<br />
_____________________________________________________________________________________________<br />
N° <strong>11</strong> – <strong>Giugno</strong> <strong>2006</strong> pag.20 di 32
ll <strong>Mondragone</strong><br />
_____________________________________________________________________________________________<br />
Alcune vicende della Cappella Maggiore<br />
Con l’insediamento del <strong>Collegio</strong> nella Villa<br />
<strong>Mondragone</strong>, avvenuto nel 1865, fu subito<br />
evidente che le esigenze cultuali della vasta<br />
comunità andata a “rivitalizzare” il malconcio<br />
edificio erano ben diverse da quelle legate<br />
all’originaria funzione della struttura.<br />
Nella Villa erano presenti due cappelle: quella più<br />
antica realizzata nel 1573-4 su disegno di Martino<br />
Longhi il Vecchio per il cardinale Marco Sitico<br />
Altemps che la intitolò a San Gregorio in onore<br />
dell’amico pontefice Gregorio XIII (Ugo<br />
Boncompagni 1572-1585) e quella aggiunta,<br />
meno di mezzo secolo dopo, con l’intervento del<br />
Vasanzio curato per conto del cardinale Scipione<br />
Caffarelli Borghese; entrambe, seppur piccole<br />
dimensionalmente, erano idonee, per qualità<br />
formali e ricchezza delle decorazioni, al culto<br />
“privato” di un pontefice in una residenza<br />
“secondaria”, quale appunto una Villa Tuscolana.<br />
Nella prima cappella – sin dall’origine considerata<br />
appannaggio del Papa – erano stati realizzati<br />
numerosi affreschi che avevano visto impegnato,<br />
per l’affresco soprastante l’altare, Giuseppe<br />
Cesari, più noto come Cavalier d’Arpino, mentre<br />
nel nuovo seicentesco ambiente, ad esclusivo uso<br />
del cardinal nepote di Paolo V (Camillo Borghese<br />
1605-1621), Annibale Durante era stato chiamato<br />
a decorare con profusione di dorature il fastoso<br />
intradosso cassettonato della volta a botte e<br />
Alessandro Turchi, detto l’Orbetto, a realizzare la<br />
pala d’altare con l’Assunzione di Maria Vergine.<br />
Con il nuovo utilizzo della Villa come struttura<br />
scolastica, entrambi gli ambienti mantennero la<br />
loro funzione, pur con nuove consacrazioni: il<br />
primo alla Vergine, il secondo al Santissimo<br />
Sacramento (quest’ultimo, però, fu poi degradato<br />
ad ambiente di passaggio nell’ambito della<br />
consistente ristrutturazione dovuta a Clemente<br />
Busiri Vici negli anni Trenta del secolo scorso).<br />
Le cappelle risultavano, tuttavia, del tutto<br />
inadeguate a ospitare la nutrita popolazione di<br />
padri, inservienti e dei sempre più numerosi<br />
allievi del <strong>Collegio</strong> e così – già nel 1868 – fu<br />
inaugurato il più ampio ambiente sacro per<br />
l’Istituto (in virtù di tale caratteristica<br />
diversamente e variamente chiamato Cappella<br />
Maggiore, Grande, Principale o anche dei<br />
Convittori).<br />
di Rodolfo Maria Strollo<br />
1.La prima pagina del <strong>Mondragone</strong> del 6 maggio 1906<br />
Ricavata dal vestibolo della Villa sottostante il<br />
Salone degli Svizzeri, la Cappella fu dotata di “un<br />
altare modesto ma non indegno con drappi ed<br />
addobbi”, come un articolo apparso sul<br />
<strong>Mondragone</strong> del 1906 ricordava (fig. 1).<br />
Una mattina dell’anno 1892 Camillo Corsetti,<br />
convittore addetto alle mansioni di sagrestano, con<br />
un’errata manovra sulle candele dell’altare causò<br />
l’incendio dell’arredo sacro. Rapidamente le<br />
fiamme si svilupparono espandendosi all’altare<br />
stesso – poiché di legno – e al quadro soprastante:<br />
una grande tela raffigurante la Sacra Famiglia con<br />
San Giovanni Battista, attribuito per l’ideazione (il<br />
cartone) al gesuita Padre Spillman e per<br />
l’esecuzione a Pietro Gagliardi, pittore di soggetti<br />
sacri, molto attivo in ambito romano per buona<br />
parte del secolo XIX (affiancato, sul finire, dal<br />
nipote Giovanni).<br />
_____________________________________________________________________________________________<br />
N° <strong>11</strong> – <strong>Giugno</strong> <strong>2006</strong> pag.21 di 32
ll <strong>Mondragone</strong><br />
_____________________________________________________________________________________________<br />
È facile immaginare lo scompiglio nel quale, in<br />
breve tempo, venne a trovarsi tutto il <strong>Collegio</strong><br />
allertato dalle grida dell’involontario “piromane”.<br />
Fortunatamente, il pronto accorrere dei padri,<br />
degli inservienti e dei convittori, con secchi<br />
d’acqua e quant’altro potesse contribuire allo<br />
spegnimento delle fiamme, limitò gli effetti<br />
dell’incendio che, comunque, risultò fatale per il<br />
quadro e per l’altare.<br />
Il padre Rettore Luigi Caterini avviò subito<br />
l’opera di ricostruzione: al professor Nobili fu<br />
commissionata la copia della tela perduta (fig. 2) e<br />
il Rettore si premurò di disegnare personalmente<br />
il nuovo altare che fece realizzare “in legno<br />
verniciato di bianco e ricco di intagli e dorature”<br />
(fig. 3); l’inaugurazione avvenne durante la festa<br />
del Patrocinio di San Giuseppe, nel maggio del<br />
1895.<br />
La mensa - all’epoca ovviamente nella disposizione<br />
“preconciliare” a ridosso dell’ancona –<br />
2.La tela del Nobili trafugata, copia di quella di<br />
Spillman e Gagliardi (distrutta nell’incendio del 1892)<br />
3. La Cappella Maggiore all’epoca del <strong>Collegio</strong><br />
recava verso l’aula un pannello asportabile in modo<br />
da consentire l’esposizione della teca con le spoglie<br />
di San Claudio Provinciale, conservata nella<br />
Cappella sin dal 1870, quando il “martire<br />
giovinetto” fu spostato nel <strong>Collegio</strong> con grande<br />
solennità.<br />
La tela, disposta centralmente al di sopra della<br />
mensa, era inquadrata da due colonne che<br />
sostenevano una trabeazione con soprastante<br />
timpano curvo; le colonne erano scanalate e<br />
rudentate per il terzo inferiore e decorate con motivi<br />
vegetali stilizzati per i restanti due terzi, mentre la<br />
trabeazione (lievemente aggettante in<br />
corrispondenza dei capitelli) recava nel fregio un<br />
elemento decorativo ripetuto; il timpano curvo<br />
ospitava il simbolo dello Spirito Santo, in forma di<br />
colomba, posto entro una ricca raggiera. La<br />
doratura di tutte le decorazioni (quelle citate e le<br />
altre cornici e intagli a rilievo presenti nell’ancona e<br />
nella mensa) spiccava sul chiarore della tinta di<br />
fondo, conferendo un certo tono di “ricchezza”<br />
all’insieme.<br />
_____________________________________________________________________________________________<br />
N° <strong>11</strong> – <strong>Giugno</strong> <strong>2006</strong> pag.22 di 32
ll <strong>Mondragone</strong><br />
_____________________________________________________________________________________________<br />
4. L’altare nella attuale collocazione nella chiesa della<br />
Madonna del Buon Consiglio in Colle di Fuori<br />
Due statue in gesso raffiguranti i Santi Pietro e<br />
Paolo, collocate simmetricamente entro nicchie ai<br />
lati dell’altare, con altrettante consolle in legno<br />
dorato sottostanti, completavano l’arredo “più<br />
importante” della Cappella.<br />
Dopo la chiusura del <strong>Collegio</strong> nel 1953, soltanto<br />
le statue sono rimaste sino ad oggi nella Villa<br />
(trasferite al piano superiore ove danno il nome a<br />
uno degli ambienti del Centro Congressi). Le<br />
spoglie del Santo furono traslate, nel 1977, nella<br />
chiesa parrocchiale di San Pio X in Grottaferrata.<br />
La tela del Nobili risulta che fu trafugata nei tardi<br />
anni Settanta; di essa è disponibile una<br />
riproduzione fotografica nel volume Uomini per<br />
gli altri di p. Vito Bondani (mentre la foto del<br />
dipinto originale fu pubblicata nell’articolo su Il<br />
<strong>Mondragone</strong> del 1906).<br />
Nel 1983, successivamente al passaggio di<br />
proprietà della Villa dai Padri Gesuiti all’allora<br />
Seconda Università degli Studi di Roma Tor<br />
Vergata (1981) – per interessamento di padre<br />
Severino Mecozzi e dietro autorizzazione del<br />
Direttore Amministrativo dell’Ateneo, dott.ssa<br />
Rosa Fusco Ciccone – il gruppo dell’altare (mensa<br />
ed ancona), privato del timpano curvo e di parte del<br />
basamento, fu collocato non troppo distante da<br />
<strong>Mondragone</strong>, nella chiesa della Madonna del Buon<br />
Consiglio in Colle di Fuori, frazione del Comune di<br />
Rocca Priora (fig. 4).<br />
Questa chiesa dalle insolite (ma pregevoli) forme –<br />
che le conferiscono un aspetto vagamente “alpino”<br />
(figg. 5, 6), specialmente riguardo al campanile e<br />
alla copertura – fu costruita nel piccolo borgo rurale<br />
– emergenza di spicco nella storiografia sociale<br />
della Campagna Romana – nel 1935, per volontà<br />
del cardinale Michele Lega (vescovo titolare della<br />
Diocesi Suburbicaria Tuscolana) e su progetto<br />
dell’ingegnere Carlo Strocchi (cugino del<br />
cardinale). Il gruppo ligneo proveniente da<br />
<strong>Mondragone</strong>, nonostante l’evidente difformità<br />
stilistica, si inserisce in modo non disdicevole nello<br />
spazio sacro contribuendo, anzi, a qualificarlo; esso,<br />
peraltro – a distanza di oltre un secolo dalla sua<br />
5. Prospettiva dal progetto dell’ing. Strocchi per la<br />
chiesa di Colle di Fuori<br />
_____________________________________________________________________________________________<br />
N° <strong>11</strong> – <strong>Giugno</strong> <strong>2006</strong> pag.23 di 32
ll <strong>Mondragone</strong><br />
_____________________________________________________________________________________________<br />
6. La chiesa della Madonna del Buon Consiglio in<br />
Colle di Fuori<br />
realizzazione e con la separazione tra mensa e<br />
ancona dovuta alle nuove esigenze liturgiche –<br />
risulta ancora ben conservato.<br />
La chiesa e i suoi apparati decorativi sono stati<br />
recentemente oggetto di rilevamenti e indagini<br />
storico-documentali (dalle quali provengono<br />
alcune immagini qui presentate) nell’ambito delle<br />
attività di esercitazione del corso di Rilievo<br />
dell’Architettura della Facoltà di Ingegneria<br />
dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata<br />
(fig. 7). Il lavoro, inizialmente svolto in gruppo<br />
dagli studenti Francesca Boschi, Alberto Chiarucci,<br />
Chiara Corsi, Emanuela Serpi, Roberto Verdinelli e<br />
Chiara Rossi, è stato poi approfondito da<br />
quest’ultima quale argomento della sua prova di<br />
primo livello in Ingegneria Edile, svolta nell’ambito<br />
della stessa disciplina. La neolaureata, in virtù di<br />
tale lavoro, ha recentemente conseguito uno dei<br />
premi banditi dalla XI Comunità Montana del Lazio<br />
– Castelli Romani e Prenestini per studi e ricerche<br />
svolti sul territorio di competenza, che le è stato<br />
consegnato proprio nel Salone degli Svizzeri della<br />
Villa, alla presenza di molte autorità e del<br />
Magnifico Rettore, professor Alessandro Finazzi<br />
Agrò.<br />
7. La mensa dell’altare; disegno di rilievo<br />
Rodolfo Maria Strollo<br />
_____________________________________________________________________________________________<br />
N° <strong>11</strong> – <strong>Giugno</strong> <strong>2006</strong> pag.24 di 32
ll <strong>Mondragone</strong><br />
_____________________________________________________________________________________________<br />
Uno sguardo fuori dalla finestra in un<br />
momento di pausa di lavoro.<br />
E’ il tardo pomeriggio di una giornata di<br />
fine inverno.<br />
Il cielo è sereno ed il sole ha ancora<br />
qualche ora prima di tramontare.<br />
Stanco di lavorare spengo il computer, mi<br />
infilo una giacchetta, mi metto in tasca la<br />
piccola macchina fotografica digitale ed<br />
esco di casa.<br />
Passeggio senza una méta e senza pensieri<br />
nella mente.<br />
Cammino a passo lento guardando tutto<br />
quello che ho d’intorno e che ho già visto<br />
tante altre volte ma quasi sempre senza<br />
osservare: le belle ville ed i palazzi di<br />
epoca passata, con le inferriate alle<br />
finestre e le cancellate in stile floreale, con<br />
l’edera che ricopre gran parte delle pareti e<br />
con i fiori ai balconi .<br />
Uno o due secoli or sono queste case, ed<br />
anche quella dove abito, si affacciavano<br />
sull’Olona, uno dei corsi d’acqua che<br />
allora a cielo aperto attraversavano la città<br />
e che oggi sono tutti canalizzati sotto le<br />
strade di grande comunicazione.<br />
A quel tempo, quando circolavano solo<br />
carrozze a cavalli, forse si riusciva a<br />
sentire anche il fruscio dell’acqua che<br />
scorreva lentamente.<br />
Oggi è il traffico di mezzi e di gente che<br />
scorre, con tanto rumore e confusione.<br />
Per trovare un po’ meno di frastuono e di<br />
movimento, mi inoltro nei vialetti alberati<br />
interni.<br />
Una passeggiata in relax<br />
Attraverso un giardino con una area<br />
recintata con l’altalena, lo scivolo ed altri<br />
attrezzi per far giocare i bambini.<br />
Mi soffermo a godermi, con gli occhi di<br />
nonno, le corse e le baruffe dei piccoli<br />
spensierati che si divertono sotto lo sguardo<br />
vigile delle proprie mamme o di uno dei loro<br />
nonni.<br />
Riprendo la mia passeggiata.<br />
Fiancheggio l’alto muro di cinta del parco<br />
che circonda la imponente costruzione della<br />
Università Cattolica del Sacro Cuore.<br />
Non vedo nessuno attraverso l’ampio portone<br />
di accesso semiaperto.<br />
Non è ora di lezioni : non c’è la confusione<br />
di studenti che contraddistingue le scuole.<br />
Riprendo il cammino a passo lento; il vialetto<br />
sbuca in una strada trafficata e mi ritrovo nel<br />
caotico mondo dei frettolosi.<br />
_____________________________________________________________________________________________<br />
N° <strong>11</strong> – <strong>Giugno</strong> <strong>2006</strong> pag.25 di 32
Il <strong>Mondragone</strong><br />
_______________________________________________________________________________________________<br />
Mi soffermo davanti al palazzo del<br />
Pontificio Istituto per le Missioni Estere,<br />
con annessa la<br />
Chiesa di S. Francesco Saverio, e poi<br />
rientro nelle viuzze interne, a gustarmi<br />
ancora un poco di tranquillità .<br />
Camminando noto il succedersi in maniera<br />
disordinata dei fabbricati di vecchio stile<br />
con quelli di costruzione più recente.<br />
E’ il moderno che ha riempito gli spazi<br />
vuoti lasciati dalle distruzioni dell’antico<br />
causate dalle incursioni aeree durante le<br />
guerre.<br />
Nel viale, sotto gli alberi, ci sono anche<br />
delle panchine.<br />
Ne approfitto per riposarmi qualche<br />
attimo.<br />
Il traffico scorre abbastanza lontano per<br />
sentirlo come un sordo rumore di fondo<br />
che non disturba.<br />
Arriva un signore che porta a spasso il<br />
suo cane, mi saluta con un cenno e si<br />
allontana .<br />
Passano alcune macchine, ma non<br />
corrono. Incomincia a far freddo; il sole è<br />
molto basso sull’orizzonte e l’aria si è<br />
rinfrescata.<br />
Si fa sera, è l’ora di rientrare.<br />
Avviandomi verso casa passo davanti alla<br />
abitazione di un noto personaggio della<br />
televisione.<br />
La si riconosce facilmente la sua casetta a due<br />
piani: nel motivo ornamentale di marmo<br />
bicolore che percorre in orizzontale la<br />
facciata della graziosa villetta si è fatto<br />
inserire le iniziali del suo nome D ed M<br />
incrociate fra loro<br />
Simpatica persona questo signore: lo si vede<br />
spesso portare a passeggio il suo cane nei<br />
giardini prospicenti la sua casa o con le borse<br />
della spesa fatta al supermercato.<br />
Modesto e riservato, e ciò non di meno, ha<br />
scelto un modo alquanto strano per<br />
distinguersi !<br />
Sono ormai vicino a casa.<br />
Il suono della sirena di una autoambulanza<br />
che si avvicina a gran velocità mi riporta alla<br />
movimentata realtà quotidiana.<br />
Il momento di relax è finito!<br />
________________<br />
rolando tonarelli<br />
(in collegio dal 1947 al 1953 )<br />
_____________________________________________________________________________________________<br />
N° <strong>11</strong> – <strong>Giugno</strong> <strong>2006</strong> pag.26 di 32
Il <strong>Mondragone</strong><br />
_______________________________________________________________________________________________<br />
Le strutture archeologiche, attualmente visibili,<br />
nella Villa <strong>Mondragone</strong> di Monte Porzio Catone.<br />
Francesco Grossi Gondi nella prefazione al<br />
suo libro “La villa dei Quintili e la villa di<br />
<strong>Mondragone</strong>” ad un certo punto dice: “…E le<br />
memorie della sua passata grandezza, ormai in<br />
gran parte perdute, andai io con amore<br />
rintracciando in quei ritagli di tempo che mi<br />
lasciarono liberi le ordinari occupazioni…”<br />
Noi ugualmente nei ritagli di tempo, abbiamo<br />
intrapreso l’esplorazione del territorio della villa<br />
<strong>Mondragone</strong> per poter ritrovare e vedere quanto<br />
ancora è presente delle antiche strutture. E il nostro<br />
progetto ha potuto essere portato a compimento<br />
quando i Padri Gesuiti sono stati in procinto di<br />
cedere la villa alla Università di Tor Vergata.<br />
Naturalmente abbiamo seguito le tracce<br />
lasciate e dal Grossi Gondi e dal Canina soprattutto<br />
per ritrovare le opere murarie ancora presenti.<br />
Infatti abbiamo potuto ritrovare e vedere le<br />
strutture prevalentemente a carattere idraulico,<br />
come la grande cisterna che fino ad epoca recente<br />
ha fornito il teatro delle acque, primitivamente,<br />
costruita per l’alimentazione della villa dei<br />
Quintili, e poi riparata dal Cardinale Marco Sitico<br />
Altemps per il rifornimento della nuova villa fatta<br />
da lui costruire sui resti di quella dei Quintili.<br />
Inoltre a circa metà percorso del viale che dalla<br />
Villa Vecchia sale alla Villa Parisi, già Borghese e<br />
Taverna, vi è un’altra grande cisterna<br />
verosimilmente utilizzata per il rifornimento delle<br />
costruzioni presenti nel sito, dove oggi sorge il<br />
palazzo della villa Parisi, e probabilmente anche<br />
delle costruzioni presenti nella località oggi<br />
chiamata Bargo Borghese.<br />
Quest’ultima inoltre è quella conserva che molto<br />
probabilmente ha permesso il rifornimento idrico<br />
per l’esecuzione dei lavori di costruzione della<br />
villa Angelina, Tuscolana e Vecchia.<br />
Di queste due cisterne però, non è stato<br />
possibile fare i rilievi e le necessarie osservazioni,<br />
perché tuttora ripiene completamente di acqua.<br />
Della seconda, ovvero di quella presente sulla<br />
strada che conduce a villa Parisi, tuttavia esiste un<br />
rilievo effettuato da Luigi Canina, pubblicato nel<br />
volume “Descrizione dell’antico Tuscolo” nel<br />
1841.<br />
Una terza grande conserva per le acque inoltre si<br />
trova in corrispondenza del limite superiore a sud<br />
del territorio denominato “Macchia della Formica”,<br />
dove è presente una cava di pozzolana, attualmente<br />
non più in funzione.<br />
Pianta e sezione della cisterna situata sulla strada che da villa Vecchia sale a villa Parisi .<br />
Da “Descrizione dell’antico Tuscolo” di Luigi Canina del 1841.<br />
_____________________________________________________________________________________________<br />
N° <strong>11</strong> – <strong>Giugno</strong> <strong>2006</strong> pag.27 di 32
Il <strong>Mondragone</strong><br />
_______________________________________________________________________________________________<br />
Infatti, dopo essere entrati nello spazio lasciato<br />
dai prelievi del materiale pozzolanico, effettuati<br />
nel tempo, è possibile vedere sulla parete nord<br />
della cava una parte delle murature della cisterna<br />
messe allo scoperto dagli scavi effettuati per il<br />
prelievo del materiale. Quest’ultima conserva è<br />
costituita da dieci navate, disposte una a fianco<br />
dell’altra, e separate ognuna da un muro di metri<br />
0,80 di spessore, aperto ad intervalli uguali da sei<br />
porte di metri 1,60 di larghezza e metri 2 di<br />
altezza.<br />
La cisterna misura in toto metri 20 sull’asse<br />
minore e metri 31,80 su quello maggiore. Ogni<br />
navata ha una lunghezza di metri 20, una<br />
larghezza di metri 2,50 e un’altezza di metri 4.<br />
Vi sono poi aperture rettangolari di circa 2 metri<br />
di lunghezza che presentano una chiusura<br />
effettuata con opus caementicium verosimilmente<br />
subito dopo il completamento dei lavori di<br />
costruzione.<br />
Queste aperture molto probabilmente sono state<br />
lasciate aperte fino al termine dei lavori di<br />
costruzione per l’esecuzione delle rifiniture<br />
all’interno della cavità.<br />
Questa cisterna quasi certamente ha svolto la<br />
funzione di serbatoio centrale e di limarla per, poi,<br />
rifornire le cisterne della sottostante villa dei<br />
Quintili, ma, quasi certamente, anche i serbatoi<br />
delle costruzioni presenti sui luoghi oggi occupati<br />
dalla villa Parisi, dalla villa Vecchia e dal Bargo<br />
Borghese.<br />
Cisterna di “Macchia della Formica”.<br />
Parte delle strutture murarie della cisterna viste dalla<br />
cavità lasciata dagli scavi nella cava.<br />
Le acque pervenute a questo serbatoio possono<br />
essere state convogliate da diversi punti e<br />
precisamente : dal cunicolo originario<br />
dall’acquedotto Aldobrandini che ancora oggi<br />
raggiunge la zona sovrastante le costruzioni della<br />
villa <strong>Mondragone</strong>; dal cunicolo proveniente da<br />
Rocca priora che attraversa la zona della<br />
Montagnola; e dalla sovrastante sorgente di<br />
Formello situata al di sotto dell’Eremo di<br />
Camaldoli.<br />
La costruzione è stata realizzata utilizzando l’opus<br />
caementicium con coperture a volta a tutto sesto<br />
dove sono presenti apertura circolari e quadrate,<br />
comunicanti con pozzi, verosimilmente lasciate per<br />
poter entrare nella cisterna per eventuali ispezioni,<br />
riparazioni e pulizie.<br />
Veduta parziale di una delle navate della cisterna di<br />
“Macchia della Formica” dove sono visibili due porte di<br />
comunicazione tra una navata e l’altra, il notevole<br />
interramento della cisterna e sulla volta una delle<br />
aperture rettangolari chiuse con una gettata di opus<br />
caementicium al termine della costruzione della cisterna.<br />
L’epoca della sua costruzione può essere<br />
compresa tra il 50 a.C. e il 50 d.C.<br />
Durante l’esecuzione dei lavori per la<br />
ristrutturazione degli edifici da destinare agli scopi<br />
dell’Università sono riapparse molte delle strutture<br />
murarie dell’antico edificio.<br />
Ma già all’epoca del <strong>Nobile</strong> <strong>Collegio</strong>, diretto<br />
dai Padri Gesuiti, numerosi ritrovamenti sono stati<br />
effettuati e sistemati sulle pareti di una sala del<br />
piano superiore a costituire un piccolo antiquarium.<br />
_____________________________________________________________________________________________<br />
N° <strong>11</strong> – <strong>Giugno</strong> <strong>2006</strong> pag.28 di 32
Il <strong>Mondragone</strong><br />
_______________________________________________________________________________________________<br />
Inoltre, sempre durante i recenti lavori di<br />
ristrutturazione nella zona pressoché centrale del<br />
grande cortile interno, sono stati ritrovati i resti<br />
murari di un’altra grande cisterna.<br />
Vogliamo, poi, dire che la via proveniente<br />
dalla nuova strada del Tuscolo e diretta alla villa<br />
<strong>Mondragone</strong>, attuale strada di accesso ad una<br />
recente lottizzazione, verisimilmente in antico è<br />
stata un percorso utilizzato per raggiungere dalla<br />
città di Tuscolo la villa dei Quintili.<br />
Le antiche strutture della strada che<br />
avrebbero permesso la sua identificazione con<br />
esattezza, molto probabilmente sono state asportate<br />
durante la sua ristrutturazione effettuata dai<br />
Borghese con la costruzione dell’Eremo di<br />
Camaldoli e l’ampliamento della villa <strong>Mondragone</strong><br />
per poter più agevolmente effettuare il trasferimento<br />
da una delle due località all’altra.<br />
Infine vogliamo dire che sarebbe molto<br />
interessante se nel territorio della villa venissero<br />
effettuati degli scavi, perché certamente molte<br />
strutture murarie, e non solo, potrebbero essere<br />
portate alla luce per completare la storia di questo<br />
luogo.<br />
Luigi Devoti<br />
Pianta e sezioni della cisterna di “Macchia della Formica”.<br />
= * = * = * = * =<br />
_____________________________________________________________________________________________<br />
N° <strong>11</strong> – <strong>Giugno</strong> <strong>2006</strong> pag.29 di 32
Il <strong>Mondragone</strong><br />
_______________________________________________________________________________________________<br />
Le Sorprese dei Mercatini<br />
di Massimo Carafa Jacobini (in collegio dal 1942 al 1946).<br />
Riccione: mercatino ai giardinetti del pattinaggio,una cartolina di Luigi Filippo Von Mehelem,<br />
Carissimo Luigi Filippo, fortunatamente gli<br />
studi andavano un po’ meglio, ma un bel<br />
tratto rosso su quel “ p’ò ” con troppi accenti<br />
te lo debbo mettere.<br />
Stai comunque tranquillo che la cara zia non<br />
avrà di certo meno gradita la tua cartolina per<br />
quel piccolo errore commesso da un piccolo<br />
convittore di <strong>Mondragone</strong> il 14 Maggio 1943.<br />
Un abbraccio.<br />
Massimo Carafa Jacobini<br />
Foto di Luigi Filippo von Mehelem appena entrato in<br />
collegio nel 1942<br />
_____________________________________________________________________________________________<br />
N° <strong>11</strong> – <strong>Giugno</strong> <strong>2006</strong> pag.30 di 32
Il <strong>Mondragone</strong><br />
_______________________________________________________________________________________________<br />
GLI AMICI , AI QUALI E’ STATA INVIATA LA TESSERA DI SOCIO<br />
ONORARIO DELLA NOSTRA ASSOCIAZIONE,<br />
CHE CI HANNO INVIATO I LORO RINGRAZIAMENTI<br />
Ciro Cacchione Presidente della FEDEREX.<br />
_____________________<br />
Padre Gianpaolo Salvini S.I. Direttore de La Civiltà Cattolica.<br />
_____________________<br />
Padre Michele Laimer S.I. Prefetto in collegio dal 1945 al 1947. Vive ad Innsbruck.<br />
_____________________<br />
Prof. Rodolfo Maria Strollo dell’Università degli Studi di Roma TOR VERGATA<br />
______________________<br />
Ferdinando Sanfelice figlio del nostro Ex Marcello Sanfelice di Monteforte in collegio dal 1918<br />
al 1921 e Presidente della Associazione Ex Alunni <strong>Nobile</strong> <strong>Collegio</strong> <strong>Mondragone</strong><br />
dal 1960 al 1991.<br />
_______________________<br />
Annapia Sciolari sorella di Angelo in collegio dal 1940 al 1946 e di Adriano Sciolari<br />
in collegio dal 1941 al 1947<br />
_______________________<br />
Alessandro Sciolari figlio del nostro Ex Angelo, in collegio dal 1940 al 1946.<br />
__________________________<br />
Maria Arnaldi vedova del nostro Ex Francesco in collegio dal 1930 al 1938.<br />
_________________________<br />
Valentin Kakarrigi in collegio dal 1938 al 1943. Vive a Tirana.<br />
_____________________________________________________________________________________________<br />
N° <strong>11</strong> – <strong>Giugno</strong> <strong>2006</strong> pag.31 di 32
Il <strong>Mondragone</strong><br />
_______________________________________________________________________________________________<br />
redatto a cura di :<br />
Vittorio Spadorcia<br />
vispador@tin.it<br />
Rolando Tonarelli<br />
rolando.tonarelli@fastwebnet.it<br />
_____________________________________________________________________________________________<br />
N° <strong>11</strong> – <strong>Giugno</strong> <strong>2006</strong> pag.32 di 32