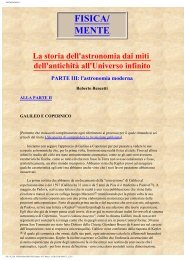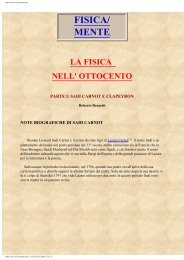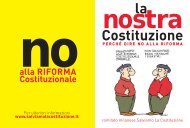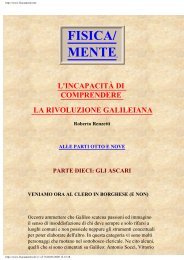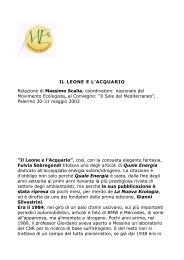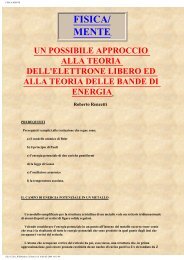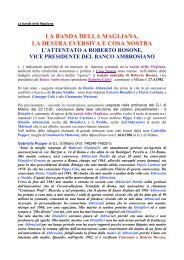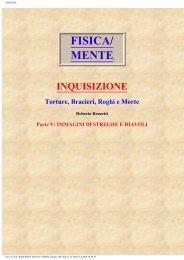Capitolo 3 – Le centrali termoelettriche - fisica/mente
Capitolo 3 – Le centrali termoelettriche - fisica/mente
Capitolo 3 – Le centrali termoelettriche - fisica/mente
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>Capitolo</strong> 3 <strong>–</strong> <strong>Le</strong> <strong>centrali</strong> <strong>termoelettriche</strong><br />
le varie superfici di scambio, al raggiungimento della temperatura critica passa dallo stato liquido<br />
diretta<strong>mente</strong> allo stato di vapore surriscaldato.<br />
Anche effettuando più risurriscaldamenti si possono ottenere miglioramenti di rendimento.<br />
Tutto ciò comporta però l’adozione di impianti costruttiva<strong>mente</strong> sempre più complessi, con<br />
maggiori costi d’investimento.<br />
I progetti per aumentare l’efficienza del ciclo Rankine, aumentando le pressioni e le temperature del vapore, sono stati<br />
sviluppati costante<strong>mente</strong>.<br />
<strong>Le</strong> prime unità <strong>termoelettriche</strong>, all’inizio del ‘900, erano costruite per pressioni e temperature del vapore all’ingresso in<br />
turbina di circa 13 bar e 250°C.<br />
Poi, all’aumentare delle potenze, anche le pressioni e le temperature aumentarono.<br />
Intorno al 1950 vi fu un decisivo incremento nelle taglie degli impianti e si passò dai 35 MW fino ai 150 MW. Il ciclo<br />
adottato fu quello a semplice surriscaldamento, con vapore all’ammissione turbina inizial<strong>mente</strong> a 145 bar e 538°C, poi a<br />
165 bar e 538°C.<br />
Negli anni ’60 furono installate parecchie unità con queste caratteristiche termodinamiche (165 bar, 538°C e<br />
risurriscaldamento a 538°C) e si passò alla taglia 320 MW.<br />
L’ENEL costruì negli anni successivi molti impianti con gruppi da 320 MW, che ancora oggi costituiscono l’ossatura<br />
del parco termoelettrico italiano.<br />
Nel 1968 entrarono in servizio in Italia le prime due unità ipercritiche di taglia 600 MW con doppio risurriscaldamento<br />
(258 bar, 540°C/552°C/556°C), dotate di turbine cross-compound.<br />
I grandi costruttori (General Electric e Westinghouse) negli anni ’60-70 realizzarono impianti di potenza 350÷1100 MW<br />
con condizioni ipercritiche del vapore (241 bar, 538°C/565°C), sia a semplice che a doppio risurriscaldamento, con<br />
turbine cross-compound o tandem-compound.<br />
Dal 1980, utilizzando l’esperienza maturata con le unità a semplice e a doppio risurriscaldamento, i grandi costruttori<br />
hanno sviluppato progetti con condizioni del vapore sempre più spinte (300 bar e 600°C). Questi progetti hanno trovato<br />
applicazione soprattutto in Asia e Nord Europa.<br />
L’incremento di rendimento di questi impianti è mostrato nei due grafici seguenti e deve natural<strong>mente</strong> essere<br />
considerato unita<strong>mente</strong> ai maggiori costi impiantistici di installazione e di manutenzione.<br />
I cicli con condizioni del vapore surriscaldato e risurriscaldato superiori a 4000 psi (276 bar) e 1025°F (552°C) sono<br />
detti ultrasupercritici.<br />
L’adozione di un doppio risurriscaldamento dà luogo ad incrementi di rendimento variabili in funzione delle condizioni<br />
del vapore.<br />
Per massimizzare il guadagno di rendimento dei cicli ultrasupercritici, bisogna anche ottimizzare il ciclo rigenerativo<br />
con l’aggiunta di nuovi riscaldatori e la scelta di una più alta temperatura dell’acqua alimento all’ingresso<br />
dell’economizzatore.<br />
In molti casi si inserisce un riscaldatore al di sopra del punto di risurriscaldamento. Questo riscaldatore è denominato<br />
con termine anglosassone HARP (Heater Above the Reheat Point).<br />
10