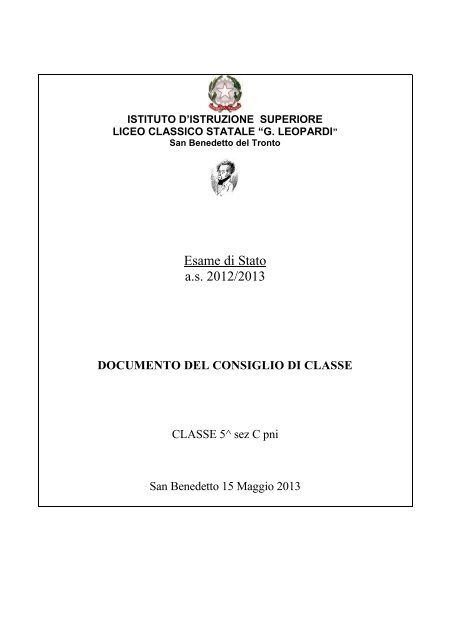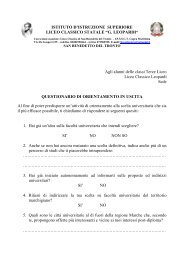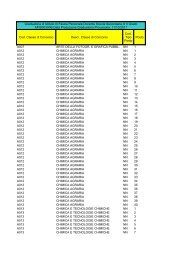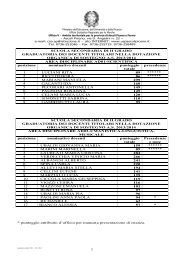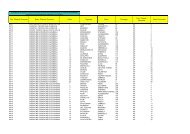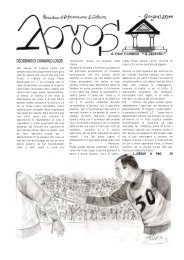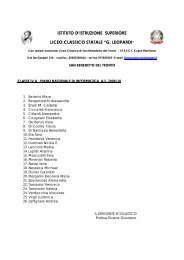Documento del 15 Maggio - Liceo Classico "G. Leopardi"
Documento del 15 Maggio - Liceo Classico "G. Leopardi"
Documento del 15 Maggio - Liceo Classico "G. Leopardi"
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE<br />
LICEO CLASSICO STATALE “G. LEOPARDI”<br />
San Benedetto <strong>del</strong> Tronto<br />
Esame di Stato<br />
a.s. 2012/2013<br />
DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE<br />
CLASSE 5^ sez C pni<br />
San Benedetto <strong>15</strong> <strong>Maggio</strong> 2013
Indice<br />
Composizione <strong>del</strong> Consiglio di Classe .............................................................................................................. 3<br />
Elenco Candidati ............................................................................................................................................... 4<br />
Storia <strong>del</strong>la classe nel triennio finale ................................................................................................................. 5<br />
Presentazione <strong>del</strong>la classe .................................................................................................................................. 5<br />
Attività integrative svolte……………………..…………………………...………………………………...... 6<br />
Finalità generali <strong>del</strong>l’indirizzo classico ............................................................................................................. 7<br />
Obiettivi <strong>del</strong> Consiglio di Classe ....................................................................................................................... 7<br />
Percorsi interdisciplinari realizzati .................................................................................................................... 7<br />
Criteri di valutazione ......................................................................................................................................... 7<br />
Simulazione Terza Prova .................................................................................................................................. 9<br />
PERCORSI FORMATIVI DISCIPLINARI .................................................................................................... 10<br />
ITALIANO…………………………………………….……………………………………………………...11<br />
GRECO ........................................................................................................................................................... 17<br />
LATINO .......................................................................................................................................................... 21<br />
MATEMATICA .............................................................................................................................................. 25<br />
FISICA ............................................................................................................................................................ 27<br />
SCIENZE……………………………………………………………………….…………………………….30<br />
FILOSOFIA…………………………………………………………………………………………………..34<br />
STORIA……………………………………………………………………………………………………....38<br />
INGLESE……………………………………………………………………..................................................42<br />
STORIA DELL’ARTE…………………………………………………………………………………….....46<br />
EDUCAZIONE FISICA……………………………………………………………………………………...49<br />
RELIGIONE CATTOLICA………………………………………………………………………………….51<br />
CONSIGLIO DI CLASSE……………………………………………………………………………………52<br />
ALLEGATI…………………………………………………………………………………………………..53<br />
2
Composizione <strong>del</strong> Consiglio di Classe<br />
Nome Docente<br />
Disciplina<br />
Continuità didattica<br />
1° <strong>Liceo</strong> 2° <strong>Liceo</strong> 3° <strong>Liceo</strong><br />
Sgattoni Margherita Italiano X X<br />
Pugliese Maura Italiano X<br />
Sgattoni Margherita Latino X X<br />
Amadio Ines Latino X<br />
Amadio Ines Greco X X X<br />
Rosetti Catia Storia X X X<br />
Rosetti Catia Filosofia X X X<br />
Rossi Pietro Matematica X X<br />
Marsili Caterina Matematica X<br />
Zazzetti Luciano Fisica X X<br />
Castelletti Marida Scienze X X X<br />
Ciarrocchi Daniela Inglese X<br />
Anzivino Margherita Inglese X X<br />
Calinich Maddalena Storia <strong>del</strong>l’arte X X X<br />
Amatucci Giuseppe Educazione Fisica X X<br />
Pilotti Giuseppina Educazione Fisica X<br />
Don Armando Guido Moriconi Religione X X X<br />
3
Elenco Candidati<br />
1 AMADIO Nicola<br />
2 BIOCCA Beatrice<br />
3 BONANNI Francesco<br />
4 CAROSI Giulia<br />
5 CENSORI Elisa<br />
6 DE ZIO Isabella Ester<br />
7 DI GIUSTO Elena<br />
8 EMIDI Paolo<br />
9 KALAJA Alba<br />
10 LUCIANI Eleonora<br />
11 MARRA Vincenzo<br />
12 MICOZZI Eleonora<br />
13 NATALI Massimo<br />
14 PACIONI Sofia<br />
<strong>15</strong> RANNO Alessio<br />
16 RANNO Eleonora<br />
17 ROSATI Maria Elena<br />
18 SCIOCCHETTI Francesca<br />
19 TAMBURRINI Giulia<br />
20 TORRESETTI Marco<br />
21 TREVISANI Eleonora<br />
4
Storia <strong>del</strong>la classe nel triennio finale<br />
Anno<br />
Scolastico<br />
N° studenti<br />
promossi<br />
N° studenti<br />
promossi con uno<br />
o più debiti<br />
2010/2011 21 2<br />
2011/2012 21<br />
N° studenti<br />
trasferiti ad altra<br />
sezione<br />
Anno<br />
scolastico<br />
2012/2013<br />
Studenti<br />
provenienti<br />
dalla 4^ C<br />
21<br />
Studenti<br />
provenienti da<br />
altra scuola<br />
Studenti trasferiti<br />
ad altra sezione<br />
Presentazione <strong>del</strong>la classe<br />
La classe 5^ C, all’inizio <strong>del</strong>l’anno, era composta da ventuno alunni, tutti provenienti dalla sezione<br />
C <strong>del</strong> ginnasio. Nel corso <strong>del</strong>l’anno scolastico 2011-2012, precisamente nel pentamestre <strong>del</strong> 4°<br />
anno, l’alunno Amadio Nicola ha frequentato le lezioni presso il Maria Theresia Gymnasium<br />
Augsburg – Bayern (Augusta, Baviera).<br />
Nel mese di settembre, all’inizio <strong>del</strong> 5° <strong>Liceo</strong>, dopo aver sostenuto prove integrative nelle materie<br />
non presenti nel curricolo <strong>del</strong> corso di studio frequentato all’estero, l’alunno è stato reinserito nella<br />
classe con l’integrazione <strong>del</strong> precedente credito scolastico.<br />
I processi di socializzazione nella classe si sono svolti in un’ottica di piccoli gruppi, coesi al loro<br />
interno, piuttosto che assumere un carattere globale.<br />
Nel corso <strong>del</strong> triennio, la classe ha perso la continuità didattica per Italiano, Latino, Matematica,<br />
Educazione Fisica ed Inglese.<br />
Verso i docenti, gli alunni sono sempre stati educati e corretti ed hanno globalmente risposto con<br />
puntualità e serietà agli impegni ed alle sollecitazioni didattiche, risposta che per alcuni alunni ha<br />
significato una generosa e ragguardevole disponibilità agli approfondimenti.<br />
Obiettivi didattici e criteri di valutazione sono stati regolarmente esplicitati, al fine di promuovere<br />
sia la massima condivisione <strong>del</strong>le finalità educative sia la responsabilizzazione di ciascuno verso la<br />
propria crescita culturale ed umana. L’insegnamento <strong>del</strong>le varie discipline è stato impostato in<br />
modo da promuovere, attraverso l’acquisizione dei contenuti e dei linguaggi specifici, la graduale<br />
acquisizione di un metodo di studio sempre meno mnemonico, più critico e rielaborativo, nonché lo<br />
sviluppo <strong>del</strong>le capacità logiche, analitiche ed espositive.<br />
I programmi sono stati svolti in modo nel complesso regolare, secondo tempi adeguati al ritmo di<br />
apprendimento medio <strong>del</strong>la classe.<br />
In ordine alle capacità individuali, alle attitudini, ai ritmi di apprendimento, alla partecipazione<br />
nonché al grado di autodisciplina nell’impegno domestico, la classe può essere divisa<br />
sostanzialmente in due gruppi. Un primo gruppo è costituito da alunni che, anche grazie ai solidi<br />
prerequisiti, sin dall’inizio <strong>del</strong>l’anno seguono e si impegnano con costanza, serietà e partecipazione<br />
in tutte le discipline, si avvalgono di un metodo di studio efficace e, sostenuti da buone ed in alcuni<br />
casi eccellenti capacità individuali, conseguono un rendimento molto soddisfacente, con punte di<br />
eccellenza.<br />
Un altro gruppo è formato da alcuni alunni che si sono impossessati dei contenuti e di un metodo<br />
più efficace in maniera graduale e con diligenza e costanza, cercando – in alcuni casi – di colmare<br />
lacune relative a specifiche discipline. Costoro, anche se permangono carenze, non gravi, in alcune<br />
discipline, evidenziano una preparazione, nel complesso più che soddisfacente.<br />
5
Attività integrative svolte<br />
La classe, nel suo insieme o per gruppi, ha partecipato, nel corso <strong>del</strong> triennio, alle seguenti attività<br />
integrative:<br />
A) Orientamento universitario<br />
B) Olimpiadi <strong>del</strong>la Matematica<br />
C) Visita guidata alla mostra su Botticelli e Filippino Lippi, Scuderie Papali <strong>del</strong> Quirinale,<br />
Roma<br />
D) Partecipazione a convegni ed incontri<br />
E) Partecipazione, in ogni anno <strong>del</strong> Triennio, alla Conferenza /Dibattito nell’ambito <strong>del</strong><br />
progetto scolastico ‘Cittadinanza e Costituzione’<br />
F) Partecipazione al ‘Progetto Neve’ a Bardonecchia e Gressoney<br />
G) Partecipazione al progetto ‘Scuola di Platea’<br />
H) Partecipazione al XX e XXI Convegno Fides Vita<br />
I) Viaggio di istruzione a Torino<br />
J) Viaggio di istruzione in Sicilia<br />
K) Viaggio di istruzione a Vienna / Budapest<br />
L) Teatro in Lingua Inglese – ‘Waiting for Godot’, di Samuel Beckett, allestito dalla<br />
compagnia Palketto Stage.<br />
La ricaduta didattica <strong>del</strong>le attività sul curricolo può considerarsi globalmente positiva: gli<br />
alunni hanno utilizzato le diverse proposte formative come occasioni per arricchire il loro<br />
bagaglio culturale, per confrontarsi con realtà culturali diverse, per sviluppare la<br />
conoscenza di sé anche al fine di compiere scelte adeguate alle proprie inclinazioni, per<br />
migliorare le proprie capacità di interazione comunicativa.<br />
La ricaduta didattica, naturalmente, è stata diversa a seconda <strong>del</strong>l’attività svolta e <strong>del</strong>le attitudini di<br />
ciascuno, ma appare particolarmente positiva per quegli alunni che, pur avendo presentato qualche<br />
difficoltà nel conseguimento degli obiettivi disciplinari, hanno partecipato proficuamente alla<br />
realizzazione di alcuni progetti.<br />
6
Finalità generali <strong>del</strong>l’indirizzo classico<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Potenziare le capacità logiche e fornire strumenti critici agli studenti affinché, partendo<br />
dallo studio <strong>del</strong> passato visto nelle sue componenti storiche, filosofiche, linguistiche,<br />
artistiche, scientifiche, possano comprendere le origini e il significato <strong>del</strong>la realtà<br />
contemporanea<br />
Avvicinare gli studenti al contesto mondiale potenziando lo studio <strong>del</strong>le lingue e <strong>del</strong>le civiltà<br />
straniere<br />
Comporre l’unità umanistica e scientifica <strong>del</strong> sapere privilegiando il momento teorico e<br />
sistematico <strong>del</strong>la conoscenza, essenziale per predisporre l’individuo ad una vita lavorativa<br />
consapevole e di soddisfazione<br />
Acquisire contenuti specifici ampi e approfonditi, riutilizzarli e rielaborarli con approccio critico<br />
Formulare ipotesi e approntare verifiche fondate e attente alla globalità <strong>del</strong> sapere<br />
Obiettivi <strong>del</strong> Consiglio di Classe<br />
Conoscenze Capacità Competenze<br />
1) le strutture morfosintattiche<br />
2) i linguaggi e i contenuti<br />
specifici disciplinari<br />
3) le regole <strong>del</strong>la logica e <strong>del</strong><br />
corretto ragionamento<br />
4) alcuni mo<strong>del</strong>li teorici e/o<br />
interpretativi<br />
A. analizzare<br />
B. sintetizzare<br />
C. contestualizzare<br />
D. comparare<br />
E. esprimere con ordine<br />
logico informazioni e<br />
opinioni<br />
F. stabilire rapporti di causaeffetto<br />
A. ricomporre in un quadro<br />
organico gli elementi<br />
essenziali <strong>del</strong>le conoscenze<br />
B. valutare criticamente<br />
C. argomentare ed elaborare<br />
una propria tesi<br />
D. produrre contributi orali e<br />
scritti in modo autonomo<br />
E. interpretare<br />
Percorsi interdisciplinari realizzati<br />
Filosofia / Matematica: ‘La crisi dei fondamenti <strong>del</strong>la scienza’<br />
Storia / Inglese: ‘La questione irlandese e The Troubles’ (dopo il <strong>15</strong> maggio)<br />
Criteri di valutazione<br />
Alla formazione dei voti finali e <strong>del</strong> credito scolastico hanno concorso le verifiche formative e<br />
sommative, le osservazioni quotidiane, che sono state parametrate ed annotate, l’eventuale<br />
partecipazione <strong>del</strong>lo studente ad attività integrative previste dal POF.<br />
Per le verifiche scritte e orali si è tenuto conto dei seguenti indicatori generali:<br />
Capacità di comprensione e/o decodifica e/o analisi di un testo, di un quesito, di un<br />
documento, di un’opera d’arte, di un’immagine<br />
Conoscenza dei contenuti disciplinari<br />
Capacità di argomentazione e rielaborazione<br />
Competenza linguistica<br />
Quanto alla scala di corrispondenza tra voti e livelli di conoscenza e abilità si fa riferimento a quella<br />
di seguito riportata.<br />
7
Schema Di Corrispondenza fra Voto ( in decimi) e Prestazione<br />
Giudizio: OTTIMO<br />
(Voti: 9 - 10)<br />
Giudizio: BUONO<br />
(Voto: 8)<br />
Giudizio: DISCRETO<br />
(Voto : 7)<br />
Giudizio: SUFFICIENTE<br />
( Voto: 6)<br />
Giudizio: MEDIOCRE<br />
(Voto: 5)<br />
Giudizio:<br />
INSUFFICIENTE<br />
(Voto: 4)<br />
Giudizio:SCARSO<br />
(Voto: 3 - 2)<br />
Giudizio: PROVA NULLA<br />
(Voto: 1)<br />
Conosce i contenuti in modo ampio e pertinente e sa<br />
personalizzarli. Sa sviluppare analisi complesse, elaborare<br />
sintesi, risolvere situazioni problematiche; sa trattare e<br />
presentare idee e fenomeni argomentando in maniera<br />
efficace, critica e originale.<br />
Conosce i contenuti in modo organico ed articolato, sa<br />
stabilire connessioni tra i concetti, compiere inferenze; sa<br />
sviluppare analisi e sintesi puntuali. Utilizza un linguaggio<br />
preciso e accurato, argomentando opportunamente.<br />
Conosce gli argomenti <strong>del</strong>la disciplina nei nuclei<br />
fondamentali e nelle loro articolazioni, sa impostare<br />
semplici collegamenti disciplinari; è in grado di realizzare<br />
applicazioni funzionali. Si esprime con chiarezza e in modo<br />
adeguato.<br />
Conosce gli argomenti fondamentali, riesce ad applicare le<br />
conoscenze in modo sostanzialmente corretto, sa avviare<br />
collegamenti tra i concetti disciplinari, si esprime con un<br />
linguaggio sufficientemente appropriato seppure non troppo<br />
articolato.<br />
Conosce parzialmente i contenuti essenziali, utilizza in<br />
modo approssimativo le procedure, non sempre riuscendo a<br />
stabilire connessioni. Si esprime con un linguaggio<br />
semplice e approssimativo.<br />
Conosce gli argomenti in modo lacunoso ed incerto, utilizza<br />
procedure non corrette dimostrando confusione nell’applicare i<br />
concetti fondamentali. Si esprime in modo disorganico.<br />
Conosce in modo <strong>del</strong> tutto frammentario e superficiale i<br />
contenuti essenziali, si esprime in un linguaggio molto<br />
scorretto, non è in grado di procedere nelle applicazioni.<br />
Nella prova scritta, lo studente consegna il foglio in<br />
bianco, nella prova orale non esprime alcuna conoscenza<br />
o si rifiuta di sottoporsi a verifica.<br />
In particolare, per le verifiche sono state utilizzate le griglie di valutazione allegate al presente<br />
documento:<br />
1. Griglia per la valutazione <strong>del</strong>la prima prova<br />
2. Griglia per la valutazione <strong>del</strong>la seconda prova<br />
3. Griglia per la valutazione <strong>del</strong>la terza prova<br />
4. Griglia per la valutazione <strong>del</strong>le verifiche orali effettuate in forma di colloquio<br />
8
Simulazione Terza Prova<br />
Nel corso <strong>del</strong>l’anno scolastico, i docenti <strong>del</strong>le singole discipline hanno sperimentato diverse<br />
tipologie di verifica. In base all'esperienza maturata in tal modo, il consiglio ha riscontrato che le<br />
materie in cui la classe ha dimostrato maggiore sicurezza e un miglior rendimento per la terza prova<br />
d’ esame sono Greco, Inglese, Filosofia, Fisica, Scienze, e che la tipologia su cui la classe riesce<br />
ad esprimersi con maggiore padronanza è stata la tipologia B, “Quesiti a risposta singola” (max<br />
10 righe).<br />
Pertanto il giorno 13 <strong>Maggio</strong> 2013 si è svolta una simulazione di terza prova,tipologia B.<br />
Le discipline coinvolte sono state Greco Filosofia, Fisica, Inglese, Scienze con due quesiti<br />
ciascuna, per un totale di dieci.<br />
La durata <strong>del</strong>la prova, di cui si allega una copia, è stata fissata in tre ore.<br />
9
PERCORSI<br />
FORMATIVI<br />
DISCIPLINARI<br />
10
ITALIANO<br />
Percorso Formativo Disciplinare<br />
Docente: Prof.ssa Maura Pugliese<br />
CONTENUTI DISCIPLINARI SVILUPPATI<br />
(suddivisi per moduli o unità didattiche)<br />
LIVELLO DI<br />
APPROFONDIMENTO<br />
(Ottimo – Buono – Discreto –<br />
Sufficiente)<br />
TEMPI<br />
IN ORE<br />
1-UGO FOSCOLO<br />
Biografia e poetica. Ultime lettere di Jacopo Ortis. I sonetti. I Sepolcri.<br />
TESTI<br />
Ultime lettere di Jacopo Ortis, Al lettore; I, lettera <strong>del</strong>l’11 ottobre<br />
1797; II, lettera <strong>del</strong> 4 dicembre 1798<br />
Sonetti: Alla sera; Autoritratto; A Zacinto; In morte <strong>del</strong> fratello<br />
Giovanni<br />
I Sepolcri: caratteri generali e riassunto <strong>del</strong> contenuto<br />
BUONO 16<br />
2-IL ROMANTICISMO<br />
Coordinate essenziali. Originalità di un patrimonio condiviso. Il<br />
letterato e le istituzioni. Caratteri generali <strong>del</strong> Romanticismo europeo.<br />
L’eroe romantico. Le patrie <strong>del</strong> Romanticismo europeo.<br />
DISCRETO 5<br />
TESTI<br />
Francois René de Chateaubriand, René, Il vago pellegrinare di René<br />
3-GIACOMO LEOPARDI<br />
Biografia, pensiero e poetica. Le fasi <strong>del</strong> pessimismo. Gli idilli. Le<br />
Operette morali. Lo Zibaldone. I canti pisano-recanatesi. Il ciclo di<br />
Aspasia. La Ginestra o il fiore <strong>del</strong> deserto.<br />
TESTI<br />
L’infinito<br />
Alla luna<br />
Dialogo <strong>del</strong>la Natura e di un Islandese<br />
Dialogo di un venditore d’almanacchi e di un passeggere<br />
Dialogo di Tristano e di un amico<br />
Zibaldone, 646-648, 4418, 4174-4177, 4426<br />
A Silvia<br />
La quiete dopo la tempesta<br />
Il passero solitario<br />
A se stesso<br />
La ginestra, vv.1-86; 111-<strong>15</strong>7; 297-317<br />
OTTIMO 17<br />
4-ALESSANDRO MANZONI<br />
Biografia e poetica. Le odi civili. Le tragedie. La lettera a M. Chauvet.<br />
I Promessi Sposi: caratteri generali (un progetto rivoluzionario, la<br />
struttura narrativa e le scelte stilistiche, gli ideali politico-sociali, la<br />
tragicità <strong>del</strong>la storia).<br />
DISCRETO 8<br />
TESTI<br />
11
Il cinque maggio<br />
A<strong>del</strong>chi, atto IV, scena I, vv.122-210; coro<br />
Parte <strong>del</strong>la Lettera a Claude Fauriel <strong>del</strong> 29 maggio 1822<br />
Parte <strong>del</strong>l’Introduzione al Fermo e Lucia<br />
Fermo e Lucia, dalla parte II, capitolo 8; I Promessi Sposi (1840), dal<br />
capitolo 20 (Il Conte <strong>del</strong> Sagrato e l’Innominato)<br />
5-IL NATURALISMO FRANCESE E IL VERISMO ITALIANO<br />
Caratteri generali, analogie e differenze tra le due correnti.<br />
SUFFICIENTE 1<br />
6-GIOVANNI VERGA<br />
Biografia e poetica. Vita dei campi. Il ciclo dei vinti. I Malavoglia.<br />
Novelle rusticane. Mastro-don Gesualdo.<br />
TESTI<br />
Fantasticheria<br />
Rosso Malpelo<br />
Prefazione all’Amante di Gramigna<br />
Prefazione ai Malavoglia<br />
I Malavoglia, parte dei capitoli I e XV<br />
La roba<br />
Mastro-don Gesualdo, parte IV, conclusione <strong>del</strong> capitolo V<br />
BUONO 9<br />
7-IL SIMBOLISMO EUROPEO<br />
Charles Bau<strong>del</strong>aire. I “poeti maledetti”.<br />
TESTI<br />
Bau<strong>del</strong>aire, L’albatros<br />
Corrispondenze<br />
DISCRETO 4<br />
8-LA SCAPIGLIATURA<br />
Una rivolta non solo letteraria. Scrittori e produzione culturale.<br />
TESTI<br />
SUFFICIENTE 1<br />
Emilio Praga, Preludio<br />
9-GIOVANNI PASCOLI<br />
Biografia e poetica. Il fanciullino. Myricae. Canti di Castelvecchio.<br />
TESTI<br />
Il fanciullino, parte <strong>del</strong>le sezioni I-II<br />
Lavandare<br />
Novembre<br />
Temporale<br />
Il lampo<br />
Il tuono<br />
X Agosto<br />
L’assiuolo<br />
La mia sera<br />
Il gelsomino notturno<br />
10-GABRIELE D’ANNUNZIO<br />
Biografia e poetica. Canto novo. Laudi <strong>del</strong> cielo <strong>del</strong> mare <strong>del</strong>la terra e<br />
OTTIMO 11<br />
BUONO 7<br />
12
degli eroi. Alcyone. Le “prose di romanzi”. Il piacere. Le vergini <strong>del</strong>le<br />
rocce.<br />
TESTI<br />
Canta la gioia<br />
La sera fiesolana<br />
La pioggia nel pineto<br />
La sabbia <strong>del</strong> tempo<br />
Le stirpi canore<br />
Il piacere, libro I, parte <strong>del</strong> capitolo I e <strong>del</strong> capitolo II<br />
Le vergini <strong>del</strong>le rocce, parte <strong>del</strong> libro I<br />
11-IL CREPUSCOLARISMO<br />
Una variegata geografia poetica. Mo<strong>del</strong>li e temi <strong>del</strong>la poesia<br />
crepuscolare.<br />
SUFFICIENTE 1<br />
TESTI<br />
Sergio Corazzini, Desolazione <strong>del</strong> povero poeta sentimentale<br />
12-IL FUTURISMO<br />
Filippo Tommaso Marinetti. L’avvio <strong>del</strong> movimento. Le altre arti e<br />
l’approdo al “paroliberismo”.<br />
SUFFICIENTE 1<br />
TESTI<br />
Manifesto <strong>del</strong> Futurismo<br />
Manifesto tecnico <strong>del</strong>la letteratura futurista<br />
13-LUIGI PIRANDELLO<br />
Biografia e poetica. L’umorismo. I romanzi “siciliani”. I romanzi<br />
“umoristici”. Il fu Mattia Pascal. Uno, nessuno e centomila. Quaderni<br />
di Serafino Gubbio operatore. Novelle per un anno. Il teatro: dal<br />
Naturalismo ai drammi “grotteschi”, il passaggio al “teatro nel teatro”.<br />
TESTI<br />
L’umorismo, parte II, passo tratto dal capitolo V<br />
Il fu Mattia Pascal, Premessa e Premessa seconda (filosofica) a mo’ di<br />
scusa; parte <strong>del</strong> capitolo 18<br />
Uno, nessuno e centomila, libro II, parte <strong>del</strong> capitolo XI; libro VIII,<br />
parte <strong>del</strong> capitolo IV<br />
Quaderni di Serafino Gubbio operatore, quaderno III, parte <strong>del</strong><br />
capitolo IV<br />
Il treno ha fischiato<br />
La patente<br />
La carriola<br />
Ciaula scopre la luna<br />
14-ITALO SVEVO<br />
DISCRETO<br />
5<br />
Biografia e poetica. La figura <strong>del</strong>l’inetto. Una vita. Senilità. La coscienza<br />
di Zeno.<br />
DISCRETO 5<br />
TESTI<br />
13
La coscienza di Zeno, parte <strong>del</strong> capitolo I (Il fumo), <strong>del</strong> capitolo IV (La<br />
morte di mio padre), <strong>del</strong> capitolo VI (La moglie e l’amante), <strong>del</strong> capitolo<br />
VIII (Psico-analisi).<br />
<strong>15</strong>-GIUSEPPE UNGARETTI<br />
Biografia e poetica. L’esordio poetico. L’Allegria. Sentimento <strong>del</strong><br />
tempo. L’ultima stagione. Ungaretti maestro di modernità.<br />
TESTI<br />
Eterno<br />
Il porto sepolto<br />
Commiato<br />
Veglia<br />
Sono una creatura<br />
I fiumi<br />
Soldati<br />
Fratelli<br />
San Martino <strong>del</strong> Carso<br />
Non gridate più<br />
DISCRETO 4<br />
16-EUGENIO MONTALE<br />
Biografia e poetica. Ossi di seppia. Le occasioni. La bufera e altro.<br />
TESTI<br />
I limoni<br />
Non chiederci la parola<br />
Meriggiare pallido e assorto<br />
Spesso il male di vivere ho incontrato<br />
Cigola la carrucola <strong>del</strong> pozzo<br />
Forse un mattino andando<br />
Non recidere, forbice<br />
La casa dei doganieri<br />
L’anguilla<br />
SUFFICIENTE 3<br />
17-UMBERTO SABA<br />
Biografia e poetica. La linea “antinovecentista”. Il Canzoniere: gli<br />
elementi peculiari <strong>del</strong>l’identità poetica; l’originalità <strong>del</strong>la vena lirica;<br />
struttura e cronistoria; stile e ideologia.<br />
TESTI<br />
A mia moglie<br />
La capra<br />
Trieste<br />
Amai<br />
Quando nacqui mia madre ne piangeva<br />
Mio padre è stato per me “l’assassino”<br />
Ritratto <strong>del</strong>la mia bambina<br />
SUFFICIENTE 2<br />
18-DANTE ALIGHIERI, DIVINA COMMEDIA, PARADISO<br />
Caratteri generali <strong>del</strong> Paradiso.<br />
TESTI<br />
DISCRETO 22<br />
Canti I, VI, XI, XVII, XXIII, XXXI, XXXIII<br />
14
METODI UTILIZZATI<br />
E’ stato usato prevalentemente il metodo frontale.<br />
MEZZI<br />
Sono stati utilizzati i libri di testo in adozione:<br />
- Anselmi-Fenocchio, Tempi e immagini <strong>del</strong>la letteratura , vol.3b-4-5-6, B.Mondadori<br />
-Divina Commedia, Paradiso, in varie edizioni.<br />
Alcuni alunni hanno usato altre antologie in alternativa a quella in adozione.<br />
Testi non antologizzati o letture di approfondimento sono stati forniti in fotocopia.<br />
E’ stata creata una cartella condivisa su Dropbox in cui sono stati inseriti materiali multimediali (presentazioni in<br />
Powerpoint, articoli di riviste specializzate, video, etc.) suddivisi per singoli autori e per percorsi tematici, volti<br />
all’approfondimento individuale e alla preparazione <strong>del</strong>la prima prova <strong>del</strong>l’esame di Stato e <strong>del</strong>la tesina.<br />
SPAZI E TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO<br />
Si è utilizzata l’aula ordinaria.<br />
I tempi di sviluppo previsti dai programmi ministeriali sono di 4 ore settimanali (132 annuali).<br />
Al <strong>15</strong> maggio sono state effettuate 122 ore di lezione, di cui 10 dedicate al recupero curricolare e all’esercitazione<br />
scritta in preparazione alla prima prova e 10 ad altre attività (conferenze, assemblee d’Istituto,…). Le ore restanti fino<br />
alla fine <strong>del</strong>l’anno saranno destinate alla conclusione <strong>del</strong>le verifiche scritte e orali e ad eventuali esercitazioni scritte.<br />
CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI<br />
La valutazione è stata espressa in decimi e anche in quindicesimi per le verifiche scritte <strong>del</strong> pentamestre, ed è stata<br />
formulata in base ai criteri adottati dal Consiglio di Classe ed in riferimento a quanto indicato nel P.O.F. <strong>del</strong>l’Istituto, al<br />
quale si rimanda.<br />
STRUMENTI DI VALUTAZIONE ADOTTATI<br />
Le verifiche sono state così distribuite: due scritte, una scritta valida per l’orale e una orale nel trimestre; tre scritte, una<br />
scritta valida per l’orale e due orali nel pentamestre. Le verifiche <strong>del</strong> pentamestre sono, allo stato attuale, in fase di<br />
completamento (mancano la terza prova scritta e la seconda orale).<br />
Le prove scritte hanno ricalcato tutte le tipologie <strong>del</strong>l’esame di Stato.<br />
Per la valutazione <strong>del</strong>le prove scritte sono state utilizzate le griglie d’istituto, quindi sono stati valutati la padronanza<br />
linguistica, la rielaborazione originale e critica, l’ampiezza e la pertinenza <strong>del</strong>la conoscenza dei contenuti informativi,<br />
l’organizzazione <strong>del</strong> discorso e altri aspetti specificati nelle griglie allegate al presente documento.<br />
Le prove orali sono state costituite dal colloquio tradizionale di ampia durata e sono state valutate in base alla<br />
conoscenza dei contenuti, alla correttezza linguistica, alla capacità di effettuare collegamenti, alla rielaborazione critica<br />
e personale.<br />
SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA E OBIETTIVI RAGGIUNTI<br />
Lo svolgimento <strong>del</strong> programma è stato condizionato dal fatto che la docente è stata assegnata alla classe nell’anno<br />
scolastico in corso, pertanto la fase iniziale di conoscenza e reciproco adattamento ha allungato i tempi di trattazione dei<br />
primi argomenti, a discapito <strong>del</strong>la parte finale <strong>del</strong> programma, di cui non è stata svolta l’unità didattica relativa alla<br />
narrativa neorealista. Gli argomenti sono stati presentati per monografie, con un’introduzione generale <strong>del</strong>l’autore e un<br />
esame approfondito dei testi centrali dai quali ridiscutere criticamente gli aspetti teorici.<br />
<strong>15</strong>
La classe si è dimostrata sempre corretta e in generale disponibile al dialogo educativo, anche se di fatto vari alunni, pur<br />
comprendendo il valore formativo <strong>del</strong>la disciplina ed essendo capaci di rielaborare personalmente gli argomenti trattati,<br />
hanno manifestato una partecipazione poco attiva durante le spiegazioni o di fronte agli stimoli offerti dall’insegnante.<br />
Quanto agli obiettivi raggiunti, nello scritto gli studenti scrivono mediamente con correttezza linguistica denotando<br />
contenuti pertinenti, con punte di notevole approfondimento e vivacità critica, soprattutto nella tipologia <strong>del</strong>l’analisi<br />
testuale, di gran lunga preferita alle altre tipologie. Infatti solo pochi alunni si sono cimentati nel saggio breve e nel<br />
tema di argomento storico, nessuno nel tema di argomento generale. Nel trimestre sono stati assegnati saggi brevi come<br />
esercitazione per casa, ma pochi studenti sono stati costanti nella produzione dei testi, corretti singolarmente dalla<br />
docente.<br />
Nell’orale, tutti gli studenti, in modo differenziato per abilità e competenza, sono in grado di affrontare un dialogo<br />
culturale con esattezza di contenuti, proprietà di linguaggio e rielaborazione critica.<br />
In linea di massima si possono individuare le seguenti fasce di livello: alcuni alunni, con forte e costante impegno,<br />
attraverso un’approfondita e sicura conoscenza dei contenuti disciplinari, hanno raggiunto un’ottima competenza<br />
espositiva ed espressiva sia nella forma scritta che orale, sviluppando di pari passo un’acuta e notevole capacità critica;<br />
una parte <strong>del</strong>la classe, attraverso una buona conoscenza dei contenuti disciplinari, ha raggiunto una altrettanto buona<br />
competenza espositiva ed espressiva sia nella forma scritta che nella forma orale, con adeguata capacità critica; un’altra<br />
parte ha raggiunto, attraverso una conoscenza abbastanza sicura dei contenuti, discrete competenze e capacità sia nello<br />
scritto che nell’orale; pochi alunni hanno raggiunto una sufficiente competenza espositiva ed espressiva sia nella forma<br />
scritta che nella forma orale.<br />
Data <strong>15</strong> <strong>Maggio</strong> 2013 Firma <strong>del</strong> docente<br />
____________________________________<br />
VISTO per adesione i rappresentanti di classe<br />
_________________________________<br />
_________________________________<br />
16
1<br />
Tempi annuali previsti per la disciplina: 99 h<br />
Tempi annuali effettivamente utilizzati = 96 h<br />
(fino al <strong>15</strong>/05/2013)<br />
GRECO<br />
Percorso formativo disciplinare<br />
Docente: Prof.ssa Ines Amadio<br />
Libri di testo adottati: Rossi, Gallici, Vallarino, 'Ελληνικά,<br />
Paravia.<br />
Κατά λόγον/Versioni greche, Paravia<br />
Euripide, Baccanti, a cura di<br />
Lisia, Per l’invalido, a cura di L. Suardi, Principato<br />
CONTENUTI DISCIPLINARI SVILUPPATI<br />
(suddivisi per moduli o unità didattiche)<br />
LIVELLO DI<br />
APPROFONDIMENT<br />
O DEGLI ALUNNI<br />
(Ottimo – Buono – Discreto –<br />
Sufficiente)<br />
TEMPI IN<br />
ORE<br />
EVENTUALI<br />
NOTE<br />
AGGIUNTIVE<br />
1) Il genere oratorio fra V e IV secolo a.C.<br />
Lisia e il corpus lisiaco. L’oratoria giudiziaria tra il V e il IV a.C.<br />
-origine, forme e funzioni <strong>del</strong>l’oratoria giudiziaria<br />
-vita e opere di Lisia<br />
-Lisia oratore, il Corpus Lysiacum<br />
-lo stile<br />
Letture in italiano:<br />
“Contro Eratostene, che era stato uno dei Trenta” (1-2; 4-7)<br />
“ Per l’uccisione di Eratostene” alcuni passi in greco e in traduzione<br />
Isocrate. L’organizzazione <strong>del</strong>l’insegnamento retorico<br />
-politica e retorica<br />
-l’eloquenza come pratica didattica<br />
-vita e opere di Isocrate<br />
-la ί di Isocrate<br />
-l’oratoria epidittica<br />
-lo stile e la scrittura<br />
Lettura di alcuni passi <strong>del</strong> “Panegirico” (1-5; 28-31; 43-91)<br />
“Contro i Sofisti” (1-10)<br />
Demostene e l’oratoria <strong>del</strong> IV sec.<br />
-vita e opere: Sulle simmorie<br />
Per la libertà dei Rodii<br />
La Prima Filippica<br />
Le Olintiache<br />
La Terza Filippica<br />
Sulla corona<br />
-l’oratoria politica<br />
-la posizione politica<br />
Letture in italiano:<br />
“Filippica I” (2-10)<br />
“Filippica III” (21-33)<br />
“Per la corona” (60-69; 169-173; 192-194; 206-209)*<br />
Ottimo<br />
20<br />
Il teatro<br />
Menandro e la commedia nuova<br />
-vita e opere:<br />
Misantropo (lettura integrale in italiano)<br />
L’arbitrato<br />
La donna tosata<br />
Buono 14<br />
17
Samia<br />
Aspis<br />
-Caratteristiche <strong>del</strong> teatro di Menandro<br />
Letture in italiano:<br />
“Padre e Figlio”(Samia, 324-356)<br />
“Una legge ingiusta”(Scudo, 250-298)<br />
L’ Ellenismo<br />
Da Alessandro Magno ai regni ellenistici<br />
Letteratura alessandrina: filologia ed erudizione letteraria:<br />
-l’origine <strong>del</strong>la filologia alessandrina<br />
-il Museo e la Biblioteca<br />
-la codificazione dei generi letterari<br />
-la diffusione <strong>del</strong> libro<br />
Callimaco<br />
-una poetica innovativa<br />
-cenni biografici e opere<br />
-la poetica <strong>del</strong>la brevitas e le polemiche letterarie:<br />
-gli Inni<br />
-gli Aitia<br />
-i Giambi<br />
-l’Ecale<br />
Lettura in italiano dei seguenti passi:<br />
“Per una poesia d’élite” (fr.28 Pf.)<br />
“Al diavolo gli invidiosi” (Aitia, I, fr.1 Pf., 1-38)<br />
“ La chioma di Berenice”(Aitia, IV, fr.110 Pf., 1-90)<br />
“Per i lavacri di Pallade”(Inni, V)<br />
“Ulivo e alloro a confronto: una contesa allegorica”(Giambi, IV)<br />
La riscoperta <strong>del</strong>l’ epigramma<br />
L’Evoluzione <strong>del</strong> genere; excursus storico letterario <strong>del</strong>l’epigramma<br />
dalle origini all’età ellenistica con riferimento all’epigramma latino.<br />
L’Anthologia Palatina.<br />
Letture svolte:<br />
epigrammi scelti<br />
AP 7.317, 7.318, 6.293.<br />
In Epicarpo fr.132 K-A(Ath.6.235f-236a)<br />
8G-P(Ath.8.344F)<br />
9G-P(Ath.8.345a)<br />
Posidippo di Pella<br />
Ottimo 20<br />
Teocrito e la poesia bucolica:<br />
-l’invenzione <strong>del</strong>la poesia bucolica<br />
-vita e opere<br />
-gli idilli bucolici: Idillio I (Tirsi)<br />
Idillio VII (Le Talisie)<br />
Idillio XI (Il Ciclope)<br />
Idillio XIII (Ila)<br />
-i mimi urbani: Idillio II (L’incantatrice)<br />
-gli epilli<br />
-la poetica<br />
-la lingua e il metro<br />
Letture in italiano:<br />
“Festa per la mietitura e canti bucolici”(Idilli, VII, 10-51)<br />
“Intreccio di canti”(Idilli, I)<br />
“Amore e magia” (Idilli, II)<br />
18
“Il ciclope innamorato” (Idilli, XI)<br />
“Il mito in forma di epillio: Eracle e Ila” (Idilli XIII)<br />
L’epica. Apollonio Rodio:<br />
-il genere epico in età ellenistica<br />
-un’epica rinnovata: Apollonio Rodio<br />
-cenni biografici e opere<br />
-argomento <strong>del</strong>le Argonautiche<br />
-Apollonio Rodio e il rapporto con la Poetica di Aristotele<br />
-tradizione e innovazione nelle Argonautiche<br />
-storicizzazione <strong>del</strong> mito<br />
-struttura <strong>del</strong>la narrazione<br />
-innovazione <strong>del</strong>la figura <strong>del</strong>l’ eroe: Giasone e Medea<br />
-i temi <strong>del</strong>le Argonautiche<br />
-lingua e stile<br />
Lettura svolta:<br />
“Nel segno di Apollo: la poesia, profezia, il viaggio” (I, 1-22)<br />
“la partenza <strong>del</strong>la nave di Argo” (I, 519-558)<br />
“Il manto di Giasone” (I, 721-768)<br />
“Innamoramento” (III, 442-471)<br />
“La notte di Medea”(III,744-824)<br />
La storiografia<br />
Le tendenze <strong>del</strong>la storiografia ellenistica<br />
Polibio: vita, opere.<br />
-Confronto con Tucidide<br />
-Una concezione pragmatica <strong>del</strong>la storiografia<br />
-La concezione politica<br />
Lettura dei seguenti passi:<br />
“La costituzione romana” (VI, 11, 11-13; 12-14)<br />
“Historia magistra vitae” (I, 35)<br />
Buono 12<br />
MODULO VI: Età imperiale<br />
La retorica <strong>del</strong> V secolo aC<br />
La Seconda Sofistica e<br />
Luciano di Samosata<br />
-vita, opere, lingua e stile<br />
Lettura dei seguenti passi in italiano:<br />
“Le avventure <strong>del</strong>la storia vera” ( la storia vera )<br />
“Come si scrive la storia”,1 -2<br />
“Dialoghi dei morti” Caronte e Menippo<br />
“La morte di Peregrino” (1-6)<br />
Discreto<br />
Plutarco :<br />
-vita e opere<br />
-le Vite Parallele<br />
-<br />
-lingua e stile<br />
8<br />
Letture in italiano:<br />
“Storia e biografia” (la Vita di Alessandro)<br />
“Alessandro uccide Clito” (la Vita di Alessandro)<br />
“Il fascino di Cleopatra” (la Vita di Antonio)<br />
Il romanzo<br />
-vicende pastorali di Dafni e Cloe<br />
Letture in italiano:<br />
Longo Sofista, Dafni e Cloe: lettura di alcuni capitoli<br />
“Proemio”*<br />
“La nascita <strong>del</strong>la passione” (I, 13)*<br />
Sufficiente<br />
19
Eliodoro, Storie etiopiche: lettura di<br />
“La cerimonia <strong>del</strong>la negromanzia” (IV, 6, 14-<strong>15</strong>)*<br />
La prospettiva dei generi come categoria letteraria<br />
Lettura, traduzione e analisi di:<br />
Euripide, Baccanti, vv 1-63;170-284:784-846.<br />
Lisia, Per l’invalido<br />
Buono 22<br />
20
LATINO<br />
Percorso Formativo Disciplinare<br />
Docente: Prof.ssa Ines Amadio<br />
Tempi annuali previsti per la disciplina: 132 h<br />
Tempi annuali effettivamente utilizzati = 1<strong>15</strong> h<br />
(fino al <strong>15</strong>/05/2013)<br />
Libri di testo adottati:<br />
G. M. Bettini, Limina, letteratura e antropologia di Roma antica, La<br />
Nuova Italia<br />
H. Orazio, a cura di M.Menghi, B. Mondadori<br />
I. E. Guidi, Certamen, Cappelli Editore<br />
CONTENUTI DISCIPLINARI SVILUPPATI<br />
(suddivisi per moduli o unità didattiche)<br />
LIVELLO DI<br />
APPRENDIMENT<br />
O DEGLI ALUNNI<br />
(Ottimo – Buono –<br />
Discreto – Sufficiente)<br />
TEMPI<br />
IN ORE<br />
EVENTUALI NOTE<br />
AGGIUNTIVE<br />
MODULO I : Storia e storiografia<br />
-Gli eventi: dal principato di Tiberio a quello di Nerone<br />
(14-68 d.C.)<br />
-Le Historiae di Velleio Patercolo<br />
-La storiografia di Tacito:<br />
-cenni biografici e le opere<br />
-Agricola<br />
-Dialogus de oratoribus<br />
-Germania<br />
-Historiae<br />
-Annales<br />
Lettura in traduzione di:<br />
-Solo la libertà alimenta l’eloquenza (Dialogus 36)<br />
-Il principato spegne la virtus (Agricola 1)<br />
-L’esempio di Agricola (Agricola 6)<br />
-Storiografia sotto repubblica e principato (Historiae1,1)<br />
-Il fine <strong>del</strong>la storia (Annales 3, 65)<br />
-I rumores (Annales 4, 10-11)<br />
MODULO II: Seneca e la satira a Roma<br />
-La satira nell’età di Augusto: Orazio<br />
-cenni biografici e le opere<br />
-la poesia “eccessiva”degli Epodi<br />
-la scoperta di un tono medio: le Satire<br />
-le Odi<br />
-lettura, traduzione e analisi di 5 Odi, 2 Epodi, 1 Satira<br />
-La poesia satirica nell’età giulio-claudia: Persio<br />
-cenni biografici e le opere<br />
-il libro <strong>del</strong>le Satire<br />
-Una dichiarazione di poetica<br />
Saturae, V, 1-51<br />
-La satira di Giovenale:<br />
-la vita<br />
-la poetica <strong>del</strong>l’indignatio<br />
-aspetti <strong>del</strong>le Satire di Giovenale<br />
Lettura in traduzione di:<br />
-Pregiudizi razzisti (Saturae III,60-<strong>15</strong>3)<br />
-Ritratti di donne (Saturae VI)*<br />
Buono 19<br />
Buono<br />
24<br />
Seneca:<br />
-la vita e le opere<br />
-filosofia e potere<br />
21
-la scoperta <strong>del</strong>l’interiorità<br />
-filosofia e scienza: le Naturales Quaestiones<br />
-una satira menippea: l’Apokolokyntosis<br />
(lettura integrale in traduzione)<br />
-le tragedie<br />
- Il concetto di natura in Seneca e Shakespeare<br />
Visione <strong>del</strong> film Fellini Satyricon di F:Fellini<br />
Lettura in traduzione di:<br />
-L’uomo è prodigo <strong>del</strong> proprio tempo (De brevitate vitae<br />
3) ;<br />
-De clementia I, 1*<br />
-Il suicidio, atto estremo di libertà (Epist. ad Luc.)<br />
-Elogio di Claudio (Consolatio ad Polybium 12, 3-13, 4)*<br />
-Thyestes 920-1068<br />
MODULO III: la poesia epica<br />
-Lucano:<br />
-la vita e le opere<br />
-la Pharsalia:<br />
-struttura <strong>del</strong> poema e rapporto con i mo<strong>del</strong>li <strong>del</strong>la<br />
tradizione epica<br />
-“il poema senza eroi”<br />
-la visione <strong>del</strong> mondo<br />
Lettura in traduzione di:<br />
-Proemio e lodi di Nerone (Pharsalia, I, 1-66)<br />
-La scena <strong>del</strong>la negromanzia (Pharsalia, VI, 624-725)<br />
-Il passaggio <strong>del</strong> Rubicone(Pharsalia)*<br />
-L’ uccisione di Pompeo (Pharsalia)*<br />
-Che cos’è il saggio (Pharsalia)*<br />
-L’incantesimo di Eritto (Pharsalia)*<br />
-La poesia epica nell’età dei Flavi:<br />
-le Argonautiche di Valerio Flacco<br />
-confronto con le Argonautiche di Apollonio Rodio<br />
Ottimo<br />
Buono<br />
Discreto<br />
14<br />
MODULO IV: L’oratoria e la retorica a Roma<br />
-La decadenza <strong>del</strong>l’oratoria nel mondo romano:<br />
motivazioni politiche e culturali nel Dialogus de<br />
oratoribus di Tacito, nel Satyricon di Petronio e nelle<br />
opere di Velleio Patercolo e Quintiliano.<br />
-Il retore: identità e obiettivi di una professione nelle<br />
opere Quintiliano<br />
-cenni biografici e le opere<br />
-L’Istitutio oratoria<br />
-l’interesse pedagogico<br />
-Sguardo antropologico: Andare a scuola a Roma<br />
Lettura in traduzione di:<br />
-L’apprendimento come gioco (Insitutio Oratoria I, 1, 20)<br />
-I vantaggi <strong>del</strong>l’apprendimento collettivo (Institutio<br />
Oratoria I, 2)<br />
MODULO V: Il romanzo latino<br />
-Il Satyricon di Petronio<br />
-la questione petroniana<br />
-il Satyricon<br />
-il problema <strong>del</strong> genere e dei mo<strong>del</strong>li<br />
-struttura <strong>del</strong> romanzo e strategie narrative<br />
-realismo mimetico ed effetti di pluristilismo<br />
Letture in italiano:<br />
- lettura integrale <strong>del</strong> Satyricon<br />
-Apuleio<br />
-cenni biografici e opere<br />
Ottimo<br />
Discreto<br />
Buono 10<br />
17<br />
4<br />
22
-eloquenza e filosofia<br />
-Le Metamorfosi<br />
Lettura di “Lo sposo misterioso” (V, 21,5-23)<br />
Lettura <strong>del</strong>la novella “Amore e Psiche”<br />
MODULO VI: Società e cultura nell’età dei<br />
Flavi e di Traiano<br />
-Gli avvenimenti<br />
-Principi e cultura<br />
-Marziale e la poesia epigrammatica<br />
-origini e sviluppo<br />
-la poetica<br />
-aspetti <strong>del</strong>la poetica<br />
-la tecnica e lo stile<br />
-lettura di vari epigrammi sul libro di testo e su fotocopia<br />
Lettura, traduzione e analisi di:<br />
Seneca, De Providentia, II, 1-12;<br />
confronto con passi di Lucano e Cassio Dione in<br />
traduzione<br />
Epistulae morales ad Lucilium:Epistula 8, 70; 4-6; 14-<strong>15</strong><br />
Con traduzione in Inglese<br />
Epistula 47, 1-12<br />
Tacito, Agricola, I; XXX; Cfr. con XLII<br />
Germania, IV<br />
Historiae libro XV, cap.LXII, 1-2; cap.LXIII-LXIV<br />
Orazio, Epodi III e VII<br />
Satira I, 9<br />
Odi I, 4; I, 9; I, 11; III, 30<br />
Discreto 7<br />
Buono 20<br />
STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE ADOTTATI<br />
Nell’ottica <strong>del</strong>la impostazione didattica utilizzata, gli strumenti di valutazione sono stati di tipo<br />
diagnostico e formativo-sommativo, per accertare il raggiungimento degli obiettivi specifici e per<br />
provvedere eventualmente ad un recupero. Come indicato dal Collegio dei Docenti, tali prove sono state<br />
di varie tipologie comprendendo quindi, oltre alla tradizionale versione dal Greco e alle verifiche orali<br />
di letteratura ed autori, prove miste (traduzione più domande su elementi morfo-sintattici o stilistici); in<br />
particolare, nel corso <strong>del</strong> triennio, sono stati somministrati agli alunni tests di comprensione e<br />
conoscenza con risposte aperte e/o chiuse o la trattazione sintetica di argomenti secondo quanto<br />
configurato nella tipologia <strong>del</strong>la terza prova <strong>del</strong>l’Esame di Stato.<br />
Ci si è serviti, inoltre, di schede di valutazione di cui si allega una copia alla presente relazione. La<br />
tassonomia guida ha presentato la seguente serie di indicatori:<br />
M) Padronanza <strong>del</strong>la lingua e proprietà di linguaggio disciplinare<br />
N) Conoscenza specifica degli argomenti richiesti<br />
O) Capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e di collegarle anche in forma<br />
pluridisciplinare<br />
P) Capacità di discussione e approfondimento dei diversi argomenti<br />
Q) Originalità e creatività<br />
Naturalmente, a seconda <strong>del</strong> tipo di prova oggetto di verifica, sono stati considerati alcuni o<br />
tutti gli indicatori elencati.<br />
Sono stati inoltre distinti momenti di misurazione (attribuzione di punteggi predefiniti a determinate<br />
prestazioni) da momenti di valutazione.<br />
METODI E MEZZI UTILIZZATI:<br />
La peculiarità <strong>del</strong>lo studio linguistico–letterario è stata evidenziata anche da collegamenti<br />
interdisciplinari tra Greco e Latino e, quando possibile, con le lingue moderne studiate nell’Istituto e<br />
23
con le discipline umanistiche in genere. Lo studio <strong>del</strong>la storia letteraria ha seguito uno sviluppo<br />
parzialmente diacronico, ma è stato anche proposto, in alcuni casi, un approccio di tipo sincronico,<br />
attraverso l’individuazione di alcuni generi letterari (Epica, Storiografia e Retorica) e nodi concettuali<br />
che attraversano le letterature europee e che costituiscono un repertorio cui hanno attinto scrittori di tutti<br />
i tempi e italiani in primo luogo.<br />
La presentazione <strong>del</strong> periodo storico-culturale in cui i vari autori hanno operato si è orientata verso<br />
quegli aspetti di natura storico-sociale e filosofica funzionali a meglio ricostruire l’identità degli autori<br />
stessi e dei generi letterari di riferimento, in tale ottica sono anche stati scelti i materiali antologici,<br />
utilizzati come mezzo privilegiato per illustrare le tematiche principali degli autori di volta in volta<br />
studiati. Attraverso la contestualizzazione, la comprensione, l’analisi e l’interpretazione <strong>del</strong> fatto<br />
letterario, in cui la competenza linguistica non è fine ma strumento di analisi, si è cercato di<br />
promuovere la capacità degli alunni di porsi di fronte al testo letterario in modo personale e critico. Per<br />
questo è maturato il ricorso a metodi come la Linguistica e l’Antropologia e a strumenti diversi e<br />
complementari ai libri di testo: saggi critici, lettura integrale o parziale di testi in traduzione, traduzioni,<br />
siti di interesse specifico, affiancati dall’uso, peraltro molto sporadico, di audiovisivi e di apporti<br />
offerti dalle nuove tecnologie, in considerazione anche <strong>del</strong> fatto che la classe ha seguito un corso<br />
sperimentale di informatica (P.N.I.).<br />
Quando possibile, nello studio dei testi letterari, gli allievi sono stati invitati ad applicare la pratica<br />
<strong>del</strong>l’analisi testuale con gli stessi strumenti teorici e le stesse tecniche utilizzate per i testi in lingua<br />
italiana: il commento al testo tradotto, in questo modo, è diventato attività elaborativa, senza peraltro<br />
scadere nella mera ricognizione <strong>del</strong>le scelte formali.<br />
Le lezioni sono state costituite da metodi operativi diversi: lezioni frontali, discussioni in classe,<br />
elaborati, esercitazioni o schematizzazioni per favorire procedimenti logici non solamente sequenziali,<br />
ma piuttosto basati su un sistema di relazioni e connessioni dinamico e originale.<br />
MEZZI/STRUMENTI:<br />
Dizionario – libri - lavagna -computer<br />
SPAZI:<br />
Aula ordinaria e aula multimediale<br />
OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI<br />
La classe in oggetto può essere divisa idealmente in due gruppi.<br />
5) Un primo gruppo, composto da parecchi elementi, dimostra buone o ottime competenze<br />
esegetico-traduttive; conosce i contenuti in modo organico ed articolato, sa stabilire<br />
collegamenti tra i concetti e riesce a sviluppare analisi e sintesi puntuali. La preparazione<br />
globale conseguita, ampia, approfondita e rielaborata a livello personale, si può ritenere più che<br />
buona o addirittura eccellente.<br />
6) Un secondo gruppo dimostra sufficienti, discrete o più che discrete competenze esegeticotraduttive;<br />
conosce gli argomenti <strong>del</strong>la disciplina nei nuclei fondamentali e nelle loro<br />
articolazioni ed è in grado di impostare collegamenti disciplinari . Si esprime con chiarezza e in<br />
modo adeguato. Il livello di preparazione si può ritenere discreto e fra il discreto ed il buono.<br />
Solo pochissimi elementi presentano, ancora, competenze esegetico-traduttive mediocri o quasi<br />
sufficienti, anche se esse sono ampiamente compensate dalla dimensione teorica.<br />
Data <strong>15</strong>/05/2013<br />
Firma <strong>del</strong> docente<br />
_____________________________________<br />
VISTO per adesione i rappresentanti di classe<br />
_____________________________________<br />
_____________________________________<br />
24
MATEMATICA<br />
Percorso Formativo Disciplinare<br />
Docente: Prof.ssa Caterina Marsili<br />
Tempi annuali previsti per la disciplina: 99 h<br />
Tempi annuali effettivamente utilizzati = 77 h<br />
Libro di testo adottato: M. Re Fraschini- G. Grazzi,<br />
Moduli.mat, Analisi 1(tomo C1)- Analisi 2 (tomo C2),<br />
Atlas<br />
CONTENUTI DISCIPLINARI SVILUPPATI<br />
(suddivisi per moduli o unità didattiche)<br />
Nozioni preliminari<br />
<strong>Maggio</strong>ranti e minoranti, massimo e minimo, estremo superiore e inferiore di insiemi<br />
di numeri reali. Intorno di un numero reale. Definizione di punto di accumulazione, di<br />
punto isolato e insieme derivato.<br />
Insiemi limitati e illimitati.<br />
Funzioni<br />
Richiami sul concetto di funzione, dominio, immagine, grafico. Dominio naturale di<br />
una funzione. Funzione monotona: crescente, decrescente. Funzioni composte.<br />
Limite di una funzione:<br />
Introduzione al concetto di limite di una funzione reale di variabile reale. Definizione di<br />
limite di una funzione in un punto. Definizione generale di limite. Definizione di limite<br />
destro e sinistro.<br />
Teoremi fondamentali sui limiti. Operazioni sui limiti.. Forme determinate ed<br />
indeterminate:∞-∞,∞/∞,0/0,0∙∞<br />
Limiti notevoli:<br />
sin x<br />
lim (dimostrato) e altri conseguenti,<br />
x0<br />
x<br />
1<br />
x<br />
<br />
lim 1<br />
<br />
x<br />
x <br />
a<br />
x<br />
1<br />
coseguenti, lim .<br />
x0<br />
x<br />
Infinitesimi e infiniti e confronti.<br />
Funzioni continue<br />
Definizione di funzione continua in un punto, a destra, a sinistra ed in un intervallo.<br />
Punti di discontinuità e loro classificazione. Asintoti verticali, orizzontali, obliqui.<br />
Teoremi sulle funzioni continue (solo enunciati): teorema <strong>del</strong>la permanenza <strong>del</strong> segno,<br />
teorema di esistenza degli zeri, teorema di Weierstrass, teorema dei valori intermedi.<br />
Grafico probabile di funzione.<br />
Successioni numeriche<br />
Definizione . Limiti di successioni. Carattere di successioni. Teoremi e operazioni sui<br />
limiti di successioni. Progressioni aritmetiche e geometriche<br />
Calcolo differenziale<br />
Derivata: definizione di derivata di una funzione in punto e funzione derivata; significato<br />
geometrico <strong>del</strong>la derivata. Retta tangente (e normale) ad una funzione in suo punto.<br />
Relazione tra derivabilità e continuità . Derivata destra e sinistra, punti di non derivabilità<br />
.Calcolo <strong>del</strong>la derivata <strong>del</strong>le funzioni elementari tramite la definizione. Algebra <strong>del</strong>le<br />
derivate. Derivata <strong>del</strong>la funzione composta.<br />
Applicazioni <strong>del</strong> calcolo differenziale<br />
Funzioni monotone e derivabilità. Estremi e stremanti relativi e assoluti per una funzione<br />
(metodo grafico). Teoremi sulle funzioni derivabili: teorema di Rolle (dim.), Lagrange ,<br />
Cauchy, De l'Hopital. Derivate successive di una funzione. Concavità e flessi di una<br />
funzione (metodo grafico). Classificazione dei punti di flesso. Semplici problemi di<br />
massimo e di minimo. Studio di funzioni algebriche e trascendenti.<br />
Calcolo integrale<br />
Integrale indefinito. Primitive e integrale indefinito. Linearità <strong>del</strong>l'operatore integrale<br />
indefinito. Integrali immediati e integrazione per decomposizione. Integrazione di<br />
funzioni composte. Integrazione per sostituzione. Integrazione per parti. Integrazione<br />
<strong>del</strong>le funzioni razionali fratte.<br />
Integrale definito. Il problema <strong>del</strong> calcolo <strong>del</strong>le aree. Definizione di integrale definito<br />
secondo Riemann. Proprietà <strong>del</strong>l'integrale definito. La funzione integrale. Teorema<br />
<strong>del</strong>la media (dimostrato). Teorema fondamentale <strong>del</strong> calcolo integrale. Funzioni<br />
integrabili. I volumi dei solidi di rotazione.<br />
25<br />
e<br />
LIVELLO DI<br />
APPROFONDIMENTO<br />
(Ottimo – Buono – Discreto<br />
– Sufficiente)<br />
TEMPI IN<br />
ORE<br />
Discreto 5<br />
Discreto 3<br />
Discreto 16<br />
Buono 12<br />
Discreto 8<br />
Discreto 10<br />
Buono 10<br />
Discreto 13
OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI:<br />
La maggior parte degli alunni conosce gli argomenti fondamentali ed è in grado di impostare<br />
collegamenti; riesce ad applicare procedure di calcolo non complesse. La preparazione risulta nel<br />
complesso discreta.<br />
Nello specifico, si distinguono alcuni alunni, per aver conseguito una preparazione più che buona:<br />
conoscono i contenuti in maniera organica e articolata, sanno stabilire connessioni, hanno<br />
sviluppato ottime capacità di rielaborazione di procedure apprese per risolvere problemi complessi.<br />
VERIFICHE E VALUTAZIONI<br />
Nel corso <strong>del</strong>l'anno sono state effettuate cinque prove scritte ed almeno quattro prove orali.<br />
I criteri di valutazione hanno fatto riferimento ai seguenti parametri:<br />
- conoscenza specifica degli argomenti trattati;<br />
- uso corretto e proprietà di linguaggio matematico;<br />
- capacità di ragionamento<br />
- uso consapevole ed adeguato dei diversi strumenti operativi;<br />
- interesse, applicazione, impegno per la disciplina<br />
Per quanto riguarda la misurazione e la valutazione degli elaborati scritti, è stata utilizzata la griglia<br />
di valutazione adottata dal collegio docenti.<br />
METODI, MEZZI E STRUMENTI<br />
Le lezioni sono state prevalentemente di tipo frontale cercando di favorire il dialogo disciplinare,<br />
facendo seguire alle spiegazioni teoriche esercizi esplicativi. Non sono state proposte le<br />
dimostrazioni di tutti i teoremi utilizzati, per questioni di tempo e per non frammentare ed<br />
appesantire eccessivamente la trattazione, ma è stata fatta una scelta fra i più importanti e<br />
significativi. Per quanto riguarda la teoria è stato dato risalto alle definizioni e agli enunciati, che<br />
sono stati regolarmente richiesti durante le verifiche orali.<br />
Data <strong>15</strong> <strong>Maggio</strong> 2013 Firma <strong>del</strong> docente<br />
____________________________________<br />
VISTO per adesione i rappresentanti di classe<br />
_________________________________<br />
_________________________________<br />
26
FISICA<br />
PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE<br />
Docente: Prof. Luciano Zazzetti<br />
Tempi annuali previsti per la disciplina: 99 h<br />
Tempi annuali effettivamente utilizzati = 76h<br />
Libro di testo adottato: Le Leggi <strong>del</strong>la Fisica – A.<br />
Caforio, A. Ferilli – Ed. Le Monnier<br />
CONTENUTI DISCIPLINARI SVILUPPATI<br />
(suddivisi per moduli o unità didattiche)<br />
I Fluidi (richiami)<br />
La pressione. Pressione nei fluidi. Il principio di Pascal. La legge di<br />
Stevin. Galleggiamento e principio di Archimede. Fluidi in<br />
movimento: portata ed equazione di continuità. Equazione di<br />
Bernoulli e applicazioni.<br />
La Temperatura:<br />
Equilibrio termico, misura <strong>del</strong>la temperatura, dilatazione termica dei<br />
solidi e dei liquidi, comportamento anomalo <strong>del</strong>l’acqua.<br />
Equilibrio termodinamico, numero e principio di Avogadro, le leggi<br />
dei gas e la temperatura assoluta, equazione di stato dei gas perfetti.<br />
Mo<strong>del</strong>lo molecolare <strong>del</strong> gas perfetto, energia cinetica e temperatura,<br />
distribuzione di Maxwell-Boltzmann.<br />
Calore e cambiamenti di stato:<br />
Il calore e la sua misura, capacità termica e calore specifico. La legge<br />
fondamentale <strong>del</strong>la termologia.<br />
Propagazione <strong>del</strong> calore: conduzione, convezione, irraggiamento. Il<br />
mo<strong>del</strong>lo <strong>del</strong> corpo nero: legge di spostamento di Wien, legge di<br />
Stefan-Boltzmann, dalla 'catastrofe ultravioletta' alla legge di Planck.<br />
Cambiamenti di stato e calori latenti.<br />
I principi <strong>del</strong>la termodinamica:<br />
L’esperimento di Joule e l’equivalente meccanico <strong>del</strong> calore.<br />
Trasformazioni termodinamiche reversibili e irreversibili. Lavoro in<br />
una trasformazione termodinamica. Energia interna di un gas perfetto.<br />
Il primo principio <strong>del</strong>la termodinamica. Applicazioni <strong>del</strong> primo<br />
principio a isobare, isocore, isoterme, adiabatiche e trasformazioni<br />
cicliche.<br />
Macchine termiche e rendimento. Teorema e ciclo di Carnot.<br />
Macchine frigorifere, pompe di calore e coefficiente di prestazione.<br />
Secondo principio <strong>del</strong>la termodinamica: enunciati di Clausius e<br />
Kelvin-Planck, equivalenza dei due enunciati. Definizione di entropia<br />
secondo Clausius. Interpretazione statistica <strong>del</strong> secondo principio,<br />
equazione di Boltzmann.<br />
Carica Elettrica e campo elettrico:<br />
Elettricità statica; la carica elettrica e la sua conservazione, la carica<br />
elettrica nell'atomo, Isolanti e conduttori, la polarizzazione dei<br />
dielettrici, l’induzione elettrostatica e l’elettroscopio.<br />
La legge di Coulomb (nel vuoto ed in un dielettrico)<br />
Il campo elettrico, linee di campo, distribuzione di carica nei<br />
conduttori, flusso di un vettore, teorema di Gauss per il campo<br />
elettrico (dimostrato), circuitazione <strong>del</strong> campo elettrico. Applicazioni<br />
<strong>del</strong> teorema di Gauss. Teorema di Coulomb.<br />
Potenziale Elettrico ed Energia Elettrica; Capacità<br />
LIVELLO DI<br />
APPROFONDIMENTO<br />
Discreto<br />
Discreto<br />
Discreto<br />
Discreto<br />
Discreto<br />
Discreto<br />
27
Potenziale elettrico e differenza di potenziale, relazione tra potenziale<br />
elettrico e campo elettrico, linee equipotenziali, l’elettronvolt,<br />
potenziale elettrico dovuto a cariche puntiformi, potenziale elettrico<br />
nei conduttori. Distribuzione di carica ed andamento <strong>del</strong> campo<br />
elettrico sulla superficie dei conduttori.<br />
Capacità di un conduttore e di un condensatore, condensatori in serie<br />
ed in parallelo, energia immagazzinata in un condensatore.<br />
Moto di una carica in un campo elettrico uniforme. L’esperimento di<br />
Millikan<br />
La corrente elettrica<br />
La corrente continua ed i generatori di tensione<br />
Resistenza elettrica e leggi di Ohm. R Resistività e temperatura:<br />
dipendenza qualitativa dalla temperatura negli isolanti, nei conduttori<br />
e nei superconduttori.<br />
Leggi di Kirchhoff, resistenze in serie ed in parallelo, f.e.m e ddp,<br />
generatori in serie ed in parallelo.<br />
Strumenti di misura: amperometri, voltmetri, ohmetri<br />
Energia e potenza elettrica, effetto Joule<br />
Effetto termoionico, effetto Volta, effetto fotoelettrico.<br />
La corrente nei gas.<br />
Magnetismo<br />
I magneti e i campi magnetici.<br />
Correnti elettriche e campi magnetici (esperienza di Oersted)<br />
Forza su una corrente elettrica in un campo magnetico; definizione di<br />
B<br />
Campo magnetico prodotto da un filo rettilineo (legge di Biot-Savart)<br />
Forza di Lorentz e moto di una carica in un campo magnetico<br />
uniforme. Esperimento di Thomson e spettrografo di massa.<br />
Forza fra due fili paralleli percorsi da corrente e definizione<br />
<strong>del</strong>l’ampère.<br />
Teorema di Gauss per il campo magnetico e teorema <strong>del</strong>la<br />
circuitazione di Ampère.<br />
Momento torcente su una spira percorsa da corrente; momento<br />
magnetico. Il motore elettrico.<br />
Induzione Elettromagnetica<br />
Esperienze di Faraday e le correnti indotte, la legge di Faraday-<br />
Neumann e la legge di Lenz. Generatori di tensione alternata.<br />
Discreto<br />
Discreto<br />
Sufficiente<br />
OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI:<br />
A) Conoscenze: pur con una ovvia gradazione, quasi tutti gli allievi hanno conseguito gli<br />
obiettivi minimi di conoscenza, conoscono concetti e relazioni fondamentali relativamente<br />
alle tematiche trattate.<br />
B) Competenze: la maggioranza degli alunni sa inquadrare situazioni diverse in un medesimo<br />
schema logico ed in modo mediamente soddisfacente; sa generalmente riconoscere analogie e<br />
differenze applicando nei vari contesti le conoscenze acquisite. Riesce a scegliere ed utilizzare<br />
gli strumenti matematici adeguati ed il linguaggio specifico <strong>del</strong>la disciplina.<br />
VERIFICHE E VALUTAZIONI<br />
Nel corso <strong>del</strong>l'anno sono state effettuate sei prove scritte ed almeno due prove orali. Le prove scritte sono state di<br />
diverso tipo:<br />
C) risoluzione di problemi;<br />
D) trattazione sintetica di un argomento (sul mo<strong>del</strong>lo dei quesiti <strong>del</strong>la terza prova);<br />
28
E) combinazione <strong>del</strong>le tipologie precedenti.<br />
La valutazione di ogni singola prova orale e stata effettuata sulla base dei seguenti elementi:<br />
F) livello di partenza;<br />
G) livello di conoscenza degli argomenti trattati;<br />
H) livello di comprensione ed interpretazione e rielaborazione <strong>del</strong>le conoscenze acquisite;<br />
I) abilita nell'applicazione <strong>del</strong>le leggi fisiche;<br />
J) capacita di approfondimento e di collegamento con informazioni preacquisite;<br />
K) capacita espositive (scioltezza, precisione concettuale e terminologica).<br />
In particolare e stata attribuita la sufficienza a quegli studenti che, esprimendosi con un linguaggio semplice, ma<br />
sostanzialmente corretto, hanno dimostrato di conoscere i concetti fondamentali, di averne colto il significato e di essere<br />
in grado di applicarli alle più semplici situazioni problematiche. La scala di valutazione utilizzata e stata quella decimale:<br />
i diversi livelli di rendimento raggiunti dagli studenti sono stati quantificati attraverso voti e frazioni di voto<br />
compresi tra 1 e 10 sulla base <strong>del</strong>la griglia adottata dal collegio docenti.<br />
In sede di valutazione di fine periodo ("trimestre"/pentamestre) sono stati presi in considerazione anche l'impegno, la<br />
serieta e la costanza nello studio, la partecipazione durante le ore di lezione, l'interesse dimostrato per la materia,<br />
l'acquisizione <strong>del</strong>la capacita critica.<br />
METODI, MEZZI E STRUMENTI<br />
Durante le lezioni, che sono state prevalentemente di tipo frontale, si e evidenziato costantemente lo stretto legame che<br />
sussiste fra l'aspetto teorico e l'aspetto sperimentale <strong>del</strong>la disciplina; ci sono stati momenti di ripasso, di presentazione<br />
dei contenuti in un'ottica complessiva e sono stati risolto alcuni esercizi per consolidare la comprensione di alcuni<br />
argomenti e le competenze applicative.<br />
Sono state effettuate poche esperienze di laboratorio ritenute essenziali e l'attività di laboratorio e stata esclusivamente<br />
di tipo qualitativo.<br />
Gli strumenti matematici piu raffinati e precisi utili in fisica (derivate e integrali) sono stati introdotti nella trattazione<br />
degli argomenti dal momento in cui erano disponibili e alcuni argomenti già trattati sono stati rivisti alla luce dei nuovi<br />
strumenti, ma, considerato che il testo non usa in modo sistematico il calcolo differenziale nello sviluppare gli<br />
argomenti, durante le verifiche non sono state pretese trattazioni rigorose sotto il profilo matematico.<br />
Il laboratorio di fisica, poco fruibile per vari motivi, e stato sostituito talvolta dal laboratorio di informatica: internet e<br />
ricca di applicazioni, sviluppate da ricercatori universitari che consentono di "visualizzare" fenomeni che sono difficili o<br />
impossibili da riprodurre in un laboratorio scolastico.<br />
Il libro di testo ufficiale è stato talvolta affiancato da materiale reperibile in rete.<br />
Data <strong>15</strong> <strong>Maggio</strong> 2013 Firma <strong>del</strong> docente<br />
_____________________________________<br />
I rappresentanti di classe<br />
______________________________<br />
______________________________<br />
29
PREMESSA<br />
SCIENZE<br />
Percorso Formativo Disciplinare<br />
Docente: Prof.ssa Marida Castelletti<br />
Per ciò che concerne il programma realmente svolto, si fa presente quanto segue: rispetto alla programmazione iniziale,<br />
i programmi risultano snelliti e gli ultimi argomenti sono stati trattati con un livello di approfondimento solo sufficiente<br />
per mancanza effettiva di tempo, dovuta alle già esigue due ore settimanali e al fatto che alcune di esse sono state<br />
utilizzate per diverse attività didattiche parascolastiche (viaggi di istruzione, spettacoli teatrali etc.), altre per varie<br />
iniziative studentesche (assemblee, cento giorni all’esame, progetti etc. ), altre infine hanno coinciso con le festività .<br />
Tempi annuali previsti per la<br />
disciplina: 66 h<br />
Tempi annuali effettivamente utilizzati<br />
=55 h di cui di cui circa n° 18 sono<br />
state utilizzate per le verifiche, n°04<br />
per la proiezione di video. Le ore che<br />
restano dal <strong>15</strong> <strong>Maggio</strong> 2013 al 8<br />
Giugno 2013 verranno utilizzate per<br />
ulteriori verifiche e approfondimenti.<br />
Libro di testo adottato: Cristina Pignocchino Feyles-<br />
Ivo Neviani GEOGRAFIA GENERALE La Terra e<br />
L’Universo. SEI. Quarta edizione<br />
CONTENUTI DISCIPLINARI SVILUPPATI<br />
(suddivisi per moduli o unità didattiche)<br />
2) L’UNIVERSO<br />
OBIETTIVI: Conoscere le definizioni saper rappresentare<br />
graficamente i sistemi di riferimento equatoriale ed<br />
orizzontale - saper descrivere le caratteristiche <strong>del</strong>le stelle e<br />
la loro evoluzione - saper esporre le varie teorie sull’origine<br />
<strong>del</strong>l’universo, sistema solare, luna.<br />
LA SFERA CELESTE: le costellazioni; sistemi di<br />
riferimento equatoriale e azimutale; coordinate equatoriali;<br />
coordinate orizzontali o azimutali; i movimenti apparenti<br />
degli astri sulla sfera celeste; I movimenti giornalieri <strong>del</strong>le<br />
stelle a latitudini diverse.<br />
LE STELLE: determinazione <strong>del</strong>la distanza di una stella con<br />
il metodo <strong>del</strong>la parallasse; parallasse annua e diurna; unità di<br />
misura astronomiche; la luminosità <strong>del</strong>le stelle e la<br />
magnitudine; la spettroscopia; gli spettri dei corpi celesti; le<br />
leggi <strong>del</strong> corpo nero; l’analisi spettrale <strong>del</strong>la luce <strong>del</strong>le stelle;<br />
l’effetto Doppler e gli spettri <strong>del</strong>le stelle; diagramma H.R.<br />
nascita, vita e morte <strong>del</strong>le stelle;la fusione nucleare nelle<br />
stelle.<br />
LE GALASSIE: genesi; strutture; classificazione; la nostra<br />
galassia; il red shift espansione <strong>del</strong>l’universo.<br />
LIVELLO di<br />
APPROFONDIMENTO<br />
(Ottimo – Buono –<br />
Discreto – Sufficiente)<br />
TEMPI<br />
IN<br />
ORE<br />
Buono 3<br />
Ottimo 5<br />
Buono 1<br />
30
IPOTESI SULLA GENESI DELL’UNIVERSO: la legge di<br />
Hubble e l’espansione <strong>del</strong>l’universo l’universo stazionario;<br />
l’universo inflazionario; l’origine <strong>del</strong>l’universo secondo la<br />
teoria <strong>del</strong> big bang; le possibili evoluzioni <strong>del</strong>l’universo.<br />
3) IL SISTEMA SOLARE<br />
OBIETTIVI: conoscere e saper descrivere le varie forme di<br />
attività solare – conoscere, comprendere ed interpretare le<br />
leggi fisiche che determinano le strutture <strong>del</strong>l’universo.<br />
IL SOLE: struttura; composizione; l’attività <strong>del</strong> sole; origine<br />
<strong>del</strong> sistema solare.<br />
LEGGI: leggi di Keplero; legge di gravitazione universale.<br />
4) LA TERRA<br />
OBIETTIVI : conoscere e saper rappresentare graficamente<br />
il sistema di riferimento terrestre – saper trovare e<br />
rappresentare graficamente la latitudine e la longitudine di un<br />
punto sulla superficie terrestre. descrivere ed interpretare le<br />
prove a sostegno <strong>del</strong>la sfericità <strong>del</strong>la terra, le prove e le<br />
conseguenze <strong>del</strong>la rotazione e <strong>del</strong>la rivoluzione terrestre –<br />
saper distinguere le condizioni di illuminazione degli<br />
emisferi nei diversi periodi <strong>del</strong>l’anno – saper descrivere ed<br />
interpretare il moto doppio conico <strong>del</strong>l’asse terrestre .<br />
LA TERRA: l’interno <strong>del</strong>la terra, forma e dimensione;<br />
Eratostene e la determinazione <strong>del</strong>la circonferenza meridiana<br />
terrestre; reticolato geografico; latitudine e longitudine; prove<br />
e conseguenze <strong>del</strong> moto di rotazione, <strong>del</strong> moto di rivoluzione,<br />
dei moti millenari; le stagioni astronomiche; le zone<br />
astronomiche; due diverse durate <strong>del</strong> giorno e <strong>del</strong>l’anno.<br />
5) LA LUNA<br />
OBIETTIVI: conoscere e saper descrivere la struttura <strong>del</strong>la<br />
luna – saper descrivere ed interpretare i movimenti lunari, le<br />
fasi, le eclissi .<br />
LA LUNA: caratteri generali; i movimenti; mese sidereo e<br />
sinodico; le fasi; le eclissi; origine ed evoluzione<br />
6) LE ROCCE<br />
OBIETTIVI:saper descrivere le caratteristiche e la genesi<br />
<strong>del</strong>le rocce ignee, sedimentarie, metamorfiche – saper<br />
descrivere il ciclo litogenetico .<br />
LE ROCCE: genesi e classificazione <strong>del</strong>le rocce ignee,<br />
sedimentarie, metamorfiche; ciclo litogenetico. Cap. 12: il<br />
processo magmatico, la struttura <strong>del</strong>le rocce magmatiche, la<br />
composizione <strong>del</strong>le rocce magmatiche. Cap.13: il processo<br />
sedimentario; la classificazione <strong>del</strong>le rocce sedimentarie di<br />
tipo clastico, chimico,organogeno, i carboni; il processo<br />
metamorfico, il ciclo <strong>del</strong>le rocce.<br />
Buono 2<br />
Buono 2<br />
Ottimo 1<br />
Ottimo 7<br />
Buono 3<br />
Sufficiente 5<br />
31
7) LA DINAMICA DELLA LITOSFERA<br />
OBIETTIVI: saper descrivere il meccanismo di espansione<br />
dei fondi oceanici – saper descrivere i processi orogenetici –<br />
saper identificare il “ motore “ <strong>del</strong>la dinamica <strong>del</strong>la litosfera<br />
– saper correlare dinamica <strong>del</strong>la litosfera, sismi e<br />
vulcanesimo – saper esporre la teoria <strong>del</strong>la deriva dei<br />
continenti.<br />
LA DINAMICA DELLA LITOSFERA Cap.17: la teoria<br />
<strong>del</strong>la deriva dei continenti; la teoria <strong>del</strong>la tettonica <strong>del</strong>le<br />
zolle; i margini divergenti, i margini convergenti, i margini<br />
conservativi, il motore <strong>del</strong>la tettonica <strong>del</strong>le zolle, i punti<br />
caldi.<br />
8) I VULCANI<br />
OBIETTIVI: saper distinguere il vulcanesimo effusivo da<br />
quello esplosivo – saper distinguere i vari tipi di vulcani –<br />
saper indicare l’origine <strong>del</strong> vulcanesimo – saper descrivere i<br />
fenomeni <strong>del</strong> vulcanesimo secondario – saper correlare il<br />
vulcanesimo con la dinamica <strong>del</strong>la litosfera.<br />
I VULCANI: edifici vulcanici; vulcanismo effusivo ed<br />
esplosivo; distribuzione geografica dei vulcani;. Cap.14.: i<br />
vulcani, la genesi dei magmi, il comportamento dei magmi,<br />
la struttura, le eruzioni vulcaniche, i piroclasti, i gas, il<br />
vulcanesimo secondario.<br />
I TERREMOTI<br />
OBIETTIVI: saper descrivere le caratteristiche dei sismi e<br />
<strong>del</strong>le onde sismiche – saper distinguere la scala Mercalli dalla<br />
scala Richter; saper correlare i sismi con la dinamica <strong>del</strong>la<br />
litosfera.<br />
I TERREMOTI: natura e origine <strong>del</strong> terremoto; il ciclo<br />
sismico; le onde sismiche; propagazione<br />
e registrazione <strong>del</strong>le onde sismiche; la forza di un terremoto:<br />
scala Mercalli, scala Richter; distribuzione dei terremoti.<br />
Cap. <strong>15</strong>: i terremoti, la teoria <strong>del</strong> rimbalzo elastico, le onde<br />
sismiche, sismografi e sismogrammi, intensità e magnitudo<br />
dei terremoti (la scala <strong>del</strong>l’intensità,i limiti <strong>del</strong>la scala <strong>del</strong>le<br />
intensità,la scala di magnitudo.<br />
Sufficiente 1<br />
Sufficiente 1<br />
Discreto 2<br />
OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI<br />
Il profitto <strong>del</strong>la classe può essere complessivamente giudicato tra il sufficiente e il buono/ottimo.<br />
STRUMENTI DI VALUTAZIONE ADOTTATI<br />
Prove orali tradizionali per ogni quadrimestre e simulazione terza prova esame di stato proponendo<br />
trattazione sintetica di argomenti con un numero di righe indicato.<br />
CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI<br />
- Livello quantitativo <strong>del</strong> contenuto sviluppato;<br />
- Uso <strong>del</strong> linguaggio scientifico;<br />
- Capacità di analisi e sintesi;<br />
- Capacità espressive ed espositive;<br />
- Capacità critiche e / o di rielaborazione.<br />
32
METODI UTILIZZATI<br />
Lezione frontale. Gli alunni sono stati sempre stimolati alla partecipazione attiva sia per fare<br />
osservazioni che per trarre conclusioni.<br />
MEZZI E STRUMENTI UTILIZZATI : libro di testo,videocassette, lavagna.<br />
Data <strong>15</strong> <strong>Maggio</strong> 2013<br />
Firma <strong>del</strong> docente<br />
Visto per adesione i rappresentanti di classe<br />
____________________________________________<br />
33
FILOSOFIA<br />
Percorso Formativo Disciplinare<br />
Docente: Prof.ssa Catia Rosetti<br />
Tempi annuali previsti per la disciplina: 99 h<br />
Tempi annuali effettivamente utilizzati: 81 h<br />
Fino al <strong>15</strong>-05-2013<br />
Libro di testo adottato: “La filosofia di Nicola<br />
Abbagnano Giovanni Forero,tomo 2A,3B,3A,3B<br />
CONTENUTI DISCIPLINARI SVILUPPATI<br />
(suddivisi per moduli e unità didattiche)<br />
Livello di<br />
approfon=<br />
dimento<br />
ORE<br />
EVENTUALI NOTE AGGIUNTIVE<br />
1) Riepilogo <strong>del</strong>l’unità didattica svolta nell’a.s. 2010-2011:<br />
Temperie romantica e critica alla filosofia <strong>del</strong> limite<br />
- Le parole d’ordine <strong>del</strong> Romanticismo<br />
- Reinhold e Maimon: la revisione <strong>del</strong> criticismo e sua<br />
dissoluzione<br />
Discreto 2<br />
2) Lo sviluppo <strong>del</strong>l’Idealismo<br />
- Fichte : lo sviluppo <strong>del</strong>l’Io e la formazione <strong>del</strong>la coscienza<br />
empirica. L’Io come volontà libera ed il suo primato.<br />
L’antidogmaticismo e la libertà come missione.<br />
- Schelling e l’Idealismo estetico: dalla filosofia <strong>del</strong>la natura<br />
alla filosofia trascendentale. L’arte come organo <strong>del</strong>la<br />
filosofia.<br />
- Hegel : la realtà come ragione in divenire dialettico.<br />
Finito ed infinito, intelletto e ragione. L’Idealismo come<br />
filosofia <strong>del</strong>la totalità. La “Fenomenologia <strong>del</strong>lo Spirito” come<br />
storia <strong>del</strong>l’esperienza ascensionale <strong>del</strong>la coscienza (in<br />
particolare la dialettica servo-padrone e la “coscienza<br />
infelice”) e come autorivelarsi <strong>del</strong>l’Assoluto a se stesso. Il<br />
significato <strong>del</strong>la logica e <strong>del</strong>la filosofia <strong>del</strong>la natura. La<br />
filosofia <strong>del</strong>lo Spirito ed i suoi momenti (in particolare<br />
oggettivo ed assoluto).<br />
Buono 23<br />
Da La missione <strong>del</strong> dotto: l’impegno etico e<br />
civile <strong>del</strong>l’intellettuale.<br />
Dal Sistema <strong>del</strong>l’idealismo trascendentale : la<br />
superiorità <strong>del</strong>l’arte.<br />
Da Enciclopedia <strong>del</strong>le scienze filosofiche: lo<br />
Stato come sostanza etica.<br />
Da Lineamenti <strong>del</strong>la filosofia <strong>del</strong> diritto:la<br />
guerra.<br />
3) Critica al sistema hegeliano<br />
- I “Giovani hegeliani” ed il compito critico <strong>del</strong>la filosofia.<br />
Da L’essenza <strong>del</strong> cristianesimo: l’alienazione<br />
religiosa.<br />
- Feurbach e la svolta antropologica <strong>del</strong>la filosofia<br />
<strong>del</strong>l’avvenire.<br />
- Karl Marx: il materialismo storico, struttura e sovrastruttura.<br />
Critica <strong>del</strong>l’ economia classica e <strong>del</strong>la Sinistra hegeliana.<br />
Lavoro ed alienazione. L’analisi economica <strong>del</strong> Capitale, le<br />
sue leggi, le sue contraddizioni. Il superamento <strong>del</strong>la Stato<br />
borghese.<br />
Dal marxismo ai marxismi: Lenin. Antonio Gramsci: il ruolo<br />
<strong>del</strong>la sovrastruttura, l’egemonia culturale, l’intellettuale<br />
organico, la questione meridionale.<br />
Buono<br />
Discreto<br />
14<br />
Da Manoscritti economico-filosofico <strong>del</strong><br />
1844: l’infelicità <strong>del</strong> lavoro alienato e il<br />
lavoratore espropriatore <strong>del</strong>la sua stessa forza<br />
lavoro.<br />
Da Tesi su Feurbach: 4, 6, 7, 8, 11.<br />
Da Gli annali franco-tedeschi: l’arma <strong>del</strong>la<br />
critica e la critica <strong>del</strong>le armi.<br />
Da Stato e rivoluzione (Lenin): la scomparsa<br />
<strong>del</strong>la democrazia, lo Stato come società<br />
borghese.<br />
Da Quaderni dal carcere (Gramsci): il partito<br />
politico.<br />
34
4) Oppositori <strong>del</strong> sistema hegeliano<br />
- Schopenhauer : il mondo come volontà e rappresentazione.<br />
Lo smascheramento <strong>del</strong>la negazione <strong>del</strong> corpo e <strong>del</strong>la ragione<br />
esorcizzante. Dalla voluntas alla noluntas.<br />
- Kierkegaard e la singolarità irriducibile.<br />
Esistenza , angoscia , disperazione.<br />
Discreto<br />
Buono<br />
7<br />
Da Il mondo come volontà e<br />
rappresentazione: appagamento come<br />
elemosina al mendicante.<br />
Da Timore e tremore: nel paradosso <strong>del</strong>la<br />
fede.<br />
5) Il positivismo ed i suoi critici<br />
- Il positivismo e le sue coordinate culturali e metodologiche.<br />
- Comte: la filosofia positiva, le sue classificazioni, le sue<br />
proposte . La sociologia.<br />
- Nietzsche: la giustificazione estetica <strong>del</strong>l’esistenza,<br />
“Considerazioni inattuali”, il distacco da Wagner e<br />
Schopenhauer, la fase illuministica, il metodo genealogico e<br />
quello <strong>del</strong> sospetto. La filosofia <strong>del</strong> mattino ed il nichilismo<br />
come malattia <strong>del</strong>l’Occidente. La filosofia <strong>del</strong> mezzogiorno.<br />
Amor sé, amor fati, eterno ritorno. Il prospettivismo e la<br />
volontà di potenza.<br />
- Lo Spiritualismo francese e Bergson: la sua critica allo<br />
scientismo. Il tempo discreto <strong>del</strong>l’esperienza e quello <strong>del</strong>la<br />
coscienza. Il metodo cinematografico. La vita come èlan vital,<br />
come evoluzione creatrice. Intelligenza, istinto, intuizione.<br />
Discreto<br />
Buono<br />
20<br />
Da Il discorso sullo spirito positivo: i cinque<br />
significati di positivo.<br />
Da Corso di filosofia positiva:la legge dei tre<br />
stadi.<br />
Da La nascita <strong>del</strong>la tragedia dallo spirito<br />
<strong>del</strong>la musica: Apollo e Dioniso il sogno e<br />
l’ebbrezza, la nascita <strong>del</strong>la tragedia dal coro<br />
dei satiri, la musica si scarica in un mondo di<br />
immagini, Socrate: un logico dispotico.<br />
Da Umano troppo umano: il difetto ereditario<br />
dei filosofi.<br />
Da Gaia scienza: l’annuncio <strong>del</strong>la morte di<br />
Dio.<br />
Da genealogia <strong>del</strong>la morale:sul<br />
rovesciamento <strong>del</strong> valore di “buono”<br />
Da Al di là <strong>del</strong> bene e <strong>del</strong> male: un proverbio<br />
cinese.<br />
Da Così parlò Zarathustra: la verità <strong>del</strong><br />
tempo, il serpente.<br />
Da Saggio sui dati immediati <strong>del</strong>la coscienza:<br />
che cos’è il tempo senza coscienza.<br />
Da L’evoluzione creatrice: lo slancio vitale e<br />
la resistenza <strong>del</strong>la materia, l’io è durata.<br />
6) La crisi <strong>del</strong>le certezze nelle scienze umane e in quelle<br />
fisico-matematiche<br />
- Freud e la terza ferita narcisistica. Con Charcot e Breuer<br />
dall’ipnosi alle libere associazioni. L’analisi <strong>del</strong> lavoro onirico,<br />
dei lapsus e degli atti mancati. La struttura <strong>del</strong>la Psiche: Es,<br />
Ego, Super-Io. Le istanze <strong>del</strong>la Psiche, la nevrosi la sessualità<br />
infantile. Il disagio <strong>del</strong>la civiltà. L’origine psichica <strong>del</strong>le prime<br />
istituzioni sociali, morali, religiose. Il tema <strong>del</strong>la massa.<br />
- spazio e tempo al di là <strong>del</strong>la fisica classica<br />
- Geometria iperbolica ed ellittica<br />
- Tentativi di fondazione/ formalizzazione <strong>del</strong>la matematica.<br />
Discreto<br />
Sufficien<br />
7<br />
Da Sul sogno: contenuto latente e manifesto.<br />
Da Psicoanalisi:che cos’è il transfert, il<br />
complesso di Edipo, l’insorgere <strong>del</strong>le nevrosi<br />
e l’influenza <strong>del</strong>la civiltà.<br />
8) L’Esistenzialismo come atmosfera e come filosofia<br />
- Panorama sull’Esistenzialismo<br />
- Cenni su Jaspers<br />
- Il primo Heidegger: un’analitica esistenziale, le domande<br />
sull’essere, l’esserci, l’esistenza ed i suoi “esistenziali”,<br />
l’esistenza inautentica, l’angoscia e l’essere per la morte,<br />
esistenza autentica. La temporalità come senso autentico <strong>del</strong>la<br />
Cura.<br />
- Sartre: le strutture <strong>del</strong>l’essere, la condanna ad essere liberi,<br />
la responsabilità, il conflitto con gli altri. Dall’assurdità<br />
<strong>del</strong>l’esistenza e dalla nausea alla svolta <strong>del</strong> ’46.<br />
Discreto<br />
Buono<br />
8<br />
Da Essere e tempo: essere ed ente<br />
Da L’esistenzialismo è un umanismo:<br />
l’esistenza precede l’essenza.<br />
Da L’esistenzialismo è un umanismo:<br />
non l’uomo come fine ma come limite.<br />
35
CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI:<br />
La valutazione ha tenuto in considerazione il livello quantitativo dei contenuti sviluppati e la<br />
coerenza di questi con i quesiti proposti, le capacità di analisi e di sintesi, le capacità operative, le<br />
capacità critiche e le capacità espressive. Sono stati inoltre elementi di valutazione finale<br />
l’atteggiamento nei confronti <strong>del</strong> lavoro (impegno, coinvolgimento), la capacità autocritica, la<br />
metodicità nella pianificazione e la responsabilizzazione di fronte alle scadenze, il contributo<br />
partecipativo.<br />
STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE ADOTTATI.<br />
Sono stati utilizzati:<br />
n. 4 prove orali tradizionali<br />
n. 2 prove con quesiti a risposte aperte<br />
METODI UTILIZZATI:<br />
Si è cercato di motivare gli alunni affinché intendessero questa disciplina come opportunità per<br />
interrogare voci significative <strong>del</strong>la cultura filosofica <strong>del</strong> XIX e <strong>del</strong>la sua messa in discussione<br />
nell’età <strong>del</strong>la crisi <strong>del</strong>le certezze; l’obiettivo è stato anche quello di coinvolgerli in un percorso<br />
durante tutto il triennio nel quale il dibattito filosofico incrocia altre discipline , le riflette, le<br />
illumina.<br />
Di qui l’apertura a confronti, nonché l’insistenza sui collegamenti tra le varie aree culturali.<br />
Si è fatto ricorso alle lezioni frontali interattive, riservando attenzione ai tempi ed agli stili di<br />
apprendimento, ragione per cui sono state effettuati interventi didattici costanti e documentati per<br />
offrire rinforzi, disseminati nel corso di ogni unità didattica .Si è inoltre sollecitata la classe con<br />
simulazioni di domande, seguite da discussioni e contributi di singoli Altra pratica didattica<br />
costante è stata quella <strong>del</strong> dialogo e <strong>del</strong>la stimolazione <strong>del</strong>le domande da rivolgere alla docente, ai<br />
testi presi in esame, a se stessi. E’ stato inoltre ritenuto idoneo ricorrere a schematizzazioni e fornire<br />
agli alunni l’opportunità di produrre esercitazioni domestiche, seguite da correzioni e commenti,<br />
nonché da offerta di mo<strong>del</strong>li di risposta a quesiti aperti.<br />
MEZZI/STRUMENTI:<br />
Libro di testo - lavagna - fotocopie di altri testi ad integrazione e/o sostituzione<br />
SPAZI:<br />
Aula ordinaria, aula multimediale<br />
OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI: (per ciascun gruppo omogeneo di alunni all’interno<br />
<strong>del</strong>la classe)<br />
36
La classe in oggetto,già in possesso di prerequisiti metodologici più che solidi e di consuetudine ad<br />
un adeguato lavoro domestico,ha affrontato il percorso <strong>del</strong> presente anno scolastico con un impegno<br />
ancora maggiore,poiché generalizzato e sempre più determinato nel corso dei mesi,anche se<br />
accompagnato da ansietà,per alcuni spiegabile alla luce di un grande senso di responsabilità.Tale<br />
classe può essere divisa in due gruppi approssimativamente omogenei.<br />
Un primo gruppo, che si muove con più che apprezzabile disinvoltura sul piano ipoteticodeduttivo,<br />
è in grado di problematizzare le conoscenze, sa adottare competenti strategie<br />
comunicative.<br />
In particolare ogni alunno <strong>del</strong> primo gruppo:<br />
sa esporre in modo autonomo e competente le proprie conoscenze;<br />
sa usare in modo autonomo e competente la terminologia filosofica;<br />
sa sintetizzare / analizzare le argomentazioni sia in modo diacronico che sincronico;<br />
è in grado di enucleare le idee centrali di parti selezionate di testi filosofici e commentarle;<br />
sa correlare un argomento filosofico alla sfondo culturale di riferimento, anche con una personale<br />
biblioteca.<br />
Un secondo gruppo di alunni (la maggioranza <strong>del</strong>la classe) capace di uno studio attento e<br />
perseverante, accede alle categorie fondamentali <strong>del</strong> discorso filosofico e <strong>del</strong> suo lessico in modo<br />
sicuramente soddisfacente.<br />
Ogni alunno <strong>del</strong> secondo gruppo:<br />
sa esporre in modo autonomo e soddisfacente le proprie conoscenze;<br />
sa usare in modo autonomo e soddisfacente la terminologia filosofica;<br />
sa sintetizzare le argomentazioni in modo sincronico;<br />
è in grado di enucleare le idee centrali di parti selezionate di testi filosofici e spiegarle;<br />
sa correlare un argomento filosofico alla sfondo culturale di riferimento.<br />
Data<br />
Firma <strong>del</strong> docente<br />
_____________________________________<br />
VISTO per adesione, i rappresentanti di classe<br />
_____________________________________<br />
_____________________________________<br />
37
STORIA<br />
Percorso Formativo Disciplinare<br />
Docente: Prof.ssa Catia Rosetti<br />
Tempi annuali previsti per la disciplina: 99 h<br />
Tempi annuali effettivamente utilizzati: 83 h<br />
Fino al <strong>15</strong>-05-2013<br />
Libro di testo adottato: “Leggere la storia”<br />
di M. Manzoni, F. Occhipinti, F. Cereda, R. Innocenti,<br />
tomo 3A, 3B<br />
CONTENUTI DISCIPLINARI SVILUPPATI<br />
(suddivisi per moduli o unità didattiche)<br />
Livello di<br />
approfon=<br />
dimento<br />
(Ottimo –<br />
Buono –<br />
Discreto –<br />
Sufficien)<br />
ORE<br />
EVENTUALI NOTE AGGIUNTIVE<br />
1) Modulo di ripasso di quanto svolto nell’a. s. 2010_2011<br />
verso il Novecento: ideologie,istituzioni,dinamiche<br />
politiche<br />
- partiti di massa, movimento operaio e sue organizzazioni. La<br />
seconda Internazionale<br />
- Nazionalismo, Pangermanesimo, Panslavismo,<br />
Antisemitismo e Sionismo<br />
- Francia, Inghilterra, Austria, Impero tedesco negli anni <strong>del</strong>la<br />
pace armata e <strong>del</strong>la Belle Epoque<br />
- la Russia tra autocrazia e rivoluzione<br />
- la crisi di fine secolo in Italia<br />
Discreto<br />
Sufficiente<br />
3<br />
Doc. La via socialdemocratica (di Bernstein)<br />
Doc. Il sionismo<br />
Storiog. Pangermanesimo e Panslavismo (di<br />
Ottavio Borriè)<br />
Doc. Zola a favore di Dreyfus (di Zola)<br />
Storiog. Il riarmo navale tedesco ( di<br />
M.Sturmer)<br />
Storiog. Ritratto <strong>del</strong> nazionalismo italiano<br />
(di Giuseppe Tedeschi)<br />
Storiog. Il colonialismo atipico <strong>del</strong>l’Italia (di<br />
G. Rochat)<br />
2) Il mondo in guerra<br />
- dalla crisi <strong>del</strong>l’equilibrio alla guerra<br />
- l’Italia di Giolitti e <strong>del</strong>la sua svolta liberale. Politica interna<br />
ed estera. Dalla neutralità all’intervento<br />
- i fronti <strong>del</strong>la guerra, le trincee e le nuove modalità belliche<br />
- il genocidio degli Armeni<br />
- la fine <strong>del</strong> conflitto<br />
Discreto<br />
Buono<br />
10<br />
Doc. Dal neutralismo all’interventismo (di<br />
Benito Mussolini)<br />
Doc. Il ruolo unificante <strong>del</strong> governo (di G.<br />
Giolitti)<br />
Storiog. Il decollo industriale italiano (di<br />
Emilio Gentile)<br />
Storiog. L’esperienza <strong>del</strong>la modernità negli<br />
uomini al fronte (di Antonio Gibelli)<br />
Storiog. Innovazioni nella tattica e<br />
armamenti (di Preston)<br />
Doc. I “Quattordici punti” di Wilson<br />
Doc. La società <strong>del</strong>le nazioni<br />
3) Le rivoluzioni in Russia<br />
- la Russia nella prima guerra mondiale<br />
- la Rivoluzione di Febbraio,il governo provvisorio <strong>del</strong>la Duma<br />
- Bolscevichi, menscevichi e soviet<br />
- Lenin e le tesi di Aprile<br />
- La rivoluzione d’Ottobre, la guerra civile, la nascita<br />
<strong>del</strong>l’URSS.<br />
- Dal comunismo di guerra alla NEP<br />
- Troskij, Bucharin e Stalin.<br />
- lo stalinismo negli anni Trenta<br />
Discreto<br />
Buono<br />
7<br />
Doc. Stato e Rivoluzione – La scomparsa<br />
<strong>del</strong>la democrazia (di N. Lenin)<br />
Storiog. La confessione nei “grandi”<br />
processi staliniani ( di R. Conquest)<br />
38
4) Gli anni Venti e Trenta in Europa<br />
- il primo dopoguerra tra difficoltà economiche e politiche<br />
- la crisi <strong>del</strong>lo stato liberale in Italia; instabilità economica e<br />
sociale, il biennio “rosso-nero”, le trasformazioni <strong>del</strong> quadro<br />
politico dal ‘19 al ’22. Da Nitti a Giolitti. Giolitti ed il<br />
fascismo.<br />
- Mussolini primo ministro: il ritorno all’ordine.<br />
- Legge Acerbo, <strong>del</strong>itto Matteotti.<br />
- Francia, dalla ripresa degli anni Venti all’instabilità degli anni<br />
Trenta.<br />
- Gran Bretagna: politica deflazionistica e governi conservatori.<br />
La questione irlandese<br />
Discreto<br />
Buono<br />
10<br />
Storiog. La problematica ricostruzione<br />
europea (di H. Aldcrof)<br />
Storiog. La crisi post-bellica in Italia ( di M.<br />
Salvadori)<br />
Storiog. Il mito <strong>del</strong>la “vittoria mutilata” e la<br />
retorica nazionalista (di G. Sabbatucci)<br />
Doc. La nascita <strong>del</strong> partito popolare (di<br />
Sturzo)<br />
Doc. Il fascismo <strong>del</strong>le origini<br />
Doc. Il discorso <strong>del</strong> “bivacco” (di B.<br />
Mussolini)<br />
Doc. Il doppio strappo istituzionale (dai<br />
discorsi di Mussolini alla camera)<br />
5) La Germania: dalla Repubblica di Weimar alla<br />
costituzione <strong>del</strong> Terzo Reich<br />
- le forze politiche in campo, le tensioni con la Francia,<br />
l’inflazione, il piano Dawes, Stresemann e l’accordo di Locarno<br />
- la crisi <strong>del</strong> 1929, l’ascesa <strong>del</strong> nazionalsocialismo, Hitler al<br />
potere, la nazificazione <strong>del</strong>la società.<br />
Discreto<br />
Buono<br />
6<br />
Doc. Il nazionalsocialismo (dal programma<br />
<strong>del</strong> partito <strong>del</strong> 1920)<br />
Doc. I principi <strong>del</strong> Nazionalsocialismo<br />
Doc. Il nazismo e la difesa <strong>del</strong> mondo rurale<br />
(dalla Dichiarazione ufficiale <strong>del</strong> Partito<br />
Nazista<br />
Storiog. La politica antiebraica <strong>del</strong>la<br />
Germania nazista ( di Mosse)<br />
6) Gli anni Venti e Trenta fuori dall’Europa<br />
- gli Stati Uniti ed il gigantismo industriale. La grande crisi ed<br />
il New Deal<br />
- il formarsi <strong>del</strong>la Turchia moderna<br />
- la situazione di Cina e Giappone<br />
- l’India di Gandhi negli anni Trenta<br />
Discreto<br />
Sufficien<br />
7<br />
Storiog. Il turbine speculativo prima <strong>del</strong><br />
grande crollo (di F. Fasce)<br />
Doc. Le origini <strong>del</strong> totalitarismo (di Hannah<br />
Arendt)<br />
7) Il fascismo dal ’26 al ‘45<br />
- le Leggi fascistissime e la coincidenza tra Stato e Partito<br />
fascista<br />
- il Ministero per la cultura popolare e la macchina <strong>del</strong><br />
consenso<br />
- la politica economica dal liberismo allo Stato imprenditore<br />
- la politica estera: i Patti Lateranensi, la svolta espansionistica<br />
dopo il ’27. La guerra d’Etiopia. L’asse Roma-Berlino, il patto<br />
Anticomintern e il Patto d’Acciaio<br />
- l’antifascismo<br />
Discreto<br />
Buono<br />
7<br />
Storiog. Il totalitarismo fascista e il progetto<br />
di rigenerazione nazionale (di Emilio<br />
Gentile)<br />
Storiog. Il consenso al fascismo e al nazismo<br />
(di A. J. De Grand)<br />
Storiog. Banche e Stato negli anni Trenta in<br />
Italia ( di V. Castronovo)<br />
Storiog. I ceti medi emergenti ( di R. De<br />
Felice)<br />
8) Verso la seconda guerra mondiale<br />
- la Spagna dalla guerra civile a Francisco Franco:<br />
un’anteprima degli schieramenti ideologici<br />
- annessione hitleriana <strong>del</strong>l’Austria, i Sudeti, l’Appeasement<br />
anglo-francese, Monaco<br />
-il patto Molotov-Ribbentrop<br />
Discreto<br />
Buono<br />
4<br />
39
9) La seconda guerra mondiale<br />
- l’invasione <strong>del</strong>la Polonia, l’attacco tedesco a Danimarca e<br />
Norvegia, il fronte occidentale ed il crollo <strong>del</strong>la Francia<br />
- l’intervento italiano, la guerra da parallela a subalterna<br />
- la “Battaglia d’Inghilterra” e la guerra sui mari<br />
- l’ “operazione Barbarossa”<br />
- la Carta Atlantica e l’intervento USA dopo Pearl Harbor<br />
- il Nuovo Ordine, la Shoah e la Resistenza<br />
- la controffensiva americana nel Mediterraneo e nel Pacifico<br />
- l’Armata Rossa dopo Stalingrado<br />
- il ’43 in Italia, la fine <strong>del</strong>la Repubblica sociale<br />
- la conferenza di Teheran, lo sbarco in Normandia e l’incontro<br />
di Jalta<br />
- l’invasione <strong>del</strong>la Germania, la resa <strong>del</strong> Giappone<br />
- Bretton Woods<br />
Discreto<br />
Buono<br />
8<br />
Doc. La cancellazione <strong>del</strong>la Polonia<br />
Storiog. Il significato <strong>del</strong>l’8 sttembre nella<br />
storia d’Italia ( di E.A. Rossi)<br />
Storiog. La resistenza come guerra civile (di<br />
C. Pavone)<br />
Storiog. La resistenza italiana e i suoi<br />
obiettivi (di S. Amendola)<br />
Storiog.La strategia <strong>del</strong> terrore nell’Italia<br />
occupata (di Lutz Klinkhammer)<br />
10) Il secondo dopoguerra: dalla pace al bipolarismo<br />
- il processo di Norimberga, l’ONU<br />
- la fine <strong>del</strong>la grande alleanza: l’inizio <strong>del</strong>la guerra fredda in<br />
Europa ed oltre: la Grecia, le due Germanie, la Corea<br />
- Truman e la politica di contenimento, il patto Atlantico, il<br />
piano Marshall, la NATO. L’ultima stagione <strong>del</strong>lo stalinismo:<br />
zdanovismo, Cominform, Comecon, Patto di Varsavia<br />
- l’inizio <strong>del</strong> “disgelo” ed i suoi protagonisti (Kennedy e<br />
Krusciov)<br />
- il “caso” di Cuba<br />
- l’Italia: dal crollo <strong>del</strong> fascismo alla Costituzione repubblicana<br />
ed all’affermarsi <strong>del</strong>l’era De Gasperi, <strong>del</strong> centrismo e <strong>del</strong><br />
profilarsi <strong>del</strong> miracolo economico nell’Italia <strong>del</strong> MEC.<br />
Discreto<br />
Buono<br />
<strong>15</strong><br />
Doc.La divisione <strong>del</strong>l’Europa e la dottrina<br />
<strong>del</strong> “contenimento” (dal discorso di<br />
Churchill a Fulton e Truman al Congresso)<br />
Doc. Dichiarazione universale dei diritti<br />
<strong>del</strong>l’uomo<br />
Doc. Le riparazioni di guerra imposte<br />
all’Italia dal trattato di pace (dal trattato di<br />
pace con l’Italia)<br />
Doc. La Costituzione Italiana: Principi e<br />
articolazioni (esaminata nel triennio)<br />
Doc. Sono un berlinese (dal discorso di<br />
Kennedy <strong>del</strong> 1963 a Berlino)<br />
11) Origini e caratteri <strong>del</strong>la decolonizzazione in generale<br />
- l’Inghilterra nell’immediato dopoguerra, la nascita <strong>del</strong>la<br />
“questione palestinese”<br />
- la Francia nell’immediato dopoguerra, De Gaulle e la quinta<br />
Repubblica, Algeria<br />
- dalla crisi di Suez e le sue implicazioni<br />
- l’India dall’autonomia all’indipendenza<br />
- dall’Indocina francese al Vietnam <strong>del</strong> Nord e <strong>del</strong> Sud: le<br />
tensioni successive<br />
- i Paesi non allineati, la conferenza di Bandung, il “Terzo<br />
Mondo” ed il Neocolonialismo<br />
Sufficien 6<br />
Doc. Il manifesto programmatico di<br />
Bandung (parte finale)<br />
Storiog. All’origine <strong>del</strong>la questione<br />
palestinese (di Benny Morris)<br />
CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI:<br />
La valutazione ha tenuto in considerazione, con uguale peso, il livello espositivo-argomentativo dei contenuti sviluppati<br />
e la coerenza di questi con i quesiti proposti, le capacità di analisi e di sintesi, le capacità operative, le capacità critiche<br />
e le capacità espressive. Sono stati inoltre elementi di valutazione finale l’atteggiamento nei confronti <strong>del</strong> lavoro<br />
(impegno, coinvolgimento,puntualità responsabilizzazione ) e contributo partecipativo .<br />
Le verifiche sono state volte a testare:<br />
Le conoscenze acquisite<br />
La capacità argomentative e di concettualizzazione<br />
Le capacità di analisi e di sintesi<br />
La proprietà lessicale e la capacità espositiva<br />
STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE ADOTTATI:<br />
n. 4 prove orali tradizionali<br />
n 2 prove con quesiti a risposte aperte<br />
interventi sollecitati e/o spontanei, esercitazioni scritte sulla base di consegne date.<br />
40
METODI UTILIZZATI:<br />
Le linee di sviluppo <strong>del</strong>l’età contemporanea sono state sottolineate in blocchi tematici all’interno dei quali gli alunni<br />
sono stati sollecitati ad una riflessione critica sugli avvenimenti e sui comportamenti dei popoli , come pure sulle<br />
singole , significative personalità. Nella modulazione <strong>del</strong>l’azione didattica si è tenuto conto <strong>del</strong>la necessità di far<br />
intravedere agli alunni la molteplicità <strong>del</strong>le letture possibili, anche per le vicende apparentemente più chiare e lineari.<br />
Nelle lezioni frontali interattive, a cui si è fatto ricorso, il percorso è stato presentato stimolando gli studenti a cogliere<br />
continuità e rotture rispetto all’attualità, sul versante <strong>del</strong>le strategie politiche, dei meccanismi <strong>del</strong>l’economia, <strong>del</strong>le<br />
risposte sociali.<br />
MEZZI/STRUMENTI:<br />
Libro di testo – materiale cartaceo fornito dalla docente<br />
SPAZI:<br />
Aula ordinaria<br />
OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI: (per ciascun gruppo omogeneo di alunni all’interno <strong>del</strong>la classe)<br />
La classe in oggetto può essere divisa idealmente in due gruppi approssimativamente omogenei.<br />
Un primo gruppo di alunni, più esiguo, ha raggiunto un eccellente preparazione e gli obiettivi, sa utilizzare le<br />
conoscenze acquisite aprendole alla multidisciplinarietà, è capace di problematizzare e di orientarsi, con discreta<br />
disinvoltura, nell’ambito <strong>del</strong>la storiografia<br />
In particolare ogni alunno <strong>del</strong> primo gruppo :<br />
sa esporre in modo chiaro le proprie conoscenze;<br />
sa usare in modo autonomo e competente la terminologia storica;<br />
sa definire termini e concetti storici;<br />
sa affrontare un tema storico in modo sincronico, come pure diacronico;<br />
è in grado di enucleare le idee centrali di un testo storiografico e gli aspetti salienti di un documento, operando confronti<br />
sa correlare un argomento storico allo sfondo culturale coevo.<br />
Un secondo gruppo ha raggiunto più che adeguatamente gli obiettivi indicati nella programmazione, ha quindi<br />
dimostrato di aver acquisito abilità di analisi e di sintesi, nonché di possedere proprietà terminologica.<br />
In particolare ogni alunno <strong>del</strong> secondo gruppo:<br />
sa esporre in modo chiaro le proprie conoscenze<br />
sa usare in modo autonomo e competente la terminologia storica<br />
sa definire termini e concetti storici<br />
sa affrontare un tema storico in modo sincronico<br />
è in grado di enucleare le idee centrali di un testo storiografico e gli aspetti salienti di un documento<br />
Data <strong>15</strong> maggio 2013<br />
Firma <strong>del</strong> docente<br />
_____________________________________<br />
VISTO per adesione i rappresentanti di classe<br />
_____________________________________<br />
____________________________________<br />
41
LINGUA E LETTERATURA INGLESE<br />
Percorso Formativo Disciplinare<br />
Docente: Prof.ssa Margherita Anzivino<br />
Tempi annuali previsti per la disciplina: 99 h<br />
Tempi annuali effettivamente utilizzati = 83h<br />
al 13 maggio 2013<br />
Libro di testo adottato:<br />
Spiazzi M., Tavella, M., Only Connect…New Directions,<br />
Nineteenth Century, Zanichelli, 2009 (terza ed.);<br />
Spiazzi M., Tavella, M., Only Connect…New Directions,<br />
Twentieth Century, Zanichelli, 2009 (terza ed.)<br />
– The<br />
– The<br />
CONTENUTI DISCIPLINARI SVILUPPATI<br />
Module 1 –The Early Romantic Age<br />
The Historical and Social Context: Industrial and Agricultural Revolution;Industrial Society;<br />
The Unanimous Declaration of the Thirteen United States of America (handout)<br />
The World Picture: Emotion vs Reason, Liberty and Social Criticism<br />
The Literary Context: New Trends in Poetry, The Gothic Novel<br />
LIVELLO<br />
DI APPRO=<br />
FONDI=<br />
MENTO<br />
(Ottimo –<br />
Buono –<br />
Discreto –<br />
Sufficiente)<br />
TEMPI<br />
IN ORE<br />
Edmund Burke,<br />
o A Philosophical Enquiry into the Origin of Our Ideas of the Sublime and the Beautiful:<br />
‘On the Sublime’<br />
William Blake: essential biography and main works; Blake’s interest in social<br />
problems; Style<br />
o Songs of Experience: ‘London’;‘Tyger’<br />
Buono 19<br />
Mary Shelley: essential biography and main works<br />
o Frankenstein, or Modern Prometheus: Plot; The origin of the mo<strong>del</strong>; The influence<br />
of science; Literary influences; Narrative structure; The double; Themes.<br />
Excerpts‘The creation of the monster’; selection of quotations (handout)<br />
Critical reading: Peter Brooks, (adapted): Godlike Science / Unhallowed Arts:<br />
Language and Monstrosity in Frankenstein, or the Modern Prometheus<br />
Module 2 –The Romantic Age<br />
The Historical and Social Context: From the Napoleonic Wars to the Regency<br />
The World Picture: The Egotistical Sublime<br />
The Literary Context: Reality and Vision; The Novel of Manners;The Historical Novel<br />
The First Romantic Generation<br />
William Wordsworth: the importance of Nature and the role of Imagination<br />
Samuel Taylor Coleridge:; the importance of Nature and the role of Imagination.<br />
o Biographia Literaria”: ‘The Genesis of the Lyrical Ballads’ (handout)<br />
Discreto 20<br />
The Second Romantic Generation<br />
John Keats : essential biography and main works; Keats’s reputation; The substance of<br />
his poetry ; The role of Imagination ; Beauty : the central theme of his poetry ; Physical<br />
beauty and spiritual beauty ; Negative capability<br />
o “Ode on a Grecian Urn” ;<br />
o Sonnets: ‘Why did I laugh tonight?’; ‘On seeing the Elgin Marbles’; ‘I cry mercy’<br />
(handouts)<br />
42
Module 3 –The Victorian Age<br />
The Historical and Social Context: The Early Victorian Age; The later years of Queen<br />
Victoria’s Reign<br />
The World Picture: The Victorian Compromise;The Victorian Frame of Mind<br />
The Literary Context: The Victorian Novel;Types of Novels; Aestheticism and Decadence<br />
Compare and contrast: French Realism/Naturalism in the works of Balzac, the De<br />
Goncourt brothers, Flaubert, Zola; the influence of Bau<strong>del</strong>aire<br />
Charles Dickens: essential biography and main works; The plots of Dickens’s novels;<br />
Characters; A didactic aim; Style and reputation;<br />
o Hard Times: Plot; Structure; A critique of materialism<br />
Excerpt: ‘Coketown’ (ll. 1-46)<br />
Compare and contrast: Benjamin Disraeli, Sybil, or the Two Nations<br />
Excerpt: ‘Mr Trafford’s village’(handout)<br />
Thomas Hardy: essential biography and main works; Hardy’s deterministic view;<br />
Hardy’s Wessex; The difficulty of being alive; Style<br />
o Jude the Obscure: Plot; Jude’s obscurity; Controversial issues; A departure into the<br />
modern novel<br />
Excerpt: ‘Suicide’<br />
Ottimo 22<br />
Robert Louis Stevenson, essential biography and main works; The origins of The<br />
Strange Case of Dr. Jekyll and Mr Hyde.<br />
o The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr Hyde: Plot; The double nature of the setting;<br />
Good and Evil; Narrative Technique; Influences and Interpretations<br />
Excerpt : ‘Jekyll’s experiment’<br />
Oscar Wilde: essential biography and main works; The rebel and the dandy; Art for<br />
Art’s Sake<br />
o The Picture of Dorian Gray: Plot; Narrative Technique; Allegorical Meaning<br />
Excerpts: ‘The Preface’; ‘Basil Hallward’<br />
Compare and contrast: Arthur Rimbaud, ‘Lettre du voyant’, ‘Une saison en enfer’<br />
(incipit) (Italian version commented and contextualised in English - handout)<br />
Module 4 –The Modern Age<br />
The World Picture: The Age of Anxiety<br />
The Literary Context: Modernism; War Poetry; Modernist Poetry; Modernist Novel<br />
Rupert Brooke:<br />
o ‘The soldier’<br />
Wilfred Owen:<br />
o ‘Dulce et Decorum est’<br />
Siegfried Sassoon:<br />
o ‘Suicide in the trenches’<br />
Alfred Edward Housman:<br />
o ‘Here dead we lie’ (handout)<br />
Wilfrid Gibson:<br />
o ‘Breakfast’ (handout)<br />
<strong>15</strong><br />
Thomas Stearns Eliot: essential biography and main works; The conversion; The impersonality<br />
of the Artist; The Objective Correlative; The Mythical Method<br />
o The Waste Land: The sections; The new concept of history; The mythical method; Innovative and<br />
stylistic devices<br />
Excerpt: ‘The Burial of the Dead’ (full section - handout)<br />
Compare and contrast: Eugenio Montale, from Ossi di seppia: ‘Spesso il male di vivere<br />
ho incontrato’, ‘I Limoni’, ‘Non chiederci la parola’, ‘Forse un mattino andando’<br />
(handout)<br />
Buono<br />
James Joyce: essential biography and main works; Ordinary Dublin; The rebellion<br />
against the Church; A subjective perception of time; The impersonality of the artist; The<br />
Mythical Method; The epiphany<br />
o Ulysses: Plot; The relation to Odyssey; The setting; The representation of human<br />
nature; The mythical method; A revolutionary prose<br />
43
Excerpt: ‘Molly’s monologue’<br />
George Orwell: essential biography and main works; First-hand experience; An<br />
influential voice of the 20 th century; The artist’s development; Social themes<br />
o Animal Farm:The historical background to the novel; Plot; The animals.<br />
Excerpt: ‘Old Major’s speech’<br />
Module 5 - The Present<br />
The Literary Context: Post-War Drama<br />
John Osborne: essential biography and main works<br />
o Look back in Anger. Plot; Conventional structure; Jimmy Porter: an anti-hero; The other<br />
characters; The innovative language.<br />
Excerpt: ‘Boring Sundays’<br />
Discreto 7<br />
Samuel Beckett: essential biography and main works<br />
o Waiting for Godot: Plot; Absence of a traditional structure; The symmetric structure;<br />
Characters; The meaninglessness of time; The comic and the tragic; The language<br />
Excerpt: ‘We’ll be back tomorrow’<br />
OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI<br />
La docente è titolare <strong>del</strong>la classe dallo scorso anno scolastico, rispetto al quale gli studenti sono maturati sul piano <strong>del</strong>le<br />
abilità linguistico-comunicative in maniera costante raggiungendo livelli che vanno dalla piena sufficienza<br />
all’eccellenza. E’ stato determinante il processo di maturazione personale nonché cognitiva di un gruppo di studenti che<br />
nel corso di questi due anni ha sviluppato crescente sicurezza e disinvoltura nell’impiego dei mezzi linguisticoespressivi<br />
soprattutto in relazione all’ampiezza lessicale, alla complessità <strong>del</strong> tessuto verbale ed alla chiarezza<br />
espositiva. Al termine <strong>del</strong>l’anno scolastico, pertanto, gli obiettivi didattici previsti in uscita dal percorso linguistico<br />
liceale sono stati raggiunti da tutta la classe, pur se con livelli eterogenei, in virtù di: attitudini, più o meno spiccate,<br />
all’apprendimento <strong>del</strong>la lingua inglese; abnegazione e costanza nell’impegno, in taluni casi sostenuta da intrinseca<br />
motivazione a migliorare la propria preparazione linguistica anche attraverso contenuti letterari, utili comunque per lo<br />
sviluppo <strong>del</strong>la capacità di argomentazione e confronto su temi che prescindono da un rigido contesto cronologico;<br />
disponibilità al dialogo formativo ed educativo ed alla rielaborazione veramente critica ed attenta dei contenuti<br />
proposti.<br />
Prescindendo dalla eterogeneità dei risultati fatti registrare, con fluency ed accuracy variabili, gli studenti sono in grado<br />
di sostenere una conversazione su tutti gli argomenti oggetto di studio commentandoli sul piano referenziale ed<br />
inferenziale, discutendoli in rapporto al contesto storico-letterario di appartenenza e a quello <strong>del</strong>le altre culture studiate.<br />
VERIFICHE E VALUTAZIONI<br />
In merito ai criteri di valutazione si rimanda alla programmazione di Dipartimento ed alle griglie ivi approvate, che la<br />
docente ha regolarmente allegato alle prove somministrate per le verifiche sommative scritte. Fondamentale rilievo è<br />
stato sempre dato alla capacità di rielaborazione a livello sia scritto che orale, affinché gli studenti si impegnassero,<br />
dietro costante stimolo e guida <strong>del</strong>la docente, a compiere un salto di qualità per rendere le loro conoscenze e<br />
competenze linguistiche non meramente scolastiche né mnemoniche.<br />
Nello specifico, sono state somministrate: nel trimestre n.2 prove orali e n. 2 prove scritte; nel pentamestre n. 2 prove<br />
valide per la valutazione orale e n. 4 prove scritte (2 prove sommative scritte cui vanno aggiunte le 2 prove<br />
somministrate in sede di simulazione <strong>del</strong>la 3^ Prove Multidisciplinare).<br />
Relativamente agli strumenti di valutazione adottati per le prove scritte, l’insegnante ha somministrato prove che<br />
valutassero conoscenze, competenze linguistiche e capacità di operare collegamenti intertestuali e multidisciplinari. Le<br />
prove orali sono state somministrate sotto forma di colloqui, commenti di brani letterari, di immagini legate agli<br />
argomenti studiati, confronti tra autori, opere, correnti. Soprattutto è stato considerato elemento discriminante tra uno<br />
studio scolastico, talvolta mnemonico, ed una preparazione più consapevole la cura dei collegamenti, <strong>del</strong>le connessioni<br />
logiche, <strong>del</strong>la varietà lessicale e <strong>del</strong>la pronuncia.<br />
METODI, MEZZI E STRUMENTI<br />
Con un opportuno adeguamento in itinere in base a stile e ritmo di apprendimento <strong>del</strong>la classe, la docente ha<br />
privilegiato modalità didattiche quali: brainstorming, scoperta guidata per induzione e deduzione, commento di corredo<br />
iconografico per individuare caratteristiche generali di periodi storici, lezione frontale e dialogata. In merito alla<br />
presentazione <strong>del</strong> contesto storico, la docente ha trattato i momenti salienti <strong>del</strong>la storia britannica nel secondo ‘700 e<br />
nell’800, ma per quanto concerne il XX secolo priorità è stata data alla letteratura ed alle diverse correnti e teorie che<br />
caratterizzano il Modernismo ed il Teatro dei Giovani Arrabbiati e <strong>del</strong>l’Assurdo perché la qualità dei contenuti<br />
44
prevalesse sulla quantità di informazioni. I riferimenti al contesto storico, pertanto, sono stati visti globalmente nel<br />
commento ai War Poets e nell’analisi di Animal Farm come denuncia dei totalitarismi.<br />
La lettura di brani antologici è stata seguita da semantizzazione perché gli studenti comprendessero meglio concetti<br />
complessi e nevralgici nell’economia <strong>del</strong> testo, quindi da puntuale commento in lingua straniera. L’insegnante ha<br />
costantemente incoraggiato gli studenti ad esprimere le loro opinioni operando collegamenti intertestuali e<br />
multidisciplinari, soprattutto con la letteratura italiana e francese. Altresì la docente ha insistito sull’importanza di<br />
integrare le informazioni <strong>del</strong> libro di testo con quelle aggiuntive desunte da materiale didattico quale mappe concettuali<br />
e spiegazioni.<br />
Per la visione e l’ascolto di materiale realizzato in formato power point è stato usato il laboratorio linguistico.<br />
Per quel che concerne la scelta degli argomenti proposti, la docente ha cercato di conciliare le indicazioni ministeriali<br />
per il curricolo prettamente letterario <strong>del</strong> <strong>Liceo</strong> <strong>Classico</strong> con gli interessi degli studenti e l’attualità.<br />
Ausilio per lo svolgimento <strong>del</strong>le prove scritte è stato il dizionario bilingue e / o monolingue.<br />
Data <strong>15</strong> <strong>Maggio</strong> 2013 Firma <strong>del</strong> docente<br />
____________________________________<br />
VISTO per adesione i rappresentanti di classe<br />
_________________________________<br />
_________________________________<br />
45
STORIA DELL’ARTE<br />
Percorso Formativo Disciplinare<br />
Docente: Prof.ssa Maddalena Calinich<br />
Tempi annuali previsti per la disciplina: 66 h<br />
Libro di testo adottato:<br />
Itinerario nell’arte, Volume 3-4-5. Ed.Zanichelli.<br />
Tempi annuali effettivamente utilizzati = 61h<br />
CONTENUTI DISCIPLINARI SVILUPPATI<br />
I Modulo: Il Rinascimento<br />
LIVELLO DI<br />
APPROFON=DI<br />
MENTO<br />
(Ottimo – Buono –<br />
Discreto –<br />
Sufficiente)<br />
TEMPI<br />
IN ORE<br />
Unità Didattica I<br />
Il Primo Rinascimento: L.B.Alberti e Piero <strong>del</strong>la Francesca.<br />
Sandro Botticelli: Primavera e Nascita di Venere.<br />
Urbanistica Rinascimentale: Pienza,Urbino e Ferrara.<br />
Andrea Mantenga: La Camera Picta.<br />
Bramante. Le opere milanesi e romane.<br />
Leonardo da Vinci: Adorazione dei Magi, Cenacolo, Vergine <strong>del</strong>le Rocce, La<br />
Vergine e Sant’Anna, La Gioconda.<br />
Michelangelo: Pietà Vaticana, David, Tondo Doni, la Tomba di Giulio II, la Volta<br />
<strong>del</strong>la Cappella Sistina, il complesso Laurenziano ( Biblioteca Laurenziana, Sacrestia<br />
Nuova), il Giudizio, la Piazza <strong>del</strong> Campidoglio, San Pietro, la Pietà Rondanini.<br />
Raffaello: Lo Sposalizio <strong>del</strong>la Vergine (confronto con l'opera <strong>del</strong> Perugino), le<br />
Madonne fiorentine, i ritratti, le opere <strong>del</strong> periodo romano (Le Stanze Vaticane, La<br />
Trasfigurazione). Raffaello architetto: S.Pietro.<br />
Giorgione:” La Tempesta”, “Venere di Dresda”.<br />
Tiziano: Assunta, Venere di Urbino, Pietà.<br />
Unità Didattica II<br />
Firenze lo sperimentalismo anticlassico: Rosso Fiorentino, Jacopo Pontormo.<br />
Sviluppi <strong>del</strong>la Maniera nel Veneto: cenni all’opera di J. Tintoretto ( Miracolo di S.<br />
Marco).<br />
La Maniera Romana: Giulio Romano (Palazzo Te).<br />
Andrea Palladio:La Basilica, La Rotonda, Villa Barbaro, l'edilizia religiosa, Teatro<br />
Olimpico .<br />
Correggio: Volta Firenze lo sperimentalismo anticlassico: Rosso Fiorentino, Jacopo<br />
Pontormo.<br />
Sviluppi <strong>del</strong>la Maniera nel Veneto: cenni all’opera di J. Tintoretto ( Miracolo di S.<br />
Marco).<br />
La Maniera Romana: Giulio Romano (Palazzo Te).<br />
Andrea Palladio:La Basilica, La Rotonda, Villa Barbaro, l'edilizia religiosa, Teatro<br />
Olimpico .<br />
Correggio: Volta di S.Giovanni e Duomo a Parma, Giove ed Io.<br />
Domenico Fontana e le trasformazioni urbanistiche di Roma con Sisto V.<br />
II Modulo: Il rinnovamento <strong>del</strong>la pittura<br />
tra la fine <strong>del</strong> XVI e il principio <strong>del</strong> XVII secolo<br />
Unità Didattica I<br />
Annibale Carracci: Il mangiafagioli, la Galleria di Palazzo Farnese.<br />
Caravaggio: esame <strong>del</strong>le opere presenti nel testo.<br />
BUONO<br />
BUONO<br />
17<br />
3<br />
46
III Modulo: Il Barocco<br />
Unità Didattica I<br />
Cenni ai seguaci dei Carracci: Guido Reni.<br />
G.L.Bernini: , Apollo, il Baldacchino…, Piazza S. Pietro, Cappella Cornaro, La<br />
Fontana dei Fiumi, , Estasi di S.Teresa.<br />
F.Borromini: S. Carlo, S. Ivo.<br />
Cenni all’opera di Pietro da Cortona.<br />
Cenni alla Cappella <strong>del</strong>la Santa Sindone di Guarino Guarini e Palazzina di Stupinigi<br />
di Filippo Juvarra<br />
BUONO 6<br />
IV Modulo: Tra Rococò e Illuminismo<br />
Unità Didattica I<br />
La grande stagione pittorica veneziana: I vedutisti: cenni all'opera di A.Canaletto e<br />
F.Guardi.<br />
Luigi Vanvitelli e la Reggia di Caserta.<br />
DISCRETO 1<br />
Unità Didattica I<br />
V Modulo: L'Età Neoclassica<br />
A. Canova: dagli esordi alle opere <strong>del</strong>la maturità ( Paolina Borghese, Amore e Psiche,<br />
i monumenti funerari ).<br />
J.L.David:”Il giuramento degli Orazi”, “Marat”.<br />
VI Modulo: Il Romanticismo<br />
Unità Didattica I<br />
L'affermarsi <strong>del</strong>la nuova pittura in Francia: opera scelta "La Libertà guida il popolo"<br />
di E. Delacroix e "La zattera <strong>del</strong>la Medusa" di T.Gericault.<br />
Il Romanticismo in Italia: cenni all'opera di Hayez.<br />
VII Modulo: Il Realismo<br />
Unità Didattica I<br />
DISCRETO<br />
BUONO<br />
4<br />
2<br />
Brevi cenni all’opera di C.Corot e la scuola di Barbizon.<br />
G.Courbet: Lo spaccapietre e Signorine in riva alla Senna.<br />
BUONO 2<br />
VIII Modulo:L'Impressionismo<br />
Unità Didattica I<br />
La prima mostra dei pittori impressionisti: opere esaminate - C.Monet (,<br />
Impression… ), E.Manet ( Le déjeuner sur l'erbe, Olympia ), cenni a P.A.Renoir .<br />
Cenni all’opera di E. Degas.<br />
BUONO 3<br />
Unità Didattica I<br />
IX Modulo: Dall'Impressionismo all'Espressionismo<br />
Il Divisionismo francese: Georges Seurat, “Una domenica pomeriggio all’isola <strong>del</strong>la<br />
Grande Jatte”.<br />
Cenni all’arte in Italia tra la fine <strong>del</strong> XIX e XX secolo: Macchiaioli.<br />
Il pre-espressionismo: V.Van Gogh ( Mangiatori di patate, Campo di grano),<br />
P.Gauguin ( Come! Sei gelosa?), E.Munch (Il grido).<br />
Espressionismo: i Fauves e il Die Brucke, cenni alle opere di H.Matisse e E.Kirchner.<br />
La Secessione Viennese: G.Klimt.<br />
DISCRETO<br />
3<br />
47
Unità Didattica I<br />
X Modulo: Brevi cenni alle Avanguardie<br />
Futurismo: U. Boccioni e A.Sant’Elia ( cenni alle opere ).<br />
Cubismo: Picasso ( Les demoiselles d’Avignon, Guernica).<br />
Cenni al Dadaismo.<br />
XI Modulo: Brevi cenni al razionalismo in architettura<br />
DISCRETO<br />
2<br />
Unità Didattica I<br />
Nascita <strong>del</strong>l'architettura razionalista: cenni ai seguenti autori; W.Gropius, Le<br />
Corbusier e F.L.Wright.<br />
DISCRETO 2<br />
OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI:<br />
Alla fine <strong>del</strong> triennio la classe dimostra un ottimo livello di preparazione ed è in grado di:<br />
1. Analizzare i diversi linguaggi espressivi degli artisti e <strong>del</strong>le opere esaminate.<br />
2. Individuare i significati e i messaggi <strong>del</strong>le opere esaminate indicate nel programma<br />
VERIFICHE E VALUTAZIONI<br />
N.4 prove orali tradizionale.<br />
METODI, MEZZI E STRUMENTI<br />
Gli obiettivi cognitivi sono stati raggiunti utilizzando i seguenti strumenti: percorsi multimediali<br />
proposti dal Docente:<br />
Libri in adozione e consigliati.<br />
Giornali o riviste specializzate.<br />
Data <strong>15</strong> <strong>Maggio</strong> 2013<br />
Firma <strong>del</strong> docente<br />
_____________________________________<br />
VISTO per adesione i rappresentanti di classe<br />
___________________________________________<br />
___________________________________________<br />
48
EDUCAZIONE FISICA<br />
Percorso Formativo Disciplinare<br />
Docente: Prof.ssa Giuseppina Pilotti<br />
Tempi annuali previsti per la disciplina: 66 h<br />
Tempi annuali effettivamente utilizzati = 57 h<br />
al 14 maggio 2013<br />
Libro di testo adottato<br />
G. Fiorini, S. Coretti, S. Bocchi, Corpo Libero, Marietti Scuola<br />
CONTENUTI DISCIPLINARI SVILUPPATI<br />
Modulo 1 – Miglioramento <strong>del</strong>le capacità coordinative e condizionali<br />
GINNASTICA GENERALE<br />
LIVELLO<br />
DI APPRO=<br />
FONDI=<br />
MENTO<br />
(Ottimo –<br />
Buono –<br />
Discreto –<br />
Sufficiente)<br />
TEMPI<br />
IN ORE<br />
Corsa, salti, lanci, esercizi isotonici e isometrici di tonificazione muscolare, a corpo libero, con<br />
piccoli attrezzi (fune, cerchio, manubri, bacchetta) e con grandi attrezzi (cavallo, quadro svedese,<br />
trave di equilibrio, spalliera)<br />
Esercizi di scioltezza e mobilità articolare, di resistenza, scatti, esercizi di rapidità.<br />
Esercizi di coordinazione di ginnastica aerobica e con lo step<br />
Modulo 2 – Pallavolo<br />
PALLAVOLO<br />
Il gioco, le regole, il terreno di gioco, come si gioca.<br />
Fondamentali di palleggio, bagher e battuta.<br />
Esercizi per migliorare la tecnica dei fondamentali individuali.<br />
Modulo 3 – Pallacanestro<br />
PALLACANESTRO<br />
Il gioco, le regole, il terreno di gioco, scopo <strong>del</strong> gioco.<br />
Esercizi per migliorare i fondamentali individuali.<br />
Esercizi per migliorare i fondamentali di squadra, di attacco e di difesa.<br />
Tre contro tre.<br />
Cinque contro cinque.<br />
Modulo 6 – Atletica<br />
buono 20<br />
buono 13<br />
buono 7<br />
Salto in lungo, salto in alto.<br />
buono 10<br />
Velocità (60 – 80 mt)<br />
Lancio <strong>del</strong> peso<br />
Modulo 7 – Argomenti teorici<br />
Pallavolo buono 7<br />
OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI<br />
Gli studenti hanno imparato a:<br />
- controllare e adattare nuovi movimenti;<br />
- sapersi muovere nello spazio;<br />
- applicare con intelligenza alcuni gesti motori;<br />
- percepire e riconoscere l’affaticamento in condizioni di lavoro diversi;<br />
- migliorare la coordinazione;<br />
- migliorare la propria mobilità articolare;<br />
- migliorare la propria velocità.<br />
49
VERIFICHE E VALUTAZIONI<br />
Sono state svolte prove pratiche in relazione alle prime 5 unità, e prove teoriche e compiti in classe in relazione<br />
all’ultima unità.<br />
METODI, MEZZI E STRUMENTI<br />
La docente ha adottato il metodo prassico, basato cioè sull’esempio pratico <strong>del</strong> movimento da compiere che poi gli<br />
studenti hanno ripetuto fino a compierlo con naturalezza, non come routine motoria.<br />
In merito a mezzi e strumenti, sono stati usati grandi e piccoli attrezzi, tappatone, peso, palloni di pallavolo, di<br />
pallacanestro e calcio.<br />
Lo spazio didattico è stato soprattutto la palestra; in occasione di lezioni pratiche e verifiche scritte l’aula.<br />
Data <strong>15</strong> <strong>Maggio</strong> 2013 Firma <strong>del</strong> docente<br />
____________________________________<br />
VISTO per adesione i rappresentanti di classe<br />
_________________________________<br />
_________________________________<br />
50
RELIGIONE<br />
Percorso formativo disciplinare<br />
Docente: prof. don Armando Guido Moriconi<br />
Nel programma svolto si è prestata particolare attenzione al mistero <strong>del</strong>l’uomo, colto nel suo essere<br />
domanda di significato, esigenza di verità. Da qui si è proposto, accanto ad altri percorsi umani e<br />
religiosi, l’Avvenimento <strong>del</strong> Cristianesimo, come risposta a quel profondo desiderio che alberga nel<br />
cuore di ogni uomo. La Chiesa nella storia è stata guardata, in linea con questo percorso, come il<br />
Luogo <strong>del</strong>la attuale presenza di Cristo tra gli uomini. Non sono mancati continui riferimenti a<br />
questioni di attualità, come possibilità di dialogo e giudizio.<br />
La classe ha mostrato un buon interesse per gli argomenti trattati e ha partecipato attivamente al<br />
dialogo avuto durante le ore di lezione.<br />
Buona è stata anche la condotta.<br />
PROGRAMMA SVOLTO<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
L’attesa <strong>del</strong> cuore e <strong>del</strong>la ragione<br />
La domanda di verità nella storia <strong>del</strong>l’umanità<br />
L’enigma <strong>del</strong> dolore e <strong>del</strong>la morte<br />
La ricerca di Dio in altri percorsi religiosi<br />
Il problema <strong>del</strong>la verità nella cultura contemporanea<br />
La ricerca di Dio nella Letteratura<br />
La nostalgia <strong>del</strong> Totalmente Altro<br />
Il mistero <strong>del</strong>l’Incarnazione<br />
Il Dio di Gesù Cristo<br />
L’essenza <strong>del</strong> Cristianesimo<br />
L’incontro con Gesù nei testi evangelici<br />
La Pasqua ebraica e la Pasqua cristiana<br />
La Chiesa: luogo <strong>del</strong> Perdono e <strong>del</strong>la Festa<br />
La Chiesa nell’insegnamento di Benedetto XVI<br />
Questioni di morale speciale<br />
Questioni di attualità<br />
Data <strong>15</strong> <strong>Maggio</strong> 2013 Firma <strong>del</strong> docente<br />
____________________________________<br />
VISTO per adesione i rappresentanti di classe<br />
_________________________________<br />
_________________________________<br />
51
IL CONSIGLIO DI CLASSE<br />
Nome Docente Disciplina Firma per esteso<br />
Pugliese Maura<br />
Amadio Ines<br />
Amadio Ines<br />
Rosetti Catia<br />
Rosetti Catia<br />
Marsili Caterina<br />
Zazzetti Luciano<br />
Castelletti Marida<br />
Anzivino Margherita<br />
Calinich Maddalena<br />
Pilotti Giuseppina<br />
Italiano<br />
Latino<br />
Greco<br />
Storia<br />
Filosofia<br />
Matematica<br />
Fisica<br />
Scienze<br />
Inglese<br />
Storia <strong>del</strong>l’arte<br />
Educazione Fisica<br />
Don Armando Guido Moriconi Religione<br />
52
ALLEGATI<br />
Griglie di valutazione<br />
Copia simulazione terza prova<br />
53
LICEO CLASSICO “G.LEOPARDI”<br />
SAN BENEDETTO DEL TRONTO<br />
ESAME DI STATO ANNO SCOLASTICO 2012/2013<br />
Griglia di valutazione per la prova scritta di ITALIANO<br />
Tipologia A (Analisi e commento di un testo)<br />
Misurazione <strong>del</strong> punteggio grezzo in 100esimi e valutazione in <strong>15</strong>esimi<br />
INDICATORE<br />
DESCRITTORI<br />
SPECIFICI<br />
PESO<br />
P<br />
LIVELLI DI<br />
VALUTAZIONE<br />
PUNTEGGIO<br />
LIVELLO<br />
PL<br />
PUNTEGGIO<br />
GREZZO<br />
=<br />
P x PL<br />
PUNTEGGI<br />
PARZIALI<br />
□ Prova nulla 0 0<br />
□ Gravem. Insuff. 1 9<br />
CONOSCENZA<br />
SPECIFICA DEGLI<br />
ARGOMENTI<br />
RICHIESTI<br />
Riconoscimento,<br />
comprensione,<br />
contestualizzazione<br />
<strong>del</strong> testo<br />
9<br />
□ Insufficiente 2 18<br />
□ Mediocre 2,5 22,5<br />
□ Sufficiente 3 27<br />
□ Discreto 3,5 31,5<br />
□ Buono 4 36<br />
□ Ottimo 5 45<br />
PADRONANZA<br />
DELLA LINGUA,<br />
CAPACITA’<br />
ESPRESSIVE<br />
LOGICO-<br />
LINGUISTICHE.<br />
CAPACITA’ DI<br />
ORGANIZZARE IL<br />
TESTO<br />
Completezza<br />
<strong>del</strong>l’analisi <strong>del</strong> testo<br />
per gli aspetti<br />
morfosintattici,<br />
stilistici, retorici<br />
7<br />
□ Prova nulla 0 0<br />
□ Gravem. Insuff. 1 7<br />
□ Insufficiente 2 14<br />
□ Mediocre 2,5 17,5<br />
□ Sufficiente 3 21<br />
□ Discreto 3,5 24,5<br />
□ Buono 4 28<br />
□ Ottimo 5 35<br />
CAPACITA’ DI<br />
ELABORAZIONE<br />
CRITICA,<br />
ORIGINALITA’ E/O<br />
CREATIVITA’<br />
Esame <strong>del</strong><br />
“significato” fino ad<br />
arrivare ad<br />
un’interpretazione<br />
contestualizzata<br />
4<br />
□ Prova nulla 0 0<br />
□ Gravem. Insuff. 1 4<br />
□ Insufficiente 2 8<br />
□ Mediocre 2,5 10<br />
□ Sufficiente 3 12<br />
□ Discreto 3,5 14<br />
□ Buono 4 16<br />
□ Ottimo 5 20<br />
Corrispondenza: / <strong>15</strong>mi Punteggio Totale......100<br />
Tabella di conversione dal punteggio grezzo ai quindicesimi mediante interpolazione quadratica con i seguenti vincoli: a 0/100 corrisponde 1/<strong>15</strong> al<br />
50% <strong>del</strong>la prestazione corrisponde 10/<strong>15</strong> a 100/100 corrisponde <strong>15</strong>/<strong>15</strong>.<br />
0-2 3-7 8-12 13-18 19-23 24-29 30-35 36-42 43-49 50-56 57-64 65-73 74-82 83-93 94-100<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 <strong>15</strong><br />
Candidato_____________________________________ Classe__________________<br />
San Benedetto <strong>del</strong> Tronto, …………………<br />
La Commissione d’Esame<br />
Valutazione attribuita alla prova / <strong>15</strong><br />
Il Presidente<br />
54
LICEO CLASSICO “G.LEOPARDI”<br />
SAN BENEDETTO DEL TRONTO<br />
ESAME DI STATO ANNO SCOLASTICO 2012/2013<br />
Griglia di valutazione per la prova scritta di ITALIANO<br />
Tipologia B (saggio breve e articolo di giornale)<br />
Misurazione <strong>del</strong> punteggio grezzo in 100esimi e valutazione in <strong>15</strong>esimi<br />
INDICATORE<br />
DESCRITTORI<br />
SPECIFICI<br />
PESO<br />
P<br />
LIVELLI DI<br />
VALUTAZIONE<br />
PUNTEGGIO<br />
LIVELLO<br />
PL<br />
PUNTEGGIO<br />
GREZZO<br />
=<br />
P x PL<br />
PUNTEGGI<br />
PARZIALI<br />
□ Prova nulla 0 0<br />
□ Gravem. Insuff. 1 4<br />
CONOSCENZA<br />
SPECIFICA DEGLI<br />
ARGOMENTI<br />
RICHIESTI<br />
Conoscenza <strong>del</strong>la<br />
questione e dei<br />
problemi connessi<br />
4<br />
□ Insufficiente 2 8<br />
□ Mediocre 2,5 10<br />
□ Sufficiente 3 12<br />
□ Discreto 3,5 14<br />
□ Buono 4 16<br />
□ Ottimo 5 20<br />
PADRONANZA<br />
DELLA LINGUA,<br />
CAPACITA’<br />
ESPRESSIVE<br />
LOGICO-<br />
LINGUISTICHE.<br />
CAPACITA’ DI<br />
ORGANIZZARE IL<br />
TESTO<br />
Competenze<br />
linguistiche coerenti<br />
con il tema<br />
10<br />
□ Prova nulla 0 0<br />
□ Gravem. Insuff. 1 10<br />
□ Insufficiente 2 20<br />
□ Mediocre 2,5 25<br />
□ Sufficiente 3 30<br />
□ Discreto 3,5 35<br />
□ Buono 4 40<br />
□ Ottimo 5 50<br />
CAPACITA’ DI<br />
ELABORAZIONE<br />
CRITICA,<br />
ORIGINALITA’ E/O<br />
CREATIVITA’<br />
Capacità di sviluppo<br />
critico <strong>del</strong>la<br />
questione affrontata<br />
6<br />
□ Prova nulla 0 0<br />
□ Gravem. Insuff. 1 6<br />
□ Insufficiente 2 12<br />
□ Mediocre 2,5 <strong>15</strong><br />
□ Sufficiente 3 18<br />
□ Discreto 3,5 21<br />
□ Buono 4 24<br />
□ Ottimo 5 30<br />
Corrispondenza: / <strong>15</strong>mi Punteggio Totale.........100<br />
Tabella di conversione dal punteggio grezzo ai quindicesimi mediante interpolazione quadratica con i seguenti vincoli: a 0/100 corrisponde 1/<strong>15</strong> al<br />
50% <strong>del</strong>la prestazione corrisponde 10/<strong>15</strong> a 100/100 corrisponde <strong>15</strong>/<strong>15</strong>.<br />
0-2 3-7 8-12 13-18 19-23 24-29 30-35 36-42 43-49 50-56 57-64 65-73 74-82 83-93 94-100<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 <strong>15</strong><br />
Candidato_____________________________________ Classe__________________<br />
San Benedetto <strong>del</strong> Tronto, …………………<br />
La Commissione d’Esame<br />
Valutazione attribuita alla prova / <strong>15</strong><br />
Il Presidente<br />
55
INDICATORE<br />
CONOSCENZA<br />
SPECIFICA DEGLI<br />
ARGOMENTI<br />
RICHIESTI<br />
PADRONANZA<br />
DELLA LINGUA,<br />
CAPACITA’<br />
ESPRESSIVE<br />
LOGICO-<br />
LINGUISTICHE<br />
CAPACITA’ DI<br />
ORGANIZZARE IL<br />
TESTO<br />
LICEO CLASSICO “G.LEOPARDI”<br />
SAN BENEDETTO DEL TRONTO<br />
ESAME DI STATO ANNO SCOLASTICO 2012/2013<br />
Griglia di valutazione per la prova scritta di ITALIANO<br />
Tipologia C (Argomento di carattere storico)<br />
Misurazione <strong>del</strong> punteggio grezzo in 100esimi e valutazione in <strong>15</strong>esimi<br />
DESCRITTORI<br />
SPECIFICI<br />
Conoscenza esatta in<br />
senso diacronico<br />
(evoluzione nel<br />
tempo) e sincronico<br />
(in una data fase)<br />
Competenze<br />
linguistiche lessicali<br />
anche di tipo<br />
storiografico<br />
PESO<br />
P<br />
9<br />
7<br />
LIVELLI DI<br />
VALUTAZIONE<br />
PUNTEGGIO<br />
LIVELLO<br />
PL<br />
PUNTEGGIO<br />
GREZZO<br />
=<br />
P x PL<br />
□ Prova nulla 0 0<br />
□ Gravem. Insuff. 1 9<br />
□ Insufficiente 2 18<br />
□ Mediocre 2,5 22,5<br />
□ Sufficiente 3 27<br />
□ Discreto 3,5 31,5<br />
□ Buono 4 36<br />
□ Ottimo 5 45<br />
□ Prova nulla 0 0<br />
□ Gravem. Insuff. 1 7<br />
□ Insufficiente 2 14<br />
□ Mediocre 2,5 17,5<br />
□ Sufficiente 3 21<br />
□ Discreto 3,5 24,5<br />
□ Buono 4 28<br />
□ Ottimo 5 35<br />
PUNTEGGI<br />
PARZIALI<br />
CAPACITA’ DI<br />
ELABORAZIONE<br />
CRITICA<br />
DELL’EVENTO<br />
STORICO,<br />
ORIGINALITA’ E/O<br />
CREATIVITA’<br />
Analisi <strong>del</strong>la<br />
complessità<br />
<strong>del</strong>l’evento storico e<br />
valutazione critica<br />
4<br />
□ Prova nulla 0 0<br />
□ Gravem. Insuff. 1 4<br />
□ Insufficiente 2 8<br />
□ Mediocre 2,5 10<br />
□ Sufficiente 3 12<br />
□ Discreto 3,5 14<br />
□ Buono 4 16<br />
□ Ottimo 5 20<br />
Corrispondenza: / <strong>15</strong>mi Punteggio Totale........../100<br />
Tabella di conversione dal punteggio grezzo ai quindicesimi mediante interpolazione quadratica con i seguenti vincoli: a 0/100 corrisponde 1/<strong>15</strong> al<br />
50% <strong>del</strong>la prestazione corrisponde 10/<strong>15</strong> a 100/100 corrisponde <strong>15</strong>/<strong>15</strong>.<br />
0-2 3-7 8-12 13-18 19-23 24-29 30-35 36-42 43-49 50-56 57-64 65-73 74-82 83-93 94-100<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 <strong>15</strong><br />
Candidato_____________________________________ Classe__________________<br />
San Benedetto <strong>del</strong> Tronto, …………………<br />
La Commissione d’Esame<br />
Valutazione attribuita alla prova / <strong>15</strong><br />
Il Presidente<br />
56
LICEO CLASSICO “G.LEOPARDI”<br />
SAN BENEDETTO DEL TRONTO<br />
ESAME DI STATO ANNO SCOLASTICO 2012/2013<br />
Griglia di valutazione per la prova scritta di ITALIANO<br />
Tipologia D - (Tema di ordine generale)<br />
Misurazione <strong>del</strong> punteggio grezzo in 100esimi e valutazione in <strong>15</strong>esimi<br />
INDICATORE<br />
DESCRITTORI<br />
SPECIFICI<br />
PESO<br />
P<br />
LIVELLI DI<br />
VALUTAZIONE<br />
PUNTEGGIO<br />
LIVELLO<br />
PL<br />
PUNTEGGIO<br />
GREZZO<br />
=<br />
P x PL<br />
PUNTEGGI<br />
PARZIALI<br />
□ Prova nulla 0 0<br />
□ Gravem. Insuff. 1 4<br />
CONOSCENZA<br />
SPECIFICA DEGLI<br />
ARGOMENTI<br />
RICHIESTI<br />
(ADERENZA ALLA<br />
TRACCIA)<br />
Conoscenza <strong>del</strong>la<br />
questione e dei<br />
problemi connessi<br />
4<br />
□ Insufficiente 2 8<br />
□ Mediocre 2,5 10<br />
□ Sufficiente 3 12<br />
□ Discreto 3,5 14<br />
□ Buono 4 16<br />
□ Ottimo 5 20<br />
PADRONANZA<br />
DELLA LINGUA,<br />
CAPACITA’<br />
ESPRESSIVE<br />
LOGICO-<br />
LINGUISTICHE.<br />
CAPACITA’ DI<br />
ORGANIZZARE IL<br />
TESTO<br />
Competenze<br />
linguistiche coerenti<br />
con il tema.<br />
Costruzione di un<br />
discorso ordinato<br />
10<br />
□ Prova nulla 0 0<br />
□ Gravem. Insuff. 1 10<br />
□ Insufficiente 2 20<br />
□ Mediocre 2,5 25<br />
□ Sufficiente 3 30<br />
□ Discreto 3,5 35<br />
□ Buono 4 40<br />
□ Ottimo 5 50<br />
CAPACITA’ DI<br />
ELABORAZIONE<br />
CRITICA,<br />
ORIGINALITA’ E/O<br />
CREATIVITA’<br />
Capacità di sviluppo<br />
critico <strong>del</strong>la<br />
questione affrontata<br />
6<br />
□ Prova nulla 0 0<br />
□ Gravem. Insuff. 1 6<br />
□ Insufficiente 2 12<br />
□ Mediocre 2,5 <strong>15</strong><br />
□ Sufficiente 3 18<br />
□ Discreto 3,5 21<br />
□ Buono 4 24<br />
□ Ottimo 5 30<br />
Corrispondenza: / <strong>15</strong>mi Punteggio Totale........../100<br />
Tabella di conversione dal punteggio grezzo ai quindicesimi mediante interpolazione quadratica con i seguenti vincoli: a 0/100 corrisponde 1/<strong>15</strong> al<br />
50% <strong>del</strong>la prestazione corrisponde 10/<strong>15</strong> a 100/100 corrisponde <strong>15</strong>/<strong>15</strong>.<br />
0-2 3-7 8-12 13-18 19-23 24-29 30-35 36-42 43-49 50-56 57-64 65-73 74-82 83-93 94-100<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 <strong>15</strong><br />
Candidato_____________________________________ Classe__________________<br />
San Benedetto <strong>del</strong> Tronto, …………………<br />
La Commissione d’Esame<br />
Valutazione attribuita alla prova / <strong>15</strong><br />
Il Presidente<br />
57
LICEO CLASSICO “G.LEOPARDI”<br />
SAN BENEDETTO DEL TRONTO<br />
ESAME DI STATO ANNO SCOLASTICO 2012/2013<br />
Griglia di valutazione per la prova scritta di LATINO<br />
Misurazione <strong>del</strong> punteggio grezzo in 100esimi e valutazione in <strong>15</strong>esimi<br />
INDICATORE<br />
DESCRITTORI<br />
SPECIFICI<br />
PESO<br />
P<br />
LIVELLI DI<br />
VALUTAZIONE<br />
PUNTEGGIO<br />
LIVELLO<br />
PL<br />
PUNTEGGIO<br />
GREZZO<br />
=<br />
P x PL<br />
PUNTEGGI<br />
PARZIALI<br />
□ Prova nulla 0 0<br />
COMPETENZA<br />
MORFOSINTATTICA<br />
Correttezza <strong>del</strong>la<br />
traduzione<br />
8<br />
□ Gravem. Insuff. 1 8<br />
□ Insufficiente 2 16<br />
□ Mediocre 2,5 20<br />
□ Sufficiente 3 24<br />
□ Discreto 3,5 28<br />
□ Buono 4 32<br />
□ Buono/Ottimo 4,5 36<br />
□ Ottimo 5 40<br />
□ Prova nulla 0 0<br />
CAPACITA’ DI<br />
COMPRENSIONE<br />
DEL TESTO<br />
Coerenza interpretativa<br />
Restituzione in forma<br />
italiana<br />
Proprietà lessicali<br />
10<br />
□ Gravem. Insuff. 1 10<br />
□ Insufficiente 2 20<br />
□ Mediocre 2,5 25<br />
□ Sufficiente 3 30<br />
□ Discreto 3,5 35<br />
□ Buono 4 40<br />
□ Buono/Ottimo 4,5 45<br />
□ Ottimo 5 50<br />
□ Prova nulla 0 0<br />
CAPACITA’ DI<br />
ELABORAZIONE<br />
CRITICA E/O<br />
ORIGINALITA’<br />
Capacità critica<br />
Originalità<br />
interpretativa<br />
Originalità espressiva 2<br />
□ Scarso 1 2<br />
□ Insufficiente 2 4<br />
□ Mediocre 2,5 5<br />
□ Sufficiente 3 6<br />
□ Discreto 3,5 7<br />
□ Buono 4 8<br />
□ Buono/Ottimo 4,5 9<br />
□ Ottimo 5 10<br />
Corrispondenza: / <strong>15</strong>mi Punteggio Totale........../100<br />
Tabella di conversione dal punteggio grezzo ai quindicesimi mediante interpolazione quadratica con i seguenti vincoli: a 0/100 corrisponde 1/<strong>15</strong> al<br />
50% <strong>del</strong>la prestazione corrisponde 10/<strong>15</strong> a 100/100 corrisponde <strong>15</strong>/<strong>15</strong>.<br />
0-2 3-7 8-12 13-18 19-23 24-29 30-35 36-42 43-49 50-56 57-64 65-73 74-82 83-93 94-100<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 <strong>15</strong><br />
Candidato_____________________________________ Classe__________________<br />
San Benedetto <strong>del</strong> Tronto, …………………<br />
La Commissione d’Esame<br />
Valutazione attribuita alla prova / <strong>15</strong><br />
Il Presidente<br />
58
LICEO CLASSICO “G.LEOPARDI”<br />
SAN BENEDETTO DEL TRONTO<br />
ESAME DI STATO ANNO SCOLASTICO 2012/2013<br />
GRIGLIA DI VALUTAZIONE COLLOQUIO<br />
INDICATORE<br />
PESO<br />
P<br />
LIVELLI DI<br />
VALUTAZIONE<br />
PUNTEGGIO<br />
LIVELLO<br />
PL<br />
PUNTEGGIO<br />
GREZZO<br />
=<br />
P x PL<br />
PUNTEGGI<br />
PARZIALI<br />
CONOSCENZA SPECIFICA<br />
DEGLI ARGOMENTI RICHIESTI 9<br />
PADRONANZA DELLA LINGUA E<br />
PROPRIETA’ DI LINGUAGGIO<br />
DISCIPLINARE<br />
6<br />
CAPACITA’ DI UTILIZZARE LE<br />
CONOSCENZE ACQUISITE O DI<br />
COLLEGARLE ANCHE IN<br />
FORMA INTERDISCIPLINARE<br />
CAPACITA’ DI DISCUSSIONE E<br />
APPROFONDIMENTO DEI<br />
DIVERSI ARGOMENTI CON<br />
SPUNTI DI<br />
ORIGINALITA’/CREATIVITA’;<br />
DISCUSSIONE SUGLI<br />
ELABORATI<br />
3<br />
2<br />
□ Gravemente insuff. 9<br />
□ Insufficiente 2 18<br />
□ Mediocre 2,5 22,5<br />
□ Sufficiente 3 27<br />
□ Discreto 3,5 31.5<br />
□ Buono 4 36<br />
□ Ottimo 5 45<br />
□ Gravemente insuff.<br />
□ Insufficiente 2 12<br />
□ Mediocre 2,5 <strong>15</strong><br />
□ Sufficiente 3 18<br />
□ Discreto 3,5 21<br />
□ Buono 4 24<br />
□ Ottimo 5 30<br />
□ Gravemente insuff. 3<br />
□ Insufficiente 2 6<br />
□ Mediocre 2,5 7,5<br />
□ Sufficiente 3 9<br />
□ Discreto 3,5 10,5<br />
□ Buono 4 12<br />
□ Ottimo 5 <strong>15</strong><br />
□ Gravemente insuff. 2<br />
□ Insufficiente 2 4<br />
□ Mediocre 2,5 5<br />
□ Sufficiente 3 6<br />
□ Discreto 3,5 7<br />
□ Buono 4 8<br />
□ Ottimo 5 10<br />
6<br />
Punteggio totale /100<br />
In caso si livello di valutazione gravemente insufficiente si attribuisce a PL un valore decimale (con una sola cifra significativa) compreso tra 0 ed<br />
1 (uno compreso).<br />
In caso di prova nulla si attribuisce a PL valore 0.<br />
Tabella di conversione dal punteggio grezzo ai trentesimi mediante interpolazione quadratica con i seguenti vincoli: a 0/100 corrisponde 1/30 a<br />
60/100 corrisponde 20/30 a 100/100 corrisponde 30/30.<br />
0-3 4-6 5-9 10-12 13-<strong>15</strong> 16-18 19-21 22-24 25-27 28-30 31-33 34-36 37-39 40-42 43-45<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 <strong>15</strong><br />
46-48 49-51 52-54 55-57 58-60 61-63 64-66 67-69 70-72 73-76 77-81 82-86 87-91 92-97 98-100<br />
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30<br />
Candidato_____________________________________ Classe__________________<br />
San Benedetto <strong>del</strong> Tronto, …………………<br />
La Commissione d’Esame<br />
Valutazione attribuita alla prova / 30<br />
Il Presidente<br />
59
LICEO CLASSICO “G.LEOPARDI”<br />
SAN BENEDETTO DEL TRONTO<br />
ESAME DI STATO ANNO SCOLASTICO 2012/2013<br />
Griglia di valutazione per la TERZA prova scritta<br />
Misurazione <strong>del</strong> punteggio grezzo in 100esimi e valutazione in <strong>15</strong>esimi<br />
INDICATORI<br />
Conoscenze e competenze<br />
riferite agli argomenti<br />
richiesti<br />
Padronanza <strong>del</strong><br />
codice linguistico<br />
specifico<br />
PUNTEGGIO<br />
MASSIMO<br />
ATTRIBUIBILE<br />
ALL'INDICATORE<br />
5 punti<br />
3 punti<br />
LIVELLI DI VALORE/<br />
VALUTAZIONE<br />
• - Prest. non data<br />
• - Scarso<br />
• - Insufficiente<br />
• - Mediocre<br />
• - Sufficiente<br />
• - Discreto<br />
• - Buono<br />
• - Ottimo<br />
• - Prest. non data<br />
• - Insufficiente<br />
• - Mediocre<br />
• - Sufficiente<br />
• - Discreto<br />
• - Buono<br />
• - Ottimo<br />
PUNTEGGIO<br />
CORRISPONDENTE<br />
AI DIVERSI LIVELLI<br />
0<br />
1,2<br />
2,2<br />
2,7<br />
3<br />
3,3<br />
4<br />
5<br />
0<br />
1<br />
1,8<br />
2<br />
2,2<br />
2,5<br />
3<br />
Capacità di sintesi<br />
e/o di collegamento<br />
ed integrazione <strong>del</strong>le<br />
conoscenze e competenze<br />
2 punti<br />
• - Prest. non data<br />
• - Insuff./Mediocre<br />
• - Sufficiente<br />
• - Discreto/Buono<br />
• - Ottimo<br />
0<br />
0,5<br />
1<br />
1,5<br />
2<br />
QUESITO INDICATORE 1 INDICATORE 2 INDICATORE 3 VOTO IN DECIMI<br />
1<br />
2<br />
3<br />
4<br />
5<br />
6<br />
7<br />
8<br />
9<br />
10<br />
SCALA GRAFICA DI TRASFORMAZIONE IN <strong>15</strong>-ESIMI<br />
Punteggio grezzo:_________/100<br />
(somma dei voti in decimi)<br />
0 - 2 3 - 7 8 - 12 13-18 19-23 24-49 30-35 36-42 43-49 50-56 57-64 65-73 74-82 83-93 94-100<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 <strong>15</strong><br />
Tabella di conversione dal punteggio grezzo ai quindicesimi mediante interpolazione quadratica con i seguenti vincoli: a 0/100 corrisponde 1/<strong>15</strong> al<br />
50% <strong>del</strong>la prestazione corrisponde 10/<strong>15</strong> a 100/100 corrisponde <strong>15</strong>/<strong>15</strong>.<br />
San Benedetto <strong>del</strong> Tronto, lì_________<br />
Punteggio in <strong>15</strong>esimi attribuito alla prova………………..<br />
Il Presidente<br />
I Commissari<br />
60
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE<br />
LICEO CLASSICO STATALE “G. LEOPARDI”<br />
Con sezioni associate: <strong>Liceo</strong> <strong>Classico</strong> di San Benedetto <strong>del</strong> Tronto (AP)<br />
V.le De Gasperi 135 – Cod.Fisc. 82002590444 – Tel. 0735/82929-781051 Fax 0735/786287<br />
Sito Web: www.liceoleopardi.it E-mail: apis00300b@istruzione.it – apis00300b@pec.istruzione.it<br />
I.P.S.S.C.T. Cupra Marittima (AP) Via Della Stazione 47 Tel. 0735/779062 Fax 0735/776021<br />
Sito Web: www.cupra.it E-mail: scuolacupra@tin.it<br />
ESAME DI STATO A.S. 2012-13<br />
TERZA PROVA SCRITTA<br />
CLASSE ____________<br />
STRUTTURA DELLA PROVA: Tipologia B – Quesiti con numero predeterminato di righe n.10 (10 quesiti in totale)<br />
MATERIE COINVOLTE: Greco, Filosofia, Fisica, Inglese, Scienze.<br />
TEMPO MAX ASSEGNATO ALLA PROVA: 3 ore<br />
SUSSIDI CONSENTITI: Dizionario lingua italiana, dizionario italiano- inglese<br />
Cognome e nome <strong>del</strong> candidato ___________________________<br />
61
ESAME DI STATO 2012/2013<br />
Disciplina: Greco<br />
Quesito n°1 : Il candidato illustri l’evoluzione <strong>del</strong>l’epigramma dall’età arcaica a quella<br />
ellenistica estendendo la trattazione<br />
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />
Disciplina: Greco<br />
Quesito n°2 : Il candidato <strong>del</strong>inei, facendo riferimento al I idillio, le caratteristiche<br />
fondamentali degli Idilli teocritei<br />
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />
Firma <strong>del</strong> candidato ___________________________<br />
62
ESAME DI STATO 2012/2013<br />
Disciplina: Filosofia<br />
Quesito n°3 : Si esplichi la funzione <strong>del</strong> ‘non-io’ in Fichte<br />
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />
Disciplina: Filosofia<br />
Quesito n°4 : Si chiarisca cosa intenda Bergson con l’espressione ‘elan vital’<br />
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />
Firma <strong>del</strong> candidato ___________________________<br />
63
ESAME DI STATO 2012/2013<br />
Disciplina: Fisica<br />
Quesito n°5 : L’esperimento di Thomson: finalità e descrizione quantitativa<br />
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />
Disciplina: Fisica<br />
Quesito n°6: L’effetto fotoelettrico<br />
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />
Firma <strong>del</strong> candidato ___________________________<br />
64
ESAME DI STATO 2012/2013<br />
Disciplina: Inglese<br />
Quesito n°7: Referring to its themes, discuss the atmosphere of moral annihilation and decay<br />
in Blake’s London<br />
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />
Disciplina: Inglese<br />
Quesito n°8: Justify the stylistic hallmarks of James Joyce’s narrative technique as regards<br />
the impersonality of the artist and the elaboration of the concept of epiphany<br />
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />
Firma <strong>del</strong> candidato ___________________________<br />
65
ESAME DI STATO 2012/2013<br />
Disciplina: SCIENZE<br />
Quesito n°9: Enuncia, spiega ed interpreta la legge di Ferrel e la forza di Coriolis.<br />
Rappresenta graficamente la situazione nella pagina accanto.<br />
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />
Disciplina: SCIENZE<br />
Quesito n°10: Descrivi la teoria <strong>del</strong> ritorno elastico<br />
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />
Firma <strong>del</strong> candidato ___________________________<br />
66
LICEO CLASSICO “G.LEOPARDI”<br />
SAN BENEDETTO DEL TRONTO<br />
ESAME DI STATO ANNO SCOLASTICO 2012/2013<br />
Griglia di valutazione per la TERZA prova scritta<br />
Misurazione <strong>del</strong> punteggio grezzo in 100esimi e valutazione in <strong>15</strong>esimi<br />
INDICATORI<br />
Conoscenze e competenze<br />
riferite agli argomenti<br />
richiesti<br />
Padronanza <strong>del</strong><br />
codice linguistico<br />
specifico<br />
PUNTEGGIO<br />
MASSIMO<br />
ATTRIBUIBILE<br />
ALL'INDICATORE<br />
5 punti<br />
3 punti<br />
LIVELLI DI VALORE/<br />
VALUTAZIONE<br />
• - Prest. non data<br />
• - Scarso<br />
• - Insufficiente<br />
• - Mediocre<br />
• - Sufficiente<br />
• - Discreto<br />
• - Buono<br />
• - Ottimo<br />
• - Prest. non data<br />
• - Insufficiente<br />
• - Mediocre<br />
• - Sufficiente<br />
• - Discreto<br />
• - Buono<br />
• - Ottimo<br />
PUNTEGGIO<br />
CORRISPONDENTE<br />
AI DIVERSI LIVELLI<br />
0<br />
1,2<br />
2,2<br />
2,7<br />
3<br />
3,3<br />
4<br />
5<br />
0<br />
1<br />
1,8<br />
2<br />
2,2<br />
2,5<br />
3<br />
Capacità di sintesi<br />
e/o di collegamento<br />
ed integrazione <strong>del</strong>le<br />
conoscenze e competenze<br />
2 punti<br />
• - Prest. non data<br />
• - Insuff./Mediocre<br />
• - Sufficiente<br />
• - Discreto/Buono<br />
• - Ottimo<br />
0<br />
0,5<br />
1<br />
1,5<br />
2<br />
QUESITO INDICATORE 1 INDICATORE 2 INDICATORE 3 VOTO IN DECIMI<br />
1<br />
2<br />
3<br />
4<br />
5<br />
6<br />
7<br />
8<br />
9<br />
10<br />
SCALA GRAFICA DI TRASFORMAZIONE IN <strong>15</strong>-ESIMI<br />
Punteggio grezzo:_________/100<br />
(somma dei voti in decimi)<br />
0 - 2 3 - 7 8 - 12 13-18 19-23 24-49 30-35 36-42 43-49 50-56 57-64 65-73 74-82 83-93 94-100<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 <strong>15</strong><br />
Tabella di conversione dal punteggio grezzo ai quindicesimi mediante interpolazione quadratica con i seguenti vincoli: a 0/100 corrisponde 1/<strong>15</strong> al<br />
50% <strong>del</strong>la prestazione corrisponde 10/<strong>15</strong> a 100/100 corrisponde <strong>15</strong>/<strong>15</strong>.<br />
San Benedetto <strong>del</strong> Tronto, lì_________<br />
Punteggio in <strong>15</strong>esimi attribuito alla prova………………..<br />
Il Presidente<br />
I Commissari<br />
67