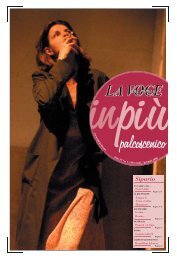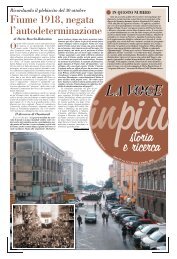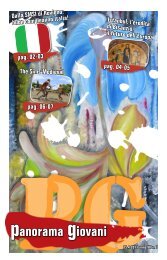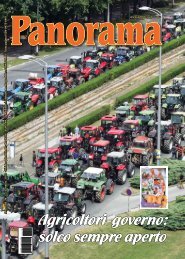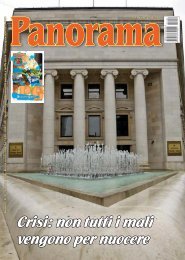16 marzo 2013 - Edit
16 marzo 2013 - Edit
16 marzo 2013 - Edit
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
del popolo<br />
sabato, <strong>16</strong> <strong>marzo</strong> <strong>2013</strong><br />
2 cultura<br />
la Voce<br />
CONVEGNO di Ilaria Rocchi<br />
LA FORZA<br />
Difficile immaginarle come delle<br />
Amazzoni, eppure, con la loro<br />
“arma”, la memoria, rievocando e<br />
conservando esperienze e conoscenze passate,<br />
hanno combattuto e continuano a combattere<br />
la guerriglia contro l’oblio, contro quel<br />
dimenticatoio in cui si voleva relegare una<br />
pagina sofferta e complessa del Novecento<br />
istriano-fiumano-dalmata. Loro, invece, con<br />
coraggio e sincerità, ma soprattutto senza<br />
animosità, senza rancori, con l’intima assenza<br />
di retorica e di tesi, hanno pescato nei loro<br />
vissuti e li hanno trasformati in narrazione<br />
individuale e al contempo collettiva di ciò che<br />
è stato il prima, il durante e il dopo dell’esodo<br />
giuliano-dalmata.<br />
Esuli e rimaste, tutte «vestali della memoria»<br />
Elette a “vestali della memoria” le polesi<br />
“rimaste” Ester Sardoz Barlessi e Nelida<br />
Milani, le esuli Anna Maria Mori, pure lei<br />
di Pola, le piranesi Elsa Fonda e Annamaria<br />
Muiesan Gaspàri, la fiumana Marisa Madieri,<br />
Lina Galli di Parenzo, Aurea Timeus di<br />
Portole, ma anche altre autrici non citate,<br />
come le prime, al convegno internazionale su<br />
“L’esodo giuliano-dalmata nella letteratura”,<br />
che ha riunito a Trieste, al Civico Museo<br />
della Civiltà istriana, fiumana e dalmata,<br />
una settantina di studiosi, in massima parte<br />
accademici di prestigiose università italiane<br />
(la Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Ca’<br />
Foscari di Venezia, gli atenei di Bari, della<br />
Calabria, di Chieti, Genova, Macerata, Pavia,<br />
Siena, Salerno e Siracusa, oltre a quello di<br />
Trieste), nonché straniere (come Bucarest,<br />
Oxford, Parigi, Lovanio, Murcia, Salonicco,<br />
Belgrado, ma pure Zara, Pola e Fiume,<br />
le ultime due rappresentate da studiose<br />
connazionali).<br />
La dimensione universale<br />
Organizzato dall’Istituto regionale per<br />
la Cultura Istriano-fiumano-dalmata,<br />
unitamente all’Università di Trieste e<br />
coordinato da Giorgio Baroni e Cristina<br />
Benussi, il simposio ha trattato la produzione<br />
letteraria di autori che hanno parlato<br />
dell’esodo giuliano-dalmata, sia per superare<br />
l’alienazione dello sradicamento sia per<br />
combattere il silenzio su una pagina di storia<br />
rimossa. Una tematica e un genere forse poco<br />
noti, ma che assumono una valenza e una<br />
dimensione universale attraverso le pagine<br />
di scrittori e poeti divenuti espressione della<br />
letteratura italiana tout court.<br />
Sono emerse delle coordinate molto<br />
importanti, le diverse prospettive e i vari<br />
livelli attraverso i quali questa letteratura<br />
si è espressa. Da una parte c’è la letteratura<br />
che parte dal cuore, che è testimonianza,<br />
che è memorialistica semplice; c’è poi<br />
la letteratura elaborata letterariamente,<br />
con tutte le retoriche e i simbolismi della<br />
letteratura. Ma c’è pure la letteratura che in<br />
qualche modo affida il proprio messaggio,<br />
anche subliminale, a una cassa di risonanza,<br />
all’industria culturale; cioè alcuni di<br />
questi autori puntano, o hanno puntato,<br />
direttamente alla diffusione mediatica con<br />
degli stratagemmi anche extra testuali,<br />
che sono molto ben identificabili. E questo<br />
consente di leggere la letteratura dell’esodo<br />
omologamente a tutte le letterature.<br />
L’intento di chiamare esperti da più parti<br />
del mondo ha significato anche voler<br />
inserire questa letteratura identificata come<br />
dell’esodo e dei rimasti dentro una tradizione<br />
letteraria che tratta temi analoghi, anche<br />
se svolti in tempi diversi, per confrontarne<br />
omologie e diversità. E uno dei risultati<br />
dell’incontro triestino è che si è cominciato<br />
a distinguere, dentro una tematica che<br />
sembrava molto omogenea, valori letterari<br />
molto diversi.<br />
Affermazione di un filone nuovo<br />
Ed è altresì affiorata l’esistenza di un filone,<br />
di un genere della letteratura italiana al<br />
femminile, quello della scrittura dell’esodo,<br />
con i suoi contenuti, stili, linguaggio, che<br />
meriterebbe di essere ancora più conosciuto<br />
per la sua qualità. Le donne affrontano in<br />
maniera diversa queste stesse tematiche<br />
di cui hanno consapevolezza e magari le<br />
vedono da una prospettiva diversa (Giusy<br />
Criscione, di Roma, nel suo excursus su<br />
più autrici ha illustrato come il rapporto<br />
con il proprio ambito familiare, il passato,<br />
la lingua, le usanze, le storie di tanti che<br />
non hanno avuto la voce diventino, nelle<br />
autrici dell’esodo, elemento creativo per<br />
la scrittura). Le vicende drammatiche che<br />
hanno vissuto in prima persona permettono<br />
di inserirle a pieno merito in quelli che sono<br />
i filoni della narrativa femminile.<br />
Il periodo storico in cui questi si sono<br />
sviluppati è del resto favorevole a questo tipo<br />
di operazione anche perché queste autrici – il<br />
riferimento in particolare è ad Anna Maria<br />
Mori – hanno fatto anche testi di altro genere<br />
e che rientra no in quelli della letteratura<br />
“rosa”.<br />
Lina Galli, poesie del dolore<br />
Il simposio triestino ha cercato di focalizzare<br />
maggiormente l’attenzione (anche) su questa<br />
produzione, a partire dal percorso letterario<br />
di Lina Galli, parentina esule a Trieste, in una<br />
sorta di omaggio nel ventennale della morte.<br />
La figura e l’opera della Galli sono state<br />
analizzate mediante i suoi versi, immediati<br />
e schietti, in cui si riscontra un approccio<br />
dolente e originale (Paola Baioni, Università<br />
DELLA SCRITTURA FEMMINILE<br />
Cattolica del Sacro Cuore, Milano – “Il Deus<br />
Absconditus nella lirica di Lina Galli”; Anco<br />
Marzio Mutterle, Università Ca’ Foscari,<br />
Venezia – “Storia ed ermetismo in Lina<br />
Galli”; Barbara Stagnitti, Università Cattolica<br />
del Sacro Cuore, Milano – “‘Sono venuta a<br />
cercare/ciò che ho perso’. Memorie istriane<br />
di Lina Galli”, Maria Pagliara, Università<br />
degli Studi di Bari – Memoria e poesia nella<br />
poesia di Lina Galli). L’esodo, la persecuzione<br />
etnica, lo sradicamento, che marchiarono<br />
per sempre la comunità giuliano-dalmata,<br />
costituiscono il perno della poesia della Galli,<br />
la quale proprio alla parola poetica affidò il<br />
compito di presevare il ricordo, affinché<br />
gli eventi che sconvolsero la sua terra<br />
continuassero a vivere nel tempo, a memoria<br />
perenne per l’umanità.<br />
L’agognata Itaca raggiungibile con le parole<br />
Ma non ci sono solo le sue poesie: va<br />
ricordato il libro “Il volto dell’Istria<br />
attraverso i secoli”, che ha avvicinato storia,<br />
arte e cultura della penisola soprattutto ai<br />
giovani (Silva Bon, Istituto regionale per la<br />
Storia del Movimemto di Liberazione nel<br />
Friuli Venezia Giulia, Trieste – “Lina Galli<br />
per la civiltà istriana”), quindi i contribui<br />
pubblicati sul quindicinale “La Voce<br />
Giuliana” (più di ottanta articoli, usciti tra<br />
il 1958 e il 1990, che dimostrano la sua<br />
instancabile attenzione verso l’Istria, come<br />
rilevato da Caterina Conti, dell’Università<br />
degli Studi di Trieste), la stestura del<br />
romanzo “Vita di mio marito” di Livia<br />
Veneziani Svevo (contenente inediti di<br />
Italo Svevo), le testimonianze e gli appunti<br />
raccolti dalla Galli tra il 1943 e i primi<br />
anni Cinquanta (Roberto Spazzali, ISIS<br />
“Leonardo da Vinci”, Trieste), riguardanti<br />
le condizioni in cui si trovarono l’Istria e la<br />
sua popolazione in quella travagliata fase<br />
storica.<br />
E si è poi parlato della sua singolare<br />
religiosità (Pietro Zovatto, Università degli<br />
Studi di Trieste), delle tipologie e delle<br />
funzioni assunte dal “gioco” nei suoi lavori<br />
(Paola Ponti, Università Cattolica), ma<br />
anche della percezione del presente, della<br />
sua rappresentazione e della persistenza<br />
della patria nei suoi lavori (Edda Serra,<br />
Centro Studi Biagio Marin, Grado). Poste<br />
a confronto (Graziella Semacchi Gliubich,<br />
giornalista pubblicista di Trieste) le voci<br />
di Lina Galli, Marisa Madieri e Annamaria<br />
Muiesan Gaspári, tre esuli e tre scrittrici e<br />
amiche personali; tracciati pure parallelismi<br />
con Luigi Miotto: per entrambi la tanto<br />
agognata Itaca diventa meta sempre più<br />
irragiungibile, che può essere riacquisita solo<br />
tramite la scrittura, dice Marianna Deganutti<br />
(Università di Oxford).<br />
Un trio meraviglioso: Madieri, Milani, Mori<br />
La potenza delle parole semplici, della<br />
sincerità e la “microepica”: è quanto<br />
accomuna alcune delle autrici più gettonate<br />
all’interno della letteratura femminile<br />
dell’esodo e, in generale, di tutta la letteratura<br />
dell’esodo. Una delle scrittrici più lette è<br />
indubbiamente Anna Maria Mori, presa in<br />
esame da Anna Bertini e Carla Carotenuto<br />
(Università degli Studi di Macerata), Natalie<br />
Dupré (Università Cattolica di Lovanio),<br />
Monica Giachino (Università Ca’ Foscari,<br />
Venezia), Milena Montanile (Università<br />
degli Studi di Salerno) ed Elena Rondena<br />
(Università Cattolica del Sacro Cuore,<br />
Milano).<br />
Se il suo “Bora” (Frassinelli, 1998), è un<br />
viaggio – compiuto insieme con Nelida Milani<br />
– nella memoria e nel cuore, “Nata in Istria”<br />
(Rizzoli, 2006) è un libro esemplare che fa<br />
conoscere ai più una terra nella molteplicità<br />
degli aspetti e delle identità; mentre il più<br />
recente “L’anima altrove” (Rizzoli, 2012) è<br />
quasi una conlcusione, non più focalizzata<br />
sull’esodo ma sulla condizione esistenziale<br />
dell’esilio, del trauma, delle tenebre<br />
dell’ignoto, il disagio dello straniamento.<br />
Ecco allora che per recuperare ricordi e<br />
identità, si dà voce alle “cose”: un angioletto<br />
in marmo, una pagella ingiallita, due<br />
scendiletto rosa…<br />
Oggetti quotidiani, piccole cose, profumi da<br />
ritrovare per cogliere il filo della memoria,<br />
ritrovare il legame con il luogo di nascita e<br />
la propria identità: elementi presenti nella<br />
fiumana Marisa Madieri, di cui al convegno<br />
si sono occupati Corinna Gerbaz Giuliano<br />
(Università di Fiume), Pedro Luis Ladrón<br />
De Guevara (Università di Murcia), Stefania<br />
Nociti (Università della Calabria), e Barbara<br />
Strumar (Università degli Studi di Trieste)<br />
quest’ultima con una proposta inedita,<br />
attraverso l’approfondimento e il confronto<br />
delle memorie olfattive.<br />
Tasselli della produzione di Nelida Milani –<br />
“Una valigia di cartone” (Sellerio, 1991), il<br />
citato “Bora” con la Mori, “Crinale estremo”<br />
(EDIT, 2007), “Racconti di guerra” (Il<br />
Ramo d’Oro, 2008) è stata al centro delle<br />
relazioni di Michela Rusi (Università Ca’<br />
Foscari, Venezia), Tiziana Piras (Università<br />
degli Studi di Trieste) e Titus Heydenreich<br />
(Università di Erlangen-Nürnberg). Nella<br />
narrativa della Milani – questa una delle<br />
conclusioni –, l’esperienza dell’esodo trova la<br />
sua espressione più origiale e profonda. La<br />
scrittura diventa per l’autrice una battaglia<br />
culturale che aiuta i vinti a diventare vittime<br />
invincibili. Altra conclusione: sono passaggi<br />
che andrebbero tematicamente scelti,<br />
pubblicati in un’antologia e possibilmente<br />
tradotti in croato, sloveno, inglese...