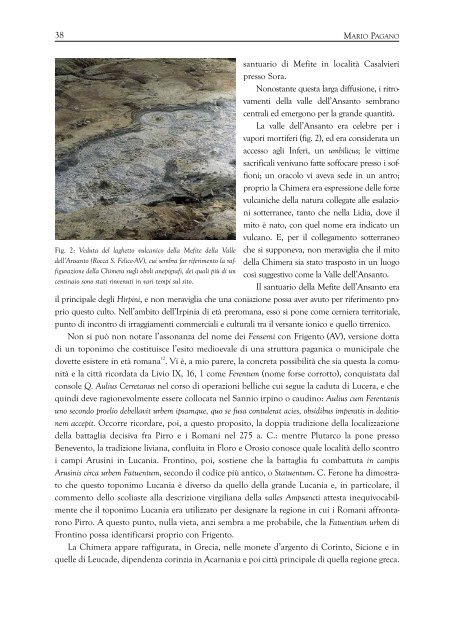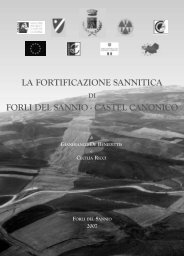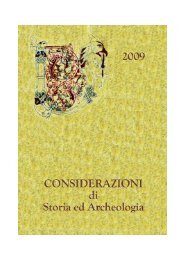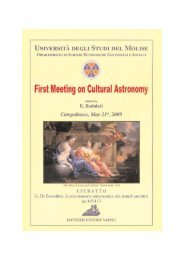You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
38<br />
Fig. 2: Veduta del laghetto vulcanico della Mefite della Valle<br />
dell’Ansanto (Rocca S. Felice-AV), cui sembra far riferimento la raffigurazione<br />
della Chimera sugli oboli anepigrafi, dei quali più di un<br />
centinaio sono stati rinvenuti in vari tempi sul sito.<br />
MARIO PAGANO<br />
santuario di Mefite in località Casalvieri<br />
presso Sora.<br />
Nonostante questa larga diffusione, i ritrovamenti<br />
della valle dell’Ansanto sembrano<br />
centrali ed emergono per la grande quantità.<br />
La valle dell’Ansanto era celebre per i<br />
vapori mortiferi (fig. 2), ed era considerata un<br />
accesso agli Inferi, un umbilicus; le vittime<br />
sacrificali venivano fatte soffocare presso i soffioni;<br />
un oracolo vi aveva sede in un antro;<br />
proprio la Chimera era espressione delle forze<br />
vulcaniche della natura collegate alle esalazioni<br />
sotterranee, tanto che nella Lidia, dove il<br />
mito è nato, con quel nome era indicato un<br />
vulcano. E, per il collegamento sotterraneo<br />
che si supponeva, non meraviglia che il mito<br />
della Chimera sia stato trasposto in un luogo<br />
così suggestivo come la Valle dell’Ansanto.<br />
Il santuario della Mefite dell’Ansanto era<br />
il principale degli Hirpini, e non meraviglia che una coniazione possa aver avuto per riferimento proprio<br />
questo culto. Nell’ambito dell’Irpinia di età preromana, esso si pone come cerniera territoriale,<br />
punto di incontro di irraggiamenti commerciali e culturali tra il versante ionico e quello tirrenico.<br />
Non si può non notare l’assonanza del nome dei Fenserni con Frigento (AV), versione dotta<br />
di un toponimo che costituisce l’esito medioevale di una struttura paganica o municipale che<br />
dovette esistere in età romana 12 . Vi è, a mio parere, la concreta possibilità che sia questa la comunità<br />
e la città ricordata da Livio IX, 16, 1 come Ferentum (nome forse corrotto), conquistata dal<br />
console Q. Aulius Cerretanus nel corso di operazioni belliche cui segue la caduta di Lucera, e che<br />
quindi deve ragionevolmente essere collocata nel Sannio irpino o caudino: Aulius cum Ferentanis<br />
uno secondo proelio debellavit urbem ipsamque, quo se fusa contulerat acies, obsidibus imperatis in deditionem<br />
accepit. Occorre ricordare, poi, a questo proposito, la doppia tradizione della localizzazione<br />
della battaglia decisiva fra Pirro e i Romani nel 275 a. C.: mentre Plutarco la pone presso<br />
Benevento, la tradizione liviana, confluita in Floro e Orosio conosce quale località dello scontro<br />
i campi Arusini in Lucania. Frontino, poi, sostiene che la battaglia fu combattuta in campis<br />
Arusinis circa urbem Fatuentum, secondo il codice più antico, o Statuentum. C. Ferone ha dimostrato<br />
che questo toponimo Lucania è diverso da quello della grande Lucania e, in particolare, il<br />
commento dello scoliaste alla descrizione virgiliana della valles Ampsancti attesta inequivocabilmente<br />
che il toponimo Lucania era utilizzato per designare la regione in cui i Romani affrontarono<br />
Pirro. A questo punto, nulla vieta, anzi sembra a me probabile, che la Fatuentium urbem di<br />
Frontino possa identificarsi proprio con Frigento.<br />
La Chimera appare raffigurata, in Grecia, nelle monete d’argento di Corinto, Sicione e in<br />
quelle di Leucade, dipendenza corinzia in Acarnania e poi città principale di quella regione greca.