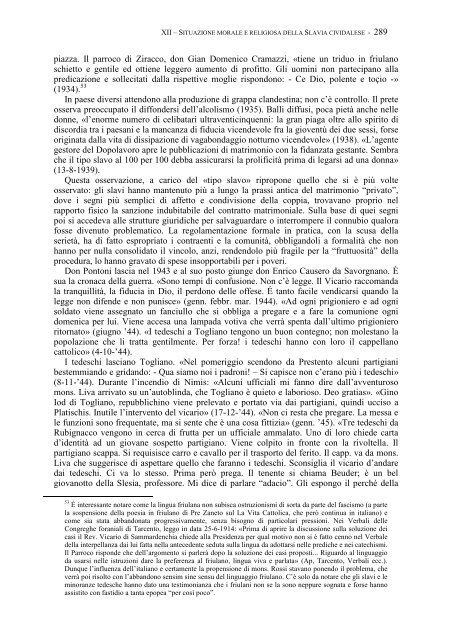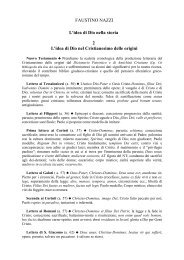Capitolo XII – Situazione morale e religiosa della Slavia cividalese
Capitolo XII – Situazione morale e religiosa della Slavia cividalese
Capitolo XII – Situazione morale e religiosa della Slavia cividalese
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
<strong>XII</strong> <strong>–</strong> SITUAZIONE MORALE E RELIGIOSA DELLA SLAVIA CIVIDALESE - 289<br />
piazza. Il parroco di Ziracco, don Gian Domenico Cramazzi, «tiene un triduo in friulano<br />
schietto e gentile ed ottiene leggero aumento di profitto. Gli uomini non partecipano alla<br />
predicazione e sollecitati dalla rispettive moglie rispondono: - Ce Dio, polente e toçio -»<br />
(1934). 53<br />
In paese diversi attendono alla produzione di grappa clandestina; non c’è controllo. Il prete<br />
osserva preoccupato il diffondersi dell’alcolismo (1935). Balli diffusi, poca pietà anche nelle<br />
donne, «l’enorme numero di celibatari ultraventicinquenni: la gran piaga oltre allo spirito di<br />
discordia tra i paesani e la mancanza di fiducia vicendevole fra la gioventù dei due sessi, forse<br />
originata dalla vita di dissipazione di vagabondaggio notturno vicendevole» (1938). «L’agente<br />
gestore del Dopolavoro apre le pubblicazioni di matrimonio con la fidanzata gestante. Sembra<br />
che il tipo slavo al 100 per 100 debba assicurarsi la prolificità prima di legarsi ad una donna»<br />
(13-8-1939).<br />
Questa osservazione, a carico del «tipo slavo» ripropone quello che si è più volte<br />
osservato: gli slavi hanno mantenuto più a lungo la prassi antica del matrimonio “privato”,<br />
dove i segni più semplici di affetto e condivisione <strong>della</strong> coppia, trovavano proprio nel<br />
rapporto fisico la sanzione indubitabile del contratto matrimoniale. Sulla base di quei segni<br />
poi si accedeva alle strutture giuridiche per salvaguardare o interrompere il connubio qualora<br />
fosse divenuto problematico. La regolamentazione formale in pratica, con la scusa <strong>della</strong><br />
serietà, ha di fatto espropriato i contraenti e la comunità, obbligandoli a formalità che non<br />
hanno per nulla consolidato il vincolo, anzi, rendendolo più fragile per la “fruttuosità” <strong>della</strong><br />
procedura, lo hanno gravato di spese insopportabili per i poveri.<br />
Don Pontoni lascia nel 1943 e al suo posto giunge don Enrico Causero da Savorgnano. É<br />
sua la cronaca <strong>della</strong> guerra. «Sono tempi di confusione. Non c’è legge. Il Vicario raccomanda<br />
la tranquillità, la fiducia in Dio, il perdono delle offese. É tanto facile vendicarsi quando la<br />
legge non difende e non punisce» (genn. febbr. mar. 1944). «Ad ogni prigioniero e ad ogni<br />
soldato viene assegnato un fanciullo che si obbliga a pregare e a fare la comunione ogni<br />
domenica per lui. Viene accesa una lampada votiva che verrà spenta dall’ultimo prigioniero<br />
ritornato» (giugno ’44). «I tedeschi a Togliano tengono un buon contegno; non molestano la<br />
popolazione che li tratta gentilmente. Per forza! i tedeschi hanno con loro il cappellano<br />
cattolico» (4-10-’44).<br />
I tedeschi lasciano Togliano. «Nel pomeriggio scendono da Prestento alcuni partigiani<br />
bestemmiando e gridando: - Qua siamo noi i padroni! <strong>–</strong> Si capisce non c’erano più i tedeschi»<br />
(8-11-’44). Durante l’incendio di Nimis: «Alcuni ufficiali mi fanno dire dall’avventuroso<br />
mons. Liva arrivato su un’autoblinda, che Togliano è quieto e laborioso. Deo gratias». «Gino<br />
Iod di Togliano, repubblichino viene prelevato e portato via dai partigiani, quindi ucciso a<br />
Platischis. Inutile l’intervento del vicario» (17-12-’44). «Non ci resta che pregare. La messa e<br />
le funzioni sono frequentate, ma si sente che è una cosa fittizia» (genn. ’45). «Tre tedeschi da<br />
Rubignacco vengono in cerca di frutta per un ufficiale ammalato. Uno di loro chiede carta<br />
d’identità ad un giovane sospetto partigiano. Viene colpito in fronte con la rivoltella. Il<br />
partigiano scappa. Si requisisce carro e cavallo per il trasporto del ferito. Il capp. va da mons.<br />
Liva che suggerisce di aspettare quello che faranno i tedeschi. Sconsiglia il vicario d’andare<br />
dai tedeschi. Ci va lo stesso. Prima però prega. Il tenente si chiama Beuder; è un bel<br />
giovanotto <strong>della</strong> Slesia, professore. Mi dice di parlare “adacio”. Gli espongo il perché <strong>della</strong><br />
53 É interessante notare come la lingua friulana non subisca ostruzionismi di sorta da parte del fascismo (a parte<br />
la sospensione <strong>della</strong> poesia in friulano di Pre Zaneto sul La Vita Cattolica, che però continua in italiano) e<br />
come sia stata abbandonata progressivamente, senza bisogno di particolari pressioni. Nei Verbali delle<br />
Congreghe foraniali di Tarcento, leggo in data 25-6-1914: «Prima di aprire la discussione sulla soluzione dei<br />
casi il Rev. Vicario di Sammardenchia chiede alla Presidenza per qual motivo non si è fatto cenno nel Verbale<br />
<strong>della</strong> interpellanza dai lui fatta nella antecedente seduta sulla lingua da adottarsi nelle prediche e nei catechismi.<br />
Il Parroco risponde che dell’argomento si parlerà dopo la soluzione dei casi proposti... Riguardo al linguaggio<br />
da usarsi nelle istruzioni dare la preferenza al friulano, lingua viva e parlata» (Ap, Tarcento, Verbali ecc.).<br />
Dunque l’influenza dell’italiano e certamente la propensione di mons. Rossi stavano ponendo il problema, che<br />
verrà poi risolto con l’abbandono sensim sine sensu del linguaggio friulano. C’è solo da notare che gli slavi e le<br />
minoranze tedesche hanno dato una testimonianza che i friulani non se la sono neppure sognata e forse hanno<br />
assistito con fastidio a tanta epopea “per così poco”.