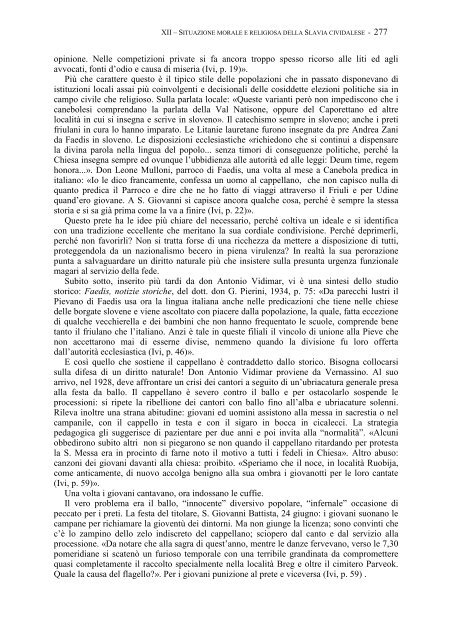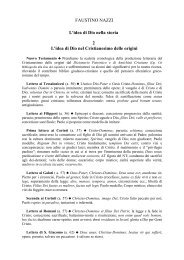Capitolo XII – Situazione morale e religiosa della Slavia cividalese
Capitolo XII – Situazione morale e religiosa della Slavia cividalese
Capitolo XII – Situazione morale e religiosa della Slavia cividalese
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>XII</strong> <strong>–</strong> SITUAZIONE MORALE E RELIGIOSA DELLA SLAVIA CIVIDALESE - 277<br />
opinione. Nelle competizioni private si fa ancora troppo spesso ricorso alle liti ed agli<br />
avvocati, fonti d’odio e causa di miseria (Ivi, p. 19)».<br />
Più che carattere questo è il tipico stile delle popolazioni che in passato disponevano di<br />
istituzioni locali assai più coinvolgenti e decisionali delle cosiddette elezioni politiche sia in<br />
campo civile che religioso. Sulla parlata locale: «Queste varianti però non impediscono che i<br />
canebolesi comprendano la parlata <strong>della</strong> Val Natisone, oppure del Caporettano ed altre<br />
località in cui si insegna e scrive in sloveno». Il catechismo sempre in sloveno; anche i preti<br />
friulani in cura lo hanno imparato. Le Litanie lauretane furono insegnate da pre Andrea Zani<br />
da Faedis in sloveno. Le disposizioni ecclesiastiche «richiedono che si continui a dispensare<br />
la divina parola nella lingua del popolo... senza timori di conseguenze politiche, perché la<br />
Chiesa insegna sempre ed ovunque l’ubbidienza alle autorità ed alle leggi: Deum time, regem<br />
honora...». Don Leone Mulloni, parroco di Faedis, una volta al mese a Canebola predica in<br />
italiano: «Io le dico francamente, confessa un uomo al cappellano, che non capisco nulla di<br />
quanto predica il Parroco e dire che ne ho fatto di viaggi attraverso il Friuli e per Udine<br />
quand’ero giovane. A S. Giovanni si capisce ancora qualche cosa, perché è sempre la stessa<br />
storia e si sa già prima come la va a finire (Ivi, p. 22)».<br />
Questo prete ha le idee più chiare del necessario, perché coltiva un ideale e si identifica<br />
con una tradizione eccellente che meritano la sua cordiale condivisione. Perché deprimerli,<br />
perché non favorirli? Non si tratta forse di una ricchezza da mettere a disposizione di tutti,<br />
proteggendola da un nazionalismo becero in piena virulenza? In realtà la sua perorazione<br />
punta a salvaguardare un diritto naturale più che insistere sulla presunta urgenza funzionale<br />
magari al servizio <strong>della</strong> fede.<br />
Subito sotto, inserito più tardi da don Antonio Vidimar, vi è una sintesi dello studio<br />
storico: Faedis, notizie storiche, del dott. don G. Pierini, 1934, p. 75: «Da parecchi lustri il<br />
Pievano di Faedis usa ora la lingua italiana anche nelle predicazioni che tiene nelle chiese<br />
delle borgate slovene e viene ascoltato con piacere dalla popolazione, la quale, fatta eccezione<br />
di qualche vecchierella e dei bambini che non hanno frequentato le scuole, comprende bene<br />
tanto il friulano che l’italiano. Anzi è tale in queste filiali il vincolo di unione alla Pieve che<br />
non accettarono mai di esserne divise, nemmeno quando la divisione fu loro offerta<br />
dall’autorità ecclesiastica (Ivi, p. 46)».<br />
E così quello che sostiene il cappellano è contraddetto dallo storico. Bisogna collocarsi<br />
sulla difesa di un diritto naturale! Don Antonio Vidimar proviene da Vernassino. Al suo<br />
arrivo, nel 1928, deve affrontare un crisi dei cantori a seguito di un’ubriacatura generale presa<br />
alla festa da ballo. Il cappellano è severo contro il ballo e per ostacolarlo sospende le<br />
processioni: si ripete la ribellione dei cantori con ballo fino all’alba e ubriacature solenni.<br />
Rileva inoltre una strana abitudine: giovani ed uomini assistono alla messa in sacrestia o nel<br />
campanile, con il cappello in testa e con il sigaro in bocca in cicalecci. La strategia<br />
pedagogica gli suggerisce di pazientare per due anni e poi invita alla “normalità”. «Alcuni<br />
obbedirono subito altri non si piegarono se non quando il cappellano ritardando per protesta<br />
la S. Messa era in procinto di farne noto il motivo a tutti i fedeli in Chiesa». Altro abuso:<br />
canzoni dei giovani davanti alla chiesa: proibito. «Speriamo che il noce, in località Ruobija,<br />
come anticamente, di nuovo accolga benigno alla sua ombra i giovanotti per le loro cantate<br />
(Ivi, p. 59)».<br />
Una volta i giovani cantavano, ora indossano le cuffie.<br />
Il vero problema era il ballo, “innocente” diversivo popolare, “infernale” occasione di<br />
peccato per i preti. La festa del titolare, S. Giovanni Battista, 24 giugno: i giovani suonano le<br />
campane per richiamare la gioventù dei dintorni. Ma non giunge la licenza; sono convinti che<br />
c’è lo zampino dello zelo indiscreto del cappellano; sciopero dal canto e dal servizio alla<br />
processione. «Da notare che alla sagra di quest’anno, mentre le danze fervevano, verso le 7,30<br />
pomeridiane si scatenò un furioso temporale con una terribile grandinata da compromettere<br />
quasi completamente il raccolto specialmente nella località Breg e oltre il cimitero Parveok.<br />
Quale la causa del flagello?». Per i giovani punizione al prete e viceversa (Ivi, p. 59) .