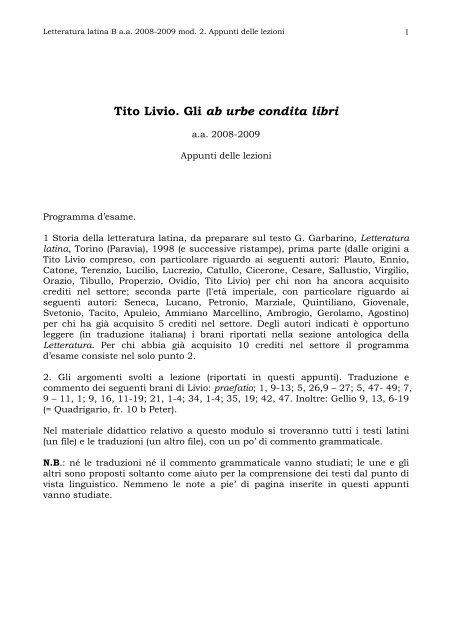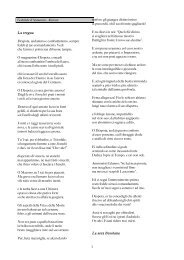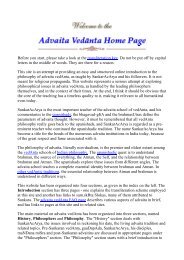Tito Livio. Gli ab urbe condita libri - Facoltà di Lettere e Filosofia
Tito Livio. Gli ab urbe condita libri - Facoltà di Lettere e Filosofia
Tito Livio. Gli ab urbe condita libri - Facoltà di Lettere e Filosofia
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Letteratura latina B a.a. 2008-2009 mod. 2. Appunti delle lezioni 1<br />
Programma d’esame.<br />
<strong>Tito</strong> <strong>Livio</strong>. <strong>Gli</strong> <strong>ab</strong> <strong>urbe</strong> <strong>con<strong>di</strong>ta</strong> <strong>libri</strong><br />
a.a. 2008-2009<br />
Appunti delle lezioni<br />
1 Storia della letteratura latina, da preparare sul testo G. Garbarino, Letteratura<br />
latina, Torino (Paravia), 1998 (e successive ristampe), prima parte (dalle origini a<br />
<strong>Tito</strong> <strong>Livio</strong> compreso, con particolare riguardo ai seguenti autori: Plauto, Ennio,<br />
Catone, Terenzio, Lucilio, Lucrezio, Catullo, Cicerone, Cesare, Sallustio, Virgilio,<br />
Orazio, Tibullo, Properzio, Ovi<strong>di</strong>o, <strong>Tito</strong> <strong>Livio</strong>) per chi non ha ancora acquisito<br />
cre<strong>di</strong>ti nel settore; seconda parte (l'età imperiale, con particolare riguardo ai<br />
seguenti autori: Seneca, Lucano, Petronio, Marziale, Quintiliano, Giovenale,<br />
Svetonio, Tacito, Apuleio, Ammiano Marcellino, Ambrogio, Gerolamo, Agostino)<br />
per chi ha già acquisito 5 cre<strong>di</strong>ti nel settore. Degli autori in<strong>di</strong>cati è opportuno<br />
leggere (in traduzione italiana) i brani riportati nella sezione antologica della<br />
Letteratura. Per chi <strong>ab</strong>bia già acquisito 10 cre<strong>di</strong>ti nel settore il programma<br />
d’esame consiste nel solo punto 2.<br />
2. <strong>Gli</strong> argomenti svolti a lezione (riportati in questi appunti). Traduzione e<br />
commento dei seguenti brani <strong>di</strong> <strong>Livio</strong>: praefatio; 1, 9-13; 5, 26,9 – 27; 5, 47- 49; 7,<br />
9 – 11, 1; 9, 16, 11-19; 21, 1-4; 34, 1-4; 35, 19; 42, 47. Inoltre: Gellio 9, 13, 6-19<br />
(= Quadrigario, fr. 10 b Peter).<br />
Nel materiale <strong>di</strong>dattico relativo a questo modulo si troveranno tutti i testi latini<br />
(un file) e le traduzioni (un altro file), con un po’ <strong>di</strong> commento grammaticale.<br />
N.B.: né le traduzioni né il commento grammaticale vanno stu<strong>di</strong>ati; le une e gli<br />
altri sono proposti soltanto come aiuto per la comprensione dei testi dal punto <strong>di</strong><br />
vista linguistico. Nemmeno le note a pie’ <strong>di</strong> pagina inserite in questi appunti<br />
vanno stu<strong>di</strong>ate.
Letteratura latina B a.a. 2008-2009 mod. 2. Appunti delle lezioni 2<br />
NOTIZIE SULL’AUTORE. ATTIVITÀ LETTERARIA<br />
<strong>Tito</strong> <strong>Livio</strong> si può considerare lo storico “ciceroniano” per eccellenza: nella sua opera<br />
appaiono infatti accolti ed applicati i precetti teorici sulla storiografia esposti da<br />
Cicerone 1, che si possono riassumere e sintetizzare nella formula historia opus oratorium:<br />
<strong>Livio</strong> non è solo un narrator, ma anche, o soprattutto, un exornator rerum.<br />
Data <strong>di</strong> nascita. Delle vicende biografiche e dell’attività letteraria <strong>di</strong> <strong>Livio</strong> le fonti<br />
antiche <strong>di</strong>cono assai poco. La parte conservata della sua opera storica giunge soltanto al<br />
167 a.C.: i cenni <strong>di</strong> carattere autobiografico, che lo storico potrebbe aver inserito nella<br />
narrazione degli eventi a lui contemporanei, sono andati perduti.<br />
Le incertezze sulla sua biografia iniziano forse con la data <strong>di</strong> nascita, tramandata<br />
da Girolamo 2 sotto l’anno 1958 <strong>di</strong> Abramo, corrispondente al 59 a.C., ma messa in<br />
dubbio perché associata a quella <strong>di</strong> Messala Corvino. Girolamo <strong>di</strong>ce: Messala Corvinus<br />
orator nascitur et Titus Livius Patavinus scriptor historicus. Nel 59 a.C. dunque “nascono<br />
Messala Corvino oratore e <strong>Tito</strong> <strong>Livio</strong> <strong>di</strong> Padova, storiografo”.<br />
Messala Corvino è il fondatore del circolo letterario cui appartennero, tra gli altri,<br />
Tibullo e Ovi<strong>di</strong>o da giovane. Per questo personaggio la data <strong>di</strong> nascita in<strong>di</strong>cata da<br />
Gerolamo potrebbe essere sbagliata. Messala Corvino fu infatti un uomo politico, e<br />
alcune tappe del suo cursus honorum ci sono note: in particolare, sappiamo che fu<br />
console nel 31 a.C., ad un’età – se nacque nel 59 a.C. - troppo giovane, inferiore a quella<br />
(30 anni) fissata dalla riforma sillana non per il consolato (che era, a quanto pare, <strong>di</strong> 43<br />
anni), ma per iniziare il cursus honorum. Si ritiene perciò opportuno anticipare <strong>di</strong> alcuni<br />
anni la data <strong>di</strong> nascita <strong>di</strong> Messala, precisamente al 64 a.C. In questo anno infatti i nomi<br />
dei consoli (che come è noto venivano comunemente usati per in<strong>di</strong>care l’anno) sono molto<br />
simili a quelli dei consoli dell’anno 59: Cesare e Figulo nel 64 e Cesare e Bibulo nel 59.<br />
Girolamo, o la sua fonte, potrebbe aver confuso i nomi dei consoli dei due anni; ne<br />
conseguirebbe che anche per <strong>Livio</strong> la data <strong>di</strong> nascita vada spostata al 64 a.C. Come si<br />
vede, non si tratta <strong>di</strong> un argomento cogente: le norme per il cursus honorum fissate da<br />
Silla furono spesso violate, soprattutto negli ultimi tempi della repubblica; inoltre, se per<br />
1 In de or. II, 1-64 e de leg. I, 1-10.<br />
2 Girolamo (347-420 d.C.) tradusse dal greco il Chronicon <strong>di</strong> Eusebio <strong>di</strong> Cesarea (265-340 d.C.),<br />
un’opera in cui i principali avvenimenti della storia universale erano <strong>di</strong>sposti in tavole<br />
cronologiche sincroniche, a partire da Abramo (2016-2015 a.C.). Nella sua traduzione Girolamo<br />
mantenne il medesimo punto <strong>di</strong> partenza cronologico, e arricchì il testo con molte notizie relative<br />
alla storia e alla letteratura romane; per queste si servì del de viris illustribus <strong>di</strong> Svetonio; inoltre<br />
proseguì l’esposizione dal 325 d.C., anno a cui si fermava l’opera <strong>di</strong> Eusebio, fino al 378.
Letteratura latina B a.a. 2008-2009 mod. 2. Appunti delle lezioni 3<br />
Messala la data <strong>di</strong> nascita può essere sbagliata, ciò non comporta necessariamente che<br />
lo sia anche per <strong>Livio</strong> 3.<br />
Morte. Sotto l’anno 2033 (= 17 d.C.) Girolamo registra la morte dello storico:<br />
Livius historiographus Patăvi moritur, “muore a Padova lo storiografo <strong>Livio</strong>”. Il luogo <strong>di</strong><br />
nascita è confermato da altre fonti antiche 4, e dalla famosa accusa <strong>di</strong> Patavinitas, su cui<br />
torneremo, mossa allo storico da Asinio Pollione.<br />
Opere filosofiche. Le notizie che si possono inserire fra le due date tramandate da<br />
Girolamo non sono molte. Il nome <strong>di</strong> <strong>Livio</strong> è legato all’opera storica, ma alcune<br />
testimonianze antiche in<strong>di</strong>cano che egli ebbe interessi, e svolse attività letteraria, anche<br />
in campi <strong>di</strong>versi da quello della storiografia. Seneca gli attribuisce la composizione <strong>di</strong><br />
<strong>di</strong>alogi e <strong>di</strong> <strong>libri</strong> <strong>di</strong> filosofia: scripsit <strong>di</strong>alogos, quos non magis philosophiae adnumerare<br />
possis quam historiae, et ex professo philosophiam continentis libros (ep. ad Luc. 100,9),<br />
“scrisse <strong>di</strong>aloghi che si potrebbero assegnare tanto alla filosofia quanto alla storia, e <strong>libri</strong><br />
<strong>di</strong> contenuto propriamente filosofico”.<br />
I <strong>di</strong>aloghi <strong>di</strong> argomento filosofico e storico insieme potrebbero essere, sul modello<br />
dei <strong>di</strong>aloghi ciceroniani, scritti in cui personaggi storici reali sia espongono e <strong>di</strong>scutono le<br />
<strong>di</strong>verse opinioni delle scuole filosofiche, sull’etica (per es. de finibus), sulla teoria della<br />
conoscenza (per es. Academica), sugli dèi (de natura deorum), sia analizzano, con<br />
riferimenti concreti agli stati reali e soprattutto a quello romano e alla sua storia, temi<br />
quali la funzione della giustizia nella vita civile, la miglior forma <strong>di</strong> governo, le doti del<br />
princeps, ecc. (gli argomenti trattati nel de republica e nel de legibus). Dai <strong>di</strong>aloghi Seneca<br />
<strong>di</strong>stingue <strong>libri</strong> propriamente filosofici: forse la <strong>di</strong>fferenza era soprattutto <strong>di</strong> forma (trattati,<br />
sul modello ciceroniano del de officiis). In ogni caso, si trae con certezza dall’accenno <strong>di</strong><br />
Seneca uno spiccato interesse <strong>di</strong> <strong>Livio</strong> per la filosofia, cui de<strong>di</strong>cò opere apposite.<br />
Opinioni sullo stile. Anche sull’eloquenza <strong>Livio</strong> espresse – non sappiamo se in<br />
opere apposite, come Cicerone – le proprie opinioni, come si deduce da qualche accenno<br />
<strong>di</strong> Quintiliano e <strong>di</strong> Seneca Padre. Accingendosi ad in<strong>di</strong>care quali autori l’oratore debba<br />
leggere per trarne giovamento, smarrito <strong>di</strong> fronte alla vastità del compito che sta per<br />
affrontare, Quintiliano osserva: Fuit igitur brevitas illa tutissima, quae est apud Livium in<br />
epistula ad filium scripta, legendos Demosthenen atque Ciceronem, tum ita ut quisque<br />
esset Demstheni aut Ciceroni simillimus (10,1,39), “Molto sicuro fu quel breve consiglio<br />
che <strong>Livio</strong> <strong>di</strong>ede in una lettera al figlio, <strong>di</strong> leggere Demostene e Cicerone, e poi tutti quelli<br />
che più si avvicinavano a Demostene e a Cicerone”. L’ammirazione per i modelli più alti e<br />
in<strong>di</strong>scussi nel campo dell’eloquenza si univa all’esigenza della chiarezza nell’esposizione,<br />
3 In genere in effetti si accetta la correzione della data <strong>di</strong> Girolamo soltanto per Messala.<br />
4 Plutarco, Caes., 47,3; cf. Marziale I,61,3, che parla della Apǒni tellus (Abano), che deve la sua<br />
fama al “suo <strong>Livio</strong>”, e Stazio, Silvae IV,7,55-56, che accosta a Sallustio il Timāvi /alumnum, “il<br />
figlio del Timavo”.
Letteratura latina B a.a. 2008-2009 mod. 2. Appunti delle lezioni 4<br />
come sembra <strong>di</strong> poter dedurre da un altro breve accenno <strong>di</strong> Quintiliano, che<br />
condannando coloro che <strong>di</strong> proposito rendono oscuro il loro eloquio osserva: Neque id<br />
vitium novum est, cum iam apud Titum Livium inveniam fuisse praeceptorem aliquem qui<br />
<strong>di</strong>scipulos obscurare quae <strong>di</strong>cerent iuberet, Graeco verbo utens sko/tison. Unde illa scilicet<br />
egregia laudatio: ‘tanto melior: ne ego quidem intellexi’ (8,2,18), “E questo <strong>di</strong>fetto non è<br />
nuovo, giacché già in <strong>Tito</strong> <strong>Livio</strong> trovo che vi fu un maestro che prescriveva ai suoi allievi<br />
<strong>di</strong> rendere oscuro ciò che <strong>di</strong>cevano, usando il voc<strong>ab</strong>olo greco sko/tison. Di qui quell’elogio<br />
davvero straor<strong>di</strong>nario: ‘sei migliorato davvero! Nemmeno io ho capito!’ ”<br />
Che anche <strong>Livio</strong> <strong>di</strong>sapprovasse questo precetto (parlare in modo oscuro) sembra<br />
confermato da un passo <strong>di</strong> Seneca Padre, che riferisce che <strong>Livio</strong> si prendeva gioco <strong>di</strong><br />
quegli oratori qui verba antiqua et sor<strong>di</strong>da consectantur et orationis obscuritatem<br />
severitatem putant (contr. 9,2,26), “che vanno in cerca <strong>di</strong> voc<strong>ab</strong>oli arcaici e volgari, e<br />
ritengono che un <strong>di</strong>scorso oscuro sia un <strong>di</strong>scorso solenne”.<br />
Anche l’eccessiva concisione poteva rendere il <strong>di</strong>scorso oscuro, ed era condannata<br />
da <strong>Livio</strong>, come si può dedurre da un suo giu<strong>di</strong>zio su Sallustio, ricordato da Seneca Padre,<br />
che lo considera malevolo. Dopo aver menzionato una frase <strong>di</strong> Tuci<strong>di</strong>de, che Sallustio<br />
avrebbe tradotto riuscendo ad essere ancora più conciso del modello, e vincendolo<br />
dunque sul suo stesso terreno5, Seneca aggiunge: T. autem Livius tam iniquus Sallustio<br />
fuit ut hanc ipsam sententiam et tamquam translatam et tamquam corruptam dum<br />
transfertur obiceret Sallustio. Nec hoc amore Thucy<strong>di</strong><strong>di</strong>s facit, ut illum praeferat, sed laudat<br />
quem non timet et facilius putat posse a se Sallustium vinci si ante a Thucy<strong>di</strong>de vincatur.<br />
(contr. IX,1,14), “Ma <strong>Tito</strong> <strong>Livio</strong> è così ingiusto nei confronti <strong>di</strong> Sallustio da rimproverargli<br />
sia <strong>di</strong> aver tradotto questa frase, sia <strong>di</strong> averla rovinata traducendola. E fa questo non per<br />
5 Contr. IX,1,13: Multa oratores, historici, poetae Romani a Graecis <strong>di</strong>cta non subripuerunt sed<br />
provocaverunt. Tunc deinde rettulit (sc. Arellio Fusco) aliquam Thucy<strong>di</strong><strong>di</strong>s sententiam: deinaiì ga\r ai¸<br />
eu)praci¿ai sugkru/yai kaiì suskia/sai ta\ e(ka/stwn a(marth/mata, deinde Sallustianam: res secundae mire<br />
sunt vitiis obtentui. [Hist. 1,55 (or. Lep.), 24]. Cum sit praecipua in Thucy<strong>di</strong>de virtus brevitas, hac<br />
eum Sallustius vicit et in suis illum castris ceci<strong>di</strong>t; nam in sententia Graeca tam brevi h<strong>ab</strong>es quae<br />
salvo sensu detrahas: deme vel sugkru/yai vel suskia/sai, deme e(ka/stwn: const<strong>ab</strong>it sensus, etiamsi<br />
non aeque comptus, aeque tamen integer. At ex Sallusti sententia nihil demi sine detrimento sensus<br />
potest., “In molti casi oratori, storici, poeti romani non hanno rubato ai Greci le loro parole, ma si<br />
sono posti in competizione con loro. Riferì quin<strong>di</strong> una frase <strong>di</strong> Tuci<strong>di</strong>de: ‘I successi in effetti sono<br />
efficaci per nascondere e mettere in ombra gli errori <strong>di</strong> ciascuno’, e poi una <strong>di</strong> Sallustio: ‘I successi<br />
fanno mir<strong>ab</strong>ilmente da schermo ai vizi’. Benché la brevità sia la dote precipua <strong>di</strong> Tuci<strong>di</strong>de,<br />
Sallustio con questa frase lo ha superato, e lo ha sbaragliato nel suo campo stesso. Nella frase<br />
greca, pur così breve, ci sono parole che si possono togliere senza danneggiare il senso: togli<br />
nascondere o mettere in ombra, togli <strong>di</strong> ciascuno; il senso sopravviverà, anche se non egualmente<br />
adorno, tuttavia egualmente compiuto. Dalla frase <strong>di</strong> Sallustio invece nulla si può togliere senza<br />
che il senso ne sia danneggiato”. La “frase <strong>di</strong> Tuci<strong>di</strong>de” non compare nell’opera giunta a noi; una<br />
formulazione molto simile, ma non identica, si legge invece in una epistola a Filippo <strong>di</strong> (o<br />
attribuita a) Demostene, ep. Phil. 13: ai( ga\r eu)praci/ai deinai\ sugkru/yai kaiì suskia/sai ta\j a(marti/aj<br />
tw=n a)nqrw/pwn ei)si/n.
Letteratura latina B a.a. 2008-2009 mod. 2. Appunti delle lezioni 5<br />
amore <strong>di</strong> Tuci<strong>di</strong>de, per anteporlo a Sallustio, ma loda un autore che non teme, e ritiene<br />
<strong>di</strong> poter più facilmente superare Sallustio, se prima Sallustio è superato da Tuci<strong>di</strong>de.”<br />
Le testimonianze <strong>di</strong> Quintiliano e <strong>di</strong> Seneca Padre in<strong>di</strong>cano soltanto la posizione <strong>di</strong><br />
<strong>Livio</strong> nei confronti <strong>di</strong> una tendenza dell’eloquenza contemporanea: egli condannava<br />
l’oscurità arcaizzante, ed era favorevole a modelli classici, quali Demostene e Cicerone.<br />
Anche il giu<strong>di</strong>zio su Sallustio, forse malevolo, va nella medesima <strong>di</strong>rezione. Da questi<br />
pochi dati non si può dedurre che <strong>Livio</strong> avesse scritto opere <strong>di</strong> retorica; si potrebbe<br />
piuttosto pensare ad una attività <strong>di</strong> retore professionale, o quasi: <strong>Livio</strong> avrebbe cioè<br />
frequentato le scuole <strong>di</strong> retorica, e tenuto declamazioni. Un’ultima testimonianza <strong>di</strong><br />
Seneca Padre parrebbe appoggiare questa ipotesi: pertinere ad rem non puto quomodo<br />
Lucius Magius, gener Titi Livi, declamaverit, quamvis aliquo tempore suum populus<br />
h<strong>ab</strong>uerit, cum illum homines non in ipsius honorem laudarent, sed in soceri fere (contr. X,<br />
pr.2), “non mette conto valutare le qualità <strong>di</strong> declamatore <strong>di</strong> Lucio Magio, genero <strong>di</strong> <strong>Tito</strong><br />
<strong>Livio</strong>, per quanto egli <strong>ab</strong>bia avuto per un certo tempo un suo pubblico: la gente infatti<br />
prob<strong>ab</strong>ilmente lo applau<strong>di</strong>va per rendere onore non a lui ma al suocero”.<br />
E’ però possibile, anzi prob<strong>ab</strong>ile, che fosse la fama <strong>di</strong> <strong>Livio</strong> storico, non<br />
declamatore, che procurava al genero consensi che Seneca giu<strong>di</strong>ca non del tutto meritati.<br />
Dalle testimonianze <strong>di</strong> Quintiliano e Seneca Padre si ricava anche, in<strong>di</strong>rettamente, che lo<br />
storico ebbe un figlio e una figlia.<br />
Rapporti con Augusto. Sui rapporti <strong>di</strong> amicizia <strong>di</strong> <strong>Livio</strong> con Augusto <strong>ab</strong>biamo una<br />
testimonianza famosa <strong>di</strong> Tacito, che a Cremuzio Cordo, uno storico processato sotto<br />
Tiberio per aver elogiato nella sua opera storica i cesarici<strong>di</strong>, fa pronunciare queste parole:<br />
Titus Livius, eloquentiae et fidei praeclarus in primis, Gnaeum Pompeium tantis lau<strong>di</strong>bus<br />
tulit ut Pompeianum eum Augustum appellaret neque id eorum amicitiae offecit (ann. IV,34),<br />
“<strong>Tito</strong> <strong>Livio</strong>, autore fra i più illustri per eloquenza e per atten<strong>di</strong>bilità, esaltò con tanto<br />
entusiasmo Pompeo che Augusto lo chiamava ‘Pompeiano’: ma questo non guastò la loro<br />
amicizia”.<br />
Svetonio (Claud. 41,1) ricorda che da giovane Clau<strong>di</strong>o fu incoraggiato da <strong>Livio</strong> a<br />
coltivare i suoi interessi per la storiografia, e a comporre un’opera storica per la quale gli<br />
fornì aiuto e consiglio: ciò conferma i rapporti <strong>di</strong> <strong>di</strong>mestichezza e amicizia dello storico<br />
con la corte.<br />
Queste sono tutte le notizie che gli antichi hanno tramandato su <strong>Tito</strong> <strong>Livio</strong>:<br />
certamente egli non intraprese la carriera politica, ma de<strong>di</strong>cò l’intera sua vita alla<br />
composizione della sua monumentale opera storica.<br />
La città natale esercitò indubbiamente su <strong>di</strong> lui una forte influenza. Padova, che la<br />
tra<strong>di</strong>zione voleva fondata da Antenore, profugo troiano, prima <strong>di</strong> Roma (al tempo<br />
all’incirca in cui Enea approdava sulle coste del Lazio), era al tempo <strong>di</strong> <strong>Livio</strong> un centro
Letteratura latina B a.a. 2008-2009 mod. 2. Appunti delle lezioni 6<br />
commerciale assai fiorente e ricco; aveva anche fama – in contrasto con Roma – <strong>di</strong> essere<br />
<strong>di</strong> costumi molto morigerati e severi. Parlando <strong>di</strong> una matrona <strong>di</strong> origine padovana<br />
modello <strong>di</strong> modestia e <strong>di</strong> virtù, così si esprime Plinio il Giovane: “Serrana è persino per i<br />
Padovani un modello <strong>di</strong> austerità” (ep.1,14,6).<br />
Con<strong>di</strong>zione sociale ed educazione. La famiglia doveva essere <strong>di</strong> con<strong>di</strong>zioni agiate:<br />
<strong>Livio</strong> ricevette infatti evidentemente una buona educazione, e poté de<strong>di</strong>care tutta la vita<br />
agli stu<strong>di</strong> e all’attività letteraria senza preoccupazioni economiche. Dovette ricevere a<br />
Padova i primi elementi della sua istruzione, o forse, più prob<strong>ab</strong>ilmente, a Padova<br />
frequentò l’intero ciclo <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>: ludus, scuola del grammaticus e scuola del rhetor. <strong>Gli</strong><br />
allievi più ricchi e più dotati in genere completavano a Roma la loro istruzione (scuola del<br />
rhetor); ma quando <strong>Livio</strong> aveva l’età (circa 16 anni) a cui <strong>di</strong> solito si iniziava a frequentare<br />
la scuola <strong>di</strong> retorica, non era forse il momento più adatto per mandare un ragazzo a<br />
stu<strong>di</strong>are nella capitale (secondo la cronologia alta, n. 64, infuriava la guerra civile fra<br />
Cesare e Pompeo; secondo quella bassa, n. 59, la guerra contro i cesarici<strong>di</strong> e poi tra<br />
Ottaviano e Antonio). Forse non compì neppure il viaggio in Grecia, che spesso<br />
concludeva il corso <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>: i pirati <strong>di</strong> Sesto Pompeo infestavano i mari, e i viaggi erano<br />
pericolosi.<br />
Patavinitas. La Patavinitas infine, a qualunque caratteristica si riferisca, sembra<br />
in<strong>di</strong>care che <strong>Livio</strong> <strong>ab</strong>bia trascorso gli anni formativi nella città natale. Come attesta<br />
Quintiliano, “Asinio Pollione, ritiene che in <strong>Tito</strong> <strong>Livio</strong>, uomo <strong>di</strong> facon<strong>di</strong>a straor<strong>di</strong>naria, vi<br />
sia una certa qual patina padovana” 6. Il contesto in cui Quintiliano inserisce questa<br />
osservazione mostra che egli riferiva il giu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong> Pollione a caratterisitiche linguistiche,<br />
che avrebbero rivelato l’origine padovana dello scrittore. Ma Quintiliano non <strong>di</strong>ce in che<br />
cosa consistesse la “padovanità” <strong>di</strong> <strong>Livio</strong>, e forse non era in grado <strong>di</strong> rilevare nel latino <strong>di</strong><br />
<strong>Livio</strong> caratteri provinciali. E’ possibile che in realtà il rilievo <strong>di</strong> Pollione non riguardasse<br />
peculiarità <strong>di</strong> lingua o <strong>di</strong> stile, ma il moralismo, il conservatorismo <strong>di</strong> <strong>Livio</strong>, che ben si<br />
accordano con i costumi proverbialmente austeri della sua patria d’origine, e sono<br />
evidenti nella sua opera.<br />
Composizione dell’opera storica. A Roma comunque <strong>Livio</strong> si recò prima <strong>di</strong><br />
iniziare la composizione dell’ opera storica, forse anche per consultare testi che a Padova<br />
non erano <strong>di</strong>sponibili. Non <strong>ab</strong>biamo testimonianze certe che consentano <strong>di</strong> datare con<br />
precisione questo viaggio da Padova alla capitale, ma si può egualmente in<strong>di</strong>care come<br />
anno più prob<strong>ab</strong>ile il 30, o il 29. Il tono della prefazione generale dell’opera lascia<br />
supporre che <strong>Livio</strong> si accinga comporla per uno stato ormai in pace, per richiamare i<br />
citta<strong>di</strong>ni – conclusisi gli orrori delle guerre civili – ai mores <strong>di</strong> un tempo. Dopo Azio,<br />
6<br />
Et in <strong>Tito</strong> <strong>Livio</strong>, mirae facun<strong>di</strong>ae viro, putat inesse Pollio Asinius quandam Patavinitatem, Quint.<br />
8,1,3
Letteratura latina B a.a. 2008-2009 mod. 2. Appunti delle lezioni 7<br />
Ottaviano si apprestava a restaurare la pace: prob<strong>ab</strong>ilmente <strong>Livio</strong> intraprese il viaggio a<br />
Roma solo dopo il 31, quando Antonio e Cleopatra erano stati definitivamente sconfitti.<br />
Forse era presente a Roma nell’estate del 29, e assistette al ritorno trionfale <strong>di</strong> Ottaviano<br />
dall’Oriente. Se è così, possiamo assegnare due anni alle ricerche preliminari, e alla<br />
composizione del primo libro, che fu pubblicato fra il 27, e il 25 (dopo il 27 e prima del<br />
25), come si deduce da un dato interno. In 1,19,3 <strong>Tito</strong> <strong>Livio</strong> scrive che fu il re Numa ad<br />
introdurre l’usanza <strong>di</strong> in<strong>di</strong>care con la chiusura o l’apertura del tempio <strong>di</strong> Giano se la città<br />
fosse in pace o in guerra. Fornita questa notizia, aggiunge che dopo il regno <strong>di</strong> Numa due<br />
volte soltanto, nella storia <strong>di</strong> Roma, il tempio fu chiuso: sotto il consolato <strong>di</strong> <strong>Tito</strong> Manlio,<br />
alla fine della prima guerra punica (241), e post bellum Actiacum <strong>ab</strong> imperatore Caesare<br />
Augusto pace terra marique parta, “dopo la guerra <strong>di</strong> Azio, quando la pace fu rist<strong>ab</strong>ilita<br />
per terra e per mare dall’imperatore Cesare Augusto”. Ottaviano assunse il titolo <strong>di</strong><br />
Augusto nel 27 (terminus post quem), e chiuse una seconda volta il tempio <strong>di</strong> Giano nel<br />
25 (terminus ante quem). E’ ovvio che in questo contesto <strong>Livio</strong> avrebbe menzionato questa<br />
nuova chiusura delle porte del tempio da parte <strong>di</strong> Augusto; si deduce dunque con<br />
certezza dal suo silenzio che il primo libro fu scritto, e prob<strong>ab</strong>ilmente pubblicato, prima<br />
<strong>di</strong> quella data.<br />
Libri conservati e periǒchae. L’opera, che giunse a 142 <strong>libri</strong>, copriva il periodo<br />
che va dalla fondazione <strong>di</strong> Roma (anzi dall’arrivo <strong>di</strong> Enea in Italia) alla morte <strong>di</strong> Druso,<br />
nel 9 a.C. Ne rimangono soltanto 35: 1-10 e 21-45 (relativi agli anni 754-293; e 219-167<br />
a.C.)<br />
Certamente la mole dell’opera non ne favorì la sopravvivenza: ben presto se ne<br />
fecero epitomi, compen<strong>di</strong>, estratti, e la maggior parte del testo originario andò perduto.<br />
Oltre ai <strong>libri</strong> in<strong>di</strong>cati, posse<strong>di</strong>amo le periǒchae <strong>di</strong> tutti i <strong>libri</strong> (tranne due 136 e 137): sono<br />
riassunti <strong>di</strong> breve o brevissima estensione, molto utili però non soltanto per conoscere il<br />
contenuto dei <strong>libri</strong> perduti, ma anche per avere un’idea del piano generale dell’opera.<br />
E’ molto prob<strong>ab</strong>ile che il primo libro, che <strong>ab</strong>braccia l’intero periodo regio, sia stato<br />
pubblicato separatamente. Il secondo libro infatti si apre con una nuova, breve<br />
prefazione. Con la pubblicazione del primo libro (oltre che, secondo l’uso, con letture<br />
pubbliche <strong>di</strong> brani nel corso della composizione) l’opera cui <strong>Livio</strong> stava lavorando <strong>di</strong>venne<br />
nota. Essa venne poi pubblicata, molto prob<strong>ab</strong>ilmente, a gruppi <strong>di</strong> <strong>libri</strong> (5 o 10), a mano<br />
a mano che veniva composta. Ogni gruppo <strong>di</strong> <strong>libri</strong> doveva aprirsi con una apposita<br />
prefazione o premessa 7. Certamente il principe seguiva con interesse il procedere del<br />
7 A volte si tratta solo <strong>di</strong> un breve riepilogo della parte già composta e <strong>di</strong> un annuncio del nuovo<br />
tema: così è ad es. l’introduzione al libro 2, che sottolinea il fondamentale passaggio dalla<br />
monarchia alla res publica; anche quella con cui si apre il libro 21, più solenne, sottopone al<br />
lettore l’importanza del tema che verrà trattato (la guerra annibalica, che occupa 10 <strong>libri</strong>),<br />
presentando i due popoli che si affrontarono, i motivi dell’ostilità, le alterne vicende del lungo
Letteratura latina B a.a. 2008-2009 mod. 2. Appunti delle lezioni 8<br />
lavoro; e informò tempestivamente lo storico <strong>di</strong> una importante scoperta archeologica,<br />
perché egli potesse inserire nella sua opera la notizia: cosa che <strong>Livio</strong> naturalmente fa 8,<br />
cogliendo l’occasione <strong>di</strong> tributare un elogio al principe, e anche <strong>di</strong> mostrare la sua grande<br />
<strong>di</strong>mestichezza con lui.<br />
conflitto e la sua conclusione. In altri casi invece la prefazione contiene considerazioni più<br />
personali, riguardanti l’atteggiamento dello storico verso la sua opera, e la <strong>di</strong>fficoltà del compito in<br />
cui è impegnato: <strong>di</strong> questo genere è la prefazione al libro 6, in cui <strong>Livio</strong> lamenta – con argomenti<br />
prob<strong>ab</strong>ilmente presi in prestito da Clau<strong>di</strong>o Quadrigario – la mancanza <strong>di</strong> documenti sicuri per il<br />
periodo antecedente l’incen<strong>di</strong>o gallico, <strong>di</strong> cui ha appena concluso il racconto, ed annuncia per la<br />
parte successiva un resoconto più sicuro, fondato sulla maggior <strong>di</strong>sponibilità <strong>di</strong> documenti<br />
atten<strong>di</strong>bili. Così la prefazione al libro 31, oltre a rilevare formalmente la cesura costituita dalla<br />
conclusione della seconda guerra punica narrata nella decade precedente, esprime lo sconforto<br />
dello storico per la mole del lavoro, che invece <strong>di</strong> ridursi cresce a <strong>di</strong>smisura a mano a mano che<br />
l’opera procede. Tono ancora più personale aveva a quanto pare la prefazione ad uno dei <strong>libri</strong><br />
perduti, in cui – come si apprende da Plinio il Vecchio, n.h. praef. 16 – lo storico <strong>di</strong>chiarava <strong>di</strong><br />
essersi ormai conquistato sufficiente gloria, ma che il suo animo inquieto gli impe<strong>di</strong>va <strong>di</strong> porre<br />
fine alla sua fatica. Evidentemente, alla maniera degli annalisti antichi, <strong>Livio</strong> non aveva un punto<br />
d’arrivo prefissato, ma procedeva seguendo la successione cronologica degli avvenimenti, per<br />
giungere fino all’età contemporanea.<br />
8 In 4,23,2.
Letteratura latina B a.a. 2008-2009 mod. 2. Appunti delle lezioni 9<br />
GLI AB URBE CONDITA LIBRI<br />
<strong>Tito</strong>lo Di solito le opere storiografiche <strong>di</strong> impianto annalistico, quale è quella <strong>di</strong><br />
<strong>Livio</strong>, si intitolavano annales oppure historiae 9. <strong>Livio</strong> scelse invece un titolo <strong>di</strong>verso da<br />
quelli più usuali, semplice e preciso, <strong>ab</strong> <strong>urbe</strong> <strong>con<strong>di</strong>ta</strong> <strong>libri</strong>. Era consuetu<strong>di</strong>ne <strong>ab</strong>bastanza<br />
<strong>di</strong>ffusa nella storiografia sia greca sia latina quella <strong>di</strong> iniziare l’esposizione dei fatti dal<br />
punto in cui si concludeva l’opera <strong>di</strong> un predecessore, oppure da una data prima della<br />
quale i fatti si supponevano noti o già sufficientemente trattati; a volte questo punto <strong>di</strong><br />
partenza veniva in<strong>di</strong>cato nel titolo, con un <strong>ab</strong>lativo <strong>di</strong> allontanamento. Possiamo citare,<br />
anche se più tarde <strong>di</strong> <strong>Livio</strong>, l’opera storica <strong>di</strong> Plinio il Vecchio (perduta) a fine Aufi<strong>di</strong>i<br />
Bassi; e gli annales <strong>di</strong> Tacito, il cui vero titolo era, forse, <strong>ab</strong> excessu <strong>di</strong>vi Augusti. <strong>Livio</strong><br />
non si riallaccia a nessun predecessore, e sceglie come punto <strong>di</strong> partenza l’inizio stesso<br />
della storia <strong>di</strong> Roma.<br />
Fonti documentarie. Si può affermare con certezza che per la sua opera storica<br />
<strong>Livio</strong> non fece ricorso né a documenti originali né in genere a ricerche <strong>di</strong> prima mano. I<br />
documenti che avrebbe potuto consultare a Roma erano:<br />
1. gli annales maximi, una raccolta in 80 volumi delle tavole annuali su cui il<br />
pontefice massimo annotava, anno dopo anno, i fatti <strong>di</strong> maggior importanza (esito <strong>di</strong> una<br />
campagna militare, pro<strong>di</strong>gi, andamento dell’annata agricola), per metterne al corrente<br />
con tempestività il popolo. Quando l’uso <strong>di</strong> compilare la tavola ogni anno cessò (fra il 132<br />
e il 114), tutto l’archivio conservato nella regia del pontefice venne pubblicato<br />
(prob<strong>ab</strong>ilmente per la parte più antica della storia <strong>di</strong> Roma le tavole o non erano mai<br />
esistite, o erano andate perdute: ma chi curò la pubblicazione provvide a ricostruire la<br />
storia <strong>di</strong> Roma fin dall’inizio)<br />
2. gli archivi privati delle gentes. Come si apprende da numerose testimonianze<br />
antiche ogni gens custo<strong>di</strong>va con cura la propria storia, tramandandola e arricchendola<br />
generazione dopo generazione. Tale uso è certamente connesso con lo ius imaginum, il<br />
<strong>di</strong>ritto gentilizio <strong>di</strong> conservare nell’atrio della casa le immagini in cera (prob<strong>ab</strong>ilmente<br />
busti o maschere) degli antenati, sotto le quali erano annotati il nome del personaggio, le<br />
cariche ricoperte, forse anche le imprese compiute. Di qui nasce il liber commentarius,<br />
cioè la storia della famiglia: a questo liber si attingevano le notizie per la composizione<br />
degli elogi funebri, pronunciati durante il funerale da un figlio o un parente del morto:<br />
oltre ai meriti del defunto , venivano ricordate anche le imprese degli antenati, per<br />
mostrare che il personaggio elogiato le aveva eguagliate o superate. Anche i testi degli<br />
9 Servio, ad Aen. I,373 afferma che gli annales riguardano le epoche più lontane, le historiae<br />
invece i fatti recenti, cui l’autore ha potuto assistere; osserva anche che l’opera <strong>di</strong> <strong>Livio</strong> comprende<br />
sia annales sia historiae.
Letteratura latina B a.a. 2008-2009 mod. 2. Appunti delle lezioni 10<br />
elogia venivano conservati nell’archivio della gens, e arricchivano così il corpus delle<br />
testimonianze sulla storia della famiglia. Di solito in questi archivi privati si<br />
conservavano anche gli acta, cioè i documenti ufficiali relativi all’attività che i membri<br />
della famiglia avevano svolto come magistrati. Questo complesso <strong>di</strong> memorie relative alla<br />
gens, che aveva ogni interesse ad esaltare se stessa e i propri antenati, non sempre era<br />
del tutto atten<strong>di</strong>bile: sia Cicerone (Brutus, 61 s.) sia <strong>Livio</strong> (8,40,4), riferendosi in<br />
particolare agli elogi funebri, affermano che avevano riempito <strong>di</strong> menzogne la storia più<br />
antica <strong>di</strong> Roma. E’ prob<strong>ab</strong>ile che quella parte degli annales dei pontefici ricostruita (dopo<br />
l’incen<strong>di</strong>o gallico, e anche in seguito) rispecchiasse la tra<strong>di</strong>zione delle famiglie nobili più<br />
potenti, che certo non furono estranee a questa ricostruzione. Le falsificazioni più<br />
comuni, come si apprende da Cicerone, riguardavano le cariche conseguite: a volte si<br />
attribuivano ai propri antenati trionfi falsi e consolati più numerosi del vero. Inoltre,<br />
grazie anche al fatto che i nomi gentilizi erano relativamente pochi, era possibile inserirsi<br />
in una stirpe <strong>di</strong>versa dalla propria e più illustre <strong>di</strong> identico nomen, impadronendosi <strong>di</strong><br />
antenati altrui la cui stirpe si fosse estinta: “come se io – esemplifica Cicerone –<br />
sostenessi <strong>di</strong> <strong>di</strong>scendere da Manio Tullio, un patrizio che fu console insieme a Servio<br />
Sulpicio <strong>di</strong>eci anni dopo la cacciata dei re”.<br />
Per quanto dunque notoriamente viziati da falsificazioni <strong>di</strong> questo genere, gli<br />
archivi privati esistevano, e contenevano documenti pubblici anche importanti, e<br />
consultarli, confrontandoli eventualmente tra loro, poteva essere molto utile nella<br />
ricostruzione storica.<br />
3. i senatus consulta, cioè i decreti votati dal senato: al tempo <strong>di</strong> <strong>Livio</strong> erano<br />
<strong>di</strong>sponibili e consult<strong>ab</strong>ili, in forma <strong>di</strong> libro. I testi delle leggi e dei trattati erano più<br />
<strong>di</strong>spersi, ma procurarseli e consultarli non era impossibile: dobbiamo a Polibio la<br />
citazione fedele del testo <strong>di</strong> tutti i trattati stipulati tra Roma e Cartagine prima della<br />
seconda guerra punica (3,22-26)<br />
4. elenchi <strong>di</strong> magistrati erano conservati nei Fasti e nei <strong>libri</strong> lintei, custo<strong>di</strong>ti –<br />
questi ultimi – nel tempio <strong>di</strong> Giunone Moneta.<br />
<strong>Livio</strong> non <strong>di</strong>ce mai <strong>di</strong> aver <strong>di</strong>rettamente consultato qualcuno <strong>di</strong> questi documenti;<br />
e <strong>ab</strong>biamo alcune prove che non lo fece.<br />
Ad es. in 4,23,2 lo storico cita le versioni contrastanti <strong>di</strong> due annalisti, Macro e<br />
Tuberone, sui nomi dei consoli dell’anno 434: eppure entrambi, osserva <strong>Livio</strong>, adducono<br />
a sostegno della propria notizia la medesima fonte documentaria, i <strong>libri</strong> lintei. <strong>Livio</strong> aveva<br />
la possibilità <strong>di</strong> appurare chi dei due avesse ragione, andando a consultare<br />
personalmente questo documento; invece preferisce lasciare la questione in sospeso: sit<br />
inter cetera vetustate cooperta hoc quoque in incerto positum; “fra le altre questioni che<br />
sono sommerse dall’antichità, lasciamo anche questa nell’incertezza”.
Letteratura latina B a.a. 2008-2009 mod. 2. Appunti delle lezioni 11<br />
Molto significativo è l’atteggiamento assunto dallo storico a proposito <strong>di</strong> un<br />
documento – prob<strong>ab</strong>ilmente falso 10, ma questo non ha importanza – <strong>di</strong> cui fu informato<br />
da Augusto in persona. In 4,17-19 <strong>Livio</strong> narra che nel 438 la colonia <strong>di</strong> Fidene si ribellò<br />
ai Romani, e si alleò a Tolumnio, re dei Veienti. Il senato decide che la <strong>di</strong>rezione della<br />
guerra sia affidata ad un <strong>di</strong>ttatore, e viene nominato Mamerco Emilio. Nello sconto<br />
decisivo, e alla fine vittorioso, davanti alle mura <strong>di</strong> Fidene, si <strong>di</strong>stinse il tribuno militare<br />
Aulo Cornelio Cosso, che uccise il generale nemico, il re Tolumnio: spogliato, com’era<br />
consuetu<strong>di</strong>ne, il cadavere delle armi (e tagliatane la testa), portò questo prezioso trofeo<br />
nella processione del trionfo, accordato dal senato al generale vittorioso Mamerco Emilio,<br />
e de<strong>di</strong>cò poi, con una solenne cerimonia, le “spoglie opime” (quelle del generale Tolumnio)<br />
a Giove Feretrio nel suo tempio. Il racconto si conclude con l’osservazione che in quel<br />
giorno Cosso fu esaltato e ammirato più del <strong>di</strong>ttatore stesso, e con l’affermazione che<br />
questa versione dei fatti è attestata da tutte le fonti (omnes ante me auctores<br />
secutus...exposui, <strong>di</strong>ce <strong>Livio</strong> in 4,20,5). Solo a questo punto egli inserisce notizia del<br />
documento nuovo scoperto da Augusto, che mette in <strong>di</strong>scussione la versione dei fatti che<br />
ha appena dato: “però, a parte il fatto che <strong>di</strong> regola sono considerate spoglie opime solo<br />
quelle che un comandante supremo ha tolto ad un altro comandante supremo, [...]<br />
l’iscrizione stessa che si trova su quelle spoglie <strong>di</strong>mostra, contro quegli storici e anche<br />
contro <strong>di</strong> me, che Cosso le conquistò essendo console. Quando io appresi che Cesare<br />
Augusto, fondatore e restauratore <strong>di</strong> tutti i templi, entrato nel tempio <strong>di</strong> Giove Feretrio,<br />
che fece ricostruire perché rovinato dall’azione del tempo, lesse personalmente questa<br />
iscrizione sulla corazza <strong>di</strong> lino, mi parve quasi un sacrilegio togliere a Cosso e alle sue<br />
spoglie la testimonianza <strong>di</strong> Cesare, restauratore del tempio stesso” (4,20,6-8). Forse <strong>Livio</strong><br />
non ritenne necessario verificare <strong>di</strong> persona l’iscrizione “Aulo Cornelio Cosso console” sul<br />
reperto archeologico, ma questo è secondario; quello che importa rilevare è che non<br />
riscrive la sua ricostruzione storica, sulla base <strong>di</strong> questo nuovo documento <strong>di</strong> cui è<br />
venuto a conoscenza; si limita a <strong>di</strong>chiarare che gli antichi annali dai quali ha tratto la<br />
sua versione debbono essere in errore. E c’è <strong>di</strong> più. Quando, a soli 12 capitoli <strong>di</strong> <strong>di</strong>stanza,<br />
nomina nuovamente Cornelio Cosso scrive: “era comandante della cavalleria quel<br />
10 Non solo sembra <strong>di</strong>fficile che su una corazza <strong>di</strong> lino, certo sporca <strong>di</strong> sangue, si potesse scrivere<br />
qualcosa, ma soprattutto è improb<strong>ab</strong>ile che l’indumento si fosse potuto conservare intatto per<br />
oltre quattro secoli, in un tempio <strong>di</strong>roccato ed esposto all’azione degli elementi. Come argomentò<br />
persuasivamente il Dessau (“Hermes” 41,1906, 142 ss.), il reperto fu f<strong>ab</strong>bricato prob<strong>ab</strong>ilmente per<br />
respingere la richiesta, avanzata nel 29 a.C., da Lucio Licinio Crasso, proconsole <strong>di</strong> Macedonia, <strong>di</strong><br />
poter offrire gli spolia opima tolti al capo dei Bastarni, che aveva ucciso in battaglia. Come si<br />
apprende da Dione Cassio (51,24,4), Ottaviano gli rifiutò questo onore motivandolo con il fatto che<br />
Crasso in quella circostanza non deteneva il pieno imperium. Naturalmente Crasso avrebbe potuto<br />
invocare il precedente <strong>di</strong> Aulo Cornelio Cosso, se davvero, come narra <strong>Livio</strong>, egli era solo tribuno<br />
militare quando gli fu accordato questo onore. Occorreva allora <strong>di</strong>mostrare che questa tra<strong>di</strong>zione<br />
era errata, e che Cosso in realtà era console: fu dunque f<strong>ab</strong>bricata la prova, e Augusto ebbe cura<br />
<strong>di</strong> farla conoscere a <strong>Tito</strong> <strong>Livio</strong>.
Letteratura latina B a.a. 2008-2009 mod. 2. Appunti delle lezioni 12<br />
medesimo Aulo Cornelio Cosso che da tribuno militare nella precedente guerra, dopo<br />
aver ucciso il re dei Veienti Tolumnio sotto gli occhi dei due eserciti, ne aveva recato le<br />
spoglie opime nel tempio <strong>di</strong> Giove Feretrio” (4,32,4).<br />
Un altro esempio, molto più semplice, della scarsa considerazione accordata da<br />
<strong>Livio</strong> ai documenti originali (e questo, a <strong>di</strong>fferenza della corazza <strong>di</strong> lino <strong>di</strong> Tolumnio, si<br />
<strong>di</strong>rebbe un documento davvero autentico) è offerto dalle stime sull’entità numerica delle<br />
truppe condotte da Annibale in Italia. In 21,38,2-3, dopo aver detto che fra gli autori non<br />
vi è accordo su questo dato, elenca tre stime <strong>di</strong>fferenti: “quelli che danno le cifre più alte<br />
parlano <strong>di</strong> 100.000 fanti e 20.000 cavalieri quelli che danno le più basse <strong>di</strong> 20.000 fanti e<br />
<strong>di</strong> 6.000 cavalieri; Cincio Alimento, che scrive <strong>di</strong> essere stato fatto prigioniero da<br />
Annibale, sarebbe certo il più atten<strong>di</strong>bile, sen non che confonde il numero,<br />
aggiungendovi i Galli e i Liguri (80.000 fanti e 10.000 cavalieri)”. Come si vede, a parte il<br />
rilievo su Cincio Alimento, le altre due stime, la più alta e la più bassa, sono accostate,<br />
senza che lo storico si pronunci su quella che ritiene più atten<strong>di</strong>bile. Eppure aveva a<br />
<strong>di</strong>sposizione un elemento sicuro per scegliere. La stima più bassa corrisponde infatti<br />
esattamente a quella fornita da Polibio (3,33 e 56), che senza dubbio è la fonte <strong>di</strong> <strong>Livio</strong><br />
per questo dato. Ma Polibio aggiungeva <strong>di</strong> aver letto le cifre che riferisce su una stele <strong>di</strong><br />
bronzo, fatta iscrivere da Annibale in persona al capo Lacinio (nell’o<strong>di</strong>erna Cal<strong>ab</strong>ria).<br />
Dietro l’espressione generica “quelli che danno la stima più bassa” c’è con ogni<br />
prob<strong>ab</strong>ilità soltanto il testo <strong>di</strong> Polibio.<br />
<strong>Livio</strong> non solo non affronta la ricerca della documentazione originale, ma anche<br />
quando si imbatte, senza averlo cercato, in uno <strong>di</strong> questi documenti, non vi attribuisce<br />
molta importanza, e lo pone sul medesimo piano delle sue fonti letterarie.<br />
Fonti letterarie e metodo del loro impiego. In sostanza il metodo <strong>di</strong> <strong>Livio</strong><br />
consiste nell’acquisire, come materiale su cui lavorare, le opere storiche precedenti,<br />
senza risalire oltre. E per un’opera <strong>di</strong> mole così vasta come gli <strong>ab</strong> <strong>urbe</strong> <strong>con<strong>di</strong>ta</strong> <strong>libri</strong> questo<br />
era prob<strong>ab</strong>ilmente il solo metodo possibile. Il lavoro <strong>di</strong> <strong>Livio</strong> consistette dunque in gran<br />
parte nel tradurre nella prosa augustea, in una veste letteraria accurata e attraente, il<br />
materiale già raccolto da altri. Chi erano questi “altri”?<br />
Non rientrava nelle consuetu<strong>di</strong>ni degli storici antichi l’in<strong>di</strong>cazione esauriente delle<br />
fonti usate; per lo più una fonte veniva menzionata o per criticarla, oppure,<br />
occasionalmente, per in<strong>di</strong>care <strong>di</strong> un fatto versioni <strong>di</strong>verse da quella accolta. Quando le<br />
fonti impiegate sono concor<strong>di</strong>, o l’autore non ritiene degna <strong>di</strong> nota una determinata<br />
variante della versione che ha prescelto, non c’è da attendersi nessuna menzione della<br />
fonte o delle fonti.<br />
Tuttavia è stato possibile ricostruire con una certa prob<strong>ab</strong>ilità le fonti <strong>di</strong> cui <strong>Livio</strong><br />
dovette valersi: per la prima decade gli annalisti romani più antichi (da F<strong>ab</strong>io Pittore a
Letteratura latina B a.a. 2008-2009 mod. 2. Appunti delle lezioni 13<br />
Clau<strong>di</strong>o Quadrigario e Valerio Anziate); per la terza (seconda guerra punica) soprattutto<br />
Celio Antipatro e Polibio; e ancora Polibio, oltre agli annalisti e a Catone, per la quarta e<br />
la quinta.<br />
Si ritiene per lo più che per ogni sezione dell’opera <strong>Livio</strong>, pur tenendo presenti più<br />
fonti, ne segua principalmente soltanto una, impiegando le altre come riscontro, e<br />
menzionandole <strong>di</strong> tanto in tanto brevemente, soprattutto nei casi <strong>di</strong> forte <strong>di</strong>vergenza con<br />
la fonte principale, che cambia a seconda del periodo e/o dell’argomento trattato. In<br />
generale <strong>Livio</strong> non contamina tra loro le fonti, ma sceltane una per ogni sezione,<br />
riorganizza e riscrive i fatti da quella presentati secondo le su esigenze stilistiche,<br />
aggiungendovi le proprie considerazioni morali, politiche, religiose. Solo alla fine del<br />
racconto principale cita talvolta le opinioni <strong>di</strong>vergenti <strong>di</strong> altre fonti, in modo per lo più<br />
assai conciso. Le fonti secondarie insomma sono <strong>di</strong> solito aggiunte al racconto principale,<br />
non consultate prima, in modo da inserire nel racconto principale correzioni e mo<strong>di</strong>fiche,<br />
quando le fonti secondarie offrano una versione o interpretazione più prob<strong>ab</strong>ile. Per es.<br />
nel caso <strong>di</strong> Cornelio Cosso egli non tenta <strong>di</strong> me<strong>di</strong>are tra le testimonianze contrastanti,<br />
per offrire del fatto la sua ricostruzione; si limita a giustapporre le <strong>di</strong>fferenti versioni. Il<br />
confronto con la sola fonte sopravvissuta <strong>di</strong> una certa estensione, Polibio, sembra<br />
in<strong>di</strong>care che questo fosse il metodo <strong>di</strong> lavoro <strong>ab</strong>ituale <strong>di</strong> <strong>Livio</strong>: quando fonte principale è<br />
Polibio, la traccia del suo racconto è seguita in modo fedele e chiaramente riconoscibile.<br />
Non c’è ragione <strong>di</strong> ritenere che per tutte le sezioni dell’opera per le quali il confronto con<br />
la fonte non è possibile il metodo <strong>di</strong> lavoro non fosse il medesimo.<br />
Naturalmente l’impiego <strong>di</strong> più fonti può comportare qualche volta, nel passaggio<br />
dall’una all’altra, ripetizioni e contrad<strong>di</strong>zioni: può accadere che lo storico non riconosca,<br />
leggendone in fonti <strong>di</strong>verse, il medesimo fatto, e lo registri due volte; o anche che <strong>di</strong> un<br />
unico fatto offra, in sezioni <strong>di</strong>verse dell’opera, versioni contrastanti11. 11 Questo accade anche, sorprendentemente, per qualche fatto importante e memor<strong>ab</strong>ile. Tale è il<br />
famoso riscatto imposto dai Galli per <strong>ab</strong>bandonare l’asse<strong>di</strong>o del Campidoglio; come lo storico<br />
narra in 5, 48-49, Camillo giunse appena in tempo per impe<strong>di</strong>re questa onta, e sconfisse e cacciò i<br />
Galli con due battaglie. Accenni successivi a questa vicenda (10,16,6; 22,59,7; 34,5,9) sembrano<br />
invece dar per scontato che il riscatto fosse stato pagato (come prob<strong>ab</strong>ilmente avvenne). E’ vero<br />
che le menzioni successive sono tutte all’interno <strong>di</strong> <strong>di</strong>scorsi, non nella parte narrativa, e dunque la<br />
respons<strong>ab</strong>ilità dell’affermazione che il riscatto fu pagato è del personaggio che parla. Almeno in un<br />
caso però ci si attenderebbe un rinvio alla versione offerta dallo storico in 5,48-49. Il capo dei<br />
rappresentanti dei prigionieri romani catturati da Annibale dopo Canne, da lui inviati a Roma per<br />
ottenere che il senato paghi il loro riscatto ricorda, in appoggio alla richiesta, il precedente famoso<br />
con queste parole: maiores quoque acceperamus se a Gallis auro redemisse (22,59,7),“avevamo<br />
appreso che anche i nostri antenati si erano riscattati con l’oro dai Galli”. Nel lungo <strong>di</strong>scorso<br />
(22,60) con cui Manlio Torquato argomenta in senato la propria opposizione ad accogliere la<br />
richiesta non c’è nemmeno un accenno a quell’episo<strong>di</strong>o; eppure, ricordare la “vera” versione del<br />
fatto (quella <strong>di</strong> 5,48-49) sarebbe stato un ulteriore argomento a favore della decisione – che poi il<br />
senato prese – <strong>di</strong> non pagare, neppure ora, il riscatto dei prigionieri. Si <strong>di</strong>rebbe quasi che <strong>Livio</strong><br />
stesso non se ne ricor<strong>di</strong> più.
Letteratura latina B a.a. 2008-2009 mod. 2. Appunti delle lezioni 14<br />
CARATTERI IDEOLOGICI DELLA STORIA DI LIVIO<br />
Scopo <strong>di</strong> <strong>Livio</strong> non è soltanto, come è proprio <strong>di</strong> ogni storico, tramandare il ricordo<br />
<strong>di</strong> eventi importanti: a questo intento fondamentale, che naturalmente è presente, si<br />
unisce una chiara impostazione ideologica (<strong>Livio</strong> vuole anche <strong>di</strong>mostrare qualcosa),<br />
guidata da quello che in breve si potrebbe definire “pregiu<strong>di</strong>zio patriottico”.<br />
Come si deduce dalla prefazione generale dell’opera, <strong>Livio</strong> non aveva dei compiti e<br />
dello scopo della storiografia un’idea nuova o insolita: anch’egli ritiene, come molti storici<br />
prima e dopo <strong>di</strong> lui, che la storia debba essere magistra vitae, che debba insegnare.<br />
L’insegnamento cui egli soprattutto mira non è <strong>di</strong> tipo pragmatico come in Polibio, che si<br />
rivolge in modo prevalente ad un ben selezionato pubblico, quello degli uomini politici,<br />
che dall’analisi dei fatti del passato possono trarre in<strong>di</strong>cazioni utili per meglio svolgere il<br />
proprio compito. <strong>Livio</strong> si rivolge ad un pubblico vasto e indeterminato, che dalla sua<br />
opera, si augura, potrà trarre un insegnamento <strong>di</strong> tipo morale. Semplificando un poco si<br />
può <strong>di</strong>re che il lettore <strong>di</strong> <strong>Livio</strong> trova nella sua opera l’esaltazione della virtù e la condanna<br />
del vizio. In tal modo <strong>Livio</strong> si inserisce perfettamente nella tra<strong>di</strong>zione storiografica<br />
precedente, che nella Roma degli antenati vedeva il modello dello stato perfetto, l’esempio<br />
<strong>di</strong> tutte le virtù etiche e politiche, tanto più idealizzate quanto meno esse appaiono<br />
praticate nell’età presente. Il moralismo <strong>di</strong> <strong>Livio</strong> però non è astratto, né – salvo poche<br />
eccezioni – pedante e pre<strong>di</strong>catorio; fondato sui valori della Roma antica, appare per lo più<br />
incarnato dai personaggi, illustrato dalle loro azioni, è insomma <strong>di</strong> solito interno alla<br />
narrazione stessa: la lezione che occorre trarne è spesso affidata, con un espe<strong>di</strong>ente<br />
semplice ed efficace, alle parole dei personaggi stessi. Non mancano naturalmente anche<br />
commenti espliciti del narratore, ma non sono né estesi né frequenti.<br />
Sfera morale e sfera politica sono in <strong>Livio</strong> strettamente connesse: l’attività politica<br />
e militare dei Romani, ispirata e guidata dalle virtù, ha fatto grande l’imperium (è questa<br />
l’idea base che sostiene la prefazione generale dell’opera).<br />
Prima <strong>di</strong> analizzare la prefazione, cercheremo <strong>di</strong> illustrare, con qualche esempio, <strong>di</strong><br />
che cosa sia fatta questa virtù, quali qualità specifiche secondo <strong>Livio</strong> essa comprenda,<br />
tenendo presente che essa si esplica sempre nella vita sociale, e che il fine <strong>di</strong> ogni<br />
comportamento virtuoso è sempre e soltanto la salus rei publicae, il bene dello stato.<br />
Religione: pietas e fides. L’elogio che <strong>ab</strong>biamo avuto occasione <strong>di</strong> menzionare12 tributato da <strong>Livio</strong> ad Augusto restitutor dei templi e della religione tra<strong>di</strong>zionale degli avi,<br />
lo scrupolo con cui lo storico riferisce pro<strong>di</strong>gi ed espiazioni, sembrano in<strong>di</strong>care<br />
12 4,20,6-8, riportato qui sopra, p. 11.
Letteratura latina B a.a. 2008-2009 mod. 2. Appunti delle lezioni 15<br />
un’adesione sincera e personale dello storico alla religione tra<strong>di</strong>zionale. Ma in altri passi<br />
egli assume invece un atteggiamento scettico e razionale, soprattutto per quanto<br />
riguarda la ingenua credenza nel <strong>di</strong>retto intervento degli dèi nelle vicende <strong>di</strong> Roma. Per<br />
es. in 1,4,2, sulla leggenda delle origini, e sulla nascita <strong>di</strong> Romolo <strong>di</strong>rettamente da Marte,<br />
lo storico <strong>di</strong>ce: “la Vestale (Rea Silvia) fu violata e <strong>di</strong>ede alla luce due gemelli, e sia che<br />
così credesse veramente, sia che l’attribuire ad un <strong>di</strong>o la causa della colpa ne <strong>di</strong>minuisse<br />
il <strong>di</strong>sonore, assegnò a Marte la paternità dell’incerta prole”. Analogo è l’atteggiamento<br />
dello storico a proposito dell’apoteosi <strong>di</strong> Romolo 13 (1,16). Molto chiaro è anche il suo<br />
commento all’istituzione dei riti religiosi <strong>di</strong> parte <strong>di</strong> Numa, che in sostanza presenta la<br />
religione come un efficacissimo instrumentum regni: “Chiusolo (sc. il tempio <strong>di</strong> Giano),<br />
dopo aver legato a sé con trattati <strong>di</strong> alleanza tutti i popoli confinanti, messa da parte ogni<br />
preoccupazione <strong>di</strong> pericoli esterni, per impe<strong>di</strong>re che gli animi, che fino ad allora la paura<br />
dei nemici e la <strong>di</strong>sciplina militare avevano mantenuto sotto controllo, nella pace si<br />
sfrenassero, pensò <strong>di</strong> dover prima <strong>di</strong> tutto incutervi il timore degli dèi, cosa efficacissima<br />
per una massa ignorante e rozza quale era a quel tempo. Poiché questo timore non<br />
poteva penetrare negli animi senza l’invenzione <strong>di</strong> qualcosa <strong>di</strong> soprannaturale, Numa fece<br />
credere <strong>di</strong> avere degli incontri notturni con la dea Egeria; e che per suo consiglio egli<br />
andava istituendo i riti più gra<strong>di</strong>ti agli dèi, e assegnava a ciascun <strong>di</strong>o sacerdoti suoi<br />
propri” (1,19,4-5).<br />
Più ambigua e sfumata è la posizione <strong>di</strong> <strong>Livio</strong> a proposito dei pro<strong>di</strong>gi. Spesso egli<br />
inserisce nel racconto liste <strong>di</strong> pro<strong>di</strong>gi e delle relative espiazioni, così come le trovava nelle<br />
sue fonti annalistiche, senza aggiungervi nessun commento. In un caso però si sente in<br />
dovere <strong>di</strong> spiegare per quale ragione così coscienziosamente egli registri nella sua opera<br />
fenomeni <strong>di</strong> questo genere. Il tono è <strong>di</strong>fensivo, come <strong>di</strong> chi voglia rispondere a critiche,<br />
reali o immaginate. Prima <strong>di</strong> riferire una <strong>di</strong> queste liste <strong>di</strong> pro<strong>di</strong>gi, relativa all’anno 169<br />
a.C., <strong>di</strong>chiara: “Mi rendo ben conto che a causa dell’in<strong>di</strong>fferenza religiosa (neglegentia)<br />
che oggi ispira la convinzione che gli dèi non preannuncino nulla, nessun pro<strong>di</strong>gio viene<br />
più ufficialmente annunciato né registrato nelle memorie storiche. Ma poiché io scrivo <strong>di</strong><br />
tempi antichi, anche l’animo mio <strong>di</strong>venta in certo modo antico, e una sorta <strong>di</strong> scrupolo<br />
13 1,16. La scomparsa improvvisa <strong>di</strong> Romolo durante un temporale, mentre passava in rassegna le<br />
truppe, getta nello sgomento la folla; ma i patres subito la rassicurano: Romolo è stato rapito in<br />
cielo ed è <strong>di</strong>venuto un <strong>di</strong>o. Il fatto straor<strong>di</strong>nario viene confermato poco tempo dopo dalla<br />
testimonianza <strong>di</strong> un senatore, Giulio Proculo, al quale Romolo stesso <strong>di</strong>vinizzato è apparso,<br />
affidandogli un importante messaggio per il suo popolo, con queste precise parole: “Va’, annuncia<br />
ai Romani che gli dèi vogliono che la mia Roma sia la capitale del mondo; coltivino dunque l’arte<br />
della guerra, e sappiano e traman<strong>di</strong>no ai posteri che nessuna potenza umana potrà resistere alle<br />
armi romane” (1,16,7). Fra la scomparsa improvvisa <strong>di</strong> Romolo e il racconto fatto da Giulio<br />
Proculo del suo incontro con il re <strong>di</strong>vinizzato, <strong>Livio</strong> menziona anche, molto brevemente, e senza<br />
<strong>di</strong>scuterla, una versione ben <strong>di</strong>versa: “Credo che già allora ci siano stati <strong>di</strong> quelli che senza <strong>di</strong>rlo<br />
sospettavano che il re fosse stato fatto a pezzi con le loro mani dai senatori” (1,16,4)
Letteratura latina B a.a. 2008-2009 mod. 2. Appunti delle lezioni 16<br />
religioso (religio) mi impe<strong>di</strong>sce <strong>di</strong> considerare indegni della mia storia fatti <strong>di</strong> cui quegli<br />
uomini assai saggi (illi prudentissimi viri, i Romani <strong>di</strong> un tempo) ritennero dovesse<br />
occuparsi lo stato” (43,13,1). A volte, su singoli pro<strong>di</strong>gi, egli si mostra incredulo; ed è ben<br />
consapevole che, in tempi <strong>di</strong> terrore e sconfitta, può verificarsi una psicosi religiosa<br />
collettiva: “molti pro<strong>di</strong>gi si verificarono in quell’inverno, o, come solitamente avviene<br />
quando le menti degli uomini sono piene del terrore religioso, molti furono riferiti e<br />
precipitosamente creduti” (21,62,1). Ciononostante <strong>Livio</strong> nota molto spesso che<br />
l’inosservanza dei riti, l’in<strong>di</strong>fferenza <strong>di</strong> fronte ai pro<strong>di</strong>gi, furono causa <strong>di</strong> <strong>di</strong>sastri e<br />
sconfitte; senza dare una personale adesione incon<strong>di</strong>zionata alla fede in questi fenomeni,<br />
<strong>Livio</strong> ne sottolinea tuttavia l’importanza, senza escludere che i pro<strong>di</strong>gi possano essere, o<br />
forse fossero nei tempi antichi, più puri e incorrotti, una manifestazione della volontà<br />
<strong>di</strong>vina, che non è comunque saggio ignorare: religio e pietas degli antichi sono insomma<br />
considerati dallo storico valori positivi, elementi imprescin<strong>di</strong>bili della virtù del popolo<br />
romano.<br />
Nella interpretazione globale della storia <strong>di</strong> Roma, ma in particolar modo nella<br />
prima decade, si riconosce poi una idea guida <strong>di</strong> carattere religioso (che sembra iscriversi<br />
nel provvidenzialismo stoico): la grandezza <strong>di</strong> Roma non è frutto del caso, è preor<strong>di</strong>nata<br />
e provvidenziale. Per es. prima <strong>di</strong> riferire, con le riserve che <strong>ab</strong>biamo ricordato 14, la<br />
leggenda dei gemelli, <strong>Livio</strong> <strong>di</strong>chiara: sed debebatur, ut opinor, fatis tantae origo urbis<br />
maximique secundum deorum opes imperii principium (1,4,1), “dai fati era fissata, io credo,<br />
l’origine <strong>di</strong> una città così grande, e l’inizio del dominio più grande dopo la potenza degli<br />
dèi”. Per quanto scettico possa essere sulla leggenda che ingenuamente connette in modo<br />
<strong>di</strong>retto con un <strong>di</strong>o l’origine <strong>di</strong> Roma, <strong>Livio</strong> è però convinto che fin dalla sua nascita la<br />
città fu assistita dalla benevolenza degli dèi, o del fato. Una benevolenza non immotivata,<br />
ma al contrario legata <strong>di</strong>rettamente alla virtù straor<strong>di</strong>naria del popolo che gli dèi hanno<br />
scelto <strong>di</strong> proteggere. Ma anche <strong>di</strong> mettere continuamente alla prova. Ricorrono, nella<br />
prima decade, frasi finali che tendono ad ottenere l’impressione che una necessità<br />
impersonale intervenga spesso a saggiare le virtù civiche e militari del popolo romano,<br />
per renderlo tanto forte da dominare il mondo, ma anche moralmente degno <strong>di</strong> guidarlo.<br />
Il nuovo stato è minacciato da popoli stranieri; il fatto viene dallo storico introdotto con<br />
queste parole: “perché il medesimo ciclo <strong>di</strong> avvenimenti ricorresse ogni anno (ut idem in<br />
singulos orbis volveretur), ecco che gli Ernici annunziarono che i Volsci e gli Equi, per<br />
quanto le loro forze fossero state duramente provate, stavano ricostituendo i loro eserciti”<br />
(3,10,9). Se non vi sono minacce esterne, i Romani sono travagliati da <strong>di</strong>fficoltà interne:<br />
Etruschi e Sanniti sono quieti e, almeno momentaneamente, in pace con Roma; la plebe<br />
14 1,4,2: v. qui sopra, p. 15.
Letteratura latina B a.a. 2008-2009 mod. 2. Appunti delle lezioni 17<br />
è tranquilla, e impegnata nella deduzione <strong>di</strong> colonie. Tamen, ne un<strong>di</strong>que tranquillae res<br />
essent, scoppiò per istigazione dei tribuni della plebe una contesa tra i primores civitatis<br />
(10,6,3). Se vi è pace con gli altri popoli e concor<strong>di</strong>a all’interno, ecco che scoppia una<br />
pestilenza, o qualche altra calamità naturale affligge i Romani. Anche queste sciagure<br />
sono introdotte da frasi del medesimo tipo: et <strong>ab</strong> se<strong>di</strong>tione et a bello quietis rebus, ne<br />
quando a metu ac periculo vacarent, pestilentia ingens orta (7,1,7), “la situazione era<br />
tranquilla, senza <strong>di</strong>sor<strong>di</strong>ni interni né guerra: perché non potessero essere mai liberi da<br />
paura e pericoli, scoppiò una grave pestilenza”. Questa intenzione <strong>di</strong> non lasciar mai<br />
tranquilli i Romani sembra da attribuire al fato, che, in armonia con il <strong>di</strong>segno<br />
provvidenziale che guida il corso degli eventi, mette alla prova lo spirito <strong>di</strong> resistenza dei<br />
Romani.<br />
Coerente con questa visione provvidenziale è anche il concetto liviano <strong>di</strong> fortuna<br />
(espresso con termini vari: fortuna, fatum, fors). Il concetto <strong>di</strong> fortuna come entità<br />
volubile e capricciosa, che <strong>di</strong>stribuisce il suo favore in modo del tutto arbitrario, e spesso<br />
favorisce l’ingiusto e sconvolge i <strong>di</strong>segni umani, era largamente impiegato nella<br />
letteratura ellenistica: esso compare, per quanto raramente, anche in <strong>Livio</strong>, ma per lo più<br />
in <strong>di</strong>scorsi, che non necessariamente riflettono il pensiero dell’autore. Più caratteristico e<br />
più frequente, e costante nelle parti narrative, in cui lo storico parla in prima persona, è<br />
il concetto <strong>di</strong> fortuna come entità che ha il compito <strong>di</strong> mantenere l’armonia del mondo, <strong>di</strong><br />
assecondare l’opera della provvidenza o degli dèi. In luogo della contrapposizione, molto<br />
sfruttata nella letteratura ellenistica, e non solo, <strong>di</strong> virtù e fortuna, in <strong>Livio</strong> troviamo<br />
invece un sostanziale accordo dei due concetti: secondo <strong>Livio</strong> <strong>di</strong> solito la fortuna protegge<br />
la virtù (e punisce il vizio). Tale concetto è espresso frequentemente nella formula fortuna<br />
populi Romani, fortuna urbis. La protezione accordata dalla fortuna a Roma è congiunta<br />
con la virtù dei citta<strong>di</strong>ni, e ne risultano per lo stato prosperità e potenza.<br />
A volte naturalmente la fortuna <strong>ab</strong>bandona i Romani, ma <strong>di</strong> solito <strong>Livio</strong> mette in<br />
relazione questi momenti con una colpa o una mancanza, verso gli dèi o verso gli uomini,<br />
in seguito alla quale la fortuna ha voltato le spalle ai suoi beniamini.<br />
Per esempio la conquista <strong>di</strong> Roma da parte dei Galli è preceduta da una grave<br />
colpa dei Romani, che <strong>Livio</strong> debitamente sottolinea (5,35-37). Minacciati dai Galli, gli<br />
<strong>ab</strong>itanti <strong>di</strong> Chiusi mandano ambasciatori a Roma a chiedere aiuti. Roma, che non era<br />
legata a Chiusi da nessun trattato <strong>di</strong> alleanza, decide per il momento solo l’invio <strong>di</strong> tre<br />
ambasciatori, incaricati <strong>di</strong> intavolare trattative con i Galli, per cercare, in qualità <strong>di</strong><br />
me<strong>di</strong>atori, <strong>di</strong> far sì che i contendenti giungano ad un accordo. La trattativa fallisce, e i<br />
Galli attaccano la città <strong>di</strong> Chiusi. I tre ambasciatori romani, invece <strong>di</strong> rientrare in patria a<br />
riferire al senato l’esito della missione, si uniscono ai Clusini, e partecipano ai<br />
combattimenti, <strong>di</strong>stinguendosi per il loro valore. Uno <strong>di</strong> loro uccide il comandante dei
Letteratura latina B a.a. 2008-2009 mod. 2. Appunti delle lezioni 18<br />
Galli. Questo comportamento sleale è condannato da <strong>Livio</strong> con queste parole: ibi, iam<br />
urgentibus Romanam <strong>urbe</strong>m fatis, legati contra ius gentium arma capiunt (5,36,6), “un<br />
destino <strong>di</strong> rovina già incombeva su Roma: contro il <strong>di</strong>ritto delle genti, gli ambasciatori<br />
impugnarono le armi”. E’ soprattutto la colpa che in<strong>di</strong>gna i Galli, e attira sui Romani la<br />
giusta punizione. Da questo momento in poi infatti tutto va a rovescio per Roma, che<br />
commette un errore dopo l’altro. I Galli mandano ambasciatori a Roma a protestare per<br />
l’offesa, e a chiedere la consegna dei tre legati <strong>di</strong>sonesti. Il senato, pur riconoscendo la<br />
legittimità della richiesta dei Galli, si lascia dominare dalla potenza della gens F<strong>ab</strong>ia, cui<br />
i tre ambasciatori appartenevano, e rimette la decisione al popolo, che si schiera a favore<br />
dei legati colpevoli: in tal modo la colpa dei tre viene assunta dall’intera collettività dei<br />
citta<strong>di</strong>ni. <strong>Gli</strong> ambasciatori galli se ne vanno ormai decisamente ostili, e pronti a muover<br />
guerra a Roma, haud secus quam <strong>di</strong>gnum erat commenta <strong>Livio</strong>. Abbandonati ormai dalla<br />
fortuna, i Romani sottovalutano il nemico, e si preparano alla guerra nel modo or<strong>di</strong>nario:<br />
non viene nominato un <strong>di</strong>ttatore, non si intensificano le leve, “a tal punto – osserva <strong>Livio</strong><br />
– la fortuna acceca gli animi, quando non vuole che la sua forza incalzante sia<br />
ostacolata”. La descrizione della battaglia presso il fiume Allia che segue poco dopo mira<br />
ancora, in modo evidente, a <strong>di</strong>mostrare che la fortuna ha <strong>ab</strong>bandonato i Romani. Dopo<br />
aver descritto lo schieramento dei due eserciti, e l’<strong>ab</strong>ile manovra dei Galli, <strong>Livio</strong><br />
commenta: adeo non fortuna modo, sed ratio etiam cum barbaris st<strong>ab</strong>at (5,38,4). Dalla<br />
parte dei Romani nihil simile Romanis, non apud duces, non apud milites erat; gli animi<br />
sono invasi dal panico, tutti pensano solo a fuggire, e nella retroguar<strong>di</strong>a alcuni, nella<br />
confusione della fuga, si feriscono e uccidono a vicenda. L’insistenza sull’ostilità <strong>di</strong>vina,<br />
che acceca le menti e paralizza i Romani al punto che non sembrano più Romani, serve<br />
anche a scagionarli in parte della vergogna per questa sconfitta. Ma all’origine <strong>di</strong> questo<br />
<strong>di</strong>sastro (e <strong>di</strong> quello peggiore che seguirà, la conquista della città stessa) c’è la grave<br />
colpa commessa dai Romani, ripetutamente ricordata da <strong>Livio</strong>: giustamente la fortuna<br />
cum barbaris st<strong>ab</strong>at. L’insistenza sull’accecamento dei colpevoli, che richiama la tecnica<br />
della trage<strong>di</strong>a, e che forse <strong>Livio</strong> imita dal filone della storiografia drammatica o tragica,<br />
non serve tanto a giustificare la sconfitta e a salvare l’onore militare <strong>di</strong> Romani, ma a<br />
mostrare la gravità irrime<strong>di</strong><strong>ab</strong>ile della colpa commessa. Lo storico naturalmente non<br />
trascura le cause propriamente militari e contingenti della sconfitta (sottovalutazione del<br />
nemico e leva inadeguata), ma queste vengono subor<strong>di</strong>nate alla violazione della fides, cui<br />
segue la punizione <strong>di</strong>vina.<br />
La fides verso gli uomini, strettamente connessa alla pietas verso gli dèi, è però in<br />
generale una delle virtù tipicamente romane: innumerevoli esempi del rispetto scrupoloso<br />
della parola data, <strong>di</strong> lealtà nella condotta <strong>di</strong> guerra, <strong>di</strong> osservanza dei trattati illustrano<br />
come secondo <strong>Livio</strong> questa virtù sia particolarmente gra<strong>di</strong>ta agli dèi, e assicuri la loro
Letteratura latina B a.a. 2008-2009 mod. 2. Appunti delle lezioni 19<br />
protezione a coloro che la praticano. Certo, qualche volta (come nel caso appena<br />
ricordato) i Romani vengono meno alla fides, ma si tratta <strong>di</strong> deplorevoli eccezioni, come lo<br />
storico non manca <strong>di</strong> rilevare, con commenti ingenui e facilmente preve<strong>di</strong>bili. Quando il<br />
re Tarquinio il Superbo, non riuscendo ad impadronirsi della città <strong>di</strong> G<strong>ab</strong>ii, ricorse a<br />
fraus e dolus, lo storico non manca <strong>di</strong> rilevare che si trattava <strong>di</strong> arti “per nulla romane”<br />
(1,53,4).<br />
Molto significativo per illustrare questo atteggiamento dello storico è un episo<strong>di</strong>o<br />
della seconda guerra punica. Dopo Canne, Annibale offre ai prigionieri romani catturati<br />
la possibilità <strong>di</strong> essere riscattati. Fissato il prezzo del riscatto, <strong>di</strong>eci prigionieri vengono<br />
inviati a Roma, perché trattino la questione in senato: nec pignus aliud fidei, quam ut<br />
iurarent se re<strong>di</strong>turos, acceptum (22,58,6), “non si pretese da loro altro pegno <strong>di</strong> lealtà se<br />
non che giurassero <strong>di</strong> ritornare” (sc. se la trattativa con il senato non avesse avuto esito<br />
positivo). Evidentemente anche Annibale sapeva che i Romani non vengono mai meno<br />
alla fides, e ritenne il giuramento una garanzia sufficiente. Ma in uno almeno <strong>di</strong> quei<br />
<strong>di</strong>eci la fiducia <strong>di</strong> Annibale era mal riposta: uno <strong>di</strong> loro infatti, subito definito da <strong>Livio</strong><br />
minime Romani ingeni homo (22,58,8), appena uscito dal campo <strong>di</strong> Annibale con i<br />
compagni, vi fa ritorno, fingendo <strong>di</strong> aver <strong>di</strong>menticato qualcosa, e si scioglie così in<br />
anticipo dal giuramento. Poi li raggiunge e si reca a Roma con loro. Il senato decide <strong>di</strong><br />
non accettare la proposta <strong>di</strong> riscatto, e i prigionieri tristi vengono accompagnati alle porte<br />
della città, per far ritorno al campo <strong>di</strong> Annibale. Resta a Roma solo quello che con<br />
l’inganno si era sciolto da quell’obbligo; il senato però lo fa arrestare e ricondurre sotto<br />
scorta al campo <strong>di</strong> Annibale. Un comportamento esemplare, che riscatta i Romani dalla<br />
colpa <strong>di</strong> quel solo prigioniero. Tuttavia esisteva – e la menziona anche <strong>Livio</strong> – anche<br />
un’altra versione, assai meno e<strong>di</strong>ficante, dell’episo<strong>di</strong>o: tutti e <strong>di</strong>eci i prigionieri erano<br />
ricorsi al medesimo stratagemma, e il senato permise loro <strong>di</strong> rimanere a Roma.<br />
Politica interna. I valori supremi nell’ambito della vita civile sono per <strong>Livio</strong> la<br />
libertas e la concor<strong>di</strong>a. Il contenuto politico della libertas viene efficacemente sintetizzato<br />
da <strong>Livio</strong> nella premessa al secondo libro: Liberi iam hinc populi Romani res pace belloque<br />
gestas, annuos magistratus, imperiaque legum potenti ora quam hominum peragam (2,1,1),<br />
“Tratterò <strong>di</strong> qui in avanti le imprese in pace e in guerra del popolo romano ormai libero,<br />
le magistrature annuali e il dominio delle leggi più potente <strong>di</strong> quello degli uomini”.<br />
L’ultimo dei re, prosegue lo storico, aveva reso più desider<strong>ab</strong>ile, con la sua superbia, la<br />
libertà; i consoli annuali furono garanzia contro la tirannide e l’arbitrio, garanzia resa<br />
st<strong>ab</strong>ile da Bruto, che impose a tutto il popolo romano <strong>di</strong> giurare solennemente “che non<br />
avrebbe mai più consentito a nessuno <strong>di</strong> regnare a Roma” (2,1,9). La libertas si<br />
caratterizza dunque in primo luogo come antitesi al regnum, voc<strong>ab</strong>olo che ha sempre in
Letteratura latina B a.a. 2008-2009 mod. 2. Appunti delle lezioni 20<br />
<strong>Livio</strong> una connotazione negativa. L’accusa, o anche solo il vago sospetto, <strong>di</strong> aspirare al<br />
regnum è la più grave che possa colpire un uomo politico. Garanzia della libertas contro il<br />
pericolo del regnum è l’avvicendamento annuale al potere supremo; il suo contenuto<br />
specifico, l’essenza della libertas, è il dominio della legge. Il concetto viene sviluppato da<br />
<strong>Livio</strong>, secondo una consuetu<strong>di</strong>ne frequente, non in forma <strong>di</strong> commento <strong>di</strong>retto ai fatti, ma<br />
attraverso le argomentazioni dei sostenitori della monarchia. La repubblica appena nata<br />
deve subito affrontare un grave pericolo: un complotto dei Tarquini cacciati mira ad<br />
imporre <strong>di</strong> nuovo il regno, con l’aiuto e la complicità <strong>di</strong> elementi della nobiltà romana<br />
scontenti del nuovo stato <strong>di</strong> cose. Le considerazioni <strong>di</strong> questi giovani nobili, che, coetanei<br />
e compagni dei giovani Tarquini, si erano <strong>ab</strong>ituati ormai a vivere more regio, sono riferite<br />
dallo storico in forma <strong>di</strong> <strong>di</strong>scorso in<strong>di</strong>retto: “ora che tutti avevano eguali <strong>di</strong>ritti, la libertà<br />
degli altri si era risolta nella loro servitù; un re, <strong>di</strong>cevano, è un uomo, dal quale si può<br />
ottenere quando occorra il giusto e l’ingiusto; è accessibile al favore e al beneficio, può<br />
a<strong>di</strong>rarsi e perdonare, sa <strong>di</strong>stinguere l’amico dal nemico; le leggi invece sono cosa sorda,<br />
che non si piega alle preghiere, più giovevole e buona per il debole che per il potente; se<br />
si oltrepassa il limite imposto non si può sperare né indulgenza né perdono; è pericoloso<br />
insomma essere costretti a vivere contando solo sull’onestà, essendo la natura umana<br />
tanto debole e incline all’errore” (2,3,3).<br />
La concor<strong>di</strong>a è per <strong>Livio</strong> essenziale nella vita dello stato: essa si configura come<br />
coll<strong>ab</strong>orazione armoniosa, che comporta moderazione, buon senso, rinuncia, spirito <strong>di</strong><br />
sacrificio, in vista <strong>di</strong> un bene superiore. Essa riguarda i comandanti in guerra<br />
(innumerevoli gli esempi <strong>di</strong> <strong>di</strong>scor<strong>di</strong>a fra i capi che provoca <strong>di</strong>sastri e sconfitte), i<br />
magistrati in pace, ma soprattutto le classi sociali (concor<strong>di</strong>a or<strong>di</strong>num). Quest’ultima è un<br />
bene assoluto, da ottenere e conservare a qualsiasi costo. Proprio in questa prospettiva<br />
vengono da <strong>Livio</strong> presentati i contrasti dei primi secoli della repubblica fra patrizi e plebei,<br />
certo molto idealizzati. Lo storico coglie ogni occasione per sottolineare e lodare i<br />
provve<strong>di</strong>menti atti a promuovere la concor<strong>di</strong>a. Si tratta dapprima <strong>di</strong> graziose concessioni<br />
fatte dai patrizi alla plebe perché si mantenga <strong>di</strong>sciplinata e obbe<strong>di</strong>ente, e soprattutto<br />
faccia la guerra quando è necessario. Bruto amplia a 300 il numero dei senatori,<br />
immettendovi un certo numero <strong>di</strong> citta<strong>di</strong>ni <strong>di</strong> rango equestre: “questo giovò<br />
straor<strong>di</strong>nariamente – commenta <strong>Livio</strong> – alla concor<strong>di</strong>a della città, e a conciliare ai patrizi<br />
l’animo della plebe” (2,1,11). Porsenna sta preparando la guerra contro Roma; il senato è<br />
preoccupato, teme che la plebe, pur <strong>di</strong> avere la pace, accetti <strong>di</strong> nuovo i re e la servitù.<br />
Allora si mostra largo <strong>di</strong> blan<strong>di</strong>menta per la plebe: gran<strong>di</strong> rifornimenti <strong>di</strong> grano,<br />
nazionalizzazione del sale, esenzione dai dazi e dal tributo <strong>di</strong> guerra per la plebe.<br />
Naturalmente il risultato è quello voluto: “questa generosità del senato, anche più tar<strong>di</strong>,<br />
quando la città fu asse<strong>di</strong>ata e mancavano i viveri, mantenne la città così concorde che il
Letteratura latina B a.a. 2008-2009 mod. 2. Appunti delle lezioni 21<br />
nome <strong>di</strong> re era o<strong>di</strong>ato dai più umili non meno che dai sommi citta<strong>di</strong>ni, e in seguito<br />
nessun uomo politico <strong>di</strong>venne con cattive arti tanto popolare quanto allora il senato tutto<br />
con il suo buon governo” (2,9,7-8).<br />
La notizia della morte <strong>di</strong> Tarquinio il Superbo in esilio segna l’inizio <strong>di</strong> un periodo<br />
più <strong>di</strong>fficile: dopo aver fino a quel momento trattato con ogni riguardo la plebe, gli<br />
aristocratici iniziano a vessarla. Che cosa fecero <strong>di</strong> preciso <strong>Livio</strong> non <strong>di</strong>ce, si limita a<br />
questa in<strong>di</strong>cazione piuttosto vaga: iniuriae a primoribus fieri coeptae (2,21,76). Scoppia<br />
all’improvviso la rivolta della plebe, e le cause <strong>di</strong> essa sono appena accennate:<br />
“incombeva la minaccia della guerra contro i Volsci, e la città <strong>di</strong>scorde al suo interno<br />
ardeva per l’o<strong>di</strong>o fra patrizi e plebei, soprattutto a causa della schiavitù per debiti<br />
(maxime propter nexos ob aes alienum)” (2,23,1). Si tratta <strong>di</strong> un tema del tutto nuovo, ma<br />
<strong>Livio</strong> vi accenna brevemente come se fosse cosa già nota (forse sono queste le iniuriae dei<br />
patrizi contro la plebe?) Con una tecnica <strong>ab</strong>ituale, piuttosto che analizzare le cause della<br />
rivolta, <strong>Livio</strong> preferisce presentarle drammaticamente con un episo<strong>di</strong>o <strong>di</strong> grande effetto.<br />
Un vecchio trasandato, macilento, stracciato si precipita nel foro, dove molti riconoscono<br />
in lui un antico centurione che nell’esercito si era fatto onore. Radunatasi una grande<br />
folla, il vecchio spiega tra i lamenti la ragione del suo aspetto attuale: mentre prestava<br />
servizio nell’esercito, le sue terre erano state devastate, la fattoria bruciata, il bestiame<br />
rubato; ridottosi in miseria e indebitatosi, era <strong>di</strong>venuto schiavo del suo cre<strong>di</strong>tore. C’erano<br />
evidentemente molti nella con<strong>di</strong>zione <strong>di</strong> questo personaggio, se poco dopo la plebe si<br />
rifiuta <strong>di</strong> arruolarsi per la guerra contro i Volsci; un e<strong>di</strong>tto che impone ai cre<strong>di</strong>tori <strong>di</strong><br />
lasciar liberi i debitori perché essi possano arruolarsi risolve sul momento la situazione.<br />
Sconfitto il nemico e passato il pericolo, la situazione torna quella <strong>di</strong> prima, e <strong>di</strong> nuovo i<br />
plebei, ad una nuova minaccia <strong>di</strong> guerra (da parte <strong>di</strong> S<strong>ab</strong>ini), rifiutano l’arruolamento,<br />
opponendosi anche ai littori che hanno il compito <strong>di</strong> arrestare i ribelli. Nemmeno in<br />
questa circostanza, afferma <strong>Livio</strong>, si giunse alla violenza; l’intervento dei consoli sedò la<br />
rissa, nella quale sine lapide sine telo plus clamoris atque irarum quam iniuriae fuerat<br />
(2,29,4), “nessuno aveva messo mano a pietre o armi, e c’era stato più chiasso e r<strong>ab</strong>bia<br />
che vera violenza”.<br />
Quando per la terza volta i patrizi si rifiutano <strong>di</strong> prendere in considerazione e <strong>di</strong><br />
cercare <strong>di</strong> risolvere la questione dei debiti, si arriva alla secessione sul Monte Sacro. I<br />
patrizi sono sconfitti, ma la concor<strong>di</strong>a va rist<strong>ab</strong>ilita ad ogni costo. Queste le<br />
considerazioni che lo storico attribuisce ai patrizi: “fino a quando quella moltitu<strong>di</strong>ne che<br />
si era ritirata se ne sarebbe rimasta tranquilla? Che cosa sarebbe accaduto, se nel<br />
frattempo fosse scoppiata una guerra esterna? Certo non restava nessuna speranza, se<br />
non la concor<strong>di</strong>a fra i citta<strong>di</strong>ni. Bisognava restituirla alla città con qualsiasi mezzo,<br />
giusto o ingiusto”(2,32,6-7). Si manda così Menenio Agrippa, “uomo eloquente e caro alla
Letteratura latina B a.a. 2008-2009 mod. 2. Appunti delle lezioni 22<br />
plebe”, che con la nota favoletta 15 persuade i ribelli ad intavolare trattative, che<br />
porteranno ad una delle più importanti conquiste per la plebe, l’istituzione, nel 493, del<br />
tribunato della plebe (2,32,8-33,1). Pochissime parole <strong>Livio</strong> spende per spiegare le<br />
caratteristiche <strong>di</strong> questa magistratura – che certo poteva presumere sufficientemente<br />
nota ai suoi lettori -, né accenna più alla questione dei debiti, dalla quale la <strong>di</strong>scor<strong>di</strong>a<br />
aveva avuto origine.<br />
In tutto il lungo racconto del primo conflitto fra patrizi e plebei è notevole<br />
l’insistenza con cui <strong>Livio</strong> ripete che non si giunse mai, da nessuna delle due parti, alla<br />
violenza aperta, pur essendo gli interessi in gioco così importanti. Questa presentazione è<br />
certo, se non proprio una falsificazione dei dati, almeno una idealizzazione. Qualche atto<br />
violento c’era stato, e risulta da <strong>Livio</strong> stesso: in un <strong>di</strong>scorso Coriolano (2,34,11) si<br />
riferisce a devastazioni e razzie che durante la secessione la plebe aveva compiuto nei<br />
campi dei patrizi.<br />
Anche a proposito delle successive conquiste della plebe – la co<strong>di</strong>ficazione delle<br />
leggi in un testo scritto (XII tavole) 16, la lex Canuleia (<strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> conubium fra patrizi e<br />
plebei) 17 , le leges Liciniae Sextiae 18 (la più importante delle quali accordava ai plebei<br />
l’accesso al consolato) – <strong>Livio</strong> rileva tutti gli esempi <strong>di</strong> moderazione, che consentirono il<br />
mantenimento della concor<strong>di</strong>a pur nel corso <strong>di</strong> questo duro conflitto. Ad es. dopo aver<br />
ottenuto che anche i plebei possano essere eletti tribuni consolari (tappa interme<strong>di</strong>a nella<br />
lotta per il consolato), la plebe elegge alla carica soltanto dei patrizi, e <strong>Livio</strong> commenta:<br />
“tale moderazione, equità e altezza d’animo che allora tutto il popolo <strong>di</strong>mostrò, dove si<br />
potrebbero trovare oggi in un uomo solo?” (4,6,12). In questo caso la moderazione<br />
consiste nel rinunciare a valersi subito del <strong>di</strong>ritto appena conquistato; la concor<strong>di</strong>a in<br />
effetti il più delle volte scaturisce dal mantenimento, spontaneamente accettato,<br />
dell’or<strong>di</strong>ne sociale esistente. L’approvazione <strong>di</strong> <strong>Livio</strong> per esempi <strong>di</strong> moderazione <strong>di</strong> questo<br />
tipo in<strong>di</strong>ca chiaramente che il suo atteggiamento è fondamentalmente conservatore. Ciò è<br />
15<br />
Il racconto, con la sua morale esplicita, è questo: “Al tempo in cui nell’uomo non c’era, come ora,<br />
accordo armonioso fra tutte le sue parti, ma ciascuna <strong>di</strong> esse era dotata <strong>di</strong> pensiero e <strong>di</strong> parola<br />
autonomi, le altre parti si risentirono che il loro impegno, la loro fatica, i loro servigi andassero<br />
tutti esclusivamente a vantaggio del ventre, e che il ventre invece se ne stesse senza far nulla nel<br />
mezzo, limitandosi a godere dei piaceri che gli venivano offerti; fecero allora una congiura,<br />
concordando fra loro che le mani non portassero il cibo alla bocca, che la bocca non lo accogliesse,<br />
che i denti non lo masticassero. A causa <strong>di</strong> questa ribellione, mentre volevano soggiogare il ventre<br />
con la fame, le singole membra e il corpo tutto quanto si ridussero ad un deperimento estremo.<br />
Fu evidente allora che anche il ventre aveva una sua funzione, non passiva, e che era nutrito non<br />
più <strong>di</strong> quanto esso stesso nutrisse, <strong>di</strong>stribuendo in ogni parte del corpo, equamente <strong>di</strong>viso<br />
attraverso le vene, il sangue che ci dà vita e vigore, prodotto attraverso la <strong>di</strong>gestione del cibo.<br />
Mostrando quin<strong>di</strong>, con questo apologo, quanto la ribellione interna del corpo fosse simile al<br />
risentimento della plebe contro i patrizi, (Menenio Agrippa) riuscì a piegare l’animo dei ribelli”<br />
(2,32.9-12).<br />
16<br />
Nel 451-50 (3,32 ss.)<br />
17<br />
Nel 445 (4,2 ss,)<br />
18<br />
Nel 367 (6,36 ss,)
Letteratura latina B a.a. 2008-2009 mod. 2. Appunti delle lezioni 23<br />
confermato dal suo giu<strong>di</strong>zio sulle riven<strong>di</strong>cazioni popolari sostenute dai tribuni della<br />
plebe: le varie proposte sia <strong>di</strong> riforme agrarie, che in parte prefigurano le proposte dei<br />
Gracchi, sia <strong>di</strong> <strong>di</strong>stribuzioni gratuite <strong>di</strong> grano alla plebe più povera, sono considerate da<br />
<strong>Livio</strong> deleterie per lo stato; in un caso lo storico impiega ad<strong>di</strong>rittura il termine venenum19. Nel racconto <strong>di</strong> <strong>Livio</strong> i tribuni della plebe sono quasi tutti dei se<strong>di</strong>ziosi, che fomentano<br />
l’o<strong>di</strong>o contro i patrizi, turbano l’or<strong>di</strong>ne pubblico, seminano <strong>di</strong>scor<strong>di</strong>a e mettono in<br />
pericolo la patria; lo storico esprime persino dei dubbi sull’opportunità dell’istituzione <strong>di</strong><br />
questa magistratura20. Politica estera e guerra. La moderazione è presentata da <strong>Livio</strong> come regola <strong>di</strong><br />
condotta dei Romani anche nei confronti dei popoli soggetti o alleati; a questa virtù si<br />
aggiunge la clementia nei confronti degli sconfitti. Ci sono naturalmente episo<strong>di</strong> in cui i<br />
Romani si comportano senza alcuna moderazione né clemenza, e <strong>Livio</strong> è costretto a<br />
riconoscerlo, senza tuttavia rinunciare ad un tentativo <strong>di</strong> giustificazione. E’ il caso, ad es.,<br />
del brutale sterminio dei citta<strong>di</strong>ni inermi <strong>di</strong> Enna (durante la guerra annibalica). I<br />
Cartaginesi sono in Sicilia, molte città alleate <strong>di</strong> Roma passano dalla loro parte. Marcello<br />
allora fa porre presi<strong>di</strong> romani nelle città ancora fedeli, per costringerle a mantenersi tali.<br />
Ad Enna i maggiorenti della città protestano contro questo trattamento: sono stati privati<br />
delle chiavi della loro città, sono trattati come dei prigionieri, pretendono che i rapporti<br />
con Roma tornino ad essere quelli <strong>di</strong> alleanza. Per <strong>di</strong>scutere questa questione il generale<br />
romano fa radunare l’assemblea dei citta<strong>di</strong>ni <strong>di</strong> Enna nell’anfiteatro; quando tutti sono<br />
ammassati inermi in un unico spazio, i soldati romani si gettano sulla folla e ne fanno<br />
strage. Il commento conclusivo <strong>di</strong> <strong>Livio</strong> è: ita Henna aut malo aut necessario facinore<br />
retenta (24,39,7), “e così Enna fu conservata, con un’azione o malvagia o necessaria”. Il<br />
tentativo <strong>di</strong> giustificazione contenuto nell’aggettivo necessario è bilanciato<br />
dall’osservazione che <strong>Livio</strong> fa subito seguire. Questa azione, <strong>di</strong>chiara, non ottenne l’effetto<br />
sperato: la notizia dell’ecci<strong>di</strong>o, invece <strong>di</strong> rafforzare nella fedeltà a Roma le altre città della<br />
19 Nel 476, cessato, almeno momentaneamente, il pericolo esterno dei Veienti, tribuni plebem<br />
agitare suo veneno, agraria lege, in resistentes incitare patres (2,52,2), “i tribuni presero a sobillare<br />
la plebe con il loro solito veleno, la legge agraria, e ad aizzarla contro i patrizi”.<br />
20 Siamo nel 491, la magistratura è appena stata istituita; una grave carestia ha colpito la città;<br />
quando dalla Sicilia arriva un ingente quantitativo <strong>di</strong> grano, si apre in senato la <strong>di</strong>scussione sul<br />
prezzo cui lo si debba dare alla plebe; molti pensavano si potesse cogliere l’occasione per ricattare<br />
la plebe, e recuperare i <strong>di</strong>ritti dei patrizi, loro estorti con la secessione e la violenza. <strong>Livio</strong> riferisce<br />
il <strong>di</strong>scorso <strong>di</strong> Coriolano, hostis tribuniciae potestatis, che propone, in sostanza, <strong>di</strong> affamare la plebe,<br />
per ven<strong>di</strong>care le violenze della passata secessione. Lo storico invece fa questa considerazione:<br />
“Non è facile <strong>di</strong>re se i patrizi avrebbero dovuto – cosa che ritengo potessero fare – in cambio <strong>di</strong> un<br />
ribasso del prezzo del grano, liberarsi della potestà tribunizia e <strong>di</strong> tutti i <strong>di</strong>ritti che loro malgrado<br />
la plebe aveva loro estorto” (2,34,12). Anche sui Gracchi, soprattutto su Gaio, il giu<strong>di</strong>zio dello<br />
storico doveva essere molto negativo; le proposte <strong>di</strong> legge <strong>di</strong> Gaio Gracco sono definite perniciosae<br />
(per. 60).
Letteratura latina B a.a. 2008-2009 mod. 2. Appunti delle lezioni 24<br />
Sicilia, provocò molte defezioni, a riprova che è il governo moderato e giusto e non il<br />
terrore che mantiene gli alleati fedeli.<br />
Tipicamente liviano, e privo <strong>di</strong> ripensamenti, è il breve commento che segue alla<br />
narrazione dell’orrenda punizione che fu inflitta a Mezio Fufezio per il suo tra<strong>di</strong>mento21: “fu quello – <strong>di</strong>chiara incre<strong>di</strong>bilmente lo storico - presso i Romani il primo e ultimo<br />
supplizio <strong>di</strong> un genere poco rispettoso delle leggi umane; negli altri nessun popolo può<br />
vantarsi <strong>di</strong> aver applicato pene più miti” (1,28,11).<br />
Nei rapporti con gli altri popoli, accanto alla clementia verso i vinti, i Romani<br />
praticano la iustitia: le loro guerre non sono mai aggressioni brutali; il motivo per la<br />
<strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> guerra è sempre un motivo giusto, vale a <strong>di</strong>re rispondere ad un attacco<br />
nemico, riparare un torto subito, o, più spesso, intervenire in aiuto <strong>di</strong> alleati o <strong>di</strong> popoli<br />
più deboli, che aggre<strong>di</strong>ti hanno richiesto la protezione del popolo romano. Ovviamente<br />
<strong>Livio</strong> si rendeva conto che una simile presentazione delle ragioni <strong>di</strong> guerra romane non<br />
poteva essere cre<strong>di</strong>bilmente applicata a tutte le guerre intraprese da Roma. Fino a che si<br />
tratta <strong>di</strong> guerre <strong>di</strong> espansione in Italia, o anche dello scontro con Cartagine, questo<br />
schema interpretativo più o meno funziona. Proprio poco prima della conclusione della<br />
guerra annibalica, <strong>Livio</strong> riferisce con ampiezza <strong>di</strong> particolari un episo<strong>di</strong>o che dovrebbe<br />
riba<strong>di</strong>re il concetto che in guerra i Romani rispettano sempre la iustitia. Dopo la sconfitta<br />
del loro alleato Siface, i Cartaginesi inviano a Scipione, in Africa, trenta seniorum<br />
principes (i membri più anziani e influenti del senato) per chiedere la pace, <strong>di</strong>chiarandosi<br />
<strong>di</strong>sposti ad accettare le con<strong>di</strong>zioni che Scipione vorrà imporre: paratis oboe<strong>di</strong>enter servire<br />
imperaret quae vellet (30,16,7) “comandasse pure quel che voleva: essi erano pronti a<br />
sottomettersi alle sue con<strong>di</strong>zioni”. La risposta <strong>di</strong> Scipione è riferita così: “Scipione<br />
risponde che era venuto in Africa con la speranza, accresciuta poi dal felice successo<br />
della guerra, <strong>di</strong> riportare in patria vittoria, non pace; e tuttavia, benché <strong>ab</strong>bia già quasi in<br />
mano la vittoria, non respinge la proposta <strong>di</strong> pace, perché tutti i popoli sappiano che il<br />
popolo romano con giustizia intraprende le guerre e con giustizia le conclude” (30,16,8-9).<br />
Detta quin<strong>di</strong> le con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> pace, molto severe, e pretende che il senato cartaginese<br />
decida entro tre giorni: se le con<strong>di</strong>zioni saranno accettate, i Cartaginesi dovranno<br />
stipulare una tregua con lui, e inviare ambasciatori a Roma. Il senato cartaginese accetta<br />
tutte le con<strong>di</strong>zioni, ma solo, sembra implicare lo storico, per guadagnar tempo, in attesa<br />
21 La guerra tra Roma e Alba, al tempo del re Tullo Ostiliio, è stata decisa, <strong>di</strong> comune accordo, dal<br />
duello tra Orazi e Curiazi. Dopo la vittoria romana, il capo albano Mezio Fufezio riceve l’or<strong>di</strong>ne <strong>di</strong><br />
partecipare con i Romani alla battaglia contro Veienti e Fidenati. Il suo comportamento ambiguo<br />
durante il combattimento viene punito così: “Fatte avvicinare due quadrighe, fa legare (sc. il re<br />
Tullo) Mezio <strong>di</strong>steso ai carri; quin<strong>di</strong> i cavalli furono lanciati in <strong>di</strong>rezioni opposte, e ne trascinarono<br />
via il corpo smembrato sui due carri, là dove le membra erano state fissate con i lacci”. Il supplizio<br />
è preceduto da queste parole che il re rivolge al colpevole: “Come poco fa il tuo animo era <strong>di</strong>viso<br />
fra Fidene e Roma, così ora verrà fatto a pezzi il tuo corpo”. (1,28,9-10).
Letteratura latina B a.a. 2008-2009 mod. 2. Appunti delle lezioni 25<br />
che Annibale sbarchi in Africa. Quando ciò avviene la guerra riprende; ma i Romani<br />
hanno <strong>di</strong>mostrato il loro rispetto della iustitia: il solo respons<strong>ab</strong>ile della ripresa delle<br />
ostilità è Annibale.<br />
Sostenere però che Roma lottasse per la propria sopravvivenza nelle successive<br />
guerre <strong>di</strong> conquista narrate nella quarta e nella quinta decade era molto più <strong>di</strong>fficile; e<br />
non è certo un caso che proprio in questi <strong>libri</strong>, lasciata un po’ in ombra la iustitia, si<br />
moltiplichino le menzioni della straor<strong>di</strong>naria clementia dei Romani. Lo scontro con<br />
Filippo V <strong>di</strong> Macedonia è presentato come una guerra <strong>di</strong>sinteressata e generosa,<br />
intrapresa da Roma soltanto per liberare la Grecia dal suo dominio. Questo concetto<br />
viene efficacemente svolto in due <strong>di</strong>scorsi.<br />
Nel 200, davanti all’assemblea degli Etòli (<strong>di</strong> cui sia Filippo sia i Romani<br />
sollecitano l’alleanza) parlano un inviato <strong>di</strong> Filippo e un ambasciatore romano. Il <strong>di</strong>scorso<br />
del Macedone (31,29) svolge i temi antiromani classici; il legato romano, oltre a riba<strong>di</strong>re<br />
che Roma è sempre intervenuta nelle guerre perché il suo aiuto è stato richiesto, <strong>di</strong>fende<br />
la moderazione con cui sempre Roma ha trattato i popoli vinti, come <strong>di</strong>mostra l’esempio<br />
recentissimo <strong>di</strong> Cartagine (“dopo averla sconfitta <strong>ab</strong>biamo concesso a Cartagine pace e<br />
libertà” 31,31,15), e <strong>di</strong>chiara: “c’è piuttosto da temere che concedendo troppo<br />
generosamente il nostro perdono ai vinti, noi incoraggiamo un sempre maggior numero<br />
<strong>di</strong> popoli a cercare occasioni <strong>di</strong> guerra contro <strong>di</strong> noi” (31,31,16).<br />
Il secondo <strong>di</strong>scorso è quello in cui <strong>Tito</strong> Quinzio Flaminino, dopo aver sconfitto nel<br />
197 Filippo a Cinocefale, proclama solennemente, durante i giochi istmici del 196, la<br />
libertà <strong>di</strong> tutta la Grecia: “il senato romano e il generale <strong>Tito</strong> Quinzio, debellati Filippo e i<br />
Macedoni, decidono che siano liberi, esenti da tributi, retti dalle proprie leggi, i Corinzi, i<br />
Focesi, ....” (segue l’elenco <strong>di</strong> tutti i popoli che prima erano sotto il dominio <strong>di</strong> Filippo)<br />
(33,32,5). Il commento a questo incre<strong>di</strong>bile gesto <strong>di</strong> generosità è affidato da <strong>Livio</strong> alla folla<br />
presente alla <strong>di</strong>chiarazione, in forma <strong>di</strong> <strong>di</strong>scorso in<strong>di</strong>retto: “c’era al mondo un popolo che<br />
a sue spese, affrontando fatiche e pericoli, faceva la guerra per la libertà altrui, e offriva<br />
questo beneficio non a popoli confinanti o vicini o della medesima terra, ma attraversava<br />
i mari, perché non esistesse sulla terra un dominio ingiusto, ma dappertutto<br />
dominassero il <strong>di</strong>ritto, la giustizia, la legge” (33,33,5). Le medesime considerazioni erano<br />
svolte dalla fonte (Polibio, 18,46), da cui certamente <strong>Livio</strong> <strong>di</strong>pende, ma che impiega con<br />
accortezza: mentre Polibio in prima persona <strong>di</strong>chiara che la gioia e l’incredulità della folla<br />
presente all’annuncio erano ben comprensibili, giacché era cosa splen<strong>di</strong>da che i Romani<br />
avessero sostenuto spese e affrontato pericoli per la libertà della Grecia, ecc., <strong>Livio</strong> non<br />
commenta l’avvenimento, ma assai più efficacemente attribuisce questo elogio della<br />
generosità romana ai popoli che ne beneficiano.
Letteratura latina B a.a. 2008-2009 mod. 2. Appunti delle lezioni 26<br />
Se <strong>Livio</strong> evita <strong>di</strong> solito <strong>di</strong> esprimere <strong>di</strong>rettamente la sua approvazione per il<br />
comportamento romano, ancor più raramente interviene a criticarlo. Ma non ignorava<br />
certamente le accuse che venivano mosse alla politica imperialistica <strong>di</strong> Roma; in un caso<br />
in particolare dà voce a queste critiche, in modo in<strong>di</strong>retto, come nell’elogio della<br />
generosità <strong>di</strong> Flaminino. Quando Antioco III è minacciato in Asia dall’esercito guidato<br />
dagli Scipioni22, nel 190 invia una lettera al re <strong>di</strong> Bitinia Prusia, per indurlo ad allearsi<br />
con lui. Polibio (21,11,1) <strong>di</strong>ce semplicemente: “il re Antioco [...] mandò ambasciatori a<br />
Prusia, invitandolo a far alleanza con lui”; <strong>Livio</strong> aggiunge la lettera 23 , e ne rivela<br />
brevemente il contenuto: “aveva mandato (sc. Antioco) a Prusia ambasciatori, e una<br />
lettera, in cui lamentava che i Romani fossero passati in Asia: venivano – scriveva – per<br />
<strong>ab</strong>battere tutti i regni, perché su tutta la terra non esistesse altro dominio che quello<br />
romano; Filippo, N<strong>ab</strong>ide erano stati sbaragliati; ora come terzo veniva assalito lui; una<br />
sorta <strong>di</strong> inarrest<strong>ab</strong>ile incen<strong>di</strong>o si sarebbe propagato, colpendo via via tutti quelli che si<br />
trovavano più vicini al regno già sottomesso; da lui sarebbero passati in Bitinia, giacché<br />
Eumene volontariamente aveva già accettato la servitù” (37,25,4-6). Questo breve testo,<br />
tanto più se si tratta <strong>di</strong> una creazione dello storico, in<strong>di</strong>ca che anche <strong>Livio</strong> si rendeva<br />
conto che la condotta romana in politica estera e verso i popoli alleati o soggetti era<br />
andata mutando; è prob<strong>ab</strong>ile che non riuscisse né volesse più continuare a giustificare<br />
come “guerre giuste” anche i meto<strong>di</strong> dell’imperialismo romano nei tempi più recenti della<br />
repubblica. Anche se i brevi riassunti delle periǒchae non consentono <strong>di</strong> capire quali<br />
fossero l’atteggiamento e il giu<strong>di</strong>zio dello storico sulle guerre <strong>di</strong> conquista più recenti, un<br />
in<strong>di</strong>zio interessante è offerto dalle considerazioni che lo storico attribuisce ad alcuni<br />
anonimi senatori romani moris antiqui memores sull’inganno perpetrato con successo da<br />
due ambasciatori romani ai danni <strong>di</strong> Perseo (42, 47,1-4: v. testi).<br />
Sotto questo aspetto (la lealtà in guerra) l’antica repubblica è secondo <strong>Livio</strong> un<br />
modello. <strong>Gli</strong> elementi fondamentali della condotta giusta in guerra, e degli esiti positivi<br />
che questa produce (spontanea sottomissione e duratura fedeltà dei vinti) sono da <strong>Livio</strong><br />
sintetizzati, ad esempio, nel famoso episo<strong>di</strong>o del maestro <strong>di</strong> Faleri (5, 27: v. testi).<br />
Tra le virtù romane grande rilievo assume in <strong>Livio</strong> la <strong>di</strong>sciplina, sia in pace sia<br />
soprattutto in guerra, dove la pronta obbe<strong>di</strong>enza ai superiori, la docile accettazione <strong>di</strong><br />
rimproveri e punizioni riscuote a volte l’approvazione esplicita dello storico. Per es.<br />
22 Il comando supremo era affidato a Lucio Scipione; il più famoso fratello, Publio Scipione<br />
(l’Africano), lo affiancava con il semplice titolo <strong>di</strong> legato.<br />
23 Secondo Polibio (21,11) invece furono soltanto i Romani a scrivere a Prusia: una lettera inviata<br />
dai fratelli Lucio e Publio Scipione rassicurò il re, che prima temeva “che i Romani passassero in<br />
Asia e ne <strong>ab</strong>battessero tutti i regni” (il medesimo timore attribuito da <strong>Livio</strong> ad Antioco), e lo<br />
indusse ad <strong>ab</strong>bandonare la causa <strong>di</strong> Antioco. Anche <strong>Livio</strong> menziona la lettera (anzi due <strong>di</strong>stinte<br />
lettere) degli Scipioni, il cui contenuto persuase Prusia a non prendere le armi contro i Romani.
Letteratura latina B a.a. 2008-2009 mod. 2. Appunti delle lezioni 27<br />
quando il <strong>di</strong>ttatore Cincinnato degrada il console Minucio 24 ed esclude dalla preda il suo<br />
esercito 25, <strong>Livio</strong> fa questo commento: “a tal punto allora gli animi erano <strong>di</strong>sposti ad<br />
obbe<strong>di</strong>re docilmente ad un or<strong>di</strong>ne superiore che questo esercito, tenendo conto più del<br />
beneficio ricevuto che dell’onta inflittagli [...], decretò una corona d’oro per il <strong>di</strong>ttatore”<br />
(3,29,3).<br />
Se la <strong>di</strong>sciplina è la virtù propria dei soldati, per i condottieri le doti più importanti<br />
sono prudentia e ratio. <strong>Livio</strong> mette particolarmente in evidenza queste doti nella<br />
caratterizzazione <strong>di</strong> Quinto F<strong>ab</strong>io Massimo, il Cunctator, e anche, per converso, ogni volta<br />
che rileva come sconfitte e <strong>di</strong>sastri siano stati causati dalla temeritas <strong>di</strong> un generale26. La<br />
prudentia consiste soprattutto nel non lasciare mai niente al caso, e nel posporre sempre<br />
l’ambizione a conquistarsi gloria personale ad una valutazione attenta delle circostanze.<br />
Dopo aver illustrato il nuovo corso impresso alla guerra dal Temporeggiatore, <strong>Livio</strong><br />
osserva che Annibale comprende che finalmente i Romani, ammaestrati da tanti <strong>di</strong>sastri,<br />
hanno trovato un condottiero accorto, <strong>di</strong> cui egli dovrà temere non la vis ma la prudentia.<br />
Vita privata. Nell’ambito privato, oltre alla pu<strong>di</strong>citia esemplarmente illustrata e<br />
celebrata nelle famose leggende <strong>di</strong> Lucrezia (1,58-59) e <strong>di</strong> Virginia (3,44-50), ha grande<br />
valore la frugalitas, un costume <strong>di</strong> vita semplice e austero, lontano dal lusso che<br />
corrompe e fiacca. L’occasione per esaltare in modo esplicito (e in questo caso davvero<br />
enfatico) questa virtù dei Romani antichi è offerta a <strong>Livio</strong> dalla vicenda <strong>di</strong> Cincinnato,<br />
introdotta così: “Val la pena che ascoltino coloro che <strong>di</strong>sprezzano ogni valore umano<br />
all’infuori della ricchezza, e ritengono che non vi sia posto per un grande onore o virtù se<br />
non là dove vi sia benessere sovr<strong>ab</strong>bondante. L’unica speranza del popolo romano, Lucio<br />
Quinzio, stava coltivando al <strong>di</strong> là del Tevere [...] un campo <strong>di</strong> quattro iugeri [...] Qui,<br />
mentre appoggiato alla pala scavava una fossa, o mentre stava arando, intento ad ogni<br />
modo – questo è certo – ad un lavoro agreste, fu salutato dagli inviati (sc. del senato)”<br />
(3,26,7-9). Asciugatosi il sudore e indossata la toga, Cincinnato viene salutato <strong>di</strong>ttatore, e<br />
si reca senza indugio a Roma per assumere la carica.<br />
24 Nel 458, inviato contro gli Equi, per imperizia e viltà si lascia rinchiudere ed asse<strong>di</strong>are nel suo<br />
accampamento stesso; per far fronte alla grave situazione (l’altro console accorso con le sue<br />
truppe non riesce a spezzare l’asse<strong>di</strong>o) si decide la nomina <strong>di</strong> un <strong>di</strong>ttatore, nella persona <strong>di</strong> Lucio<br />
Quinzio Cincinnato, che ottiene pieno successo, e conquista l’accampamento nemico.<br />
25 “Conquistato l’accampamento dei nemici, pieno d’ogni cosa [...], <strong>di</strong>stribuì il bottino soltanto ai<br />
suoi soldati; rimbrottando l’esercito consolare e il console stesso, <strong>di</strong>sse: ‘non avrete parte, soldati,<br />
della preda conquistata a quel nemico <strong>di</strong> cui per poco non <strong>di</strong>ventaste voi la preda. E tu, Lucio<br />
Minucio, fino a che non comincerai ad avere l’animo che si conviene ad un console, comanderai<br />
queste legioni come mio luogotenente’ ”, 3,29,1-2.<br />
26 Le sconfitte alla Trebbia e a Canne furono secondo <strong>Livio</strong> causate dalla precipitazione e<br />
dall’ambizione del generale, rispettivamente il console Sempronio, ansioso <strong>di</strong> dar battaglia e<br />
vincere prima che entrino in carica i nuovi consoli, e contro il parere del collega Scipione, che è a<br />
letto ammalato (21,53 ss.), e il console (plebeo) Terenzio Varrone (22,40-43).
Letteratura latina B a.a. 2008-2009 mod. 2. Appunti delle lezioni 28<br />
Complementare all’esaltazione della frugalitas è la <strong>di</strong>mostrazione che vita agiata e<br />
lusso hanno conseguenze <strong>di</strong>sastrose: è il caso dei famosi ozi <strong>di</strong> Capua <strong>di</strong> Annibale.<br />
Condotti a svernare, dopo Canne, in una città minime salubris militari <strong>di</strong>sciplinae, i<br />
soldati <strong>di</strong> Annibale si <strong>ab</strong>ituano alla pigrizia, ai banchetti, all’ubriachezza, alla compagnia<br />
<strong>di</strong> meretrici: in questo errore va in<strong>di</strong>viduata ad<strong>di</strong>rittura la causa principale della sconfitta<br />
<strong>di</strong> Annibale, che da Capua uscì con un esercito trasformato, che aveva perduto la<br />
<strong>di</strong>sciplina <strong>di</strong> un tempo27. Il pregiu<strong>di</strong>zio patriottico induce <strong>Livio</strong> a presupporre che devozione religiosa, lealtà,<br />
valore in guerra, giustizia, amor <strong>di</strong> patria, <strong>di</strong>sciplina dei soldati e saggezza <strong>di</strong> uomini<br />
politici e generali, moderazione e sobrietà nei costumi <strong>di</strong> vita privati siano doti proprie dei<br />
Romani, soprattutto <strong>di</strong> quelli antichi; ma le virtù sono esaltate come valori autonomi,<br />
non perché possedute dai Romani: lo storico non manca talvolta <strong>di</strong> biasimare quei<br />
Romani che non vi si adeguano, e <strong>di</strong> giu<strong>di</strong>care positivamente i non Romani che si<br />
avvicinano a questo ideale.<br />
In generale egli interpreta i fatti, i successi e gli insuccessi militari e politici,<br />
facendo sempre riferimento a qualità morali, che costituiscono il criterio <strong>di</strong> giu<strong>di</strong>zio<br />
fondamentale.<br />
27 3,18,11-16. I periti artium militarium, sostiene <strong>Livio</strong>, ritennero che in quell’occasione Annibale<br />
avesse commesso un errore più grave <strong>di</strong> quello <strong>di</strong> non aver subito marciato su Roma dopo Canne:<br />
illa enim cunctatio <strong>di</strong>stulisse modo victoriam videri potuit, hic error vires ademisse ad vincendum. Lo<br />
storico attribuisce certo un peso eccessivo a questi famosi ozi: come infatti risulta dal suo<br />
racconto stesso, in quel medesimo inverno 216-215 i Cartaginesi asse<strong>di</strong>arono e conquistarono<br />
Casilino (23,19 e 22), e ciò avvenne prima del consolato <strong>di</strong> Gracco, che entrò in carica a marzo<br />
(23,24): la bella vita dell’esercito cartaginese a Capua non dovette dunque durare molto.
Letteratura latina B a.a. 2008-2009 mod. 2. Appunti delle lezioni 29<br />
LA PREFAZIONE<br />
La prefazione è la sezione dell’opera storiografica in cui la persona del narratore è<br />
in primo piano, e si rivolge <strong>di</strong>rettamente al suo pubblico, <strong>di</strong>chiarando ragioni e natura del<br />
proprio lavoro, le <strong>di</strong>fficoltà incontrate, quali scopi si proponga, come sia consapevole<br />
della necessità che il resoconto storico sia veritiero e imparziale, ecc.<br />
Come si è detto, l’opera <strong>di</strong> <strong>Livio</strong> conteneva <strong>di</strong>verse prefazioni, o premesse. La più<br />
importante è naturalmente la prefazione generale, che funge da presentazione dell’intera<br />
opera.<br />
Quando <strong>Livio</strong> scrive esisteva già una tra<strong>di</strong>zione antica e <strong>ab</strong>bastanza complessa<br />
sulla funzione e sui compiti <strong>di</strong> una praefatio, stu<strong>di</strong>ati, catalogati e co<strong>di</strong>ficati dai retori. In<br />
particolare, come si può dedurre dall’esame delle prefazioni delle opere storiche a noi<br />
note, si <strong>di</strong>rebbe che lo storico consideri necessario non solo e non tanto annunciare il<br />
tema che sarà trattato (questo è l’atteggiamento tipico del poeta epico), quanto<br />
soprattutto giustificare l’opera che sta per iniziare.<br />
I retori in<strong>di</strong>cavano come scopo fondamentale dell’esor<strong>di</strong>o, inteso come brano<br />
introduttivo in generale, ma in particolare <strong>di</strong> un’orazione, quello <strong>di</strong> ottenere la docilitas,<br />
l’adtentio, la benevolentia del pubblico (o del lettore), cioè la <strong>di</strong>sposizione generica ad<br />
ascoltare, la <strong>di</strong>sposizione specifica ad ascoltare quanto l’oratore (o l’autore) <strong>di</strong>rà, e un<br />
atteggiamento favorevole verso chi parla (o scrive). La docilitas si ottiene con una breve<br />
in<strong>di</strong>cazione del tema che sarà trattato, la adtentio con la <strong>di</strong>chiarazione dell’importanza o<br />
novità del tema, la benevolentia con l’elogio, ma senza arroganza, del compito che ci si è<br />
assunti, con un accenno alle <strong>di</strong>fficoltà incontrate, con la denigrazione degli avversari, con<br />
<strong>di</strong>chiarazioni che mostrino quanto chi parla stimi il suo pubblico, come consideri<br />
importante il suo giu<strong>di</strong>zio, ecc. Questi precetti, che i retori el<strong>ab</strong>orano soprattutto in<br />
relazione all’oratoria giu<strong>di</strong>ziaria, si possono trasferire anche alla prefazione dell’opera<br />
storica.<br />
In relazione specificamente ai proemi delle opere storiche <strong>ab</strong>biamo un testo<br />
interessante, <strong>di</strong> un retore anonimo tardo, che <strong>di</strong>ce:<br />
“I proemi <strong>di</strong> un’opera storica sono <strong>di</strong> tre tipi: possono riguardare la storia, la<br />
persona, la materia (de historia, de persona, de materia). Infatti o elogiamo in termini<br />
generali l’utilità della storia, come fa Catone, o in rapporto alla persona <strong>di</strong> chi scrive<br />
esponiamo il motivo per cui ha intrapreso questo compito, come Sallustio [...] oppure
Letteratura latina B a.a. 2008-2009 mod. 2. Appunti delle lezioni 30<br />
mostriamo che l’argomento che ci accingiamo a trattare è degno sia <strong>di</strong> essere scritto sia<br />
<strong>di</strong> essere letto, come <strong>Livio</strong> nei suoi <strong>libri</strong> dalla fondazione della città” 28.<br />
Era poi considerata tipica della prefazione <strong>di</strong> un’opera storica la professione <strong>di</strong><br />
veri<strong>di</strong>cità e <strong>di</strong> imparzialità.<br />
Tutti questi temi sono presenti nella prefazione <strong>di</strong> <strong>Livio</strong>. Come vedremo infatti,<br />
anche se in essa è prevalente il tema de materia, non mancano quelli de historia e de<br />
persona, trattati non ad uno ad uno, separatamente, ma intrecciati e fusi tra loro in<br />
modo originale.<br />
§§ 1-2 Il periodo iniziale, cui la sequenza esametrica 29 delle prime parole<br />
conferisce particolare solennità, è una el<strong>ab</strong>orata captatio benevolentiae. L’autore si<br />
presenta con un atteggiamento simpaticamente modesto e sincero: vorrebbe, come è<br />
naturale, che la sua fatica avesse successo, ma <strong>di</strong>chiara subito che non è affatto certo <strong>di</strong><br />
ottenere questo risultato, e anche che, quando pure avesse soggettivamente questa<br />
certezza, avrebbe ritegno a <strong>di</strong>chiararlo. Nelle parole si a primor<strong>di</strong>o...perscripserim è già<br />
contenuta una prima sommaria in<strong>di</strong>cazione dell’argomento dell’opera, semplice e solenne<br />
insieme, per l’impiego del termine primor<strong>di</strong>um, e anche, più precisamente, del modello<br />
storiografico prescelto. Sia l’in<strong>di</strong>cazione del punto <strong>di</strong> partenza (l’origine della città) sia<br />
l’impiego <strong>di</strong> perscribo30 informano i lettori, fin dalla prima riga, che non devono aspettarsi<br />
un’opera <strong>di</strong> tipo nuovo, alla moda, come quelle <strong>di</strong> Sisenna e <strong>di</strong> Sallustio, come quella che<br />
stava scrivendo il contemporaneo Asinio Pollione 31 : opere che trattavano un periodo<br />
breve e vicino nel tempo, o, come le monografie sallustiane, un singolo episo<strong>di</strong>o della<br />
storia <strong>di</strong> Roma. Quella che inizia è invece l’intera storia <strong>di</strong> Roma, esposta secondo il<br />
28<br />
Principiorum ad historiam pertinentium species sunt tres: de historia, de persona, de materia. Aut<br />
enim historiae bonum generaliter commendamus, ut Cato, aut pro persona scribentis rationem eius<br />
quod hoc officium adsumpserit red<strong>di</strong>mus, ut Sallustius [...], aut eam rem, quam relaturi sumus,<br />
<strong>di</strong>gnam quae et scribatur et legatur osen<strong>di</strong>mus, ut Livius <strong>ab</strong> <strong>urbe</strong> <strong>con<strong>di</strong>ta</strong>., Rhet. Latini min. Halm, p.<br />
588.<br />
29<br />
Fāctūrūsn(e) ǒpěrāe prětĭūm sim: come si vede, <strong>ab</strong>biamo i primi quattro metri <strong>di</strong> un esametro.<br />
Questo or<strong>di</strong>ne delle parole non è attestato dai co<strong>di</strong>ci (tra<strong>di</strong>zione <strong>di</strong>retta), che hanno facturusne<br />
sim..., ma da una citazione <strong>di</strong> Quintiliano (tra<strong>di</strong>zione in<strong>di</strong>retta): tutti gli e<strong>di</strong>tori accettano questa<br />
preziosa testimonianza. Questo inizio viene citato da Quintiliano (9,4,75) come esempio <strong>di</strong> un<br />
<strong>di</strong>fetto che nella prosa va <strong>di</strong> solito evitato, e cioè iniziare un periodo con una sequenza poetica,<br />
precisamente, in questo caso, con la parte iniziale <strong>di</strong> un verso. La testimonianza <strong>di</strong> Quintiliano è<br />
davvero preziosa: non solo conserva, con ogni prob<strong>ab</strong>ilità, il testo autentico, ma attesta l’origine<br />
molto antica del <strong>di</strong>verso or<strong>di</strong>ne delle parole presente nella tra<strong>di</strong>zione <strong>di</strong>retta. Aggiunge infatti: nam<br />
ita e<strong>di</strong><strong>di</strong>t, estque id melius quam quo modo emendatur. La sequenza esametrica non va<br />
naturalmente considerata una svista <strong>di</strong> <strong>Livio</strong>, ma un ritmo scelto <strong>di</strong> proposito per conferire<br />
solennità all’esor<strong>di</strong>o.<br />
30<br />
Il preverbo per- aggiunge al concetto <strong>di</strong> “scrivere” quello <strong>di</strong> scrivere “compiutamente, dall’inizio<br />
alla fine”, dunque anche “per or<strong>di</strong>ne”, esponendo i fatti uno dopo l’altro secondo la loro<br />
successione cronologica.<br />
31<br />
Come si apprende da Orazio, carm 2,1, l’opera <strong>di</strong> Pollione prendeva le mosse dal 60 e narrava le<br />
guerre civili.
Letteratura latina B a.a. 2008-2009 mod. 2. Appunti delle lezioni 31<br />
tra<strong>di</strong>zionale e antico schema annalistico. Proprio a questa sua scelta prob<strong>ab</strong>ilmente lo<br />
storico lega il dubbio espresso nell’interrogativa in<strong>di</strong>retta iniziale: egli si accinge a<br />
trattare infatti una res 32 che è sia vetus sia volgata, cioè antica, perché risale molto<br />
in<strong>di</strong>etro nel tempo, e <strong>di</strong>ffusa, perché già trattata da molti autori precedenti (da F<strong>ab</strong>io<br />
Pittore in avanti il tema scelto da <strong>Livio</strong> è quello <strong>di</strong> tutte le opere <strong>di</strong> impianto annalistico).<br />
Nell’aggettivo vetus si può scorgere anche una sfumatura lievemente negativa, che<br />
qualifica il tema scelto da <strong>Livio</strong> come “sorpassato”: il modello annalistico è ormai<br />
superato, e i tempi antichi non suscitano più l’interesse del pubblico (tema<br />
esplicitamente toccato più avanti, § 4).<br />
Nella subor<strong>di</strong>nata introdotta da dum l’autore prende in considerazione, in termini<br />
generali, gli altri storici a lui contemporanei, i novi scriptores, non però per in<strong>di</strong>care,<br />
come ci si potrebbe attendere, i temi <strong>di</strong>versi, meglio rispondenti ai gusti del pubblico, che<br />
essi solitamente scelgono <strong>di</strong> trattare. Dei novi scriptores <strong>Livio</strong> menziona l’aspirazione, a<br />
tutti comune, ad una ricostruzione del vero più accurata e ad uno stile più raffinato<br />
rispetto agli antichi. Nel verbo credunt si può scorgere un piccolo accenno polemico,<br />
peraltro subito lasciato cadere. E’ implicito che le due esigenze avvertite dagli storici<br />
contemporanei sono con<strong>di</strong>vise anche da <strong>Livio</strong>. Anch’egli si propone (o crede) <strong>di</strong> accertare<br />
meglio i fatti, e <strong>di</strong> essere non un semplice narrator, ma un exornator rerum.<br />
Il senso complessivo del periodo iniziale potrebbe dunque essere questo: non so se<br />
la mia opera avrà successo (né, se lo pensassi, oserei <strong>di</strong>rlo), per questi motivi: intendo<br />
trattare una materia antica e già nota, perché trattata in passato da molti; i pregi che<br />
nonostante ciò l’opera potrebbe avere, un accertamento dei fatti più accurato e una veste<br />
letteraria più elegante rispetto ai molti che già hanno scritto delle medesime vicende, non<br />
sono tali da assicurare il successo alla mia fatica, giacché si tratta <strong>di</strong> esigenze avvertite<br />
da tutti gli storiografi contemporanei, che si stu<strong>di</strong>ano <strong>di</strong> sod<strong>di</strong>sfarle.<br />
§ 3. Con le parole utcumque erit l’accenno polemico contenuto in credunt è messo<br />
da parte, e rimane aperta la questione iniziale. Sarà il lettore a rispondere, giu<strong>di</strong>cando se<br />
<strong>Livio</strong> sia riuscito nel suo intento. Per parte sua lo storico si limita a <strong>di</strong>chiarare che gli<br />
basta sapere <strong>di</strong> aver contribuito a tramandare le imprese del popolo princeps terrarum, e<br />
32 Questa mi sembra l’interpretazione più prob<strong>ab</strong>ile del termine res, e dell’intero periodo. Secondo<br />
un’altra interpretazione invece la res vetus e volgata è la <strong>di</strong>chiarazione, comune nelle prefazioni<br />
storiografiche, dell’importanza dell’argomento prescelto, cui è implicitamente legata l’attesa del<br />
successo dell’opera. Si vedano, per l’illustrazione sintattica delle due possibili interpretazioni<br />
dell’intero periodo iniziale, le note alla traduzione. Un atteggiamento <strong>di</strong> ritegno simile a quello <strong>di</strong><br />
<strong>Livio</strong> è presente già in Sallustio, nella prefazione al bellum Iugurthinum. Dopo aver <strong>di</strong>chiarato che<br />
la storiografia è una delle più nobili attività dello spirito, lo storico taglia corto all’elogio con queste<br />
parole: “sui pregi della storiografia non ritengo <strong>di</strong> dovermi soffermare oltre”, e ne in<strong>di</strong>ca i motivi:<br />
già molti altri lo hanno fatto, e soprattutto qualcuno potrebbe malignamente pensare che, lodando<br />
l’oggetto della propria attività, lo storico intenda in realtà lodare se stesso (Iug. 4,2 s.). Così <strong>Livio</strong><br />
non oserebbe affermare la sua certezza, ove l’avesse, perché è una consuetu<strong>di</strong>ne che può attirare<br />
critiche.
Letteratura latina B a.a. 2008-2009 mod. 2. Appunti delle lezioni 32<br />
ostenta <strong>di</strong>sinteresse (finto) per la fama. L’idea, appena accennata nel periodo iniziale, <strong>di</strong><br />
una aemulatio con gli altri scriptores, qui viene sviluppata: nella gran turba 33 <strong>di</strong> scriptores<br />
solo quelli dotati <strong>di</strong> nobilitas e magnitudo (insomma solo quelli eccellenti, nei due aspetti<br />
che tutti si propongono <strong>di</strong> curare, l’accertamento del vero e la veste letteraria accurata)<br />
potranno, forse, oscurare la sua fama: evidentemente anch’egli vi aspira, e le sue<br />
<strong>di</strong>chiarazioni iniziali non sono così modeste e <strong>di</strong>messe come paiono a tutta prima.<br />
§ 4. La sezione si apre con un accenno al tema de materia, nei suoi due aspetti del<br />
semplice contenuto (ut quae supra septingentesimum repetatur annum) e della sua<br />
importanza (quae <strong>ab</strong> exiguis profecta initiis eo creverit...); esso è legato alle considerazioni<br />
svolte precedentemente, in cui in primo piano è la persona dello storico. La mole<br />
immensa dell’opera è un terzo (praeterea) motivo <strong>di</strong> incertezza sul risultato della fatica<br />
dello scrittore, che si aggiunge ai due già illustrati (tema non nuovo, concorrenza degli<br />
altri storici). Accennare alle <strong>di</strong>fficoltà del compito intrapreso è uno dei mo<strong>di</strong> per<br />
accattivarsi la benevolentia del pubblico. Il sostantivo res, polivalente ed indeterminato<br />
(più del suo corrispondente italiano “cosa”), è impiegato in questa frase con due<br />
significati: la materia dell’opera e lo stato che ne costituisce l’oggetto. Ad avvertire del<br />
mutamento <strong>di</strong> significato è sufficiente la ripetizione del pronome relativo (quae repetatur:<br />
la storia; quae l<strong>ab</strong>oret: lo stato, la res Romana). Con un espe<strong>di</strong>ente stilistico semplice ed<br />
efficace l’autore ottiene ad<strong>di</strong>rittura <strong>di</strong> identificare la propria opera con il popolo <strong>di</strong> cui si<br />
accinge a narrare le imprese. Inoltre viene qui già annunciato un tema nuovo, che<br />
riceverà nel seguito più ampio e compiuto sviluppo: con l<strong>ab</strong>oret per ora <strong>Livio</strong> avverte che<br />
la grandezza raggiunta comporta per il popolo romano anche qualche <strong>di</strong>fficoltà.<br />
L’attenzione si sposta quin<strong>di</strong> sul pubblico, introducendo un ulteriore elemento <strong>di</strong><br />
incertezza sulla possibilità per lo storico <strong>di</strong> conquistare la fama e la considerazione cui<br />
anch’egli, come tutti, aspira, cioè le preferenze dei lettori: lo storico sa che gran parte del<br />
pubblico si appassiona alla storia recente o contemporanea, e tuttavia non intende<br />
assecondarne le attese.<br />
.§ 5. La netta contrapposizione con quanto precede, annunciata dalle parole ego<br />
contra, ha uno sviluppo alquanto inatteso. <strong>Livio</strong> non si impegna a <strong>di</strong>mostrare come il<br />
gusto del pubblico sia corrotto, né che la storia non deve mirare come suo primo scopo<br />
alla voluptas. Il motivo per cui <strong>Livio</strong> non intende assecondare le attese del pubblico – non<br />
subito per lo meno – è molto personale, e si collega, per mezzo <strong>di</strong> quoque, al tema della<br />
fama toccato sopra. Oltre alla gloria, che forse non otterrà, oltre alla sod<strong>di</strong>sfazione <strong>di</strong> aver<br />
contribuito a tramandare le imprese del popolo più grande del mondo, un premio sicuro<br />
egli avrà dalla sua fatica: <strong>di</strong>stogliere la mente, almeno per un poco, dai mali presenti (o<br />
33 Il termine è lievemente spregiativo, poiché significa “folla” in<strong>di</strong>stinta, con annessa l’idea <strong>di</strong><br />
confusione e <strong>di</strong>sor<strong>di</strong>ne: in questa folla non tutti gli scriptores sono eccellenti e gran<strong>di</strong>.
Letteratura latina B a.a. 2008-2009 mod. 2. Appunti delle lezioni 33<br />
appena trascorsi, come in<strong>di</strong>ca il perfetto vi<strong>di</strong>t). Si <strong>di</strong>rebbe che <strong>Livio</strong> intenda scrivere per<br />
sé soltanto. O forse, con queste parole, vuole in<strong>di</strong>rettamente invitare i lettori a <strong>di</strong>stogliere<br />
anch’essi l’attenzione dai mala, preparando l’invito esplicito del § 9 ad illa...pro se<br />
quisque intendat animum. Il tema prevalente qui è la persona dello scrittore, che viene<br />
esponendo con semplicità le ragioni della sua opera. Accanto a questo tema ne viene<br />
introdotto anche un altro, nella seconda parte del periodo. Con le parole omnis expers<br />
curae... <strong>Livio</strong>, senza insistervi, mostra <strong>di</strong> conoscere ed accettare, come cosa ovvia, la<br />
prima legge della storia, il rispetto della verità, che deve essere ricostruita ed esposta con<br />
assoluta imparzialità. Quanto al significato complessivo della frase, essa non va intesa<br />
come una <strong>di</strong>chiarazione che chi scrive <strong>di</strong> eventi contemporanei, se non vuole mentire,<br />
deve temere per sé qualche concreto pericolo34. <strong>Livio</strong> infatti non esclude la trattazione<br />
degli eventi contemporanei; ed inoltre è il conspectus dei mali, non la loro trattazione, che<br />
fa nascere in lui la cura, cioè affanno, pena, <strong>di</strong>spiacere nel contemplarli. Questo potrebbe<br />
togliergli la serenità, cioè il premio, rendendo ingrata (non pericolosa) la sua fatica.<br />
Anche l’irreale posset conferma questa interpretazione, ed equivale all’assicurazione che<br />
<strong>Livio</strong> è consapevole che lo storico non solo deve sempre rispettare la verità, per quanto<br />
sgradevole e angosciosa essa possa essere, ma anche impe<strong>di</strong>re che la cura in qualche<br />
modo offuschi la sua libertà <strong>di</strong> giu<strong>di</strong>zio.<br />
Quanto ai mala da cui lo storico, almeno per un poco, vuole <strong>di</strong>stogliere la mente,<br />
essi sono stati già preannunciati da due accenni in quanto precede. Con un metodo che<br />
sembra caratteristico <strong>di</strong> questa prefazione, l’autore vi si accosta per approssimazioni<br />
successive. Il primo accenno è contenuto nelle parole res... quae eo creverit ut iam<br />
magnitu<strong>di</strong>ne l<strong>ab</strong>oret sua (§ 4). In quella sezione il tema principale è un altro, la vastità<br />
dell’opera, che intende ripercorrere la storia <strong>di</strong> Roma dalle origini fino alla grandezza<br />
presente. La consecutiva introduce un tema nuovo, non ancora orientato in senso<br />
chiaramente negativo. La “sofferenza” dello stato dovuta alla sua grandezza potrebbe far<br />
pensare soltanto alle oggettive <strong>di</strong>fficoltà poste dal governo e dall’organizzazione <strong>di</strong> un<br />
dominio così vasto, con tanti popoli <strong>di</strong>versi, con il problema <strong>di</strong> <strong>di</strong>fendere i confini, ecc.<br />
Poco oltre, nel medesimo § 4, con vires se ipsae conficiunt, questo stesso tema, anche qui<br />
subor<strong>di</strong>nato ad un altro prevalente (i gusti del pubblico), si precisa maggiormente: le<br />
<strong>di</strong>fficoltà che travagliano lo stato si rivelano come <strong>di</strong>fficoltà interne; le forze che si<br />
rivolgono contro se stesse sono una chiara allusione alle guerre civili, l’argomento dei<br />
34 Un’interpretazione <strong>di</strong> questo genere non è, <strong>di</strong> per sé, inverosimile. La trattazione <strong>di</strong> fatti<br />
contemporanei poteva effettivamente far temere qualche inconveniente all’autore. Per es. Orazio<br />
definisce la storia delle guerre civili in cui era impegnato Asinio Pollione periculosae plenum opus<br />
aleae, “un’opera piena <strong>di</strong> rischio pericoloso”, e aggiunge, rivolto all’autore: ...ince<strong>di</strong>s per ignes /<br />
suppositos cineri doloso, “proce<strong>di</strong> per un cammino insi<strong>di</strong>oso, sul fuoco che cova sotto la cenere”<br />
(carm 2,1,5-7).
Letteratura latina B a.a. 2008-2009 mod. 2. Appunti delle lezioni 34<br />
tempi recenti e recentissimi cui soprattutto è rivolta l’attesa dei lettori. Ora infine questi<br />
eventi recenti, dai quali lo storico vuole per il momento <strong>di</strong>stogliere l’attenzione, sono<br />
esplicitamente definiti mala: un termine negativo ma generico, scelto certo <strong>di</strong> proposito,<br />
perché può riferirsi sia ai fatti luttuosi cui ha accennato sopra (le forze che si rivolgono<br />
contro se stesse) sia anche a “colpe, mali morali”. In tal modo si prepara l’ulteriore<br />
sviluppo <strong>di</strong> questo tema, al § 9: sono i mores corrotti la vera causa per cui lo stato più<br />
grande e potente del mondo ha forse iniziato la sua par<strong>ab</strong>ola <strong>di</strong>scendente. Non va<br />
trascurato peraltro un piccolo segno che potremmo <strong>di</strong>re <strong>di</strong> cauto ottimismo, contenuto<br />
nel perfetto vi<strong>di</strong>t: il periodo più triste è passato; dopo Azio Augusto ha riportato la pace<br />
nello stato, ed ha messo mano ad un vasto programma <strong>di</strong> restaurazione religiosa e<br />
morale.<br />
§ 6. Dopo il tema de persona prevalente sin qui, lo storico passa a trattare<br />
compiutamente il tema de materia; il collegamento con quanto precede è offerto<br />
dall’accenno al verum: <strong>Livio</strong> vuole anzitutto chiarire quale posizione intenda assumere<br />
sulle tra<strong>di</strong>zioni relative al passato leggendario, operando una netta <strong>di</strong>stinzione fra poesia<br />
(cui è concessa una libertà assai maggiore) e storia. I perio<strong>di</strong> ai quali si applica la<br />
sospensione <strong>di</strong> giu<strong>di</strong>zio dello storico, espressa con le parole nec adfirmare nec refellere,<br />
sono due, <strong>di</strong>stinti. Con l’espressione ante <strong>con<strong>di</strong>ta</strong>m <strong>urbe</strong>m <strong>Livio</strong> si riferisce alle vicende<br />
anteriori alla fondazione <strong>di</strong> Roma, ma ad essa connesse in quanto la preparano, cioè<br />
l’arrivo <strong>di</strong> Enea in Italia, la guerra contro i Rutuli, la fondazione <strong>di</strong> Alba Longa, la<br />
<strong>di</strong>scendenza <strong>di</strong> Enea fino a Numitore e Amulio. A queste leggende lo storico de<strong>di</strong>ca i primi<br />
tre capitoli del primo libro. Con l’espressione ante condendam <strong>urbe</strong>m rinvia invece alle<br />
leggende connesse alla fondazione: la vicenda <strong>di</strong> Rea Silvia, la nascita dei gemelli, la loro<br />
esposizione e il salvataggio, l’allevamento, il recupero del regno <strong>di</strong> Numitore, la decisione<br />
<strong>di</strong> fondare una nuova città, l’auspicio e l’uccisione <strong>di</strong> Remo. A questi fatti <strong>Livio</strong> de<strong>di</strong>ca<br />
altri tre capitoli e mezzo; il resto <strong>di</strong> 1,7 è anch’esso <strong>di</strong> carattere leggendario, con la<br />
<strong>di</strong>gressione su Ercole e Caco. La sud<strong>di</strong>visione qui in<strong>di</strong>cata con i due participi <strong>con<strong>di</strong>ta</strong>m e<br />
condendam è mantenuta puntualmente anche nel racconto: il cap. 4 si apre con le parole<br />
sed debebatur fatis origo tantae urbis, premesse al racconto della nascita dei gemelli. Di<br />
qui inizia la parte ante condendam <strong>urbe</strong>m, che si conclude, dopo l’uccisione <strong>di</strong> Remo, con<br />
le parole <strong>con<strong>di</strong>ta</strong> urbs con<strong>di</strong>toris nomine appellata (1,7,3). Da questo momento in avanti<br />
tutto il materiale tramandato è considerato storia, monumentum incorruptum. In realtà,<br />
anche nel corso della narrazione successiva a volte <strong>Livio</strong> spesso assume un<br />
atteggiamento simile a questo (nec adfirmare nec refellere), quando riferisce tra<strong>di</strong>zioni<br />
posteriori alla fondazione <strong>di</strong> Roma: a volte si impegna a fornire spiegazioni razionalistiche<br />
<strong>di</strong> alcune leggende, più spesso si limita a <strong>di</strong>ssociare elegantemente la propria<br />
respons<strong>ab</strong>ilità <strong>di</strong> storico da quanto riferisce, con formule come ut ferunt, tradunt,
Letteratura latina B a.a. 2008-2009 mod. 2. Appunti delle lezioni 35<br />
tra<strong>di</strong>tum est ecc. In queste <strong>di</strong>chiarazioni programmatiche della prefazione invece egli<br />
separa come leggenda poetica solo tutto ciò che precede il regno <strong>di</strong> Romolo. Non vi è<br />
contrad<strong>di</strong>zione: prima <strong>di</strong> Romolo tutto ciò che è stato tramandato va considerato poetica<br />
f<strong>ab</strong>ula; il periodo successivo presenta invece, in un tessuto <strong>di</strong> fatti storici (secondo <strong>Livio</strong>,<br />
naturalmente), alcune leggende sulle quali egli non intende pronunciarsi. A queste allude<br />
in modo generico con l’espressione his similia, all’inizio del § 8. Benché tali leggende non<br />
siano adatte alla serietà <strong>di</strong> una documentata opera storica, egli le menzionerà<br />
ugualmente, in ossequio alla tra<strong>di</strong>zione. Questo atteggiamento scettico è confermato dal<br />
paragrafo che segue.<br />
§§ 7-9. Anche Roma, come molte altre città, si conforma alla consuetu<strong>di</strong>ne <strong>di</strong><br />
nobilitare le proprie origini, facendovi intervenire dèi o eroi. Da questa constatazione<br />
<strong>Livio</strong> trae uno spunto polemico: se le humanae gentes sopportano <strong>di</strong> buon grado (!) il<br />
dominio imposto loro da Roma in forza della sua superiorità militare, possono anche<br />
tollerare che Roma si sia scelto come progenitore Marte, il <strong>di</strong>o più adatto ad un popolo<br />
guerriero. Il tono è ironico, <strong>Livio</strong> sa bene che la Vestale (Rea Silvia) credette oppure finse<br />
che il padre dei gemelli fosse Marte (1,4). L’accenno polemico viene subito troncato, come<br />
al § 2, con una movenza stilistica analoga; lo storico volge invece l’attenzione a ciò cui<br />
attribuisce la massima importanza, ed espone il contenuto propriamente storico<br />
dell’opera, sviluppando più ampiamente gli accenni già <strong>di</strong>stribuiti in quanto precede.<br />
Il dativo etico mihi, insieme al cong. esortativo intendat, costituisce una esplicita e<br />
<strong>di</strong>retta sollecitazione a por mente a ciò che secondo lo storico è veramente importante,<br />
con un accento personale e commosso: dopo aver <strong>di</strong>chiarato <strong>di</strong> non essere <strong>di</strong>sposto ad<br />
assecondare i gusti del pubblico, e <strong>di</strong> esser pago <strong>di</strong> scrivere per sé solo, lo storico<br />
recupera <strong>ab</strong>ilmente l’attenzione e la simpatia dei lettori, cui intende <strong>di</strong>mostrare come una<br />
res vetus e volgata possa essere interessante e utile per ciascuno. L’espe<strong>di</strong>ente più<br />
significativo ed efficace <strong>di</strong> questa appassionata esortazione è forse da scorgere nel<br />
pronome quisque, che isola ciascuno dei lettori nella sua in<strong>di</strong>vidualità: lo storico si<br />
rivolge a ciascuno <strong>di</strong> loro, non ad una massa in<strong>di</strong>stinta; il concetto è rafforzato da pro se,<br />
cioè secondo le sue capacità e possibilità. Lo storico assume in tal modo un<br />
atteggiamento <strong>di</strong> grande rispetto per ogni singolo lettore, al quale egli non intende <strong>di</strong>re<br />
che cosa debba pensare; dalla storia ognuno, per conto proprio e con libertà <strong>di</strong> giu<strong>di</strong>zio,<br />
potrà trarre l’insegnamento che ne scaturisce. Naturalmente <strong>Livio</strong> orienta sempre il<br />
giu<strong>di</strong>zio del lettore, ma <strong>di</strong> solito senza assumere un atteggiamento <strong>di</strong>dascalico, lasciando<br />
che l’insegnamento scaturisca da sé dai fatti narrati.<br />
<strong>Gli</strong> elementi più importanti su cui lo storico vuole si concentri l’attenzione del<br />
lettore sono vita e mores (vita e costumi, s’intende, del popolo romano antico); viri e artes<br />
sono in una posizione subor<strong>di</strong>nata, in quanto sono presentati come i mezzi con cui
Letteratura latina B a.a. 2008-2009 mod. 2. Appunti delle lezioni 36<br />
l’imperium è stato creato ed è <strong>di</strong>ventato grande. La connotazione positiva del termine<br />
mores in questa frase è implicita, e risulta dal contrasto con la loro successiva<br />
degradazione, descritta subito dopo.<br />
Il passaggio dall’età antica, sede del bene, a quella presente, in cui largamente il<br />
male prevale, non è presentata come una contrapposizione netta, ma come un processo<br />
in più sta<strong>di</strong>, una corruzione progressiva, descritta stilisticamente per mezzo <strong>di</strong> una<br />
climax (un passaggio dal meno al più, o viceversa, in più <strong>di</strong> due tappe). Ciascuno dei tre<br />
momenti successivi, che rappresentano un progressivo peggioramento, è contrassegnato<br />
da un avverbio <strong>di</strong> tempo, primo, deinde, tum. Il culmine negativo, che coincide con l’età<br />
contemporanea, è presentato come l’ultimo sviluppo della terza fase, introdotto dalla<br />
subor<strong>di</strong>nata temporale donec...perventum est. Questo culmine negativo raggiunto nell’età<br />
contemporanea dalla decadenza dei mores è in<strong>di</strong>cato dal fatto che “non siamo in grado <strong>di</strong><br />
sopportare né i nostri vizi né i loro rime<strong>di</strong>”, immagine <strong>ab</strong>bastanza comune, <strong>di</strong> carattere<br />
me<strong>di</strong>co: i vitia sono equiparati a malattie, da curare con reme<strong>di</strong>a (me<strong>di</strong>cine). Quali sono i<br />
reme<strong>di</strong>a cui lo storico allude? La frase è molto generica, e consente due <strong>di</strong>verse<br />
interpretazioni, una politica e una morale.<br />
Secondo la prima, <strong>Livio</strong> constaterebbe che i citta<strong>di</strong>ni, pur desiderando una vita<br />
or<strong>di</strong>nata, la concor<strong>di</strong>a, la pace, non sono però <strong>di</strong>sposti a rinunciare alla libertas: i<br />
reme<strong>di</strong>a sarebbero allora i successivi provve<strong>di</strong>menti con cui Augusto andava accentrando<br />
nelle proprie mani il potere, offrendo, in cambio della libertà repubblicana, la pace,<br />
propagandata con ogni mezzo. E’ insomma la giustificazione che, molto più tar<strong>di</strong>, Tacito<br />
avrebbe el<strong>ab</strong>orato per l’istituzione del principato35. Ma Tacito scrive quando il processo <strong>di</strong><br />
trasformazione costituzionale è ormai irreversibilmente compiuto; <strong>Livio</strong>, che compone la<br />
sua prefazione fra il 27 e il 25, o pochi anni più tar<strong>di</strong>, non può ancora, forse, già<br />
el<strong>ab</strong>orare una giustificazione <strong>di</strong> questo genere <strong>di</strong> una trasformazione che era ancora in<br />
atto.<br />
Sembra dunque preferibile l’interpretazione morale: i reme<strong>di</strong>a vanno cercati in<br />
provve<strong>di</strong>menti miranti a ripristinare nella società il rispetto per i valori del tempo antico,<br />
per quelle virtù cui <strong>Livio</strong> strettamente lega la grandezza <strong>di</strong> Roma. La campagna<br />
moralizzatrice <strong>di</strong> Augusto mirò alla restaurazione degli antichi valori soprattutto in due<br />
ambiti, la famiglia e la religione. Forse la restaurazione della religione e delle cerimonie<br />
antiche36 non incontrava particolare resistenza e opposizione. Il malcontento sarà stato<br />
piuttosto per altri provve<strong>di</strong>menti, che tentavano, senza molto successo, <strong>di</strong> imporre per<br />
35<br />
Hist. 1,1,1: omnem potentiam ad unum conferri pacis interfuit ; ann. 1,9,4: non aliud <strong>di</strong>scordantis<br />
patriae reme<strong>di</strong>um quam ut <strong>ab</strong> uno regeretur<br />
36<br />
Per es. organizzò, nel 17, una celebrazione solenne dei lu<strong>di</strong> saeculares, per la quale Orazio<br />
compose il carmen saeculare. Inoltre, come ricorda Augusto stesso nelle sue res gestae (20,4), nel<br />
28 fece restaurare ben 82 templi nella città <strong>di</strong> Roma.
Letteratura latina B a.a. 2008-2009 mod. 2. Appunti delle lezioni 37<br />
legge un costume <strong>di</strong> vita morigerato e casto. I principali provve<strong>di</strong>menti legislativi che<br />
conosciamo dalle fonti in questo campo sono: la lex Iulia de coercen<strong>di</strong>s adulteriis del 18<br />
a.C. e la successiva lex Papia Poppaea de maritan<strong>di</strong>s or<strong>di</strong>nibus del 9 d.C. 37, che, per<br />
incoraggiare il matrimonio e la procreazione <strong>di</strong> figli (contro il crescente calo demografico),<br />
istituiva lo ius trium liberorum, una serie <strong>di</strong> privilegi (sia <strong>di</strong> carattere fiscale sia negli<br />
avanzamenti <strong>di</strong> carriera) per i padri <strong>di</strong> almeno tre figli legittimi; la legge prevedeva inoltre<br />
multe per i celibi e gli sposi senza prole, e punizioni molto severe per gli adultèri. I<br />
risultati furono scarsi, e i costumi <strong>di</strong> vita della gente non mutarono sensibilmente.<br />
Provve<strong>di</strong>menti <strong>di</strong> questo tipo dovevano certo suscitare l’approvazione incon<strong>di</strong>zionata <strong>di</strong><br />
un moralista come <strong>Livio</strong>; sfortunatamente sono troppo recenti perché ad essi egli possa<br />
alludere nella sua prefazione (senza contare che l’effetto sperato non si poteva<br />
imme<strong>di</strong>atamente valutare). E’ possibile però che già <strong>di</strong>eci anni prima della lex Iulia<br />
Ottaviano avesse fatto un tentativo analogo, fallito perché la legge dovette essere<br />
<strong>ab</strong>rogata, o forse ne fu respinta la proposta stessa. A questa legge prob<strong>ab</strong>ilmente allude<br />
Properzio, in 2,7. Rivolgendosi a Cinzia il poeta <strong>di</strong>ce:<br />
Gavisa es certe sublatam, Cynthia, legem<br />
qua quondam e<strong>di</strong>cta flemus uterque <strong>di</strong>u,<br />
ni nos <strong>di</strong>videret; quamvis <strong>di</strong>ducere amantes<br />
non queat invitos Iuppiter ipse duos.<br />
At magnus Caesar. Sed magnus Caesar in armis: 5<br />
devictae gentes nil in amore valent.<br />
Nam citius paterer caput hoc <strong>di</strong>scedere collo,<br />
quam possem nuptae perdere amore faces,<br />
aut ego transirem tua limina clausa maritus,<br />
respiciens u<strong>di</strong>s pro<strong>di</strong>ta luminibus. 10<br />
[...]<br />
Unde mihi patriis natos praebere triumphis? 13<br />
Nullus de nostro sanguine miles erit.<br />
[...]<br />
Certo ti sei rallegrata, Cinzia, quando fu <strong>ab</strong>rogata* la legge<br />
che un tempo, quando fu emanata**, ci fece piangere a lungo,<br />
nel timore che potesse <strong>di</strong>viderci; per quanto, separare due<br />
amanti contro la loro volontà non potrebbe Giove stesso.<br />
Ma Cesare è grande. Sì, grande nelle armi: il fatto che<br />
<strong>ab</strong>bia sottomesso molte genti non vale nulla in amore.<br />
Mi lascerei staccare la testa dal collo piuttosto<br />
che perdere te, mia fiamma, per amore <strong>di</strong> una sposa,<br />
o passare maritato davanti alla tua porta chiusa,<br />
volgendomi a guardarla dopo averla tra<strong>di</strong>ta, con gli occhi pieni <strong>di</strong> lacrime.<br />
[...]<br />
Perché dovei fornire figli per i trionfi della patria?<br />
Nessun soldato nascerà dal mio sangue.<br />
[...]<br />
* opp. “ritirata”; ** opp. “proposta”<br />
Da questi accenni si comprende che la legge che fu <strong>ab</strong>rogata, o non entrò<br />
nemmeno in vigore, era del medesimo tipo <strong>di</strong> quelle successivamente emanate da<br />
Augusto, e prevedeva l’imposizione del matrimonio ai citta<strong>di</strong>ni e sanzioni per chi non<br />
obbe<strong>di</strong>sse38, oltre ad incoraggiare la procreazione <strong>di</strong> figli per la patria39. Se il fallimento<br />
della legge cui allude Properzio è del 28 (come è possibile, ma non certo40), può darsi che<br />
37 Preceduta prob<strong>ab</strong>ilmente da una lex Iulia sulla medesima materia, non sappiamo in quale anno:<br />
il fatto che venissero emanate successivamente leggi <strong>di</strong> contenuto simile in<strong>di</strong>ca quanto la loro<br />
effettiva applicazione fosse <strong>di</strong>fficile.<br />
38 V. Prop. 2,7,7 citius paterer caput hoc <strong>di</strong>scedere collo; naturalmente si tratta <strong>di</strong> un’iperbole.<br />
39 V. Prop. 2,7,14 nullus de nostro sanguine miles erit.<br />
40 Non si conosce con esattezza la data <strong>di</strong> composizione del secondo libro delle elegie <strong>di</strong> Properzio:<br />
dati interni sembrano però in<strong>di</strong>care un periodo fra il 28 e il 26. Inoltre Tacito, ann. 3,28,2,<br />
accenna, in modo generico, all’inizio dell’attività legislativa (de<strong>di</strong>t iura) <strong>di</strong> Augusto nel suo sesto<br />
consolato, che è appunto del 28 (quando in realtà Ottaviano non aveva ancora il titolo <strong>di</strong> Augusto).
Letteratura latina B a.a. 2008-2009 mod. 2. Appunti delle lezioni 38<br />
ad essa, o anche ad essa, pensi <strong>Livio</strong>, quando <strong>di</strong>ce reme<strong>di</strong>a pati non possumus. Dal<br />
fallimento <strong>di</strong> questo provve<strong>di</strong>mento (un dato <strong>di</strong> fatto singolo e oggettivo, assunto come<br />
sintomo della resistenza dei contemporanei a rime<strong>di</strong> <strong>di</strong> questo genere), <strong>Livio</strong> poteva trarre<br />
la considerazione più generale che la gente era ormai insofferente <strong>di</strong> tutto ciò che potesse<br />
contrastare la rilassatezza morale, una delle cause, nella visione <strong>di</strong> <strong>Livio</strong>, che possono<br />
portare lo stato alla rovina.<br />
§ 10. In questo paragrafo <strong>Livio</strong> offre la sua personale (anche se non originale)<br />
interpretazione dell’utilità della storia. Tema topico delle prefazioni o delle sezioni<br />
programmatiche era proprio l’illustrazione dell’utilità della storia (in<strong>di</strong>cata dall’anonimo<br />
retore citato sopra 41 con l’espressione bonum historiae). <strong>Livio</strong> si conforma alla<br />
consuetu<strong>di</strong>ne, anch’egli sa che la storiografia è utile, e lo <strong>di</strong>chiara; per parte sua tiene a<br />
precisare che la famosa utilità della storia da tutti riconosciuta consiste nel suo valore<br />
para<strong>di</strong>gmatico; essa presenta infatti al lettore fatti, vicende, personaggi esemplari,<br />
modelli positivi e negativi, da cui ognuno può trarre norme <strong>di</strong> comportamento privato (tibi)<br />
e pubblico (rei publicae). Ma raccogliere esempi positivi e negativi non è sufficiente:<br />
bisogna anche porli in un inlustre monumentum. Con queste parole <strong>Livio</strong> si riferisce<br />
prob<strong>ab</strong>ilmente 42 all’opera storica, all’ideale cui aspira, all’opera insomma che intende<br />
scrivere. Al § 6 l’agg. incorruptum in<strong>di</strong>ca l’in<strong>di</strong>spens<strong>ab</strong>ile rispetto per la verità e<br />
l’imparzialità, la ricostruzione fedele e atten<strong>di</strong>bile dei fatti; ora, con l’agg. inlustre, viene<br />
definito l’aspetto formale dell’opera. Per riuscire veramente utile la narrazione veritiera e<br />
imparziale dei fatti deve essere proposta in una forma letterariamente curata e attraente.<br />
Per mezzo <strong>di</strong> questi due aggettivi che qualificano l’opera che intende scrivere, <strong>Livio</strong> fa<br />
sapere in<strong>di</strong>rettamente ai lettori che anch’egli, come i novi scriptores, si sforzerà <strong>di</strong><br />
raggiungere la certezza nelle res e la perfezione nello stile. Il fatto che le sue aspirazioni<br />
siano presentate in modo così <strong>di</strong>screto, affidate a due semplici aggettivi, è in accordo con<br />
il tono <strong>di</strong> modestia con cui la prefazione si apre; vi contribuisce anche il fatto che <strong>Livio</strong><br />
non si ponga – a <strong>di</strong>fferenza dei novi scriptores – in concorrenza o a confronto con altri;<br />
egli non mira a “maggior” certezza o a uno stile “più” elegante rispetto agli scrittori<br />
antichi; gli bastano la certezza (incorruptum) e la forma letteraria <strong>di</strong>gnitosa e chiara<br />
(inlustre).<br />
§§ 11-12. Per mezzo <strong>di</strong> ceterum, con valore restrittivo e debolmente avversativo,<br />
<strong>Livio</strong> si collega alle ultime parole del periodo precedente, all’allusione agli esempi negativi,<br />
41 V. pp. 29-30 e nota 28.<br />
42 Anche un’altra interpretazione (assai meno prob<strong>ab</strong>ile) <strong>di</strong> inlustre monumentum è possibile, a<br />
partire dal senso fondamentale <strong>di</strong> monumentum, “ciò che fa ricordare” (medesima ra<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> moneo),<br />
e cioè il “personaggio eminente”, la “vicenda famosa”, cui è affidata la funzione <strong>di</strong> exemplum.<br />
Sembra preferibile intendere il sostantivo monumentum con la medesima accezione, “opera<br />
storica”, che ha al § 6.
Letteratura latina B a.a. 2008-2009 mod. 2. Appunti delle lezioni 39<br />
che è utile aver sotto gli occhi, per stu<strong>di</strong>arsi <strong>di</strong> evitarli. Lo storico non desidera<br />
soffermarsi molto a lungo su questo aspetto. L’analisi della decadenza morale, dei mali<br />
della società contemporanea, che pure viene svolta, è presentata sotto forma <strong>di</strong><br />
commosso elogio per la res publica che in misura maggiore e per un tempo più lungo <strong>di</strong><br />
ogni altra si è mantenuta fedele ai buoni costumi. I vitia, che infine lo storico si risolve ad<br />
in<strong>di</strong>care, avaritia e luxuria, rinviano – con una <strong>di</strong>fferenza significativa - all’analisi già<br />
svolta da Sallustio, soprattutto nella prima monografia. Dopo la prefazione vera e propria<br />
e il ritratto <strong>di</strong> Catilina, Sallustio presenta (capp. 6-13) la storia passata <strong>di</strong> Roma,<br />
sud<strong>di</strong>visa nettamente in due perio<strong>di</strong> contrapposti, l’epoca anteriore alla <strong>di</strong>struzione <strong>di</strong><br />
Cartagine e quella successiva. Il periodo anteriore al 146 è presentato come<br />
caratterizzato dalla virtus: in quest’epoca tutti i Romani in<strong>di</strong>stintamente aspirano solo a<br />
compiere splen<strong>di</strong>de imprese a vantaggio dello stato, sono <strong>di</strong>sciplinati, concor<strong>di</strong>, assetati<br />
<strong>di</strong> gloria. Caduta Cartagine, aemula imperii Romani, venuta cioè meno la minaccia<br />
esterna che manteneva efficiente l’esercito e virtuoso e concorde il corpo civico, la pace e<br />
il benessere corruppero in breve tempo i Romani, che non erano mai stati piegati prima<br />
da fatiche, <strong>di</strong>fficoltà, pericoli. Irrompono nella società avaritia e ambitio, che portano con<br />
sé la luxuria. Questa visione è ripresa, più brevemente ma senza sostanziali mo<strong>di</strong>fiche,<br />
anche nella seconda monografia (41,2-5) e, con una notevole accentuazione del giu<strong>di</strong>zio<br />
negativo, nel proemio delle historiae. Quando <strong>Livio</strong> compone la sua prefazione ha<br />
certamente ben presente l’analisi fatta dal suo illustre predecessore, come mostrano<br />
riprese <strong>di</strong> alcune parole e immagini 43 . Il quadro della corruzione, le sue cause<br />
(soprattutto le <strong>di</strong>vitiae) e i suoi effetti (la <strong>di</strong>struzione del tessuto stesso della società) si<br />
corrispondono; ma in <strong>Livio</strong> manca uno dei tre vitia menzionati da Sallustio: troviamo l’<br />
avaritia e la luxuria (o luxus), non l’ambitio, che in Sallustio è molto importante. Dopo la<br />
<strong>di</strong>struzione <strong>di</strong> Cartagine, nel quadro <strong>di</strong> Sallustio, crescono insieme la cupido pecuniae e<br />
la cupido imperii, cioè la brama <strong>di</strong> denaro e quella <strong>di</strong> potere, insomma avaritia e ambitio<br />
(Cat.10). Sallustio cerca <strong>di</strong> <strong>di</strong>stinguere, un po’ artificiosamente, una ambitio buona da<br />
una cattiva: <strong>di</strong> per sé l’ambizione è un vizio molto vicino alla virtù, in quanto spinge a<br />
conquistare gloria, honos, imperium, aspirazioni in sé non condann<strong>ab</strong>ili. Ma quando a<br />
questi fini buoni si cerca <strong>di</strong> arrivare con ogni mezzo, con violenza, doli e fallaciae, allora<br />
l’ambitio assume le caratteristiche <strong>di</strong> un vizio dei peggiori: ciò avviene, secondo Sallustio,<br />
quando in Roma fa il suo ingresso l’avaritia, dopo il 146.<br />
In <strong>Livio</strong> manca invece, significativamente, qualsiasi accenno all’ambitio. Se <strong>Livio</strong><br />
trae da Sallustio tutto il quadro della degenerazione dei costumi, ma omette una delle<br />
43 Si confrontino per es. con la descrizione della decadenza al § 9 Sall.Cat. 10,6: haec (sc. avaritia e<br />
ambitio) primo paulatim crescere, interdum vin<strong>di</strong>cari; post ubi contagio quasi pestilentia invasit,<br />
civitas immutata e hist. Fr. 16 M ex quo tempore maiorum mores non paulatim ut antea sed<br />
torrentis modo praecipitati.
Letteratura latina B a.a. 2008-2009 mod. 2. Appunti delle lezioni 40<br />
cause, ciò prob<strong>ab</strong>ilmente significa che egli non con<strong>di</strong>vide del tutto l’analisi del suo<br />
predecessore. Secondo <strong>Livio</strong> infatti l’ambitio non entra in Roma insieme alle <strong>di</strong>vitiae, ma<br />
esiste fin dall’inizio della storia <strong>di</strong> Roma: la fondazione della città infatti altro non è che la<br />
conclusione della lotta per il potere fra i due fratelli. Inoltre, la visione <strong>di</strong> <strong>Livio</strong> è più<br />
sfumata <strong>di</strong> quella <strong>di</strong> Sallustio, che pone tutto il bene nel passato e tutto il male nel<br />
presente o nel passato prossimo. Benché anche <strong>Livio</strong> presenti come esemplare il periodo<br />
più antico della storia <strong>di</strong> Roma, egli sa che in ogni epoca male e bene sono intrecciati. Nel<br />
complesso l’analisi delle cause della decadenza morale, salvo l’omissione dell’ambitio, non<br />
è in <strong>Livio</strong> nuova né originale; originale e caratteristico è invece il modo in cui lo storico la<br />
propone: solo con nuper si risolve a constatare e considerare la <strong>di</strong>ffusione dei vizi, prima<br />
menzionati soltanto per far rilevare quanto a lungo Roma ne sia stata immune.<br />
Prima dell’implicito confronto <strong>di</strong> Roma con ogni altro stato, confronto da cui<br />
risulta la in<strong>di</strong>scutibile superiorità <strong>di</strong> Roma, <strong>Livio</strong> ammette la possibilità che il troppo<br />
amore offuschi l’obiettività del suo giu<strong>di</strong>zio, inducendolo forse a dare <strong>di</strong> Roma un quadro<br />
troppo positivo e non del tutto veritiero. Ma si tratta <strong>di</strong> un’ammissione solo formale, come<br />
è evidente dalla sua formulazione con l’alternativa aut...aut, in cui un termine esclude<br />
l’altro. La prima alternativa è tanto assurda che la seconda ne risulta rafforzata44: poiché,<br />
come ha <strong>di</strong>chiarato in modo <strong>di</strong>screto ma chiaro, <strong>Livio</strong> è ben consapevole che nulla deve<br />
far deflettere dal vero lo storico, i lettori potranno con fiducia accogliere e con<strong>di</strong>videre il<br />
suo elogio <strong>di</strong> Roma. Con negotium <strong>Livio</strong> si riferisce all’opera che intende scrivere; ma<br />
l’amore non sarà tanto per l’opera quanto per il popolo che ne è protagonista: notiamo<br />
che <strong>di</strong> nuovo, come al § 4, opera e argomento sono quasi identificati.<br />
Infine, va rilevato che anche per il tema corruzione, come per gli altri, <strong>Livio</strong><br />
procede nel modo caratteristico <strong>di</strong> questa prefazione, consistente, come si è detto, nel<br />
trattare ogni tema per accenni successivi. Il tema dei vitia compare già al § 4 (magnitudo<br />
l<strong>ab</strong>oret sua; vires se ipsae conficiunt), si precisa al § 5 con un accenno specifico ai mala;<br />
viene più ampiamente sviluppato nella seconda parte del § 9, dove la descrizione della<br />
decadenza dei costumi chiarisce la causa morale <strong>di</strong> quei mala. E infine, al § 12 quei mala<br />
sono in<strong>di</strong>viduati: si tratta <strong>di</strong> avaritia e luxuria, che hanno provocato la decadenza morale,<br />
44 Il medesimo proce<strong>di</strong>mento stilistico, con la medesima funzione (rafforzare enfaticamente<br />
un’affermazione mettendola in alternativa con un’altra palesemente assurda) è impiegato da <strong>Livio</strong><br />
anche in altri casi. Particolarmente chiaro è un esempio in 22,39,8. Nell’esortazione rivolta al<br />
console Lucio Emilio Paolo perché controlli e freni il collega Terenzio Varrone, la cui precipitazione<br />
potrebbe causare (e in effetti causerà) un <strong>di</strong>sastro, Quinto F<strong>ab</strong>io Massimo, il Temporeggiatore,<br />
<strong>di</strong>ce: [...] si hic, quod facturum se denuntiat, extemplo pugnaverit, aut ego rem militarem, belli hoc<br />
genus, hostem hunc ignoro [alternativa evidentemente assurda] aut nobilior alius Trasumenno locus<br />
nostris cla<strong>di</strong>bus erit [...], “se costui, come <strong>di</strong>chiara <strong>di</strong> voler fare, darà subito battaglia, o io non<br />
conosco l’arte militare, il carattere <strong>di</strong> questa guerra, questo nemico, oppure un altro luogo <strong>di</strong>verrà<br />
per le nostre sconfitte ancor più famoso del Trasimeno”.
Letteratura latina B a.a. 2008-2009 mod. 2. Appunti delle lezioni 41<br />
le <strong>di</strong>scor<strong>di</strong>e interne, le <strong>di</strong>fficoltà e il malessere che travagliano lo stato romano nel tempo<br />
presente.<br />
§ 13. Messi subito da parte i rimproveri (querellae 45, appena accennate al § 12,<br />
con la frase che si apre con nuper), che sarebbero <strong>di</strong> cattivo augurio, il brano introduttivo<br />
si chiude in modo molto solenne, e originale, con una invocazione agli dèi, che lo storico<br />
stesso <strong>di</strong>chiara non appropriata ad un’opera storica. Il periodo ipotetico (si<br />
esset...inciperemus, che esprime irrealtà al presente) gli consente <strong>di</strong> non violare<br />
formalmente le regole del genere storiografico, e <strong>di</strong> porre egualmente sotto la protezione<br />
<strong>di</strong>vina l’opera che sta iniziando: <strong>ab</strong> initio tantae or<strong>di</strong>endae rei. Ma ancora una volta, con<br />
l’uso del sostantivo res, <strong>Livio</strong> lascia <strong>di</strong> proposito nell’incertezza se stia parlando dell’opera<br />
o dello stato che ne è protagonista. Anche se il rinvio esplicito è all’uso dei poeti epici (che<br />
però, come si sa, si rivolgevano alla Musa), l’invocazione richiama piuttosto quella che<br />
accompagnava il generale e l’esercito in partenza per una guerra46, rivolta genericamente<br />
a tutti gli dèi e a tutte le dee, in modo da evitare <strong>di</strong> inimicarsi la <strong>di</strong>vinità eventualmente<br />
<strong>di</strong>menticata.<br />
Infine, con l’assunzione <strong>di</strong> un inizio che <strong>di</strong>chiara proprio dei poeti, l’autore vuole<br />
forse anche mostrare che egli concepisce il suo compito come quello non solo <strong>di</strong> un<br />
ricercatore, ma anche <strong>di</strong> un artista.<br />
45 Lett. “lamenti, deplorazioni”. A chi non saranno gratae le querellae? Non tanto forse a chi dovrà<br />
ascoltarle o leggerle, quanto soprattutto all’autore. Egli cioè non vuole, proprio all’inizio dell’opera<br />
da cui si ripromette il praemium <strong>di</strong> venir <strong>di</strong>stolto dal conspectus malorum, soffermarsi sui mala più<br />
del necessario, rendere sollicitus il suo animo e ingrato il suo compito. Sarebbe inoltre fuor <strong>di</strong><br />
luogo <strong>di</strong>ffondersi già ora su temi che saranno oggetto dei <strong>libri</strong> futuri, dell’ultima parte dell’opera;<br />
ora lo storico si accinge a mostrare quae vita, qui mores fuerint ecc. La mente dello scrittore si<br />
rivolge soprattutto a quella parte della sua storia che imme<strong>di</strong>atamente sarà trattata, quella più<br />
antica, una <strong>di</strong>sposizione d’animo che domina in tutta la prefazione. In essa l’autore offre, è vero,<br />
nelle sue linee molto generali il piano <strong>di</strong> tutto il lavoro (dalle origini ai tempi presenti), ma se ne<br />
vale soprattutto per introdurre la prima parte, la storia più antica. Rinvia perciò le querellae al<br />
momento in cui non potranno essere evitate. L’avv. forsitan, più che un dubbio sull’opportunità (o<br />
la necessità) <strong>di</strong> dar voce a quei rimproveri ora ban<strong>di</strong>ti, esprime la riluttanza dell’autore a<br />
soffermarvisi fin d’ora con il pensiero.<br />
46 V. per es. <strong>Livio</strong> 45,39,10 (parla Lucio Emilio Paolo, riferendosi ai riti propiziatori prima dell’inizio<br />
<strong>di</strong> una guerra e alle cerimonie <strong>di</strong> ringraziamento dopo la sua felice conclusione): maiores vestri<br />
omnium magnarum rerum et principia exorsi a <strong>di</strong>s sunt et finem statuerunt.
Letteratura latina B a.a. 2008-2009 mod. 2. Appunti delle lezioni 42<br />
IL PRIMO LIBRO. STORIA DELLA MONARCHIA<br />
Prob<strong>ab</strong>ilmente <strong>Livio</strong> pubblicò a sé il primo libro della sua opera. Esso ha una sua<br />
fisionomia peculiare, che lo <strong>di</strong>stingue da tutti gli altri. Abbraccia l’intero periodo regio<br />
(754-509), ed è organizzato attorno alle figure dei sette re tra<strong>di</strong>zionali. Tipico del primo<br />
libro è un interesse archeologico-antiquario quasi assente nel resto dell’opera, che certo<br />
<strong>Livio</strong> ricavava dalle sue fonti annalistiche: lo storico si adegua alla tra<strong>di</strong>zione che faceva<br />
risalire al periodo regio l’origine <strong>di</strong> istituzioni, riti, culti, molti dei quali ancora esistenti in<br />
epoca contemporanea, ma certo istituiti tutti (salvo forse qualche cerimonia religiosa) in<br />
epoca più tarda) 47. Anche le numerose spiegazioni <strong>di</strong> carattere eziologico rientrano in<br />
questo interesse <strong>di</strong> tipo antiquario: oggetti ancora visibili, nomi <strong>di</strong> luoghi, riti vengono<br />
legati a un episo<strong>di</strong>o antico, che ne spiega e nobilita l’origine. Ai brani <strong>di</strong> carattere eru<strong>di</strong>to<br />
si alternano numerose leggende: per queste vale la <strong>di</strong>chiarazione programmatica inserita<br />
dallo storico nella prefazione generale dell’opera (nec adfirmare nec refellere in animo est,<br />
§ 6). Sezioni antiquarie e leggende insieme conferiscono all’intero libro un aspetto arcaico,<br />
accentuato dall’uso frequente, nella parte narrativa, <strong>di</strong> termini e locuzioni poetiche.<br />
Pur nel suo carattere composito il primo libro ha, con ogni evidenza, un tema<br />
prevalente e unificatore: la crescita progressiva <strong>di</strong> Roma verso quella grandezza cui fin<br />
dall’inizio è destinata. Questo viene solennemente affermato dallo storico prima <strong>di</strong> riferire<br />
la leggenda dei gemelli48, è il motivo ricorrente dell’ostilità dei popoli vicini e delle guerre<br />
da essi suscitate contro Roma, è, infine, oggetto <strong>di</strong> incroll<strong>ab</strong>ile fede da parte dei Romani<br />
stessi.<br />
IL REGNO DI ROMOLO<br />
Al primo re sono de<strong>di</strong>cati i capp. 8-17 del primo libro. <strong>Livio</strong> ha già registrato, senza<br />
<strong>ab</strong>bellimenti né reticenze, la poco onorevole origine <strong>di</strong> Roma: i due gemelli, racconta,<br />
restituito il regno <strong>di</strong> Alba al nonno Numitore, decidono <strong>di</strong> fondare una nuova città, nei<br />
luoghi in cui erano stati esposti ed allevati. Accompagnati da molti Albani e Latini, scelto<br />
il luogo, si accingono alla fondazione. Tra i due fratelli, fino a quel momento<br />
perfettamente concor<strong>di</strong>, si insinuò un avitum malum, la regni cupido, e sorse una<br />
vergognosa contesa su chi dovesse essere il fondatore e il re della nuova città. Si decide<br />
<strong>di</strong> lasciare la decisione agli dèi, e ciascuno prende posto in un luogo d’osservazione,<br />
47<br />
Per es. l’istituzione del senato (Romolo), della maggior parte dei collegi sacerdotali (Numa), della<br />
sud<strong>di</strong>visione della popolazione in classi su base censitaria (Servio Tullio).<br />
48<br />
1,4,1 Sed debebatur, ut opīnor, fatis tantae origo urbis maximique secundum deorum opes imperii<br />
principium.
Letteratura latina B a.a. 2008-2009 mod. 2. Appunti delle lezioni 43<br />
Romolo sul Palatino e Remo sull’ Aventino (1,6,4). Per primo Remo scorge il segno, sei<br />
avvoltoi; ma subito dopo Romolo annuncia <strong>di</strong> averne visti do<strong>di</strong>ci: entrambi i gemelli sono<br />
proclamati re dai rispettivi seguaci; scoppia una zuffa, e Remo resta ucciso. <strong>Livio</strong><br />
aggiunge anche la versione più nota (volgatior fama), secondo cui Remo fu ucciso dal<br />
fratello, irato per l’atto <strong>di</strong> provocazione da lui compiuto (saltò con spregio al <strong>di</strong> là del<br />
tracciato delle nuove mura). Da questo momento <strong>di</strong> Remo non si parla più: ita solus<br />
potitus imperio Romulus; <strong>con<strong>di</strong>ta</strong> urbs con<strong>di</strong>toris nomine appellata (1,7,1-3). Romolo<br />
fortifica il Palatino, e offre sacrifici agli dèi: agli altri secondo il rito albano, ad Ercole<br />
secondo quello greco, che era stato istituito da Evandro. Segue un’ampia <strong>di</strong>gressione<br />
eziologica, in cui viene narrata la leggenda <strong>di</strong> Ercole e Caco49, e la consacrazione da parte<br />
<strong>di</strong> Evandro <strong>di</strong> un’ara che – profetizza Evandro – “un giorno il popolo più potente del<br />
mondo chiamerà Massima”. Questo lungo racconto (1,7,4-14), che non ha nulla a che<br />
fare con la fondazione <strong>di</strong> Roma e con le vicende <strong>di</strong> Romolo, non ha solo lo scopo <strong>di</strong><br />
inserire la menzione dell’ Ara Maxima, al cui rinnovato culto Augusto attribuiva grande<br />
importanza; svolge anche una importante funzione all’interno del testo, separando l’inizio<br />
poco e<strong>di</strong>ficante della città dalla narrazione dei fatti del regno <strong>di</strong> Romolo.<br />
Fatti e leggende erano offerti, come si è detto, a <strong>Livio</strong> dalle sue fonti; egli impiega il<br />
suo talento <strong>di</strong> narratore soprattutto nel dare una veste letteraria accurata ed attraente<br />
ad una res, come lo storico ha esplicitamente affermato nella prefazione, vetus e volgata.<br />
In concreto, la riel<strong>ab</strong>orazione operata da <strong>Livio</strong> (sia qui sia in generale nella sua<br />
storia <strong>di</strong> Roma) consiste in primo luogo in una <strong>di</strong>sposizione della materia atta, con la sua<br />
varietà, ad evitare la monotonia, per mezzo <strong>di</strong> una frequente alternanza <strong>di</strong> temi: per<br />
Romolo, descrizione della situazione interna a Roma e delle guerre esterne, brani eru<strong>di</strong>ti<br />
o eziologici e leggende tra<strong>di</strong>zionali. Non solo: <strong>di</strong> fronte ad una materia sterminata e<br />
spesso assai ripetitiva, <strong>Livio</strong> non si limita all’alternanza dei temi; applica anche, nella sua<br />
narrazione, un fondamentale principio <strong>di</strong> selezione: pur non rinunciando ad informare il<br />
lettore <strong>di</strong> tutti i fatti storicamente rilevanti, non li racconta però tutti per esteso.<br />
Concentra la sua attenzione su alcuni eventi più significativi, o più ricchi <strong>di</strong> spunti<br />
drammatici o patetici, o ancora che si prestano meglio <strong>di</strong> altri a trarne un insegnamento<br />
morale; a molti altri episo<strong>di</strong> analoghi si limita ad accennare brevemente, senza veramente<br />
raccontarli e sfruttarne tutte le possibilità.<br />
Sul piano artistico e stilistico, a questa selezione degli argomenti corrisponde un<br />
uso moderato e sapiente delle tecniche della storiografia drammatica: ad episo<strong>di</strong> ricchi <strong>di</strong><br />
pathos, trattati in modo da coinvolgere emotivamente il lettore, e caratterizzati da uno<br />
49 In Virgilio il mito viene narrato da Evandro ad Enea (Aen. 8,185-275). Dopo aver ucciso il<br />
mostro Gerìone ed essersi impossessato dei suoi armenti, Ercole ne viene derubato da Caco, un<br />
pastore predone (secondo la versione <strong>di</strong> <strong>Livio</strong>) o un mostro, figlio <strong>di</strong> Vulcano (secondo quella <strong>di</strong><br />
Virgilio). Scoperta la spelonca in cui Caco aveva nascosto le bestie, Ercole lo affronta e lo uccide.
Letteratura latina B a.a. 2008-2009 mod. 2. Appunti delle lezioni 44<br />
stile el<strong>ab</strong>orato (perio<strong>di</strong> ampi, termini ricercati, talvolta locuzioni poetiche) sono alternati<br />
brani più prosaici, descrittivi, composti in uno stile rapido e stringato. In tal modo la<br />
tensione drammatica creata negli episo<strong>di</strong> più el<strong>ab</strong>orati (con un principio, un nucleo<br />
narrativo, lo scioglimento finale) si allenta, e nel lettore non si ingenera la sazietà.<br />
Sul regno <strong>di</strong> Romolo la tra<strong>di</strong>zione offriva a <strong>Livio</strong> questi elementi: una serrie <strong>di</strong><br />
guerre; alcune misure <strong>di</strong> politica interna; due leggende famose, connesse entrambe alla<br />
guerra contro i S<strong>ab</strong>ini, il tra<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> Tarpea e il ratto delle donne.<br />
La sezione de<strong>di</strong>cata al regno <strong>di</strong> Romolo si apre con queste parole: “Compiute<br />
secondo il rito le cerimonie religiose e riunita in assemblea la moltitu<strong>di</strong>ne che nulla se<br />
non le leggi poteva unire a formare un solo popolo, fissò le norme del <strong>di</strong>ritto (iura de<strong>di</strong>t)”<br />
(1,8,1). Una situazione, brevemente delineata, ben <strong>di</strong>versa da quella con cui si apriva il<br />
capitolo precedente: in luogo <strong>di</strong> una folla che si azzuffa, una moltitu<strong>di</strong>ne che si avvia a<br />
<strong>di</strong>ventare un popolo; al posto <strong>di</strong> un (prob<strong>ab</strong>ile) assassino, un re risoluto e saggio, che<br />
prima <strong>di</strong> tutto si preoccupa <strong>di</strong> fissare le leggi. Segue l’istituzione dei simboli del potere, i<br />
12 littori, la sella curulis, la toga praetexta, con una <strong>di</strong>scussione <strong>di</strong> carattere eru<strong>di</strong>to<br />
sull’origine etrusca <strong>di</strong> tutti e tre questi simboli.<br />
Dopo l’ampliamento della città 50, il secondo provve<strong>di</strong>mento preso da Romolo è<br />
l’istituzione dell’asilo: un luogo, posto sotto la protezione <strong>di</strong> una <strong>di</strong>vinità, che garantisce<br />
l’inviol<strong>ab</strong>ilità a chiunque vi si rifugi; a questo è collegato il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> stanziamento, per cui<br />
coloro che ottengono asilo <strong>di</strong>ventano citta<strong>di</strong>ni del luogo. Si rifugia nell’asilo aperto da<br />
Romolo ogni sorta <strong>di</strong> persone dalle popolazioni vicine, senza <strong>di</strong>stinzione fra liberi e servi.<br />
Infine Romolo istituisce il senato, con 100 membri.<br />
Il sinecismo s<strong>ab</strong>ino<br />
Prima fase: il ratto (1,9). Il racconto della fusione fra Romani e S<strong>ab</strong>ini è costruito<br />
come una sorta <strong>di</strong> dramma in più atti, con le donne s<strong>ab</strong>ine che – come il coro nelle<br />
trage<strong>di</strong>e – fanno da sfondo e collegano fra loro le parti del dramma, e accompagnano con<br />
il graduale mutamento dei loro sentimenti lo sviluppo della vicenda, fino alla<br />
riconciliazione finale, in cui assumono il ruolo <strong>di</strong> protagoniste.<br />
La storia era notissima; il confronto con le versioni che possiamo leggere in<br />
Cicerone 51 , in Plutarco 52 e in Dionigi <strong>di</strong> Alicarnasso 53 mostra che l’el<strong>ab</strong>orazione del<br />
racconto è opera <strong>di</strong> <strong>Livio</strong>, non gli deriva dalla tra<strong>di</strong>zione.<br />
50<br />
“Cresceva frattanto la città, includendo nella cerchia delle sue mura sempre nuovi territori,<br />
giacché quelle fortificazioni venivano costruite più nell’attesa della popolazione futura che non per<br />
il numero effettivo degli <strong>ab</strong>itanti <strong>di</strong> allora” (1,8,4).<br />
51<br />
de rep. 2,7<br />
52<br />
Romolo, 14 ss.,
Letteratura latina B a.a. 2008-2009 mod. 2. Appunti delle lezioni 45<br />
<strong>Livio</strong> el<strong>ab</strong>ora un antefatto della vicenda (9,2-5), che non si trova in nessuna delle<br />
fonti parallele, evidentemente allo scopo <strong>di</strong> far apparire meno gravi, se non proprio <strong>di</strong><br />
giustificarli, l’inganno e la violenza cui i Romani ricorsero. Romolo infatti manda<br />
ambasciatori a chiedere ai popoli vicini <strong>di</strong> concedere ai Romani il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> conubium, e<br />
solo dopo aver ricevuto da tutti un rifiuto, e da molti anche un oltraggio, decide il ricorso<br />
alla violenza. La vis annunciata, e attesa dal lettore, è alquanto rimandata, per<br />
accrescere la tensione; viene infatti descritta, assai più ampiamente del ratto vero e<br />
proprio, la preparazione della festa, organizzata appositamente (ex industria) per attirare<br />
nell’agguato i popoli vicini. Il racconto procede poi lentamente, con la registrazione del<br />
successo del piano: gli ospiti arrivano numerosi, sono accolti amichevolmente e condotti<br />
in giro a visitare la città, ammirati e stupiti (9,6-9).<br />
Quando finalmente giunge il momento tanto atteso dal lettore, tutto si compie in<br />
fretta, con or<strong>di</strong>ne, quasi come un’azione militare, registrata con una sola frase (9,10). La<br />
tensione si allenta subito, nella descrizione dell’or<strong>di</strong>nata <strong>di</strong>stribuzione delle rapite (9,11):<br />
non sono registrati strilli, né confusione, né, soprattutto, risse fra i rapitori; l’ultimo<br />
accenno (le più belle sono destinate ai primi della città) fa capire che tutto era stato<br />
perfettamente organizzato in anticipo. Segue infine una notazione eru<strong>di</strong>ta, <strong>di</strong> carattere<br />
eziologico, sull’origine dell’Invocazione a Talassio, tra<strong>di</strong>zionale nelle cerimonie nuziali<br />
(9,12); essa ha anche una importante funzione all’interno del racconto, in quanto la<br />
menzione della nuptialis vox fa comprendere che tutta l’impresa non è una brutale<br />
aggressione, ma prelude a nozze regolari.<br />
L’attenzione del narratore si sposta quin<strong>di</strong> (9, 13-16) sulla parte offesa, soprattutto<br />
sulle donne. Il <strong>di</strong>scorso <strong>di</strong> Romolo (in o.o.) conclude la prima fase dell’episo<strong>di</strong>o, che si era<br />
anch’essa aperta con un <strong>di</strong>scorso (anche questo in o.o.), quello dei legati ai popoli vicini.<br />
L’unità tematica <strong>di</strong> questa prima fase, la cui scena è costantemente in Roma, è<br />
sottolineata dalla ripresa, nelle parole <strong>di</strong> Romolo, del motivo iniziale del rifiuto del<br />
conubium.<br />
Seconda fase. Il tempio <strong>di</strong> Giove Feretrio. (1,10-11,4). L’unità della sezione<br />
anche in questo caso è sottolineata dal fatto che il narratore la racchiude fra due<br />
menzioni dei parentes raptarum, all’inizio irati e in<strong>di</strong>gnati, e alla fine riconciliati con<br />
Roma al punto <strong>di</strong> trasferirsi ad<strong>di</strong>rittura in quella città cui in passato avevano rifiutato<br />
societas e conubium. La scena è per lo più fuori Roma, salvo che per la cerimonia della<br />
de<strong>di</strong>ca delle spoglie opime, il vero centro <strong>di</strong> interesse <strong>di</strong> questa fase della vicenda. In<br />
contrasto con la prima sezione (e soprattutto con l’ultima), questa è caratterizzata da<br />
53 Ant. Rom. 2,30,1
Letteratura latina B a.a. 2008-2009 mod. 2. Appunti delle lezioni 46<br />
estrema concisione: essa è una sorta <strong>di</strong> pausa, prima della guerra con i S<strong>ab</strong>ini, con la<br />
sua inattesa conclusione. La coalizione dei popoli offesi attorno al re dei S<strong>ab</strong>ini <strong>Tito</strong> Tazio<br />
si scioglie ancor prima che un’azione comune possa essere progettata e adeguatamente<br />
preparata, e ciascuno dei popoli attacca Roma da solo, in momenti successivi. Si<br />
presentavano dunque allo storico quattro <strong>di</strong>stinte campagne militari: egli sceglie <strong>di</strong><br />
concentrarsi su una soltanto <strong>di</strong> esse, naturalmente quella contro i S<strong>ab</strong>ini. Delle altre tre<br />
offre un resoconto molto stringato.<br />
I più impazienti <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>care l’offesa sono i Ceninesi. La guerra contro <strong>di</strong> loro è la<br />
prima impresa bellica in cui è impegnata la nuova città, che era, come lo storico ha<br />
asserito (1,9,1), cuilibet finitimarum civitatium bello par, e l’esito vittorioso lo <strong>di</strong>mostra. Lo<br />
scontro non è affatto memor<strong>ab</strong>ile (leve certamen), salvo che per l’uccisione da parte <strong>di</strong><br />
Romolo del re dei nemici. E’ proprio questa circostanza che offre al re l’occasione per<br />
immortalare l’evento, con la solenne istituzione della cerimonia dell’offerta delle spoglie<br />
opime e la promessa del tempio; e allo storico <strong>di</strong> inserire la sua notazione eziologica ed<br />
eru<strong>di</strong>ta. Questa ha anche la funzione narrativa <strong>di</strong> interporre una pausa dopo la prima<br />
guerra vittoriosa della storia <strong>di</strong> Roma, che per quanto insignificante andava solennizzata<br />
in qualche modo. I medesimi “fatti” (guerra contro Cenina e offerta delle spoglie) sono<br />
el<strong>ab</strong>orati in modo molto <strong>di</strong>verso da Properzio, nella sezione iniziale dell’elegia eziologica<br />
sul tempio <strong>di</strong> Giove Feretrio54. In essa il poeta presenta compiutamente il re nemico,<br />
Acrone <strong>di</strong>scendente <strong>di</strong> Ercole, lo descrive mentre assale minaccioso le porte <strong>di</strong> Roma, e<br />
accenna anche al duello da cui Romolo uscì vittorioso. <strong>Livio</strong> invece insiste sulla facilità<br />
della vittoria, e del re ucciso non <strong>di</strong>ce neppure il nome. Ogni particolare superfluo viene<br />
eliminato: centro <strong>di</strong> interesse non è l’ucciso, ma l’uccisore, e la tra<strong>di</strong>zione da lui<br />
inaugurata; per questo, pur in un resoconto molto conciso, l’uccisione del re è<br />
menzionata due volte (regem obtruncat; duce hostium occiso 55 ): occorreva mettere in<br />
rilievo la qualifica dell’ucciso, non chi egli fosse. In tal modo risulta chiaro che spolia<br />
opima sono soltanto quelle offerte dal condottiero dotato <strong>di</strong> imperium supremo che <strong>ab</strong>bia<br />
54<br />
4,10,5-18: Imbuis exemplum primae tu, Romule, palmae / huius, et exuvio plenus <strong>ab</strong> hoste re<strong>di</strong>s,<br />
/ tempore quo portas Caeninum Acrona petentem / victor in eversum cuspide fun<strong>di</strong>s equum. / Acron<br />
Herculeus Caenina ductor <strong>ab</strong> arce, / Roma, tuis quondam finibus horror erat. / Hic spolia ex umeris<br />
ausus sperare Quirini / ipse de<strong>di</strong>t, sed non sanguine sicca suo. / Hunc videt ante cavas librantem<br />
spicula turres / Romulus et votis occupat ante ratis: / 'Iuppiter, haec ho<strong>di</strong>e tibi victima corruet<br />
Acron.' / Voverat, et spolium corruit ille Iovi., “Tu per primo, Romolo, inauguri l’esempio <strong>di</strong> questo<br />
trofeo, e torni carico <strong>di</strong> spoglie dal nemico, al tempo in cui con la tua lancia vittorioso <strong>ab</strong>batti sul<br />
cavallo riverso il ceninese Acrone che assale le porte. Acrone, condottiero <strong>di</strong>scendente da Ercole,<br />
dalla rocca <strong>di</strong> Cenina minacciava un tempo, o Roma, i tuoi territori. Egli, che aveva osato sperare<br />
le spoglie tolte dagli omeri <strong>di</strong> Quirino, le offrì egli stesso, ma bagnate del suo sangue. Romolo lo<br />
vede scagliare dar<strong>di</strong> davanti alle cave torri, e lo previene formulando un voto, che fu esau<strong>di</strong>to:<br />
‘Giove, per te oggi cadrà questa vittima, Acrone’. Così aveva promesso, e quello cadde, spoglia per<br />
Giove”.<br />
55<br />
Al tempo <strong>di</strong> Romolo la medesima persona assomma in sé la carica politica più alta (rex) e il<br />
supremo comando militare (dux).
Letteratura latina B a.a. 2008-2009 mod. 2. Appunti delle lezioni 47<br />
ucciso in battaglia il suo pari grado dell’esercito nemico. Questo è riba<strong>di</strong>to nella solenne,<br />
orgogliosa formula della de<strong>di</strong>ca <strong>di</strong> Romolo: victor Romulus rex regia arma fero... regibus<br />
ducibusque hostium caesis.<br />
Le altre due campagne, contro Antemnati (11,1-2) e Crustumini (11, 3) si svolgono<br />
nel medesimo modo, e vengono registrate con concisione crescente. Lo svolgimento della<br />
guerra contro gli Antemnati è analogo a quello della guerra contro i Ceninesi: attacco del<br />
nemico, reazione <strong>di</strong> Romolo, vittoria e conquista della città. Qui però sono omessi<br />
inseguimento e fuga del nemico sconfitto. Alla <strong>di</strong>gressione su Giove Feretrio corrisponde,<br />
in certo modo, la pausa costituita dall’intercessione <strong>di</strong> Ersilia, la moglie <strong>di</strong> Romolo, a<br />
favore degli sconfitti, che prefigura già (come il <strong>di</strong>scorso <strong>di</strong> Romolo alle ragazze rapite) lo<br />
scioglimento finale della guerra contro i S<strong>ab</strong>ini, ed è riferito, come le imprese militari, con<br />
stile assai conciso: due participi congiunti (ovantem e fatigata) delineano brevemente le<br />
con<strong>di</strong>zioni che preparano e favoriscono la richiesta; i due congiuntivi introdotti da ut (det<br />
e accipiat) ne espongono il contenuto; non manca (in stile in<strong>di</strong>retto) anche una succinta<br />
valutazione politica sull’utilità <strong>di</strong> accogliere la richiesta, che ben si adatta alla moglie del<br />
re.<br />
Per la terza guerra, contro i Crustumini, <strong>Livio</strong> non <strong>di</strong>ce neppure se vi sia stata una<br />
vera e propria battaglia, o se la città si sia subito arresa. Invece <strong>di</strong> ripetere per la terza<br />
volta la medesima successione <strong>di</strong> azioni, lo storico registra il comune risultato <strong>di</strong><br />
entrambe le vittorie (utroque coloniae missae, 11, 4).<br />
Terza fase. La guerra contro i S<strong>ab</strong>ini (1, 11,5-13). Dopo aver con estrema<br />
facilità vinto tre guerre, Roma può senza <strong>di</strong>sonore apparire in <strong>di</strong>fficoltà: il nemico in<br />
questo caso si è preparato seriamente e in segreto alla guerra, e riesce a cogliere <strong>di</strong><br />
sorpresa i Romani.<br />
A questo punto del racconto <strong>Livio</strong> introduce la nota leggenda <strong>di</strong> Tarpea (11,6-7).<br />
La vicenda non viene riel<strong>ab</strong>orata come nel caso del ratto: questo mito, <strong>di</strong> cui esistevano<br />
<strong>di</strong>verse varianti, è esposto con tono <strong>di</strong>staccato e un poco scettico, da eru<strong>di</strong>to più che da<br />
narratore. Non vi è tensione drammatica, il racconto è quanto mai scarno e scolorito, e<br />
gli elementi più pittoreschi, che facevano parte tra<strong>di</strong>zionalmente della versione scelta da<br />
<strong>Livio</strong>, non vengono sfruttati per costruire il racconto, ma sono relegati nel commento<br />
eru<strong>di</strong>to finale.<br />
La leggenda era nata evidentemente per spiegare l’origine del nome del Tarpeius<br />
mons, la rupe Tarpea, una roccia sul colle del Campidoglio, dalla quale venivano nei<br />
tempi antichi precipitati i tra<strong>di</strong>tori della patria: questo fece nascere la leggenda <strong>di</strong> un eroe<br />
eponimo, Tarpea appunto. Di questo mito erano note al tempo <strong>di</strong> <strong>Livio</strong> almeno tre<br />
versioni:
Letteratura latina B a.a. 2008-2009 mod. 2. Appunti delle lezioni 48<br />
a) Tarpea tra<strong>di</strong>sce per avi<strong>di</strong>tà, per brama dell’oro da lei chiesto ai S<strong>ab</strong>ini o promesso da<br />
loro; i nemici stessi la puniscono uccidendola. Questa era prob<strong>ab</strong>ilmente la versione più<br />
antica, e certo la più <strong>di</strong>ffusa; si trovava già in F<strong>ab</strong>io Pittore e Cincio Alimento 56, ed è<br />
quella accolta da <strong>Livio</strong> stesso.<br />
b) Tarpea tra<strong>di</strong>sce per amore: è la versione famosa <strong>di</strong> Properzio (4,4), la più originale 57.<br />
<strong>Livio</strong> non mostra <strong>di</strong> conoscere questa versione, che adatta alla leggenda romana un<br />
motivo frequente nei racconti ellenistici.<br />
c) Una versione patriottica era stata el<strong>ab</strong>orata dall’annalista Pisone, ed è menzionata<br />
anche da <strong>Livio</strong>: Tarpea non intendeva tra<strong>di</strong>re, finse solo <strong>di</strong> volersi accordare con i nemici;<br />
chiedendo loro le armi come ricompensa del suo (finto) tra<strong>di</strong>mento intendeva in realtà<br />
consegnarli <strong>di</strong>sarmati ai Romani. L’inganno però non riesce, e Tarpea viene uccisa.<br />
Questa versione forse nacque, più che per motivi patriottici, per una esigenza <strong>di</strong><br />
razionalizzazione: poiché la tomba <strong>di</strong> Tarpea era oggetto <strong>di</strong> culto, evidentemente essa non<br />
poteva essersi resa colpevole <strong>di</strong> tra<strong>di</strong>mento.<br />
Sono evidenti la semplicità e la concisione del racconto <strong>di</strong> <strong>Livio</strong>, concentrato sul<br />
dolus: lo storico <strong>di</strong> proposito elimina, nel racconto principale, l’elemento fondamentale<br />
dell’ambiguità della richiesta <strong>di</strong> Tarpea, sulla quale era costruita la versione più nota del<br />
mito: Tarpea non chiese l’oro né chiese gli scu<strong>di</strong>, ma “ciò che portavano nella mano<br />
sinistra”, e i S<strong>ab</strong>ini non la ingannarono. Rinunciando a questo elemento, <strong>Livio</strong><br />
razionalizza e banalizza il racconto: lo confermano le due spiegazioni proposte del<br />
comportamento dei soldati s<strong>ab</strong>ini, che invece <strong>di</strong> compensare Tarpea la uccidono (o per<br />
dar l’impressione <strong>di</strong> aver conquistato la rocca, o per rivolgere un avvertimento<br />
minaccioso a tutti i possibili tra<strong>di</strong>tori).<br />
Anche i particolari relativi al personaggio <strong>di</strong> Tarpea sono lasciati ai margini: ciò<br />
che a <strong>Livio</strong> importa sottolineare è che fu un dolus a consegnare la rocca ai S<strong>ab</strong>ini. Il dato<br />
tra<strong>di</strong>zionale (e anacronistico) secondo cui Tarpea era una Vestale, è implicito nel termine<br />
virgo e nell’accenno ai sacra, ma per la storia del tra<strong>di</strong>mento è superfluo. L’espressione<br />
forte ierat (si noti soprattutto l’uso del piuccheperfetto) permette allo scrittore <strong>di</strong> non<br />
soffermarsi su particolari <strong>di</strong> minor conto anteriori al fatto centrale su cui è concentrata<br />
l’attenzione (il dolus), relegando in un momento precedente le circostanze che lo hanno<br />
determinato. Il lettore poteva legittimamente chiedersi come Tazio si fosse potuto<br />
accordare con Tarpea, che viveva dentro la rocca, all’interno delle mura: la frase<br />
aquam...petitum ierat fornisce, in forma quasi parentetica, la necessaria spiegazione; il<br />
racconto principale riprende subito, con la medesima parola con cui si era interrotto:<br />
56<br />
Come attesta Dionigi <strong>di</strong> Alicarnasso, Ant. rom 1,38<br />
57<br />
Non inventata prob<strong>ab</strong>ilmente da Properzio, giacché era narrata già da un certo Similo,<br />
menzionato da Plutarco, Romolo, 18.
Letteratura latina B a.a. 2008-2009 mod. 2. Appunti delle lezioni 49<br />
accipiat ... accepti. Omessi tutti i particolari relativi all’accordo, dopo la parentesi il<br />
tra<strong>di</strong>mento è già consumato, e la tra<strong>di</strong>trice punita. Con ad<strong>di</strong>tur f<strong>ab</strong>ula inizia il commento<br />
<strong>di</strong> carattere eru<strong>di</strong>to; solo qui, a racconto principale già concluso, sono infine forniti i<br />
particolari relativi al patto e all’oro; e poi è aggiunta ancora l’altra versione.<br />
Con le parole tenuere tamen arcem S<strong>ab</strong>ini riprende il racconto storico: tamen lascia<br />
implicito un enunciato <strong>di</strong> questo genere: benché la storia del tra<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> Tarpea non<br />
sia certa, né tramandata in modo concorde58, è certo però che i S<strong>ab</strong>ini occuparono la<br />
rocca del Campidoglio. Di qui <strong>Livio</strong> si impegna nella prima descrizione particolareggiata<br />
<strong>di</strong> una battaglia, che occupa per intero il capitolo 12.<br />
Esso si apre con un ampio periodo (12,1) che fornisce il quadro del luogo in cui lo<br />
scontro avverrà (la pianura fra i colli Palatino e Capitolino), descrive la rispettiva<br />
posizione dei due eserciti (in cima al pen<strong>di</strong>o i S<strong>ab</strong>ini, nella pianura i Romani), i<br />
sentimenti che animano i Romani (ira e cupi<strong>di</strong>tas reciperandae arcis), e infine il primo<br />
movimento dei due schieramenti, che si corrono incontro (in <strong>di</strong>scesa i S<strong>ab</strong>ini, in salita i<br />
Romani, dunque in situazione <strong>di</strong> svantaggio). Anche il secondo paragrafo <strong>ab</strong>braccia ad<br />
un tempo entrambi gli schieramenti. Poi la descrizione si sud<strong>di</strong>vide, e tratta<br />
separatamente prima le azioni dei Romani (12,3-7) e poi quelle dei S<strong>ab</strong>ini (12,8), con un<br />
ritorno, segnalato dall’uso dei piuccheperfetti decucurrerat, egerat, al momento iniziale<br />
dello scontro: l’azione dei S<strong>ab</strong>ini viene seguita fino al momento in cui Romolo e Mezio si<br />
trovano l’uno <strong>di</strong> fronte all’altro, accanto alla porta del Palatino; <strong>di</strong> qui inizia la ripresa dei<br />
Romani59, introdotta e propiziata dalla preghiera <strong>di</strong> Romolo.<br />
La preghiera vera e propria è costituita dai tre imperativi arce, deme, siste. Ma<br />
prima <strong>di</strong> rivolgere la supplica a Giove, Romolo riassume la situazione, per mettere, se<br />
così si può <strong>di</strong>re, rispettosamente il <strong>di</strong>o davanti alle sue respons<strong>ab</strong>ilità: tu hai voluto che<br />
io fondassi questa città; ora ve<strong>di</strong> quale pericolo essa corre; dunque salvala. I <strong>di</strong>versi<br />
momenti <strong>di</strong> questo accorato ragionamento sono scan<strong>di</strong>ti – con lo stile tipico, per l’impiego<br />
dell’anafora, delle preghiere – dalla ripetizione dell’avv. <strong>di</strong> luogo: hic...huc...hinc...hic. Altri<br />
elementi che conferiscono solennità alla preghiera sono in<strong>di</strong>vidu<strong>ab</strong>ili nell’uso del verbo<br />
58 Di questa cautela sull’incertezza della tra<strong>di</strong>zione, implicita in tamen, <strong>Livio</strong> non tiene più conto<br />
nel seguito del racconto, quando fa <strong>di</strong>re a Romolo, nella sua preghiera a Giove: arcem scelere<br />
emptam S<strong>ab</strong>ini h<strong>ab</strong>ent, 1,12,4.<br />
59 Curiosamente pare che non sia il re a guidare fin dall’inizio l’esercito romano, ma il valoroso<br />
Osto Ostilio, che però esce subito <strong>di</strong> scena. Il personaggio fu prob<strong>ab</strong>ilmente inventato dalla<br />
tra<strong>di</strong>zione annalistica per fornire al terzo re <strong>di</strong> Roma un antenato prestigioso (cf. <strong>Livio</strong> 1,22,1: ...<br />
Tullum Hostilium, nepotem Hostilii, cuius in infima arce clara pugna adversus S<strong>ab</strong>inos fuerat, regem<br />
populus iussit.). Dopo la sua prova <strong>di</strong> valore Osto Ostilio lascia infatti opportunamente il posto a<br />
Romolo. Dalla parte dei S<strong>ab</strong>ini invece il comandante è dall’inizio alla fine Mezio Curzio; il re <strong>Tito</strong><br />
Tazio (figura molto evanescente) non compare mai nella battaglia; soltanto a conflitto felicemente<br />
concluso <strong>Livio</strong> lo nomina (13,8); anche il regno in comune con Romolo dura poco: il re <strong>Tito</strong> Tazio<br />
viene ucciso, per un colpa commessa da lui solo, dalla folla inferocita <strong>di</strong> Lavinio. L’incidente non<br />
ha conseguenze per Roma; Romolo non si affligge troppo per l’accaduto, e torna a regnare da solo<br />
(1,14,1-3).
Letteratura latina B a.a. 2008-2009 mod. 2. Appunti delle lezioni 50<br />
arceo, termine tecnico del linguaggio sacrale 60, il chiasmo in deme terrorem ...fugamque<br />
foedam (con allitterazione) siste; l’aggettivo praesens (praesenti ope), che riferito ad una<br />
<strong>di</strong>vinità o al suo aiuto in<strong>di</strong>ca un intervento sia pronto sia efficace.<br />
Come per il tempio <strong>di</strong> Giove Feretrio, insieme alla promessa Romolo assegna un<br />
epiteto al <strong>di</strong>o connesso con la competenza che gli viene assegnata: stator, sostantivo che<br />
mostra la medesima ra<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> sisto. Il commento <strong>di</strong> <strong>Livio</strong> (la comparativa ipotetica veluti<br />
si sensisset) è un po’ scettico; ma l’effetto psicologico delle parole <strong>di</strong> Romolo sui soldati è<br />
reale: lo storico lo sottolinea con la ripresa del medesimo verbo: resistere ...iubet.<br />
Restitere<br />
Terminata la descrizione della battaglia dal punto <strong>di</strong> vista romano<br />
(<strong>di</strong>sorientamento, fuga, rapida ripresa), il narratore, come si è detto, fa un passo in<strong>di</strong>etro,<br />
e torna a descriverla dal punto <strong>di</strong> vista dei S<strong>ab</strong>ini. Le parole attribuite a Mezio<br />
corrispondono alla preghiera <strong>di</strong> Romolo, e nel medesimo tempo creano con essa un<br />
contrasto: troppo presto il condottiero s<strong>ab</strong>ino crede <strong>di</strong> avere ormai vinto, e usa un<br />
linguaggio tracotante. Da notare la paronomasia hospites-hostes; il parallelismo nella<br />
prima parte del periodo (agg. sost., con gli aggettivi che sono in contrasto con i sostantivi)<br />
e il chiasmo nella seconda (oggetto verbo – verbo complemento). Proprio da questo<br />
momento invece i S<strong>ab</strong>ini vengono respinti.<br />
La descrizione della battaglia si chiude, provvisoriamente, con la “peripezia” <strong>di</strong><br />
Mezio: trascinato dal cavallo nella palude – incidente che <strong>di</strong>stoglie i suoi dal<br />
combattimento61 – sembra perduto, e la situazione si fa <strong>di</strong>sperata per i S<strong>ab</strong>ini; ma il<br />
generale riesce a salvarsi, e il combattimento riprende: sed res Romana erat superior.<br />
L’imperfetto erat in<strong>di</strong>ca che il combattimento è ben lontano dall’essere concluso, quando<br />
si verifica l’evento inatteso.<br />
Questo è naturalmente l’improvviso e imprevisto irrompere delle donne s<strong>ab</strong>ine<br />
nella battaglia. Con indubbia efficacia drammatica, questa “peripezia” è collocata nel<br />
momento in cui il combattimento è ripreso con nuovo vigore, e in con<strong>di</strong>zioni quasi <strong>di</strong><br />
parità: entrambi gli eserciti sono ora nella pianura; l’esito finale dello scontro è ancora<br />
incerto, anche se <strong>Livio</strong> non rinuncia a dare ai Romani un lieve vantaggio. Le donne<br />
intervengono ora per imporre la pace, non per chiedere clemenza per i vinti, come Ersilia<br />
in 11,2.<br />
60<br />
Propriamente impiegato per in<strong>di</strong>care la necessaria esclusione dei profani da un luogo consacrato,<br />
o in cui si sta celebrando un rito.<br />
61<br />
Va rilevato che il piuccheperfetto averterat non è impiegato per riportare la descrizione ad un<br />
momento precedente (come invece decucurrerat ed egerat a 12,8), ma ha valore aspettuale (azione<br />
conchiusa): in<strong>di</strong>ca cioè la rapi<strong>di</strong>tà del processo verbale, presentandolo come già compiuto. Mezio<br />
cade nella palude, ed ecco che i suoi (prima quelli che gli stanno intorno, e poi tutti gli altri) sono<br />
già <strong>di</strong>stolti dal combattere, e seguono con trepidazione, e con le manifestazioni tipiche (gesti, grida,<br />
favor) degli spettatori ai giochi del circo, il suo tentativo <strong>di</strong> uscire dalla palude.
Letteratura latina B a.a. 2008-2009 mod. 2. Appunti delle lezioni 51<br />
L’episo<strong>di</strong>o conclusivo è messo in scena da <strong>Livio</strong> con mezzi stilistici adeguati al<br />
rilievo che intende conferirgli. L’intera descrizione dell’intervento delle S<strong>ab</strong>ine è racchiusa<br />
in un unico periodo <strong>di</strong> notevole ampiezza, privo <strong>di</strong> pause marcate, retto da un unico<br />
verbo principale ripetuto 62 , l’infinito storico <strong>di</strong>rimere...<strong>di</strong>rimere, posposto a numerosi<br />
elementi subor<strong>di</strong>nati. Il narratore apre il periodo con la presentazione del soggettoprotagonista<br />
(con la funzione quasi <strong>di</strong> un titolo), S<strong>ab</strong>inae mulieres, e ritarda il pre<strong>di</strong>cato,<br />
un espe<strong>di</strong>ente dei più comuni, mirante ad accrescere la tensione nel lettore, che fino a<br />
<strong>di</strong>rimere non sa ancora a che cosa miri o che cosa ottenga il comportamento insolito e<br />
temerario delle S<strong>ab</strong>ine. <strong>Gli</strong> elementi interposti sono:<br />
a) la relativa quarum ex iniuria bellum ortum erat, che in tono pacato e oggettivo richiama<br />
l’origine della guerra; questo stesso fatto (l’iniuria patita) nel brano in <strong>di</strong>scorso <strong>di</strong>retto<br />
<strong>di</strong>venta un patetico atto d’accusa delle donne contro se stesse (nos causa belli)<br />
b) la descrizione del loro aspetto, crinibus passis scissaque veste. Non si tratta <strong>di</strong> un<br />
elemento puramente esornativo, esso al contrario mette in rilievo un ben determinato<br />
stato d’animo; i capelli sciolti sono infatti un segno esteriore <strong>di</strong> agitazione e <strong>di</strong> dolore, e in<br />
particolare denotano un atteggiamento <strong>di</strong> supplica 63 ; le vesti strappate sono la<br />
manifestazione del lutto. L’uno e l’altro inoltre sono atteggiamenti tipicamente femminili.<br />
c) l’<strong>ab</strong>l. ass. victo pavore. Con il termine pavor, più descrittivo <strong>di</strong> timor, in quanto in<strong>di</strong>ca<br />
propriamente il tremare, la manifestazione esteriore e visibile della paura, l’autore non si<br />
riferisce alla paura della battaglia in corso, ma ad una caratteristica propria dell’essere<br />
femminile, la cui indole è naturalmente paurosa.<br />
d) il part. congiunto ausae: accostato <strong>di</strong>rettamente a pavore per accentuare il contrasto,<br />
ne <strong>di</strong>pende l’infinitiva se inferre, locuzione tipicamente militare, che, insieme alla<br />
sequenza <strong>di</strong> ritmo epico īntēr tēlă vǒlāntĭă, mette in rilievo quanto sia inconsueto e<br />
stupefacente il comportamento <strong>di</strong> queste donne.<br />
e) l’<strong>ab</strong>l. ass. impetu facto (altra espressione del lessico militare): completa la descrizione,<br />
in<strong>di</strong>cando il modo in cui le donne improvvisamente entrano nel campo <strong>di</strong> battaglia.<br />
La principale ripetuta <strong>di</strong>rimere presenta, per la prima volta dall’inizio dell’episo<strong>di</strong>o<br />
della battaglia fra Romani e S<strong>ab</strong>ini, l’infinito storico (o descrittivo o narrativo64). In latino<br />
esso è frequentemente impiegato per introdurre un elemento nuovo, violento o inatteso<br />
nella rappresentazione <strong>di</strong> un fatto, e conferisce alla descrizione un carattere <strong>di</strong> vivacità,<br />
62<br />
Il periodo ammette due interpretazioni sintattiche (v. note alla traduzione): qui si considera solo<br />
quella che pare più prob<strong>ab</strong>ile.<br />
63<br />
V. per es. Virgilio, Aen. 1,479-480: Interea ad templum non aequae Palla<strong>di</strong>s ibant / crinibus<br />
Iliades passis peplumque ferebant ; v. anche 2,404.<br />
64<br />
Si tratta <strong>di</strong> un uso latino originale, che non ha equivalenti in greco; sfruttando il valore<br />
nominale dell’infinito, esso presenta il processo verbale in sé, come pura durata, prescindendo da<br />
ogni altra determinazione grammaticale (tempo, modo, persona). Si presta particolarmente ad<br />
essere usato in serie.
Letteratura latina B a.a. 2008-2009 mod. 2. Appunti delle lezioni 52<br />
imme<strong>di</strong>atezza, drammaticità maggiori <strong>di</strong> quelli espressi dal perfetto, o anche<br />
dall’imperfetto o dal presente storico. A <strong>di</strong>rimere è legato il part. orantes, da cui<br />
<strong>di</strong>pendono le due completive ne...respergerent e ne...macularent che espongono il<br />
contenuto della preghiera, e le conseguenze che la guerra avrà per i contendenti e i loro<br />
<strong>di</strong>scendenti comuni. Alle donne stesse è riservata in questa sezione solo una menzione<br />
in<strong>di</strong>retta, anche se molto commossa e patetica, nelle parole partus suos. Le conseguenze<br />
della guerra in relazione alle donne chiudono invece la sezione in <strong>di</strong>scorso <strong>di</strong>retto (viduae<br />
aut orbae). L’argomento su cui si fonda la preghiera è la parentela ormai instauratasi tra<br />
i due popoli, tra i quali dunque la guerra è sacrilega. Il parrici<strong>di</strong>um evocato dalle donne è<br />
propriamente l’uccisione <strong>di</strong> un parente prossimo, soprattutto <strong>di</strong> un consanguineo: fra<br />
coloro che si combattono non esiste nessun legame <strong>di</strong> sangue, ma il termine viene<br />
impiegato perché qui si fa riferimento ai <strong>di</strong>scendenti, consanguinei degli uni e degli altri.<br />
Senza alcun verbo introduttivo – proce<strong>di</strong>mento spesso impiegato da <strong>Livio</strong> per<br />
segnare il culmine emotivo <strong>di</strong> un episo<strong>di</strong>o – si passa infine ad una breve sezione in<br />
<strong>di</strong>scorso <strong>di</strong>retto, cui è affidata la mozione degli affetti: <strong>di</strong>chiarandosi <strong>di</strong>sposte a subire<br />
esse sole, le uniche in realtà non colpevoli <strong>di</strong> nulla, tutte le conseguenze della guerra, le<br />
donne fanno appello all’affetto che lega a loro sia i padri sia i mariti. Non vi è più alcuna<br />
menzione dei figli, e l’attenzione è concentrata <strong>di</strong> nuovo, come all’inizio dell’episo<strong>di</strong>o, sulle<br />
S<strong>ab</strong>inae mulieres.<br />
Un proce<strong>di</strong>mento stilistico evidente infine, impiegato con insistenza in tutto il<br />
brano, è l’anafora: <strong>di</strong>rimere...<strong>di</strong>rimere; hinc...hinc (con il valore <strong>di</strong> hinc...illinc); ne...ne;<br />
si...si; nos...nos.<br />
Molto efficace – e caro a <strong>Livio</strong>, che lo impiega molto spesso per sottolineare il<br />
culmine drammatico <strong>di</strong> un episo<strong>di</strong>o – è il silenzio che segue alla preghiera, e crea un<br />
momento <strong>di</strong> sospensione e pausa prima della felice conclusione della vicenda.<br />
<strong>Gli</strong> effetti pratici e politici della pace ottenuta dalle donne sono esposti in uno stile<br />
conciso, con frasi brevi e scarne, che contrastano notevolmente con l’impegno stilistico<br />
profuso dal narratore nei paragrafi precedenti.
Letteratura latina B a.a. 2008-2009 mod. 2. Appunti delle lezioni 53<br />
MARCO FURIO CAMILLO<br />
Il personaggio <strong>di</strong> Camillo è la figura <strong>di</strong> maggior spicco nella prima decade: <strong>Livio</strong> lo<br />
caratterizza in primo luogo come estremamente rispettoso degli dèi, e delle<br />
manifestazioni (presagi, pro<strong>di</strong>gi) della loro volontà (<strong>di</strong>ligentissimus religionum cultor è<br />
definito in 5,50,1); egli è, soprattutto, il fatalis dux ad exci<strong>di</strong>um illius urbis servandaeque<br />
patriae (5,19,2), predestinato a <strong>di</strong>struggere la città nemica <strong>di</strong> Veio e a salvare la patria:<br />
l’allusione rinvia, in particolar modo, alla vittoria sui Galli, e alla ferma opposizione, alla<br />
fine vincente, ai progetti <strong>di</strong> <strong>ab</strong>bandonare Roma, incen<strong>di</strong>ata e <strong>di</strong>strutta dai Galli, per<br />
trasferire tutta la popolazione in massa a Veio; ma anche alle molte altre vittorie contro i<br />
nemici <strong>di</strong> Roma, narrate nel libro VI. Come generale, Camillo ha tutte le doti necessarie:<br />
ripristina con severità la <strong>di</strong>sciplina militare fra i soldati impegnati nell’asse<strong>di</strong>o <strong>di</strong> Veio; è<br />
dotato <strong>di</strong> prudentia (ratio, consilium), <strong>di</strong> fides65, <strong>di</strong> fortuna. Ma ha anche dei nemici, nei<br />
tribuni della plebe, che sobillano sia il popolo sia i soldati contro <strong>di</strong> lui. Dopo la<br />
conquista <strong>di</strong> Veio, e del suo immenso bottino, è costretto ad andare in esilio, con l’accusa,<br />
o il pretesto, <strong>di</strong> una ingiusta sud<strong>di</strong>visione della preda catturata a Veio. Così lo storico<br />
commenta il suo forzato allontanamento da Roma: Expulso cive quo manente, si quicquam<br />
humanorum certi est, capi Roma non potuerat, adventante fatali urbi clade legati <strong>ab</strong><br />
Clusinis veniunt auxilium adversus Gallos petentes (5,33,1), “dopo che da Roma era stato<br />
scacciato il citta<strong>di</strong>no presente il quale, se c’è qualcosa <strong>di</strong> certo nelle cose umane, Roma<br />
non avrebbe potuto essere conquistata, mentre la rovina decretata dal fato si stava<br />
avvicinando alla città, giunsero da Chiusi ambasciatori a chiedere aiuto contro i Galli”.<br />
Segue il racconto della colpa dei legati romani66, e dei molteplici errori che condurranno<br />
alla sconfitta dell’Allia e alla conquista <strong>di</strong> Roma da parte dei Galli. Camillo si trova in<br />
esilio ad Ardea, e quando una schiera <strong>di</strong> Galli attacca la città, gli Ardeati si affidano a<br />
Camillo, che ottiene uno splen<strong>di</strong>do successo. I Romani intanto, a Veio, si organizzano per<br />
riconquistare la loro città, e decidono <strong>di</strong> richiamare da Ardea Camillo, perché quello era il<br />
capo che mancava loro, il solo in grado <strong>di</strong> guidare le forze raccolte contro i Galli.<br />
Nominato <strong>di</strong>ttatore in assenza, Camillo viene condotto a Veio, organizza le truppe, cui si<br />
aggiungono reparti <strong>di</strong> Ardeati, e accorre a salvare i Romani dall’indegno riscatto che<br />
stavano trattando con i Galli. Sconfitti e messi in fuga i nemici, Camillo salva una<br />
seconda volta la città, impedendo che venga <strong>ab</strong>bandonata: <strong>Livio</strong> el<strong>ab</strong>ora per il suo<br />
personaggio un ampio, appassionato <strong>di</strong>scorso (5,51-54) contro l’empio progetto. La città<br />
viene ricostruita in pochissimo tempo.<br />
65<br />
Esemplarmente illustrata nell’episo<strong>di</strong>o del maestro <strong>di</strong> Faleri, in 5,27 (v. testi)<br />
66<br />
V. sopra, pp. 17-18
Letteratura latina B a.a. 2008-2009 mod. 2. Appunti delle lezioni 54<br />
Asse<strong>di</strong>o e resa <strong>di</strong> Faleri (5,26,9-27)<br />
<strong>Gli</strong> episo<strong>di</strong> proposti dal libro V 67 hanno entrambi come protagonista il personaggio <strong>di</strong><br />
Camillo. Il primo (conquista <strong>di</strong> Faleri) si colloca poco dopo l’espugnazione <strong>di</strong> Veio, e la<br />
capitolazione, senza combattimenti, <strong>di</strong> Capena. Nel 394 Camillo viene eletto tribunus<br />
militum consulari potestate, grazie all’appoggio dei patrizi, che vedono in lui, non a torto,<br />
un oppositore deciso e sicuro alle iniziative dei tribuni della plebe. Ufficialmente però a<br />
Camillo viene affidata la guerra contro Faleri, e in attesa che egli parta per questa guerra<br />
i tribuni della plebe rimangono tranquilli.<br />
Dopo aver ricacciato i Falisci che hanno attaccato l’accampamento romano,<br />
Camillo cinge d’asse<strong>di</strong>o la città, un asse<strong>di</strong>o che si prospetta lungo e <strong>di</strong>fficile, come <strong>Livio</strong><br />
ha cura <strong>di</strong> illustrare. Il raccontino sul maestro tra<strong>di</strong>tore, narrato da molti altri autori<br />
antichi, è un exemplum, che illustra il comportamento corretto in guerra, quello che –<br />
nella visione idealizzata <strong>di</strong> <strong>Livio</strong> – è proprio in generale dei Romani. L’episo<strong>di</strong>o ha il<br />
medesimo significato <strong>di</strong> quello, altrettanto o forse più famoso, del console F<strong>ab</strong>rizio e del<br />
me<strong>di</strong>co <strong>di</strong> Pirro, che certamente anche <strong>Livio</strong> narrava, nella prima decade (perduta) della<br />
sua opera. Il valore esemplare della vicenda viene in<strong>di</strong>cato esplicitamente dallo storico<br />
nella parte conclusiva del cap. 5,26 (§§ 9-10), che funge da introduzione al racconto.<br />
Questo, che occupa l’intero cap. 27, come per lo più avviene in <strong>Livio</strong>, non è interrotto né<br />
<strong>di</strong>sturbato da commenti del narratore, che lascia che siano i personaggi ad illustrare – in<br />
modo assai chiaro ed esauriente – la morale dell’episo<strong>di</strong>o. Lo scrittore anticipa, in queste<br />
frasi introduttive, l’esito della vicenda (la rapida vittoria del generale romano), ma il modo<br />
in cui egli giunse a tale felice conclusione si rivela solo nel corso del racconto.<br />
L’introduzione dello storico accenna solo, in termini generali, alla virtus rebus bellicis<br />
cognita <strong>di</strong> Camillo: si tratta, certo non a caso, <strong>di</strong> una in<strong>di</strong>cazione un poco fuorviante per<br />
il lettore, che certo si attende una impresa militare straor<strong>di</strong>naria, come quella che portò<br />
alla conquista <strong>di</strong> Veio, ma molto più rapida <strong>di</strong> quella. Il racconto che segue invece illustra<br />
un aspetto nuovo e ancora ine<strong>di</strong>to della virtus <strong>di</strong> Camillo, la lealtà nella condotta <strong>di</strong><br />
guerra.<br />
La storia si apre con l’antefatto, una spiegazione necessaria per la piena<br />
comprensione del successivo svolgimento della vicenda; l’esposizione comprende brevi<br />
brani in <strong>di</strong>scorso in<strong>di</strong>retto (l’indegna proposta del maestro) e in <strong>di</strong>scorso <strong>di</strong>retto (la<br />
risposta <strong>di</strong> Camillo e le parole degli ambasciatori <strong>di</strong> Faleri al senato romano). Con il<br />
67 Il quinto libro contiene la narrazione degli anni 403-390: la guerra contro Veio, iniziata nel 405,<br />
si conclude, dopo <strong>di</strong>eci anni <strong>di</strong> asse<strong>di</strong>o, nel 395, grazie al <strong>di</strong>ttatore Marco Furio Camillo, che la<br />
espugna operibus, non vi (5,22,8): <strong>Livio</strong> si riferisce con queste parole alla galleria (cuniculus) che<br />
Camillo fa scavare in segreto, e permette ai soldati <strong>di</strong> sbucare <strong>di</strong>rettamente sulla rocca della città,<br />
mentre gli asse<strong>di</strong>anti la attaccano da ogni parte.
Letteratura latina B a.a. 2008-2009 mod. 2. Appunti delle lezioni 55<br />
<strong>di</strong>scorso degli ambasciatori in senato (§14) l’episo<strong>di</strong>o è concluso. L’ultimo paragrafo<br />
registra rapidamente, in stile semplice e conciso, le conseguenze pratiche della resa <strong>di</strong><br />
Faleri.<br />
L’intero episo<strong>di</strong>o è certamente leggendario: in realtà i rapporti fra Roma e Faleri<br />
non furono in seguito così armoniosi e pacifici come indurrebbe a credere la storiella, e in<br />
particolare la solenne <strong>di</strong>chiarazione finale degli ambasciatori. I fatti successivi, registrati<br />
da <strong>Livio</strong> stesso, <strong>di</strong>mostrano che prob<strong>ab</strong>ilmente sia i Falisci ebbero a lamentarsi del<br />
dominio romano sia i Romani della lealtà dei Falisci. O piuttosto, ottenuta la vittoria in<br />
quell’occasione grazie al comportamento corretto e leale <strong>di</strong> Camillo, i Romani non<br />
imposero il loro dominio alla città <strong>di</strong> Faleri, che non rinunciò alla sua autonomia: il solo<br />
risultato pratico sarà stato verosimilmente il pagamento <strong>di</strong> una indennità <strong>di</strong> guerra (cui<br />
<strong>Livio</strong> allude brevemente nella conclusione del capitolo). Non solo infatti, pochi anni dopo<br />
questo episo<strong>di</strong>o, nel 357, Roma è <strong>di</strong> nuovo in guerra con i Falisci, ma ancora nel 293, un<br />
secolo più tar<strong>di</strong>, i Falisci sono schierati al fianco degli Etruschi contro Roma: fatti riferiti<br />
da <strong>Livio</strong> stesso (in 7,16-22 e 10,45s.): la città poté ancora opporre le sue armi a Roma, e<br />
ciò smentisce la notizia della sua sottomissione definitiva.<br />
Il contrasto, che <strong>Livio</strong> non spiega, <strong>di</strong>pende dalla <strong>di</strong>fficoltà per lo storico <strong>di</strong><br />
concepire un tipo <strong>di</strong> guerra <strong>di</strong>verso da quello ormai consueto per Roma da alcuni secoli<br />
quando <strong>Livio</strong> scrive: la guerra <strong>di</strong> conquista, che ha come scopo l’annessione del territorio<br />
del vinto, l’annullamento della sua in<strong>di</strong>vidualità e in<strong>di</strong>pendenza, attraverso l’imposizione<br />
delle leggi del vincitore, e <strong>di</strong> un tributo st<strong>ab</strong>ile.<br />
Nei secoli più antichi le guerre dovevano essere semplici scorrerie, scontri con<br />
popoli confinanti <strong>di</strong> portata assai limitata, nel tempo, nello spazio e negli scopi. Si<br />
trattava ad esempio <strong>di</strong> decidere con le armi il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> accesso a fonti o a pascoli, o <strong>di</strong><br />
recuperare il maltolto (greggi o raccolti razziati): questi conflitti non mettevano in<br />
<strong>di</strong>scussione né l’esistenza delle comunità coinvolte né la loro in<strong>di</strong>pendenza. Nell’età regia<br />
e nei primi due secoli almeno della repubblica la guerra era una sorta <strong>di</strong> competizione tra<br />
pari, che obbe<strong>di</strong>va a regole precise, non imposte unilateralmente da Roma, ma accettate<br />
e con<strong>di</strong>vise da popoli partecipi della medesima cultura religiosa e politica (Latini, S<strong>ab</strong>ini,<br />
Sanniti, Falisci ecc.). In quest’epoca il bellum iustum et pium era considerato quello<br />
indetto e <strong>di</strong>chiarato secondo il cerimoniale dei Feziali, solo dopo che il nemico avesse<br />
opposto un rifiuto alla legittima richiesta <strong>di</strong> sod<strong>di</strong>sfazione, e dopo che l’assemblea<br />
popolare avesse votato per la guerra. Questa procedura rituale e piuttosto complessa è<br />
descritta da <strong>Livio</strong> in 1,32, e fu mantenuta in vigore, in modo simbolico, per un certo<br />
tempo, anche dopo che natura e scopi della guerra erano profondamente mutati. A<br />
partire dalla fine del IV secolo, con la <strong>di</strong>ssoluzione della lega latina, a poco a poco la<br />
guerra <strong>di</strong>venta per Roma il mezzo per espandersi territorialmente, assoggettando
Letteratura latina B a.a. 2008-2009 mod. 2. Appunti delle lezioni 56<br />
politicamente i popoli vinti. Parallelamente si el<strong>ab</strong>orano giustificazioni teoriche (sostenute<br />
anche da dottrine filosofiche greche) per <strong>di</strong>mostrare il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> Roma <strong>di</strong> imporre le sue<br />
leggi al mondo intero: accanto alla guerra <strong>di</strong>fensiva e preventiva, per respingere attacchi<br />
e scongiurare pericoli, sono considerate giuste la guerra pro sociis e quella de imperio (per<br />
<strong>di</strong>fendere gli alleati e per affermare e conservare la supremazia raggiunta). Soprattutto<br />
per legittimare quest’ultimo tipo <strong>di</strong> guerra si ricorre all’esaltazione dei numerosi benefici<br />
<strong>di</strong> cui godono i popoli sottomessi all’imperium <strong>di</strong> Roma (civiltà, benessere, pace, giustizia<br />
ecc.), un imperium che va considerato, secondo la nota formulazione ciceroniana, non<br />
dominio ma “protettorato del mondo” (patrocinium orbis terrae, de off. 2,27) 68.<br />
Camillo e i Galli (5,47-49)<br />
Il personaggio <strong>di</strong> Camillo riconferma le sue doti, già ampiamente <strong>di</strong>mostrate nelle<br />
imprese precedenti, con il suo intervento in extremis nella vicenda forse più famosa della<br />
storia romana arcaica. Vicenda che <strong>Livio</strong> el<strong>ab</strong>ora accuratamente, inserendovi anche<br />
leggende, motivi offerti dalla tra<strong>di</strong>zione, notazioni eru<strong>di</strong>te, in un tutto unitario e<br />
altamente drammatico.<br />
Mentre Camillo è in esilio ad Ardea, maestior fortuna publica quam sua (5,43,7),<br />
pochi superstiti della sconfitta dell’Allia tornano a Roma, la maggior parte si <strong>di</strong>rige a Veio.<br />
Comprendendo che la città non può essere <strong>di</strong>fesa con forze così scarse, si decide che gli<br />
uomini vali<strong>di</strong> si ritirino in Campidoglio con le scorte <strong>di</strong> viveri <strong>di</strong>sponibili, che le Vestali e<br />
gli oggetti sacri siano messi in salvo fuori <strong>di</strong> Roma, e che si <strong>ab</strong>bandonino al loro destino,<br />
con il loro consenso e anzi il loro incoraggiamento, i vecchi, che si votano alla morte, con<br />
la cerimonia della devotio, per la salvezza della patria. I Galli entrano nella città quasi<br />
deserta, uccidono i vecchi, saccheggiano e danno alle fiamme le case. Dopo un tentativo<br />
fallito <strong>di</strong> conquistare con un assalto la rocca, i Galli sud<strong>di</strong>vidono le loro forze: una parte<br />
inizia l’asse<strong>di</strong>o del Campidoglio, l’altra è inviata a fare razzie nei campi. Contro questa<br />
parte dell’esercito nemico Camillo ottiene uno splen<strong>di</strong>do successo.<br />
I Romani che si erano rifugiati a Veio capiscono che occorre affidarsi <strong>di</strong> nuovo a<br />
Camillo; dopo una non facile consultazione del senato (che si trovava a Roma sul<br />
Campidoglio), Camillo viene nominato <strong>di</strong>ttatore in <strong>ab</strong>sentia.<br />
A Roma intanto prosegue l’asse<strong>di</strong>o. La prima “peripezia” è quella famosa che vede<br />
protagonisti a pari merito Marco Manlio (detto poi Capitolino) e le oche sacre. Il tentativo<br />
dei Galli <strong>di</strong> cogliere <strong>di</strong> sorpresa gli asse<strong>di</strong>ati, scalando <strong>di</strong> notte la rocca, fallisce: le oche<br />
danno l’allarme, i Romani reagiscono spronati da Manlio, la rocca è salva. (5,47) Ma la<br />
fame alla fine sta per sconfiggere i valorosi <strong>di</strong>fensori della rocca, anche se sembra che<br />
68 Si veda, per una trattazione un poco più ampia <strong>di</strong> questo tema, la scheda La guerra giusta e<br />
l’imperialismo romano, in Garbarino, pp. 276-277.
Letteratura latina B a.a. 2008-2009 mod. 2. Appunti delle lezioni 57<br />
siano i Galli a patire i <strong>di</strong>sagi peggiori (5,48,2-3). Si st<strong>ab</strong>ilisce una tregua, ma senza<br />
risultati: i Galli non se ne vanno e i Romani non si arrendono. In questo intervallo è<br />
collocata la notizia, tipica dei racconti <strong>di</strong> asse<strong>di</strong>o, del pane gettato dalle mura per far<br />
credere agli asse<strong>di</strong>anti che gli asse<strong>di</strong>ati hanno viveri per resistere ancora a lungo. La<br />
seconda “peripezia”, famosissima questa, conduce i Romani alla resa e quasi all’onta del<br />
riscatto: conferisce drammaticità al racconto la contemporaneità degli alacri preparativi<br />
<strong>di</strong> Camillo e della per<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> forze e <strong>di</strong> speranza degli asse<strong>di</strong>ati (con la nota patetica dei<br />
soldati che quasi stramazzano per la debolezza sotto il peso delle armi), e, soprattutto,<br />
l’arrivo <strong>di</strong> Camillo all’ultimo momento utile per capovolgere la situazione. Il tono dello<br />
scrittore si fa a questo punto commosso, enfatico e solenne: “a mille libbre d’oro fu<br />
fissato il prezzo del popolo che presto doveva dominare tutto il mondo” (5,48,8); e ancora:<br />
“Ma dèi e uomini impe<strong>di</strong>rono che i Romani vivessero da riscattati” (5,49,1). L’intervento<br />
<strong>di</strong>vino si scorge nella tempestività dell’arrivo <strong>di</strong> Camillo (forte quadam...<strong>di</strong>ctator intervenit);<br />
gli uomini fanno il resto, infliggendo due sconfitte in rapida successione ai Galli.<br />
Il personaggio <strong>di</strong> Camillo in questo episo<strong>di</strong>o è veramente il fatalis dux cui sono<br />
legate le sorti <strong>di</strong> Roma; ma è anche il nemico corretto e leale che già i lettori conoscono<br />
dall’episo<strong>di</strong>o del maestro <strong>di</strong> Faleri. Invece infatti <strong>di</strong> assalire senz’altro i Galli intenti a<br />
pesare l’oro e a litigare con il tribuno Sulpicio, si sofferma a spiegare perché il patto non<br />
è valido: “Per un caso fortunato, prima che lo scellerato pagamento si concludesse, non<br />
essendo stato ancora pesato tutto l’oro per via del litigio, sopraggiunge il <strong>di</strong>ttatore e<br />
or<strong>di</strong>na che l’oro sia tolto <strong>di</strong> mezzo e i Galli si allontanino”. Un atteggiamento deciso, un<br />
secco or<strong>di</strong>ne (iubet) rivolto a Romani e Galli senza <strong>di</strong>stinzione, ma nessuna aggressione.<br />
Anzi, Camillo si preoccupa <strong>di</strong> illustrare la situazione ai nemici: “Poichè quelli,<br />
protestando, <strong>di</strong>cevano <strong>di</strong> aver fatto un patto, <strong>di</strong>chiara che quel patto non è valido, perché<br />
è stato stipulato dopo la sua nomina a <strong>di</strong>ttatore, senza suo or<strong>di</strong>ne, da un magistrato <strong>di</strong><br />
grado inferiore”. Ragionamento perfettamente valido: il <strong>di</strong>ttatore è dotato <strong>di</strong> imperium<br />
superiore a quello <strong>di</strong> ogni altro magistrato, dunque ogni decisione presa iniussu suo è<br />
nulla. Solo dopo aver spiegato ai Galli il suo <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> riprendere le ostilità, si pre<strong>di</strong>spone<br />
alla battaglia. Anche questo con or<strong>di</strong>ne e con rispetto delle regole; infatti “intima ai Galli<br />
<strong>di</strong> prepararsi alla battaglia”, dà cioè modo al nemico <strong>di</strong> armarsi e provvedere allo<br />
schieramento delle truppe. Quin<strong>di</strong> prepara anche i suoi, non senza una breve allocuzione<br />
per richiamarli al comportamento che solo si ad<strong>di</strong>ce ai Romani, e per infondere loro<br />
coraggio: “Or<strong>di</strong>na ai suoi <strong>di</strong> radunare in un mucchio i bagagli e <strong>di</strong> preparare le armi, e <strong>di</strong><br />
riconquistare la patria con il ferro e non con l’oro, avendo davanti agli occhi i templi degli<br />
dèi, le spose, i figli e il suolo della patria sfigurato dai mali della guerra e tutto ciò che è<br />
sacro dovere <strong>di</strong>fendere, riconquistare e ven<strong>di</strong>care” (da notare la climax). Quin<strong>di</strong> lo<br />
schieramento delle truppe: “Schiera quin<strong>di</strong> l’esercito, come lo consentiva la natura del
Letteratura latina B a.a. 2008-2009 mod. 2. Appunti delle lezioni 58<br />
luogo, sul terreno della città semi<strong>di</strong>strutta, naturalmente accidentato, e provvide a tutto<br />
ciò che, grazie alla sua perizia bellica, si poteva scegliere e preparare a favore dei suoi”.<br />
Molto più breve <strong>di</strong> tutti i preamboli è lo svolgimento dello scontro: “I Galli, agitati per quel<br />
fatto inatteso, afferrano le armi e si gettano sui Romani con ira più che con ponderazione.<br />
Già la fortuna era mutata, già l’aiuto <strong>di</strong>vino e le decisioni umane favorivano la parte<br />
romana. E dunque al primo assalto i Galli furono sbaragliati, con la medesima facilità<br />
con cui all’Allia avevano vinto”. La menzione della precedente vittoria dei Galli non ha<br />
solo la funzione <strong>di</strong> illustrare la facilità con cui i Romani ebbero la meglio, mira<br />
soprattutto a mostrare che l’onta <strong>di</strong> quella battaglia è stata riscattata. Segue un secondo<br />
combattimento “più regolare”, sotto la guida e gli auspici <strong>di</strong> Camillo, che si conclude con<br />
una strage completa, tanto che non resta nemmeno chi possa portare agli altri Galli la<br />
notizia della sconfitta.<br />
Un ultimo particolare completa il ritratto <strong>di</strong> Camillo: conclusa nel migliore dei<br />
mo<strong>di</strong> (con il trionfo in cui gli fu assegnato dai soldati l’appellativo onorifico <strong>di</strong> parens<br />
patriae, e anche <strong>di</strong> Romolo e <strong>di</strong> secondo fondatore) l’impresa per la quale era stato<br />
nominato <strong>di</strong>ttatore, avrebbe dovuto secondo le leggi romane deporre la carica. Se non lo<br />
fece, si preoccupa <strong>di</strong> rilevare lo storico, fu per le insistenti preghiere del senato: c’è<br />
ancora bisogno <strong>di</strong> lui, per sventare il pericolo che i citta<strong>di</strong>ni <strong>ab</strong>bandonino Roma. E anche<br />
in questo nuovo, <strong>di</strong>fficile incarico, Camillo ottiene il successo.<br />
NOVA AC NIMIS CALLIDA SAPIENTIA (42,47)<br />
Con il procedere della storia <strong>di</strong> Roma, i meto<strong>di</strong> della guerra cambiano. <strong>Livio</strong> lo<br />
rileva in un passo molto significativo <strong>di</strong> uno degli ultimi <strong>libri</strong> conservati, che si presta<br />
anche ad essere accostato a quello in cui è descritta la riscossa vittoriosa <strong>di</strong> Camillo<br />
contro i Galli; è evidente che lo storico non ignora che questo mutamento era stato<br />
inevit<strong>ab</strong>ile, e tuttavia non rinuncia a manifestare, nel modo in<strong>di</strong>retto che gli è più<br />
consueto, il proprio giu<strong>di</strong>zio, e anche una evidente nostalgia per un’epoca in cui vigevano<br />
i valori e le virtù che avevano reso grande Roma.<br />
I Romani (siamo nel 171 a.C., alla vigilia della guerra contro Perseo <strong>di</strong> Macedonia)<br />
hanno già collocato in Grecia e in Epiro presi<strong>di</strong> e reparti armati, ma con Perseo ancora<br />
non c’è guerra aperta. Mentre avvengono scambi inconcludenti <strong>di</strong> ambascerie, sia i<br />
Romani sia Perseo si preparano in realtà alla guerra. I Romani però non sono ancora<br />
pronti; gli inviati Marcio e Atilio fanno credere a Perseo che Roma sia <strong>di</strong>sposta alla pace e<br />
al rinnovo dell’alleanza, e ottengono da lui una tregua ufficiale, per poter tornare a Roma<br />
in sicurezza. Giunti a Roma riferiscono il risultato della loro missione. <strong>Livio</strong> presenta
Letteratura latina B a.a. 2008-2009 mod. 2. Appunti delle lezioni 59<br />
l’episo<strong>di</strong>o con queste parole: “ Giunti a Roma, Marcio e Atilio riferirono in Campidoglio<br />
della loro missione: <strong>di</strong> nulla si vantarono più che <strong>di</strong> essere riusciti ad ingannare il re,<br />
ottenendone una tregua e facendogli balenare la speranza della pace” (42,47,1).<br />
Il primo risultato <strong>di</strong> cui gli inviati menano vanto è costituito dalle indutiae; come<br />
spiegano più chiaramente nel <strong>di</strong>scorso che segue, si tratta <strong>di</strong> un rinvio dell’inizio della<br />
guerra <strong>di</strong> vitale importanza per Roma, non <strong>di</strong> una vera tregua, come il re ha creduto. E<br />
questo è il primo inganno. Il secondo consiste nell’esser riusciti a convincere il re<br />
dell’autentica intenzione <strong>di</strong> Roma <strong>di</strong> mantenere o rist<strong>ab</strong>ilire con Perseo rapporti <strong>di</strong> pace.<br />
In forma <strong>di</strong> <strong>di</strong>scorso in<strong>di</strong>retto i due inviati illustrano le ragioni per cui ritengono <strong>di</strong><br />
aver compiuto una missione importante e utile per Roma (42,47,2-3), che in realtà non<br />
aveva mai avuto intenzione <strong>di</strong> rist<strong>ab</strong>ilire con Perseo rapporti <strong>di</strong> pace: durante le false<br />
indutiae pattuite con Perseo i Romani potranno prepararsi alla guerra; inoltre, l’aver<br />
gettato la <strong>di</strong>scor<strong>di</strong>a fra i membri della lega beotica ha tolto al nemico molti potenziali<br />
alleati. All’approvazione per l’operato dei legati espressa dalla maggioranza dei senatori si<br />
contrappone il biasimo espresso dai pochi moris antiqui memores. Le loro considerazioni,<br />
esposte anch’esse in forma <strong>di</strong> <strong>di</strong>scorso in<strong>di</strong>retto, illustrano compiutamente le Romanae<br />
artes nella condotta <strong>di</strong> guerra, che si possono compen<strong>di</strong>are nella regola della guerra<br />
<strong>di</strong>chiarata e lealmente combattuta in campo aperto, e nel rifiuto <strong>di</strong> ogni stratagemma,<br />
astuzia, inganno. Non mancano, nel <strong>di</strong>scorso dei seniores, la contrapposizione dei<br />
Romani con popoli, i Punici e i Greci, tra<strong>di</strong>zionalmente considerati infi<strong>di</strong> e sleali, né gli<br />
esempi classici della fides propria dei maiores (la denuncia del me<strong>di</strong>co <strong>di</strong> Pirro, la<br />
consegna del maestro <strong>di</strong> Faleri). A conclusione del <strong>di</strong>scorso dei seniores c’è la<br />
considerazione più significativa, quella che spesso accompagna, <strong>di</strong> solito espressa dai<br />
personaggi, episo<strong>di</strong> e<strong>di</strong>ficanti <strong>di</strong> questo genere: la lealtà in guerra ottiene anche risultati<br />
concreti vantaggiosi per chi vi si attiene.<br />
Nel racconto <strong>di</strong> <strong>Livio</strong> non sempre in realtà i maiores si comportano come sembrano<br />
credere questi senatori69; ma Camillo incarna perfettamente70 questo tipo <strong>di</strong> Romano<br />
antico. Nel brano conclusivo del passo de<strong>di</strong>cato alla sua rivincita contro i Galli egli, come<br />
si è visto, si preoccupa <strong>di</strong> spiegare la piena legittimità della ripresa delle ostilità (questo<br />
equivale a in<strong>di</strong>cere prius quam gerere bellum), e ad<strong>di</strong>rittura <strong>di</strong> denuntiare pugnam<br />
(denuntiatque Gallis ut se ad proelium expe<strong>di</strong>ant, 5,49,2)<br />
69 Ad esempio già un romano antichissimo, il re Tullo Ostilio, era ricorso all’astuzia e all’inganno<br />
per dar inizio alla guerra con Alba, come lo storico narra in 1,22.<br />
70 O quasi: Veio infatti, dopo il decennale asse<strong>di</strong>o, era stata conquistata operibus...non vi.<br />
Nell’epitafio che lo storico de<strong>di</strong>ca alla città si può scorgere forse un accenno <strong>di</strong> biasimo per il<br />
mezzo (il cuniculus) cui Camillo ricorse: Hic Veiorum occasus fuit, urbis opulentissimae Etrusci<br />
nominis, magnitu<strong>di</strong>nem suam vel ultima clade in<strong>di</strong>cantis, quod decem aestates hiemesque continuas<br />
circumsessa, cum plus aliquanto cla<strong>di</strong>um intulisset quam accepisset, postremo, iam fato quoque<br />
urgentce, operibus tamen, non vi expugnata est (5,22,8).
Letteratura latina B a.a. 2008-2009 mod. 2. Appunti delle lezioni 60<br />
Alle parole dei senatori nostalgici del mos maiorum in guerra <strong>Livio</strong> fa seguire il suo<br />
commento, realistico e un po’ sconsolato: vicit tamen ea pars senatus cui potior utilis<br />
quam honesti cura erat (42,47,9), e pertanto non solo il comportamento sleale del<br />
rappresentante <strong>di</strong> Roma invece che sanzionato viene approvato, ma gli viene confermata<br />
piena fiducia, per proseguire la sua precedente missione guidato dalla nova sapientia <strong>di</strong><br />
cui aveva dato prova.
Letteratura latina B a.a. 2008-2009 mod. 2. Appunti delle lezioni 61<br />
DUELLI<br />
Al motivo del duello fra campioni delle due parti in lotta <strong>Livio</strong> ricorre, nei <strong>libri</strong><br />
rimasti, sei volte 71: si tratta <strong>di</strong> un elemento atto a variare e soprattutto ad arricchire<br />
drammaticamente il resoconto <strong>di</strong> una guerra o <strong>di</strong> una campagna militare. Non si tratta<br />
naturalmente <strong>di</strong> episo<strong>di</strong> inventati da <strong>Livio</strong>: egli li trae certamente dalle sue fonti,<br />
arricchendoli però, prob<strong>ab</strong>ilmente, <strong>di</strong> un significato più vasto, come si può constatare in<br />
un caso, per il quale <strong>di</strong>sponiamo della fonte impiegata dallo storico.<br />
Il duello più antico e più famoso è quello fra gli Orazi e i Curiazi: nec ferme res<br />
antiqua alia est nobilior (1,24,1), <strong>di</strong>chiara <strong>Livio</strong> apprestandosi a descriverlo. In questo<br />
caso il duello è molto importante perché, per concorde decisione del capo albano, che<br />
avanza la proposta, e del re Tullo Ostilio, che la accetta, si decide <strong>di</strong> affidare al duello fra<br />
i campioni (tre per parte, un elemento che <strong>di</strong>stingue questo da tutti gli altri duelli) la<br />
decisione sull’esito della guerra, per st<strong>ab</strong>ilire utri utris imperent: il popolo i cui campioni<br />
si <strong>di</strong>mostreranno più valorosi acquisirà il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> dominare sull’altro, perché i campioni<br />
sono l’espressione delle virtù guerresche dell’intero popolo. La situazione richiama, ma<br />
solo superficialmente ed esteriormente, il famoso duello epico fra Paride e Menelao<br />
nell’Iliade, cui si vorrebbe affidare la definitiva soluzione della guerra; ma i combattenti<br />
in Omero sono gli eroi <strong>di</strong>rettamente interessati alla contesa, non i rappresentanti dei due<br />
popoli. In entrambi i casi lo scopo del duello non viene raggiunto, e la guerra riprende.<br />
Nessuno degli altri duelli descritti da <strong>Livio</strong> è preceduto, come nel caso degli Orazi e<br />
dei Curiazi, da un accordo preventivo ufficiale; ma lo storico li arricchisce <strong>di</strong> un analogo<br />
valore simbolico, poiché i combattenti incarnano le qualità (e i <strong>di</strong>fetti) dei rispettivi popoli.<br />
Tutti gli episo<strong>di</strong> <strong>di</strong> questo tipo hanno caratteristiche ricorrenti, anche se ciascuno ha<br />
naturalmente uno svolgimento suo proprio. Il primo elemento che li accomuna tutti è,<br />
<strong>ab</strong>bastanza preve<strong>di</strong>bilmente, la vittoria del campione romano; il secondo il fatto che la<br />
sfida è sempre lanciata dal nemico (salvo ovviamente che nel primo duello); il terzo è<br />
71 E cioè: 1,24-25 (Orazi e Curiazi); 7,9,8-10 (<strong>Tito</strong> Manlio Torquato e un Gallo); 7,26,1-10 (Marco<br />
Valerio Corvo e un Gallo); 8,7 (<strong>Tito</strong> Manlio il Giovane e Gèmino Mecio, comandante dei cavalieri <strong>di</strong><br />
Tuscolo, sconfitto e ucciso); 23,46,12-47 (Clau<strong>di</strong>o Asello e Cerrino Vibellio Taurea, cavaliere<br />
campano); 25,18 (<strong>Tito</strong> Quinzio Crispino e Ba<strong>di</strong>o, cavaliere campano). Questo elenco comprende<br />
soltanto i combattimenti extra or<strong>di</strong>nem, cioè quelli in cui due guerrieri si affrontano dopo un<br />
accordo preventivo – sempre, tranne che nel caso degli Orazi e Curiazi, la sfida lanciata da uno e<br />
accolta dall’altro - , in una pausa delle ostilità, e senza che altri intervengano; non gli scontri<br />
singoli nel corso <strong>di</strong> una battagliia, che sono più numerosi, ma hanno caratteristiche <strong>di</strong>verse (per<br />
es. 2,6 Arrunte e Bruto; 2,19-20 vari scontri singoli; 4,19 Cornelio Cosso e Tolumnio re dei Veienti;<br />
5,36 l’ambasciatore Quinto F<strong>ab</strong>io e il comandante dei Galli; 9,22 il magister equitum Aulio<br />
Cerretano e il generale dei Sanniti; 22,6 il cavaliere insubro Ducario e il console Flaminio, batt.<br />
del Trasimeno; ecc.). A tutti i combattimenti singoli è de<strong>di</strong>cato il libro <strong>di</strong> J.FRIES, Der Zweikampf.<br />
Historische und literarische Aspekte seiner Darstellung, Hain, 1985, che contiene molte<br />
interessanti considerazioni, ma non <strong>di</strong>stingue sufficientemente i “duelli” dagli scontri fra due<br />
guerrieri nel corso <strong>di</strong> una mischia.
Letteratura latina B a.a. 2008-2009 mod. 2. Appunti delle lezioni 62<br />
costituito dal comportamento <strong>di</strong>sciplinato del guerriero romano, che chiede al suo<br />
comandante il permesso <strong>di</strong> accogliere la sfida, salvo che in un solo caso (8,7). Questo<br />
episo<strong>di</strong>o però rende ancora più evidente il valore assoluto della <strong>di</strong>sciplina, riba<strong>di</strong>to dalla<br />
sua terribile conclusione: il guerriero romano vittorioso è condannato a morte, benché il<br />
comandante, il Manlio Torquato vincitore del Gallo, sia suo padre. Infine, il campione<br />
romano è sempre in<strong>di</strong>viduato con precisione, con l’in<strong>di</strong>cazione del suo nome, e in qualche<br />
caso con il richiamo a vicende precedenti ricordate dallo storico; dell’avversario invece<br />
non sempre è ricordato il nome: più precisamente, lo sfidante non ha nome nei due casi<br />
in cui si tratta <strong>di</strong> un Gallo, sufficientemente caratterizzato dall’etnico (i barbari sono<br />
evidentemente considerati una massa in<strong>di</strong>stinta <strong>di</strong> in<strong>di</strong>vidui tutti uguali). Anche la<br />
conclusione dei singoli duelli è <strong>di</strong>versa: fatta eccezione per l’impresa <strong>di</strong> Manlio il giovane,<br />
che si <strong>di</strong>stingue da tutte le altre anche per il comportamento in<strong>di</strong>sciplinato del guerriero<br />
romano, negli altri casi il duello si conclude con l’uccisione dello sfidante solo quando<br />
questi è un barbaro72. Il duello <strong>di</strong> <strong>Tito</strong> Manlio Torquato contro un Gallo (7,9 – 11,1)<br />
Del primo duello fra un Romano, <strong>Tito</strong> Manlio, e un guerriero gallo, <strong>ab</strong>biamo grazie<br />
a Gellio anche la versione dell’annalista Clau<strong>di</strong>o Quadrigario, che fu certamente la fonte<br />
<strong>di</strong> <strong>Livio</strong> per questo episo<strong>di</strong>o.<br />
In 9,13, 1-7 Gellio scrive:<br />
<strong>Tito</strong> Manlio <strong>di</strong>scendeva da famiglia ragguardevolissima e fu un nobile fra i primi. A questo Manlio fu dato il<br />
soprannome <strong>di</strong> Torquato. La ragione <strong>di</strong> questo soprannome, come <strong>ab</strong>biamo appreso, fu la spoglia<br />
consistente in una collana d’oro, che egli tolse al nemico che aveva ucciso e indossò. Ma chi fosse questo<br />
nemico, <strong>di</strong> che razza, e quanto gigantesca e temibile la sua corporatura, e quanto insolente la sua sfida, e<br />
come si svolse il combattimento, tutto questo è stato narrato da Quinto Clau<strong>di</strong>o nel primo libro dei suoi<br />
annali, in uno stile sommamente puro e splen<strong>di</strong>do, con la dolcezza semplice e <strong>di</strong>sadorna dell’eloquio antico.<br />
Ho trascritto qui le parole con cui Quinto Clau<strong>di</strong>o descrisse codesto duello.<br />
L’ultima frase assicura che il brano citato è la trascrizione letterale del testo <strong>di</strong><br />
Quadrigario. Che proprio questo sia la fonte <strong>di</strong> <strong>Livio</strong> si può considerare certo, anche se lo<br />
storico non lo in<strong>di</strong>ca esplicitamente, cosa che del resto <strong>di</strong> norma non fa, se non quando<br />
vuole rilevare una <strong>di</strong>scordanza tra più fonti, o aggiungere una versione <strong>di</strong>versa da quella<br />
accolta come principale73. Dimostra la <strong>di</strong>pendenza <strong>di</strong> <strong>Livio</strong> da Quadrigario la coincidenza<br />
dei due testi su alcuni particolari (le armi del soldato romano, il gesto <strong>di</strong> scherno del<br />
Gallo), oltre che lo svolgimento complessivo del duello. Il confronto dei due testi permette<br />
<strong>di</strong> constatare alcune mo<strong>di</strong>fiche significative introdotte da <strong>Livio</strong> nel racconto della fonte.<br />
72 Mentre i due Galli si battono, e trovano con onore la morte nel duello, i due Campani, tracotanti<br />
a parole, nel combattimento si rivelano vili e si salvano con la fuga.<br />
73 Il capitolo in realtà registra, nei paragrafi iniziali, un <strong>di</strong>saccordo tra le fonti, che non riguarda<br />
però l’episo<strong>di</strong>o del duello, ma la ragione per cui in quell’anno (363) fu nominato un <strong>di</strong>ttatore.
Letteratura latina B a.a. 2008-2009 mod. 2. Appunti delle lezioni 63<br />
In primo luogo, <strong>Livio</strong> elimina l’interruzione inverosimile <strong>di</strong> una battaglia in corso<br />
da parte dello sfidante, scegliendo invece per il duello un momento <strong>di</strong> pausa nei frequenti<br />
scontri fra Galli e Romani per impadronirsi del ponte 74. Trasforma poi in <strong>di</strong>scorso <strong>di</strong>retto<br />
l’enunciazione della sfida e, soprattutto, ne muta sensibilmente il tenore: il Gallo <strong>di</strong><br />
Quadrigario invita al duello uno dei nemici, uno qualsiasi (si quis vellet); quello <strong>di</strong> <strong>Livio</strong><br />
invece vuole misurarsi con il guerriero più forte, e <strong>di</strong>chiara che l’esito del duello mostrerà<br />
il valore dell’intero popolo cui il combattente appartiene. In entrambi gli storici nessuno<br />
dei Romani accoglie subito la sfida. Ma i due testi solo apparentemente si corrispondono:<br />
mentre nell’autore più antico i Romani semplicemente e comprensibilmente hanno paura<br />
(per la corporatura gigantesca e l’aspetto feroce del barbaro), in <strong>Livio</strong> essi prob<strong>ab</strong>ilmente<br />
valutano in silenzio la terribile respons<strong>ab</strong>ilità che chi accetterà <strong>di</strong> misurarsi con il Gallo<br />
si deve assumere (<strong>di</strong>mostrare quanto valga tutto il suo popolo). È questo il periculum che<br />
ognuno esita ad affrontare, non il rischio <strong>di</strong> perdere la vita. Ma infine <strong>Tito</strong> Manlio decide<br />
<strong>di</strong> affrontare la prova. Il personaggio è già noto al lettore, e lo storico lo rileva con le<br />
parole “...figlio <strong>di</strong> Lucio, quello che aveva riscattato suo padre dalla persecuzione <strong>di</strong> un<br />
tribuno75” (7,10,1). Del solenne, cerimonioso scambio <strong>di</strong> battute in <strong>di</strong>scorso <strong>di</strong>retto fra<br />
<strong>Tito</strong> Manlio e il <strong>di</strong>ttatore (7,10,2-3) non c’è traccia in Quadrigario: sono una inserzione <strong>di</strong><br />
<strong>Livio</strong>, che tiene molto, come si è detto, a sottolineare la <strong>di</strong>sciplina dei soldati romani. Per<br />
contro, al posto del gesto <strong>di</strong> scherno del Gallo, che, quando nessuno si fa avanti, tira<br />
fuori la lingua, in <strong>Livio</strong> troviamo soltanto un laconico tum (tum Titus Manlius... 7,10,2).<br />
Vinto il momento <strong>di</strong> esitazione che accomuna tutti, Manlio accetta la sfida: ma invece <strong>di</strong><br />
farsi avanti e iniziare senz’altro lo scontro, ne chiede licenza al comandante. Nelle parole<br />
<strong>di</strong> Manlio c’è una presentazione del Gallo (aspetto selvaggio e tracotanza) negativa e<br />
denigratoria, in accordo con quella fatta subito dopo <strong>di</strong>rettamente dallo scrittore.<br />
Le armi <strong>di</strong> cui i compagni dotano Manlio corrispondono esattamente a quelle<br />
menzionate da Quadrigario. <strong>Livio</strong> non si cura <strong>di</strong> correggere, o non rileva, l’anacronismo<br />
costituito dalla spada spagnola, che – almeno secondo Polibio (fr. 179) - entrò in uso<br />
nell’esercito romano solo più tar<strong>di</strong>, durante la guerra annibalica; aggiunge invece la<br />
piccola chiosa esplicativa ad propiorem h<strong>ab</strong>ili pugnam, una spada da duello. Solo quando<br />
il duello sta per iniziare <strong>Livio</strong>, ostentando il suo biasimo per chi ha ritenuto <strong>di</strong> dover<br />
tramandare questo particolare sor<strong>di</strong>do e futile, recupera il gesto <strong>di</strong> scherno del Gallo che<br />
tira fuori la lingua. Ma trasferito a questo punto il gesto muta anche significato: non una<br />
manifestazione <strong>di</strong> <strong>di</strong>sprezzo per la paura che paralizza i Romani, nessuno dei quali osa<br />
accogliere la sfida, ma un gesto immotivato e volgare, accostato alla stolida esultanza.<br />
74<br />
Lo in<strong>di</strong>ca il fatto che <strong>Livio</strong> fa avanzare il Gallo in vacuum pontem<br />
75<br />
Episo<strong>di</strong>o narrato in 7,5
Letteratura latina B a.a. 2008-2009 mod. 2. Appunti delle lezioni 64<br />
Le parole della fonte metu magno...utroque exercitu inspectante (Gellio 9,13,15)<br />
vengono da <strong>Livio</strong> sviluppate, con l’assimilazione esplicita dei due eserciti che assistono al<br />
duello agli spettatori <strong>di</strong> una gara; il metus degli uni e degli altri, accoppiato alla spes,<br />
viene registrato solo più avanti, quando il duello sta per iniziare (§ 9 animis spe metuque<br />
pendentibus). Mentre infatti la fonte registra soltanto il fronteggiarsi dei due avversari<br />
nell’imminenza dello scontro - il Gallo avanza cantando, Manlio subito attacca -, <strong>Livio</strong><br />
interpone una pausa piuttosto lunga, che contribuisce a tener ben desta l’attenzione del<br />
lettore, prima <strong>di</strong> far iniziare lo scontro, per mettere complessivamente a confronto i due<br />
guerrieri.<br />
In Quadrigario il Gallo, anonimo come in <strong>Livio</strong>, è compiutamente presentato fin<br />
dall’inizio: <strong>ab</strong>bigliamento, o meglio mancanza dello stesso, armi, ornamenti, aspetto, doti,<br />
voce. In <strong>Livio</strong> invece la presentazione è graduale: la prima notazione è riservata alla<br />
corporatura gigantesca, elemento sul quale torna più volte con insistenza, e alla voce<br />
(7,9,8 eximia corporis magnitu<strong>di</strong>ne... quantum maxima voce potuit). Abbigliamento e armi<br />
sono descritti solo nell’imminenza dello scontro, e sono funzionali alla contrapposizione<br />
dei due contendenti. All’aspetto comune e per nulla appariscente della persona (<strong>di</strong><br />
statura assai inferiore a quella dell’avversario), delle armi, dell’atteggiamento del Romano<br />
sono accostati l’aspetto sgargiante e l’atteggiamento baldanzoso del Gallo. A quest’ultimo<br />
<strong>Livio</strong> si riferisce per via negativa, mettendo in rilievo ciò che il Romano non faceva: canto,<br />
esultanza, agitar d’armi. Per contro, all’aspetto modesto del Romano si accompagnano<br />
coraggio, ira e fierezza; il Gallo invece, così spaventoso a vedersi, darà nel combattimento<br />
una prova me<strong>di</strong>ocre. Anche la trasformazione dell’<strong>ab</strong>bigliamento del Gallo ha la<br />
medesima funzione: <strong>Livio</strong> riveste la semplice nu<strong>di</strong>tà del guerriero <strong>di</strong> Quadrigario <strong>di</strong> un<br />
<strong>ab</strong>ito variopinto; lo scudo e le due spade, menzionati da Quadrigario senza qualificanti,<br />
<strong>di</strong>ventano in <strong>Livio</strong> genericamente “armi” 76, però preziose e <strong>di</strong>pinte. Collana e braccialetti<br />
sono in questa descrizione del tutto omessi da <strong>Livio</strong>, che solo alla fine menziona la<br />
collana, il trofeo strappato dal Romano al corpo del nemico ucciso.<br />
In Quadrigario – altra <strong>di</strong>fferenza significativa – il Gallo non è solo gigantesco, ha<br />
anche molte qualità, che <strong>Livio</strong> non menziona affatto: è dotato <strong>di</strong> vires, <strong>di</strong> adulescentia, <strong>di</strong><br />
virtus; insomma la caratterizzazione liviana del barbaro è esclusivamente negativa. Viene<br />
anche omessa l’osservazione contenuta nelle parole della fonte sua <strong>di</strong>sciplina (Gellio<br />
9,13,16) riferite al canto: in tal modo esso <strong>di</strong>venta, da uso proprio del modo <strong>di</strong><br />
combattere dei Galli, solo una delle tante manifestazioni <strong>di</strong> sciocca esultanza .<br />
Lo svolgimento del duello è riprodotto da <strong>Livio</strong> <strong>ab</strong>bastanza fedelmente, salvo il<br />
primo attacco, assegnato al Gallo, mentre in Quadrigario lo sfidante subisce solo colpi,<br />
76<br />
Il termine arma si riferisce soprattutto alle armi per la <strong>di</strong>fesa: ed è prob<strong>ab</strong>ile che sia proprio lo<br />
scudo che <strong>Livio</strong> immagina decorato e <strong>di</strong>pinto.
Letteratura latina B a.a. 2008-2009 mod. 2. Appunti delle lezioni 65<br />
non ne assesta mai. In <strong>Livio</strong> il Gallo incombe con la sua mole sul Romano e sferra un<br />
gran fendente sullo scudo <strong>di</strong> Manlio, ma senza conseguenze; Manlio colpisce una sola<br />
volta (non due) lo scudo del Gallo, prima <strong>di</strong> insinuarsi fra lo scudo e il corpo del nemico e<br />
infliggergli, come in Quadrigario, le due ferite mortali in rapida successione.<br />
Però <strong>Livio</strong>, avendo tanto insistito sulla corporatura gigantesca del Gallo, sulla<br />
sproporzione <strong>di</strong> statura fra i due combattenti, mo<strong>di</strong>fica sia il cozzo degli scu<strong>di</strong>, sia le parti<br />
del corpo del nemico ferite dalla spada <strong>di</strong> Manlio: mentre Quadrigario <strong>di</strong>ce semplicemente,<br />
due volte, scuto scutum percussit, <strong>Livio</strong> precisa scuto scutum imum; e le ferite non sono al<br />
petto e alla spalla destra, ma alle parti del corpo alla portata della sua modesta statura, e<br />
colpite per <strong>di</strong> più tenendo la spada alzata in alto. Di sapore epico è l’immagine finale del<br />
Gallo ucciso, il cui corpo <strong>di</strong>steso va ad occupare spatium ingens (del resto il lettore ha già<br />
capito che il Gallo era gigantesco...).<br />
Un ultimo particolare della fonte viene da <strong>Livio</strong> mo<strong>di</strong>ficato, o meglio negato:<br />
“Quin<strong>di</strong>, senza infierire in nessun modo sul corpo del nemico caduto, lo spogliò solo della<br />
collana, che si mise al collo intrisa <strong>di</strong> sangue” (7,10,11).<br />
Come si vede, il particolare della decapitazione del cadavere non è solo omesso, ma<br />
esplicitamente escluso: forse <strong>Livio</strong> considerava il gesto barbarico, selvaggio e incivile.<br />
Conserva però, un po’ incongruamente, essendo le ferite del suo Gallo ben lontane dal<br />
petto e dal collo, la collana insanguinata (senza contare la <strong>di</strong>fficoltà <strong>di</strong> sfilarla dal collo<br />
del cadavere con la testa attaccata).<br />
Molto importante, tipica <strong>di</strong> <strong>Livio</strong>, è la preoccupazione dello storico <strong>di</strong> non lasciare<br />
che il duello appaia un isolato atto <strong>di</strong> valore, fine a se stesso, ma <strong>di</strong> raccordarlo al<br />
contesto più ampio, mostrando che ebbe conseguenze positive sul prosieguo della guerra<br />
(7,11,1)<br />
Cenni ad altri duelli.<br />
A poca <strong>di</strong>stanza dalla descrizione dell’impresa <strong>di</strong> <strong>Tito</strong> Manlio Torquato, <strong>Livio</strong><br />
inserisce la narrazione <strong>di</strong> un secondo duello tra un Gallo e un Romano (7,26, anno 349<br />
a.C.). In questo caso l’elemento <strong>di</strong> spicco dell’episo<strong>di</strong>o è il verificarsi <strong>di</strong> un pro<strong>di</strong>gio, dal<br />
quale il combattente vittorioso trae il suo cognomen. L’episo<strong>di</strong>o è narrato assai più<br />
brevemente, ma la struttura fondamentale è la medesima. Un particolare interessante,<br />
assente nel duello <strong>di</strong> Manlio, è la presenza <strong>di</strong> un interprete per lanciare la sfida: “dopo<br />
aver imposto il silenzio percuotendo lo scudo con l’asta, sfida (sc. il Gallo) per mezzo <strong>di</strong><br />
un interprete uno dei Romani a misurarsi con lui” (7,26,1). Non ci sono scherni né frasi<br />
offensive; il duello non assume in questo caso, almeno non in modo esplicito, quel valore<br />
generale e altamente simbolico chiaro invece in 7,9-10. Da parte dei Romani non ci sono<br />
esitazioni, e la sfida è raccolta imme<strong>di</strong>atamente da Marco Valerio, impaziente <strong>di</strong> emulare
Letteratura latina B a.a. 2008-2009 mod. 2. Appunti delle lezioni 66<br />
l’impresa <strong>di</strong> Torquato. Naturalmente il Romano si batte prius sciscitatus consulis<br />
voluntatem; l’assenso del comandante questa volta è implicito. L’attenzione del narratore<br />
in questo caso è concentrata soprattutto sull’elemento nuovo, presentato come<br />
“l’interporsi della volontà <strong>di</strong>vina”. Fin dall’inizio dello scontro infatti un corvo si posa<br />
sull’elmo del Romano, e coll<strong>ab</strong>ora con lui alla vittoria, colpendo più volte il nemico al<br />
collo e al volto con il becco e con le unghie. Solo dopo che Valerio ha ucciso il Gallo il<br />
corvo vola via, verso oriente, lasciando al guerriero il soprannome <strong>di</strong> Corvo. In questo<br />
caso l’esito del duello viene interpretato come chiaro presagio della vittoria nella battaglia<br />
che subito dopo viene ingaggiata.<br />
Negli altri due duelli, che si svolgono entrambi nel corso della seconda guerra<br />
punica, la caratterizzazione dell’avversario del Romano è <strong>di</strong>versa: non si tratta <strong>di</strong> un<br />
barbaro, cioè <strong>di</strong> un nemico per natura e definizione, ma <strong>di</strong> un Campano, <strong>di</strong> un socius<br />
<strong>di</strong>venuto hostis. Il dato è sfruttato da <strong>Livio</strong> per far scontrare, in entrambi i casi,<br />
personaggi tra loro già reciprocamente noti. Nel primo duello (23,46-47) si tratta <strong>di</strong> ex<br />
commilitoni, nel secondo (25,18) i due avversari sono legati ad<strong>di</strong>rittura da amicizia<br />
personale. E’ evidente dunque che colui che lancia la sfida non può essere un anonimo<br />
qualsiasi: è un ben preciso in<strong>di</strong>viduo, non un tipo. Entrambi i Campani tuttavia sono<br />
dotati da <strong>Livio</strong> <strong>di</strong> una caratteristica presentata come propria in generale <strong>di</strong> tutto il loro<br />
popolo, proprio come la prestanza fisica e la sciocca tracotanza sono i tratti tipici dei<br />
Galli. Tale caratteristica è la superbia, un <strong>di</strong>fetto del carattere che assume però anche<br />
una chiara valenza politica. Dal punto <strong>di</strong> vista romano, superbi sono coloro che non<br />
accettano <strong>di</strong> sottomettersi, che oppongono resistenza alla evidente superiorità, non solo<br />
militare, dei Romani. I Campani ribelli, passati dalla parte <strong>di</strong> Annibale, sono certamente<br />
superbi anche in questo senso. La vittoria del Romano e il comportamento vile del<br />
Campano mostrano che schiacciare la superbia è possibile, giusto e doveroso.<br />
Il duello fra il campano Taurea e il romano Asello (23,46-47) non avviene neppure:<br />
dopo qualche schermaglia non dei guerrieri ma dei loro cavalli, il Campano ne ha<br />
<strong>ab</strong>bastanza, e fugge prima <strong>di</strong> essere costretto in un luogo delimitato, che renderebbe<br />
inevit<strong>ab</strong>ile il combattimento corpo a corpo.<br />
I protagonisti <strong>di</strong> 25,18, il campano Ba<strong>di</strong>o e il romano Crispino sono legati dal<br />
sacro vincolo dell’ospitalità. <strong>Livio</strong> ha cura <strong>di</strong> connettere preventivamente il duello alla<br />
narrazione principale: il lettore non deve pensare si tratti <strong>di</strong> un <strong>di</strong>versivo emozionante<br />
offerto al suo <strong>di</strong>letto; l’episo<strong>di</strong>o è al contrario la <strong>di</strong>mostrazione pratica che in guerra<br />
anche fatti <strong>di</strong> poco conto possono rivestire grande importanza. I Romani hanno subìto un<br />
rovescio, perdendo, senza quasi combattere, 1500 uomini. Il duello, esplicitamente
Letteratura latina B a.a. 2008-2009 mod. 2. Appunti delle lezioni 67<br />
definito parva res, contribuì a restituire loro fiducia. <strong>Livio</strong> el<strong>ab</strong>ora con cura l’antefatto,<br />
illustrando i precedenti rapporti intercorsi fra i due protagonisti: il Campano era stato<br />
ospitato e curato, durante una malattia, a Roma, a casa del Romano. Proprio con lui ora<br />
Ba<strong>di</strong>o vuole misurarsi in duello; non lancia la sfida ad un Romano qualsiasi, ma fa<br />
chiamare precisamente Crispino. Questi rifiuta con orrore <strong>di</strong> scontrarsi con il suo antico<br />
amico e ospite, e sopporta persino senza reagire i pesanti oltraggi verbali del Campano:<br />
questo per un Romano è davvero molto, ma in Crispino prevale ora la virtù della pietas77. I compagni devono a lungo insistere perché Crispino, pubblicamente oltraggiato, accetti<br />
la sfida. Dopo la solita cerimonia della richiesta, naturalmente accolta, al comandante<br />
del permesso <strong>di</strong> combattere extra or<strong>di</strong>nem, il duello ha inizio. I due sono a cavallo: al<br />
primo assalto Crispino ferisce Ba<strong>di</strong>o alla spalla e lo fa cadere, ma velocemente il<br />
Campano si rialza, si sottrae al colpo <strong>di</strong> grazia e fugge, parma atque equo relicto. Nella<br />
vergognosa fuga <strong>di</strong> Ba<strong>di</strong>o <strong>Livio</strong> si compiace <strong>di</strong> inserire un particolare <strong>di</strong> antica e nobile<br />
tra<strong>di</strong>zione letteraria, l’<strong>ab</strong>bandono dello scudo 78 . La medesima <strong>di</strong>savventura era stata<br />
narrata, con noncurante baldanza, già da Archiloco79 e da Alceo80, e con fine autoironia<br />
(forse) da Orazio81. 77<br />
Non, è importante sottolinearlo, il sentimento privato dell’affetto per l’amico <strong>di</strong> un tempo.<br />
78<br />
Lo scudo sarebbe naturalmente d’impaccio, impedendo una fuga veloce: <strong>ab</strong>bandonare lo scudo<br />
equivale dunque, tra<strong>di</strong>zionalmente, al fuggire, sottraendosi al combattimento.<br />
79<br />
Fr. 6 Diehl “Del mio scudo mena vanto uno dei Sai, arma eccellente che <strong>ab</strong>bandonai presso un<br />
cespuglio, e non avrei voluto. Ma ho salvato la vita. Che mi importa <strong>di</strong> quello scudo? Vada in<br />
malora: me ne comprerò un altro, non peggiore”.<br />
80<br />
Fr. 401 b Voigt “Alceo è salvo, ma il suo scudo appesero gli Attici nel tempio della Glaucopide”<br />
81<br />
Carm. 2,7,9-12: tecum Philippos et celerem fugam / sensi relicta non bene parmula, / cum fracta<br />
virtus et minaces / turpe solum tetigere mento.
Letteratura latina B a.a. 2008-2009 mod. 2. Appunti delle lezioni 68<br />
L’ INIZIO DELLA TERZA DECADE<br />
<strong>Livio</strong> de<strong>di</strong>ca per intero <strong>di</strong>eci <strong>libri</strong> (21-30) alla seconda guerra punica, un tema<br />
importante e unitario, la cui narrazione complessiva viene accuratamente organizzata. La<br />
decade è spartita in due metà <strong>di</strong> eguale ampiezza, corrispondenti alle due fondamentali<br />
fasi della guerra: i <strong>libri</strong> 21-25, dalla caduta <strong>di</strong> Sagunto all’asse<strong>di</strong>o <strong>di</strong> Siracusa (219-212),<br />
espongono successi e vittorie dei Cartaginesi; i <strong>libri</strong> 26-30, dalla conquista <strong>di</strong> Siracusa<br />
alla battaglia c.d. <strong>di</strong> Zama (212-202), sono de<strong>di</strong>cati alla lenta ma sicura ripresa romana<br />
fino alla vittoria finale. Naturalmente lo svolgimento della guerra fu proprio questo, e allo<br />
storico basta esporre i fatti nella loro successione cronologica: la contrapposizione fra le<br />
due metà della decade è certamente insita nei fatti stessi che in esse vengono narrati,<br />
non <strong>di</strong>pende da una particolare <strong>ab</strong>ilità del narratore. In realtà tuttavia le cose non stanno<br />
semplicemente così: il contrasto offerto dai fatti è accentuato e messo in rilievo, con<br />
svariati mezzi, dallo storico. In primo luogo, la sud<strong>di</strong>visione scelta dall’autore, che riserva<br />
5 <strong>libri</strong> ai successi <strong>di</strong> Annibale e 5 a quelli dei Romani, è cronologicamente asimmetrica,<br />
poiché i primi cinque <strong>libri</strong> <strong>ab</strong>bracciano sette anni e un<strong>di</strong>ci gli altri cinque. In secondo<br />
luogo, la prima pentade è dominata dalla figura <strong>di</strong> Annibale e la seconda da quella <strong>di</strong><br />
Scipione (Africano). Ma soprattutto, l’intento <strong>di</strong> sottolineare queste bipartizione della<br />
decade è rivelato da una serie <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>ati parallelismi. Ciascuna delle due metà inizia con<br />
la narrazione <strong>di</strong> un asse<strong>di</strong>o, rispettivamente quello cartaginese <strong>di</strong> Sagunto (21,6-15) e<br />
quello romano <strong>di</strong> Capua (26,4-14), che occupano uno spazio all’incirca eguale. L’asse<strong>di</strong>o<br />
<strong>di</strong> Capua segna, con la riconquista <strong>di</strong> una delle più importanti fra le città che erano<br />
passate al nemico, l’inizio della ripresa romana. E ancora: ogni libro nella prima pentade<br />
si apre con la descrizione delle attività dei Cartaginesi (quattro su cinque hanno<br />
ad<strong>di</strong>rittura il nome <strong>di</strong> Annibale nelle prime righe 82 ); quasi tutti i <strong>libri</strong> della seconda<br />
pentade riservano invece ai Romani la prima menzione 83. Difficilmente tutto ciò può<br />
essere casuale. A volte poi è possibile che <strong>Livio</strong> <strong>ab</strong>bia <strong>di</strong> proposito alterato un poco la<br />
cronologia, per far meglio rientrare tutti i fatti della guerra in questa stu<strong>di</strong>ata e artificiosa<br />
sud<strong>di</strong>visione della decade, che oppone i successi cartaginesi nella prima metà a quelli<br />
romani nella seconda. Ad esempio, rispetto alla cronologia <strong>di</strong> Polibio, <strong>Livio</strong> anticipa <strong>di</strong> un<br />
anno, ponendolo nel 212 invece che nel 211, l’evento sfortunato della morte dei due<br />
82 21,1,1: ...bellum ...quod Hannibale duce Carthaginienses cum populo Romano gessere; 22,1,1:<br />
Iam ver appetebat cum Hannibal ex hibernis movit; 23,1,1 Hannibal post Cannensem pugnam...;<br />
25,1,1 Dum haec in Africa et in Hispania geruntur, Hannibal in agro Sallentino aestatem consumpsit.<br />
Il libro 24 si apre anch’esso con le operazioni dei Cartaginesi, guidate da Annone: Ut ex Campania<br />
in Bruttios re<strong>di</strong>tum est, Hanno a<strong>di</strong>utoribus et ducibus Bruttiis Graecas <strong>urbe</strong>s temptavit<br />
83 26,1,1,: Cn. Fulvius Centumalus P. Sulpicius Galba consules...; 27,1,1: Hic status rerum in<br />
Hispania erat. In Italia consul Marcellus...; 29,1,1: Scipio postquam in Siciliam venit; 30,1,1: Cn.<br />
Servilius et C. Servilius consules... Il libro 28 si apre invece con l’illustrazione della situazione in<br />
Spagna, e delle rispettive zone controllate in quel momento da Romani e Cartaginesi.
Letteratura latina B a.a. 2008-2009 mod. 2. Appunti delle lezioni 69<br />
Scipioni, padre e zio dell’Africano, in Spagna (25,34 e 36); e posticipa <strong>di</strong> un anno, al 211<br />
invece che al 212, l’alleanza <strong>di</strong> Roma con gli Etòli (26,24), che bilancia quella <strong>di</strong> Annibale<br />
con Filippo V (23,33).<br />
Prefazione. Il giuramento <strong>di</strong> Annibale (21,1). Il rilievo che lo storico vuole<br />
conferire alla figura <strong>di</strong> Annibale nella prima metà della terza decade è evidente fin dalla<br />
prefazione. La frase con cui il libro 21 si apre, che annuncia il tema complessivo della<br />
decade, si può considerare una sorta <strong>di</strong> titolo: in essa la menzione del condottiero<br />
cartaginese (Hannibale duce) è anteposta a quella del popolo che fece guerra ai Romani.<br />
Enunciato chiaramente il tema, lo storico elenca i motivi che fanno della guerra<br />
annibalica un evento importante e memor<strong>ab</strong>ile. I quattro motivi in<strong>di</strong>cati, ma soprattutto<br />
l’ultimo, attengono all’aspetto propriamente narrativo della sezione che sta per iniziare.<br />
L’andamento mutevole e l’esito inatteso <strong>di</strong> una guerra fra popoli non solo molto potenti,<br />
ma entrambi all’apice della loro potenza, e già reciprocamente noti, prospetta un<br />
racconto particolarmente avvincente e ricco <strong>di</strong> peripezie. La menzione dell’o<strong>di</strong>o fra i due<br />
popoli (§3) serve a creare il passaggio al racconto del giuramento <strong>di</strong> Annibale bambino<br />
(§4): non un episo<strong>di</strong>o curioso o pittoresco, ma un evento che segna per sempre il futuro<br />
condottiero, e anche un mezzo che consente allo storico <strong>di</strong> porre imme<strong>di</strong>atamente la<br />
decade che inizia sotto il segno, per così <strong>di</strong>re, <strong>di</strong> Annibale, in accordo con le parole<br />
Hannibale duce. Il protagonista cartaginese della guerra, e il principale protagonista del<br />
racconto nei primi cinque <strong>libri</strong>, non può attendere, per entrare in scena, che lo storico<br />
<strong>ab</strong>bia terminato <strong>di</strong> riepilogare sommariamente i principali avvenimenti fra la fine della<br />
prima guerra punica e i progetti <strong>di</strong> riscossa <strong>di</strong> Amilcare, e poi fra la morte <strong>di</strong> Amilcare e<br />
la st<strong>ab</strong>ile assunzione del comando da parte <strong>di</strong> Annibale.<br />
Formalmente la scena del giuramento è un’aggiunta, che mostra quanto antico<br />
fosse l’o<strong>di</strong>o concepito contro i Romani dal loro futuro nemico; l’espressione hostem fore<br />
non vuol <strong>di</strong>re “che avrebbe nutrito sentimenti <strong>di</strong> ostilità” (cosa che Annibale potrebbe ben<br />
fare subito), ma, all’incirca, “che avrebbe fatto guerra ai Romani”, come mostra la<br />
precisazione cum primum posset. La scena del giuramento è presentata in <strong>di</strong>pendenza da<br />
fama est, una <strong>di</strong> quelle formule cui <strong>Livio</strong> <strong>ab</strong>itualmente ricorre o per introdurre leggende<br />
<strong>di</strong> cui si sa bene che non sono vere alla lettera, o per riferire tra<strong>di</strong>zioni delle quali come<br />
storico non può rendersi garante, ma che ritiene comunque opportuno non passare sotto<br />
silenzio.<br />
Ma il giuramento <strong>di</strong> Annibale non è una leggenda, e neppure una tra<strong>di</strong>zione <strong>di</strong><br />
origine dubbia; al contrario la fonte <strong>di</strong> questo racconto è quanto mai atten<strong>di</strong>bile, dal<br />
momento che si tratta <strong>di</strong> Annibale in persona. Molti anni più tar<strong>di</strong>, dopo esser stato<br />
sconfitto da Scipione e cacciato dalla sua patria, Annibale trova ospitalità e rifugio presso
Letteratura latina B a.a. 2008-2009 mod. 2. Appunti delle lezioni 70<br />
Antioco III il Grande, re <strong>di</strong> Siria, e mette a sua <strong>di</strong>sposizione la sua grande esperienza<br />
militare. Quando ingiustamente viene sospettato <strong>di</strong> segrete intese con i Romani, contro i<br />
quali Antioco si stava preparando a fare la guerra, Annibale riconquista la piena fiducia<br />
del re narrandogli del giuramento prestato da bambino. Il contenuto <strong>di</strong> quel giuramento<br />
era stato <strong>di</strong>verso da quello riferito da <strong>Livio</strong> all’inizio della terza decade. Lo si apprende<br />
dalle testimonianze concor<strong>di</strong> <strong>di</strong> Polibio, <strong>di</strong> Cornelio Nepote, e <strong>di</strong> <strong>Livio</strong> stesso, quando il<br />
suo racconto giunge a quei fatti (35,19: v. testi).<br />
Accingendosi a narrare dall’inizio la seconda guerra punica, Polibio anticipa il<br />
colloquio <strong>di</strong> Annibale con Antioco, e scrive:<br />
Al tempo in cui, sconfitto dai Romani e alla fine scacciato dalla patria, Annibale soggiornava presso<br />
Antioco [...] gli ambasciatori romani, trattandolo con ogni riguardo, cercavano <strong>di</strong> renderlo sospetto al re. E<br />
questo in effetti accadde. [...] Dopo aver fatto ricorso a svariati argomenti <strong>di</strong> <strong>di</strong>fesa, alla fine Annibale, non<br />
trovando più argomenti, fece al re questo racconto. Disse che quando suo padre, in procinto <strong>di</strong> partire per la<br />
Spagna, stava sacrificando [...] lo prese per mano e gli ingiunse <strong>di</strong> giurare che non sarebbe mai stato amico<br />
dei Romani (Polibio 3,11)<br />
Anche Cornelio Nepote ricorda il colloquio con Antioco, e la rievocazione del<br />
giuramento prestato da bambino, con cui Annibale si riconquistò la fiducia del re; anche<br />
in Nepote la formula del giuramento è iurare iussit numquam me in amicitia cum Romanis<br />
fore (Hann. 2,5).<br />
Esisteva evidentemente una tra<strong>di</strong>zione consolidata, che si faceva risalire ad<br />
Annibale stesso, che sapeva che Annibale bambino aveva giurato “che non sarebbe mai<br />
<strong>di</strong>ventato amico dei Romani”; richiamare questo giuramento nel contesto del malinteso<br />
con Antioco è opportuno, e appropriato alla situazione: Annibale è stato nemico dei<br />
Romani, ma ora ha bisogno <strong>di</strong> convincere Antioco che lo sarà sempre.<br />
Collocata invece molto prima che la guerra con i Romani effettivamente <strong>ab</strong>bia<br />
inizio, ad apertura della terza decade, quella promessa non sarebbe stata egualmente<br />
efficace: un impegno troppo generico, e soprattutto troppo a lunga scadenza, se la<br />
funzione <strong>di</strong> questo episo<strong>di</strong>o è, come sembra evidente, quella <strong>di</strong> presentare subito il dux<br />
che farà guerra ai Romani, quella guerra che Amilcare non ebbe tempo <strong>di</strong> iniziare, e che<br />
la politica <strong>di</strong> Asdrubale, volta a mantenere la pace, sembrava rinviare indefinitamente.<br />
<strong>Livio</strong> allora svincola l’episo<strong>di</strong>o dalla testimonianza del protagonista Annibale (fama est), e<br />
può quin<strong>di</strong> anche prendersi la libertà <strong>di</strong> mo<strong>di</strong>ficare leggermente, ma in modo significativo,<br />
il contenuto <strong>di</strong> quella promessa, in modo che si accor<strong>di</strong> meglio con l’impostazione<br />
generale della prima metà della decade, e con l’argomento annunciato, una guerra <strong>di</strong> cui<br />
Annibale fu il dux.<br />
Presentato così il protagonista principale della sezione che sta iniziando, lo storico<br />
recupera ed espone per sommi capi (21,1,5 – 3) le vicende cartaginesi del periodo, non<br />
breve, che separa la conclusione della prima punica dall’inizio della seconda (241-218).
Letteratura latina B a.a. 2008-2009 mod. 2. Appunti delle lezioni 71<br />
Non si tratta <strong>di</strong> una vera e propria esposizione narrativa, ma solo <strong>di</strong> una succinta<br />
presentazione delle iniziative e delle attività cartaginesi, considerate come preparazione<br />
(con Amilcare) o come rinvio (con Asdrubale) della ripresa delle ostilità con Roma. La<br />
considerazione che conclude la sezione de<strong>di</strong>cata ad Amilcare (21,1,5 – 2,2), ...ut<br />
appareret [...] si <strong>di</strong>utius vixisset, Hamilcare duce Poenos arma inlaturos fuisse quae<br />
Hannibalis ductu intulerunt, non risponde tanto ad una esigenza <strong>di</strong> informazione – lo<br />
storico ha appena detto che la guerra si svolse Hannibale duce – quanto al desiderio <strong>di</strong><br />
non relegare in secondo piano il protagonista cartaginese della guerra, nemmeno nel<br />
periodo in cui egli non ha nessuna parte nei fatti che lo storico sta esponendo.<br />
A <strong>di</strong>fferenza <strong>di</strong> Amilcare, Asdrubale non mostra alcuna fretta <strong>di</strong> iniziare la guerra<br />
contro Roma: si impegna invece, con un’<strong>ab</strong>ile attività <strong>di</strong>plomatica, a consolidare il potere<br />
cartaginese in Spagna; e stipula, o meglio rinnova, con Roma il famoso patto dell’Ebro,<br />
che in seguito darà origine a <strong>di</strong>scussioni sulla sua corretta interpretazione, e poi agli<br />
incidenti che porteranno, dopo la caduta <strong>di</strong> Sagunto, alla guerra. Morto Asdrubale, viene<br />
finalmente per Annibale il momento <strong>di</strong> assumere il comando: “Non vi furono dubbi su chi<br />
dovesse prendere il posto <strong>di</strong> Asdrubale: alla scelta preliminare dei soldati [...] teneva<br />
<strong>di</strong>etro anche il favore popolare” (21,3,1). Registrato così il passaggio dell’imperium<br />
militare ad Annibale, lo storico de<strong>di</strong>ca i due capitoli successivi all’esposizione <strong>di</strong> fatti<br />
precedenti e non ancora trattati, posti fra la morte <strong>di</strong> Amilcare e quella <strong>di</strong> Asdrubale, cioè<br />
i contrasti interni allo stato cartaginese, dove non tutti erano favorevoli alla politica <strong>di</strong><br />
espansione attuata e sostenuta dalla potente fazione dei Barca, e il tirocinio militare <strong>di</strong><br />
Annibale in Spagna. Si tratta <strong>di</strong> un tema accessorio rispetto a quello annunciato all’inizio<br />
del libro, e per questo lo storico ne rinvia l’esposizione. Registrato e fissato il dato<br />
essenziale, il passaggio ad Annibale del comando dell’esercito, lo storico fa un passo<br />
in<strong>di</strong>etro84, e spiega come Annibale fosse giunto ad esser scelto come generale alla morte<br />
<strong>di</strong> Asdrubale. A conclusione <strong>di</strong> questa sezione è collocato il ritratto <strong>di</strong> Annibale (21,4).<br />
Questa collocazione non è certo casuale: da un lato il ritratto si inserisce naturalmente in<br />
quella sorta <strong>di</strong> breve <strong>di</strong>gressione dal filo principale del racconto (passaggio del comando<br />
militare da Amilcare ad Asdrubale e poi ad Annibale), che spiega come Annibale si fosse<br />
conquistato il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> occupare il posto che era stato <strong>di</strong> suo padre85, dall’altro presenta<br />
compiutamente, prima che la guerra inizi, il personaggio del dux con il quale i Romani<br />
dovranno ben presto confrontarsi.<br />
84 Segnalato dalle forme verbali al piuccheperfetto accersierat e acta fuerat (= acta erat) <strong>di</strong> 21,3,2.<br />
85 Non per <strong>di</strong>ritto ere<strong>di</strong>tario, come sarcasticamente aveva insinuato Annone nel suo <strong>di</strong>scorso in<br />
senato, ma grazie alle eccellenti doti militari <strong>di</strong> cui dà prova nel tirocinio alle <strong>di</strong>pendenze <strong>di</strong><br />
Asdrubale.
Letteratura latina B a.a. 2008-2009 mod. 2. Appunti delle lezioni 72<br />
Con il cap. 21,5 riprende il racconto principale, e viene registrata la decisione <strong>di</strong><br />
far guerra ai Saguntini, presa da Annibale allo scopo <strong>di</strong> creare un incidente che provochi<br />
la reazione romana: “Del resto, dal giorno in cui fu proclamato comandante, come se<br />
l’Italia fosse la provincia che gli era stata assegnata, e la guerra contro Roma l’incarico <strong>di</strong><br />
cui era stato investito, ritenendo <strong>di</strong> non dover tardare, perché, mentre indugiava, un<br />
qualche evento sfortunato non cogliesse anche lui, come suo padre Amilcare e poi<br />
Asdrubale, decise <strong>di</strong> far guerra ai Saguntini” (21,5,1).<br />
Si può <strong>di</strong>re che a questo punto il personaggio ha già onorato il giuramento fattogli<br />
prestare dal padre (così come <strong>Livio</strong> lo ha trasformato): davvero “al più presto possibile”<br />
Annibale sta iniziando la guerra contro Roma.<br />
Ritratto <strong>di</strong> Annibale (21,4). Nel corso dell’opera <strong>Livio</strong> cura in svariati mo<strong>di</strong> la<br />
caratterizzazione dei viri sui quali, secondo la <strong>di</strong>chiarazione della prefazione (v. § 9 ...per<br />
quos viros quibusque artibus domi militiaeque et partum et auctum imperium sit), desidera<br />
che il lettore concentri la sua attenzione; non manca neppure quella, come nel caso <strong>di</strong><br />
Annibale, <strong>di</strong> alcuni insigni nemici <strong>di</strong> Roma. Molto frequente è il ritratto – epitafio: in<br />
occasione della notizia della morte <strong>di</strong> un grande personaggio lo storico ne offre una<br />
succinta biografia, in cui traccia un breve bilancio delle sue azioni più significative ed<br />
esprime il proprio giu<strong>di</strong>zio complessivo86, un congedo dal personaggio <strong>di</strong> cui, nel corso<br />
della narrazione, è stato già offerto il ritratto in<strong>di</strong>retto, attraverso le sue azioni e, talvolta,<br />
le sue parole. Meno frequenti sono i ritratti <strong>di</strong> tipo statico, quale, almeno in parte, quello<br />
<strong>di</strong> Annibale87. 86 Qualche esempio. “In quel medesimo anno [203] morì Quinto F<strong>ab</strong>io Massimo in età assai<br />
avanzata, se è vero che fu augure per 62 anni, come sostengono alcuni autori. Fu uomo certo<br />
degno <strong>di</strong> un così grande cognomen, se pure non fu lui il primo a portarlo. Superò le cariche del<br />
padre, eguagliò quelle degli antenati. Il suo avo Rullo ottenne più vittorie, e in battaglie più<br />
importanti, ma il solo fatto <strong>di</strong> aver avuto come nemico Annibale può eguagliare ogni altra impresa.<br />
Fu tuttavia ritenuto prudente più che deciso; e se può darsi che egli sia stato temporeggiatore più<br />
per indole che non perché così richiedeva la guerra che allora si combatteva, è però certo che,<br />
come <strong>di</strong>ce Ennio, fu proprio lui l’uomo che temporeggiando salvò lo stato” (30,26,7-10). Il tono<br />
generale, e alcuni temi – il confronto con gli antenati e l’affermazione che il defunto se ne mostrò<br />
degno – ricordano gli elogi funebri. Altri epitafi sono meno convenzionali, ad es. quello famoso <strong>di</strong><br />
Cicerone, conservatoci da Seneca Padre, suas.22-24 (v. Garbarino p. 456).<br />
87 Anche per Annibale naturalmente c’è quello che si è in<strong>di</strong>cato come “ritratto in<strong>di</strong>retto”, la<br />
costruzione graduale della figura del personaggio attraverso il suo agire, seguito dallo storico ben<br />
oltre la conclusione della guerra contro Roma. Ad esempio il brano, citato qui sopra, de<strong>di</strong>cato al<br />
colloquio con il re Antioco (35,19, v. testi) ne mette in luce il carattere fiero e schietto; drammatico<br />
e commosso è il racconto della sua morte (39,51): tra<strong>di</strong>to dal re <strong>di</strong> Bitinia Prusia, Annibale si<br />
sottrae con il veleno ai soldati romani <strong>di</strong> Flaminino che circondano la sua <strong>di</strong>mora, pronunciando<br />
queste nobili parole: “Liberiamo il popolo romano da una preoccupazione che dura da tanto tempo,<br />
giacché ritengono troppo lungo attendere la morte <strong>di</strong> un vecchio. Non grande né memor<strong>ab</strong>ile sarà<br />
la vittoria <strong>di</strong> Flaminino su un uomo inerme e tra<strong>di</strong>to. Questo solo giorno basterà a provare quanto<br />
siano mutati i costumi del popolo romano. <strong>Gli</strong> antenati <strong>di</strong> costoro misero in guar<strong>di</strong>a contro il<br />
veleno il re Pirro, un nemico armato, che era in Italia con l’esercito; questi hanno mandato un ex<br />
console con l’incarico <strong>di</strong> indurre Prusia ad uccidere a tra<strong>di</strong>mento un ospite” (39,51, 9-11). Il
Letteratura latina B a.a. 2008-2009 mod. 2. Appunti delle lezioni 73<br />
Il suo infatti è, nel medesimo tempo, un ritratto statico, alla maniera sallustiana 88<br />
(aspetto, carattere, vizi e virtù), svincolato cioè da qualsiasi contesto storicamente<br />
determinato, e una descrizione, inserita invece in un momento storico preciso, del<br />
tirocinio militare del giovane Annibale.<br />
La notazione relativa ai veterani (§1), colpiti dalla somiglianza <strong>di</strong> Annibale con il<br />
padre introduce un elemento <strong>di</strong> originalità nel ritratto fisico <strong>di</strong> tipo tra<strong>di</strong>zionale: le<br />
fattezze del personaggio sono presentate in modo in<strong>di</strong>retto, attraverso gli occhi dei<br />
veteres milites, che imme<strong>di</strong>atamente riconoscono in lui i tratti <strong>di</strong> Amilcare; solo il termine<br />
liniamenta, che conclude l’elenco, si riferisce in realtà alle vere e proprie fattezze fisiche;<br />
tutti gli altri (vigor, vis, h<strong>ab</strong>itus oris) rinviano piuttosto a qualità del carattere (energia,<br />
vigore) che traspaiono dall’espressione complessiva del volto. In effetti, la somiglianza con<br />
il padre non è limitata all’aspetto fisico; le doti che Annibale ben presto mostra <strong>di</strong><br />
possedere non deludono le aspettative suscitate dalla sua straor<strong>di</strong>naria somiglianza con<br />
il padre. Si tratta <strong>di</strong> doti propriamente militari, che fanno sì che i soldati apprezzino<br />
Annibale in<strong>di</strong>pendentemente dall’immagine vivente del padre che scorgono in lui (§2).<br />
Appropriata alla descrizione del tirocinio militare del giovane Annibale è la<br />
menzione della sua attitu<strong>di</strong>ne tanto ad parendum quanto ad imperandum (§3), giacché<br />
per la caratterizzazione <strong>di</strong> Annibale comandante supremo sarebbe fuor <strong>di</strong> luogo ricordare<br />
la <strong>di</strong>sposizione ad obbe<strong>di</strong>re; e così l’accenno alle imprese a lui affidate (neque Hasdrubal<br />
alium quemquam praeficere malle... §4) rinvia, anch’esso, a quel periodo. La frase è però<br />
molto generica; l’ampliamento ottenuto con le iterazioni sinonimiche (fortiter ac strenue;<br />
confidere aut audere) sembra miri a compensare, in certo modo, la mancanza <strong>di</strong><br />
riferimenti precisi a fatti specifici. Lo storico è interessato a presentare le doti del<br />
personaggio, più che a ricordare qualche impresa da lui compiuta quando militava alle<br />
<strong>di</strong>pendenze <strong>di</strong> Asdrubale; ed è prob<strong>ab</strong>ile del resto che nelle sue fonti non trovasse alcuna<br />
menzione <strong>di</strong> azioni militari degne <strong>di</strong> memoria. Sappiamo infatti 89 che il periodo <strong>di</strong><br />
comando supremo <strong>di</strong> Asdrubale era stato caratterizzato da pax, da azioni <strong>di</strong>plomatiche<br />
volte ad allargare le alleanze cartaginesi con altri popoli. Soprattutto per questo<br />
prob<strong>ab</strong>ilmente l’illustrazione delle doti militari <strong>di</strong> Annibale, necessaria nel ritratto del<br />
futuro grande generale, si mantiene piuttosto generica, e anche molto convenzionale.<br />
<strong>Livio</strong> assegna infatti al suo giovane Annibale tutte le doti che secondo la tra<strong>di</strong>zione<br />
romana il buon soldato doveva possedere: dopo la <strong>di</strong>sciplina, il coraggio, l’accortezza, gli<br />
attribuisce anche resistenza fisica, temperanza, aspirazione a primeggiare nelle battaglie.<br />
racconto della morte <strong>di</strong> Annibale è preceduto da un lusinghiero, brevissimo epitafio: morirono nel<br />
medesimo anno (183) Scipione e Annibale, “i due più gran<strong>di</strong> generali dei due popoli più potenti”<br />
(39,50,11).<br />
88<br />
Cat., 5 (Catilina); 25 (Sempronia); Iug., 63 (Mario); 95 (Silla).<br />
89<br />
V. 21,2,5-6.
Letteratura latina B a.a. 2008-2009 mod. 2. Appunti delle lezioni 74<br />
Subito dopo, con brusco contrasto, Annibale viene dotato anche <strong>di</strong> una nutrita<br />
serie <strong>di</strong> vitia. Questi, assai più che le virtù, prescindono completamente dalla situazione<br />
specifica in cui il ritratto <strong>di</strong> Annibale è inserito. Quelli che lo storico elenca sono infatti i<br />
vitia del generale cartaginese nemico dei Romani, non quelli del giovane impegnato nel<br />
tirocinio militare, non dotato <strong>di</strong> potere autonomo e <strong>di</strong>fficilmente quin<strong>di</strong> in grado <strong>di</strong> venir<br />
meno a patti o giuramenti, che non spettava certo a lui concludere o prestare. Si tratta <strong>di</strong><br />
un elenco molto scarno, anch’esso privo <strong>di</strong> esempi concreti, ma molto più schematico<br />
della descrizione delle doti positive, non altrettanto statiche. Ponendo tuttavia a<br />
conclusione del ritratto la serie dei vitia, certo lo scrittore mira a far sì che essi si<br />
imprimano nella mente del lettore con forza particolare.<br />
La maggior parte dei vitia <strong>di</strong> Annibale è presentata per via negativa, con l’anafora<br />
<strong>di</strong> nihil e <strong>di</strong> nullus; egli è insomma la vivente negazione <strong>di</strong> tutte le più importanti virtù<br />
romane. L’elenco è peraltro sia ridondante sia convenzionale: ridondante, perché la<br />
perfi<strong>di</strong>a (violazione della fides) comprende e implica quasi tutti i vizi introdotti in forma<br />
negativa, precisando i campi in cui la perfi<strong>di</strong>a può manifestarsi; convenzionale, perché<br />
nel corso del racconto Annibale non appare particolarmente perfidus, empio o crudele.<br />
Anzi, a volte lo storico registra comportamenti che smentiscono qualcuno <strong>di</strong> questi vitia.<br />
In primo luogo, il rispetto per il giuramento fatto all’età <strong>di</strong> nove anni, che tanta<br />
importanza riveste proprio nel racconto <strong>di</strong> <strong>Livio</strong>, mette evidentemente in dubbio il nullum<br />
ius iurandum.<br />
Smentisce poi il nullus deum metus, mostrando invece la pietas religiosa del<br />
generale cartaginese, il viaggio che, prima <strong>di</strong> partire per l’Italia, egli compì a Ca<strong>di</strong>ce, per<br />
sciogliere un voto fatto ad Ercole e invocarne la protezione per l’impresa che si accingeva<br />
ad iniziare (21,21,9).<br />
Quanto alla crudeltà e alla slealtà nella condotta <strong>di</strong> guerra, queste non appaiono<br />
prerogative del solo Annibale, o dei soli Cartaginesi. Anche i Romani vi ricorrono spesso,<br />
come lo storico onestamente riferisce. Per i Romani tuttavia tenta <strong>di</strong> el<strong>ab</strong>orare<br />
giustificazioni che invece per i Cartaginesi non cerca mai. Si è già ricordato90 il massacro<br />
a tra<strong>di</strong>mento dei citta<strong>di</strong>ni inermi <strong>di</strong> Enna progettato ed eseguito dai Romani senza un<br />
ripensamento (24,39), e la considerazione conclusiva dello storico: ita Henna aut malo aut<br />
necessario facinore retenta (24,39,7). Questa non è una vera e propria giustificazione <strong>di</strong><br />
un atto che lo storico certo <strong>di</strong>sapprova, ma le assomiglia molto. Un comportamento<br />
analogo, anzi meno crudele, dei Cartaginesi è invece condannato senza esitazioni dallo<br />
storico. Dopo la sconfitta del Trasimeno, seimila soldati romani scampati al massacro si<br />
arrendono, dopo una fuga durata una intera notte, al generale cartaginese Maarbale,<br />
90 V. p. 23.
Letteratura latina B a.a. 2008-2009 mod. 2. Appunti delle lezioni 75<br />
fidando nella sua promessa che, se avessero consegnato tutte le armi, li avrebbe lasciati<br />
liberi. Annibale però non mantiene la promessa fatta dal suo luogotenente: “questa<br />
parola – commenta lo storico – fu rispettata da Annibale con lo scrupolo proprio dei<br />
Cartaginesi, e tutti furono fatti prigionieri” (22,6,12).<br />
Il ritratto si conclude con una considerazione riassuntiva, che prepara e precede la<br />
ripresa del racconto, chiudendo la breve <strong>di</strong>gressione aperta al cap. 3: “Con questa indole<br />
in cui si mescolavano virtù e vizi, prestò servizio per tre anni sotto il comando <strong>di</strong><br />
Asdrubale, senza trascurare niente <strong>di</strong> ciò che un uomo destinato a <strong>di</strong>ventare un grande<br />
generale doveva compiere e conoscere” (21,4,10).<br />
Con 21, 5 riprende il filo principale del racconto, che ricorda ancora una volta la<br />
successione Amilcare, Asdrubale, Annibale. Il giuramento e il ritratto preparano<br />
efficacemente questo inizio della guerra: il lettore a questo punto conosce quel dux<br />
annunciato fin dall’introduzione alla decade91. 91 Fra gli altri ritratti presenti nell’opera <strong>di</strong> <strong>Livio</strong> si propone alla lettura quello de<strong>di</strong>cato a Papirio<br />
Cursore (9,16, v. testi). Mentre quello <strong>di</strong> Annibale ne precede l’effettiva comparsa in scena come<br />
protagonista, quello <strong>di</strong> Papirio suggella la sua impresa più gloriosa, la vittoria sui Sanniti, che<br />
riscatta l’onta delle Forche Cau<strong>di</strong>ne. A questo punto del racconto il lettore conosce già bene il<br />
personaggio e alcune delle sue caratteristiche, richiamate nel ritratto da due piccoli aneddoti<br />
caratterizzanti (cosa <strong>ab</strong>bastanza inconsueta in <strong>Livio</strong>), entrambi arricchiti da una battuta in<br />
<strong>di</strong>scorso <strong>di</strong>retto. <strong>Livio</strong> rende a Papirio un onore gran<strong>di</strong>ssimo, affermando che era opinione comune<br />
che egli sarebbe stato in grado <strong>di</strong> tener testa ad Alessandro Magno; con Alessandro Papirio<br />
con<strong>di</strong>vide una caratteristica certo biasimevole (la tendenza al bere), che <strong>Livio</strong> trasforma, senza<br />
mettere le due figure <strong>di</strong>rettamente a confronto, in un segno del suo straor<strong>di</strong>nario vigore fisico:<br />
fuisse ferunt cibi vinique eundem capacissimum. Come si è visto invece la frugalità nel mangiare e<br />
nel bere è una delle virtù <strong>di</strong> Annibale.
Letteratura latina B a.a. 2008-2009 mod. 2. Appunti delle lezioni 76<br />
DISCORSO DI CATONE CONTRO L’ABROGAZIONE DELLA LEX OPPIA (34,1-4)<br />
Il brano è un interessante esempio <strong>di</strong> <strong>di</strong>scorso <strong>di</strong>retto, <strong>di</strong> genere deliberativo. Al<br />
<strong>di</strong>scorso <strong>di</strong> Catone è fatto seguire imme<strong>di</strong>atamente quello <strong>di</strong> un avversario, secondo la<br />
tecnica dei <strong>di</strong>scorsi a coppie inaugurata da Tuci<strong>di</strong>de, cui <strong>Livio</strong> ricorre <strong>ab</strong>bastanza spesso.<br />
Oltre che ad esporre, con maggiore o minore fedeltà, ciò che fu detto effettivamente, i<br />
<strong>di</strong>scorsi contrapposti adempiono alla funzione <strong>di</strong> illustrare con imme<strong>di</strong>atezza, dando la<br />
parola ai protagonisti stessi, la situazione e i termini del problema, accostando<br />
<strong>di</strong>rettamente i due <strong>di</strong>versi punti <strong>di</strong> vista.<br />
Il libro 34 è de<strong>di</strong>cato ad un periodo <strong>di</strong> circa tre anni (195-193): il racconto relativo<br />
all’anno 195 inizia già nel libro precedente; il primo fatto preso in considerazione nel<br />
libro 34 è la proposta dell’<strong>ab</strong>rogazione della lex Oppia. Le vicende militari riguardano tre<br />
<strong>di</strong>stinti teatri <strong>di</strong> guerra: la Spagna, dove il console Catone guida una spe<strong>di</strong>zione vittoriosa<br />
ma non risolutiva contro alcune popolazioni in<strong>di</strong>gene che si erano ribellate; la Gallia,<br />
dove viene inviato l’altro console, Valerio Flacco, contro i Galli Boi; e infine la Grecia,<br />
dove <strong>Tito</strong> Quinzio Flaminino, dopo la vittoria su Filippo, affronta e sconfigge N<strong>ab</strong>ide <strong>di</strong><br />
Sparta, con il quale Roma stipula un trattato <strong>di</strong> pace. Il libro si conclude con le prime<br />
avvisaglie della guerra contro Antioco III , presso il quale ha trovato rifugio Annibale<br />
esule dalla patria.<br />
Lo spazio de<strong>di</strong>cato alla questione <strong>di</strong> politica interna costituita dalla proposta <strong>di</strong><br />
<strong>ab</strong>rogazione della lex Oppia è considerevole (otto capitoli su 62 complessivi), forse<br />
sproporzionato all’effettiva rilevanza dell’argomento, definito dallo storico stesso res parva.<br />
Il primo capitolo illustra con chiarezza la questione: una legge suntuaria, proposta<br />
e promulgata nel periodo più duro della guerra annibalica, imponeva restrizioni alle<br />
donne nel vestiario, nei gioielli e nell’uso <strong>di</strong> carrozze; passato ormai da tempo quel<br />
pericolo, tornate la prosperità e <strong>di</strong> pace, sembrava a molti che la legge potesse essere<br />
cancellata. Si fecero promotori dell’<strong>ab</strong>rogazione due tribuni della plebe; altri si opposero<br />
alla proposta: gli oratori dell’una e dell’altra opinione si alternavano alla tribuna per<br />
illustrare al popolo che avrebbe votato le ragioni a favore o contro la proposta. <strong>Livio</strong><br />
sceglie <strong>di</strong> riferire il <strong>di</strong>scorso del più illustre degli oppositori della proposta, Catone, che<br />
nel 195 era console; e poi quello <strong>di</strong> uno dei due tribuni proponenti, Lucio Valerio. Di<br />
quest’ultimo il lettore non sa nulla se non ciò che si può trarre dal <strong>di</strong>scorso che lo storico<br />
gli attribuisce: le sue parole, in contrasto con il piglio battagliero <strong>di</strong> Catone, sono<br />
ragionevoli e calme, a tratti anche finemente ironiche; la sua <strong>di</strong>fesa delle donne è efficace,<br />
ed è persuasiva la <strong>di</strong>mostrazione che l’<strong>ab</strong>olizione <strong>di</strong> pochi e ormai assur<strong>di</strong> <strong>di</strong>vieti non<br />
avrebbe certo messo a repentaglio né l’integrità dei costumi né la saldezza dello stato<br />
romano.
Letteratura latina B a.a. 2008-2009 mod. 2. Appunti delle lezioni 77<br />
Di Catone invece sappiamo che fu oratore, e che nel corso della sua lunghissima<br />
carriera politica pronunciò parecchi <strong>di</strong>scorsi, <strong>di</strong> cui curò personalmente la pubblicazione,<br />
e che al tempo <strong>di</strong> <strong>Livio</strong> si leggevano ancora in gran numero. Si potrebbe dunque pensare<br />
che, a <strong>di</strong>fferenza del <strong>di</strong>scorso del tribuno, quello attribuito a Catone sia la riel<strong>ab</strong>orazione<br />
del <strong>di</strong>scorso effettivamente pronunciato in quell’occasione. Prob<strong>ab</strong>ilmente non è così.<br />
<strong>Livio</strong> ricorda altri <strong>di</strong>scorsi pronunciati da Catone92, ma ne riferisce solo genericamente il<br />
contenuto, senza trascriverli né riscriverli (con la motivazione che il <strong>di</strong>scorso exstat93). Questo è il solo <strong>di</strong>scorso <strong>di</strong>retto che il personaggio <strong>di</strong> Catone pronuncia nella sua opera94: prob<strong>ab</strong>ilmente non ne esisteva più (o non era mai esistito) il testo originale. Questo non<br />
significa che <strong>Livio</strong> <strong>ab</strong>bia inventato l’intervento <strong>di</strong> Catone in <strong>di</strong>fesa della legge:<br />
prob<strong>ab</strong>ilmente nelle sue fonti trovava la notizia del <strong>di</strong>battito e della partecipazione ad<br />
esso <strong>di</strong> Catone. Poiché, supponiamo, nella raccolta <strong>di</strong>sponibile delle orazioni <strong>di</strong> Catone<br />
quel <strong>di</strong>scorso non c’era (nemmeno a noi sono giunti frammenti <strong>di</strong> un <strong>di</strong>scorso pro lege<br />
Oppia), <strong>Livio</strong> sfrutta l’occasione per assegnare un ampio <strong>di</strong>scorso <strong>di</strong>retto al personaggio,<br />
alla sua prima comparsa significativa nel racconto95. Le caratteristiche più note <strong>di</strong> Catone, inflessibile, autoritario, ostinatamente fedele<br />
alle sue idee <strong>di</strong> uomo all’antica, <strong>di</strong> moralista severo e un po’ misogino, sono delineate<br />
molto felicemente attraverso il <strong>di</strong>scorso che lo storico ricostruisce per lui.<br />
All’avversario <strong>Livio</strong> assegna un <strong>di</strong>scorso in totale contrasto con quello <strong>di</strong> Catone,<br />
non per gli argomenti (questo è ovvio), ma per il tono, garbato, ragionevole, conciliante<br />
quanto invece è aggressivo, categorico e aspro quello <strong>di</strong> Catone: il suo accanimento<br />
92<br />
In 38,54,11 lo storico ricorda il <strong>di</strong>scorso de pecunia regis Antiochi, pronunciato da Catone per<br />
sollecitare l’apertura <strong>di</strong> un’inchiesta sulla questione del denaro <strong>di</strong> Antioco. Sconfitto nel 189 a<br />
Magnesia sul Sipilo da Lucio Scipione, fratello dell’Africano che lo affiancava con il titolo <strong>di</strong> legatus,<br />
Antioco aveva accettato la pace <strong>di</strong> Apamea (188). Si sospettava che il re avesse versato agli<br />
Scipioni e ad altri personaggi politici romani ingenti somme <strong>di</strong> denaro per ottenere con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong><br />
pace vantaggiose, o anche solo che una parte dell’indennità <strong>di</strong> guerra imposta ad Antioco non<br />
fosse stata versata all’erario, ma trattenuta dagli Scipioni. In 39,42,5 lo storico menziona l’oratio<br />
molto severa pronunciata da Catone nell’esercizio della sua censura (184) contro Lucio Quinzio<br />
per espellerlo dal numero dei senatori durante la lectio senatus. Infine, in 45,25,2-4 si riferisce al<br />
<strong>di</strong>scorso pro Rho<strong>di</strong>ensibus pronunciato da Catone in senato contro la proposta <strong>di</strong> <strong>di</strong>chiarar guerra<br />
ai Ro<strong>di</strong>esi sulla base del semplice sospetto che essi avessero avuto intenzione <strong>di</strong> aiutare Perseo in<br />
guerra contro i Romani.<br />
93<br />
A proposito del <strong>di</strong>scorso pro Rho<strong>di</strong>ensibus <strong>Livio</strong> si esprime così: Non inseram simulacrum viri<br />
copiosi, quae <strong>di</strong>xerit referendo: ipsius oratio scripta exstat, Originum quinto libro inclusa (45,15,3),<br />
“non introdurrò qui una pallida immagine <strong>di</strong> quell’uomo facondo riferendo ciò che <strong>di</strong>sse: il suo<br />
<strong>di</strong>scorso si conserva scritto, inserito nel quinto libro delle Origines”; si deduce da ciò che anche<br />
l’opera storica <strong>di</strong> Catone era conservata e <strong>di</strong>sponibile al tempo <strong>di</strong> <strong>Livio</strong>.<br />
94<br />
Fatta eccezione per una breve allocuzione alle truppe assegnata a Catone in 34,13,5-9,<br />
nell’imminenza <strong>di</strong> un combattimento durante la campagna militare in Spagna, un brano<br />
convenzionale, prob<strong>ab</strong>ile creazione dello storico, come segnalano le parole che seguono in hunc<br />
modum [...]adhortatus...<br />
95<br />
Prima del suo consolato <strong>Livio</strong> lo menziona solo incidentalmente, in seguito invece segue con<br />
attenzione la sua carriera sia militare sia politica.
Letteratura latina B a.a. 2008-2009 mod. 2. Appunti delle lezioni 78<br />
finisce per apparire sproporzionato alla reale importanza della questione per la quale si<br />
batte.<br />
Come in tutti i <strong>di</strong>scorsi <strong>di</strong> maggior estensione inseriti nell’opera, anche questo<br />
presenta la struttura canonica prevista dalle norme della retorica: a) exor<strong>di</strong>um (2,1-3); b)<br />
tractatio (2,5-4,18), che svolge nell’or<strong>di</strong>ne questi temi: il comportamento delle donne<br />
costituisce una minaccia per lo stato; la legge <strong>di</strong> cui si propone l’<strong>ab</strong>rogazione è utile allo<br />
stato; i motivi delle donne sono cattivi; se la legge verrà <strong>ab</strong>rogata lo stato ne sarà<br />
danneggiato; c) conclusio o peroratio (4,19-21).<br />
Come lo storico riferisce in 34,1,5, le matronae, <strong>di</strong>rettamente interessate alla<br />
proposta, non rimasero <strong>di</strong>sciplinatamente in casa ad attendere l’esito della votazione (che<br />
vide la sconfitta <strong>di</strong> Catone), ma si riversarono in folla nelle strade, facendo vive pressioni<br />
sugli uomini perché la legge che ingiustamente le danneggiava venisse <strong>ab</strong>rogata.<br />
Esor<strong>di</strong>o (2,1-3). Normalmente con l’esor<strong>di</strong>o l’oratore mira ad ottenere attenzione e<br />
soprattutto benevolenza dal pubblico. Catone invece rinuncia quasi del tutto a cercare <strong>di</strong><br />
ingraziarsi l’u<strong>di</strong>torio, scegliendo un esor<strong>di</strong>o severo e aggressivo. Il punto <strong>di</strong> partenza non<br />
è la legge <strong>di</strong> cui si propone l’<strong>ab</strong>rogazione, ma il comportamento intoller<strong>ab</strong>ilmente<br />
in<strong>di</strong>sciplinato e scandaloso delle donne, segno preoccupante <strong>di</strong> un generale<br />
allontanamento dai mores antiqui: i Romani non sono più in grado <strong>di</strong> comandare alle loro<br />
donne. E’ questo il rimprovero che l’oratore rivolge agli ascoltatori, appena attenuato dal<br />
fatto che egli vi comprenda anche se stesso (quisque nostrum... sustinere non potuimus).<br />
Questo non implica l’ammissione da parte dell’oratore che anch’egli <strong>ab</strong>bia <strong>di</strong>fficoltà a<br />
controllare la sua mater familiae, è soltanto una concessione generica alla norma retorica<br />
che prescrive <strong>di</strong> non irritare fin dall’esor<strong>di</strong>o l’u<strong>di</strong>torio che si vuole persuadere.<br />
Catone ricorre quin<strong>di</strong> ad un exemplum, un elemento efficace per delineare il<br />
personaggio, che anche nel seguito del <strong>di</strong>scorso inserisce exempla e massime sentenziose<br />
<strong>di</strong> carattere generale96. L’exemplum mitico cui Catone allude con ostentato scetticismo97 conferisce efficacia alla massima <strong>di</strong> carattere generale che segue imme<strong>di</strong>atamente, che<br />
conferma invece la piena plausibilità della leggenda: non c’è categoria che non possa<br />
costituire un grave pericolo.<br />
96 Appellandosi ad un bagaglio comune <strong>di</strong> esperienze e <strong>di</strong> conoscenze, o al valore universale e<br />
in<strong>di</strong>scutibile <strong>di</strong> una massima o <strong>di</strong> un proverbio, l’oratore conferisce autorevolezza alle proprie<br />
argomentazioni, a patto naturalmente che sappia presentare il caso specifico che gli sta a cuore<br />
come rientrante nella norma generale enunciata.<br />
97 Si noti in aliqua insula, come se l’oratore non sapesse <strong>di</strong> quale isola si tratta, o non ritenesse<br />
importante precisarlo, trattandosi <strong>di</strong> una res ficta. La leggenda narrava che a Lemno tutte le<br />
donne, per aver trascurato il culto <strong>di</strong> Afro<strong>di</strong>te, erano state punite dalla dea con una puzza<br />
repellente, che non lasciava mai i loro corpi. Trascurate dai mariti, che avevano preferito loro delle<br />
donne <strong>di</strong> Tracia, si erano ven<strong>di</strong>cate sterminando tutti gli uomini; si salvò solo Toante, grazie alla<br />
figlia Issìpile.
Letteratura latina B a.a. 2008-2009 mod. 2. Appunti delle lezioni 79<br />
Tractatio 1 La consternatio muliebris (2,4-3,2). Il primo argomento svolto<br />
dall’oratore è un ampio, prolisso sviluppo del concetto enunciato nella massima generale<br />
che chiude l’esor<strong>di</strong>o. Il dubbio con cui la tractatio si apre (atque ego vix statuere possum<br />
utrum...) è retorico: l’oratore considera gravi sia la res, cioè il vero oggetto della contesa,<br />
la proposta <strong>di</strong> <strong>ab</strong>rogazione, sia l’exemplum, il precedente pericoloso che si creerebbe, se si<br />
cedesse alle pressioni delle donne. Questi due aspetti vengono ripresi due volte con<br />
<strong>di</strong>sposizione chiastica da alterum ad nos (l’exemplum) e alterum ad vos (la res), e da<br />
vestra existimatio est (la res) e da consternatio muliebris...ad culpam magistratuum<br />
pertinens (l’exemplum). L’ultima considerazione dà luogo ad un’altra struttura a due<br />
elementi, vobis...an consulibus, ripresa e sviluppata con struttura questa volta parallela<br />
(vobis...nobis).<br />
Ancora prima <strong>di</strong> <strong>di</strong>scutere dell’opportunità <strong>di</strong> mantenere in vigore la legge,<br />
<strong>ab</strong>ilmente subor<strong>di</strong>nando la questione specifica ad un problema d’or<strong>di</strong>ne generale e più<br />
importante, Catone cerca <strong>di</strong> <strong>di</strong>mostrare che la proposta va respinta in primo luogo per<br />
rist<strong>ab</strong>ilire l’or<strong>di</strong>ne interno, per punire la sollevazione delle donne e per prevenire altre<br />
situazioni <strong>di</strong>s<strong>di</strong>cevoli e pericolose come quella che si è creata. L’argomentazione è<br />
fortemente tendenziosa, basata su un uso accorto dei termini, e sull’insinuazione che il<br />
tumulto sia stato ad<strong>di</strong>rittura organizzato dai tribuni. I sostantivi usati per definire la<br />
protesta delle donne sono via via più specifici e più gravi, e anche via via più lontani<br />
dalla realtà. Consternatio descrive il fatto in modo <strong>ab</strong>bastanza obiettivo: in<strong>di</strong>ca una<br />
agitazione <strong>di</strong>sor<strong>di</strong>nata e <strong>di</strong>sorganizzata, determinata per lo più da una forte emozione<br />
(panico, r<strong>ab</strong>bia). Se<strong>di</strong>tio si applica invece ad una agitazione finalizzata ad uno scopo: è la<br />
rivolta <strong>di</strong> una parte del corpo civico, o, in ambito militare, dei soldati, contro il potere<br />
costituito, contro l’autorità; implica il concetto politico <strong>di</strong> <strong>di</strong>scor<strong>di</strong>a. Secessio infine – il<br />
ritirarsi dal resto della popolazione in segno <strong>di</strong> protesta, come aveva fatto la plebe<br />
rifiutando <strong>di</strong> arruolarsi – è il termine più grave e più improprio per descrivere la<br />
consternatio muliebris. Le donne non fanno, né minacciano <strong>di</strong> fare, perché non<br />
potrebbero, una secessio. Impiegando termini che sono sì sinonimi, ma non del tutto<br />
equivalenti, l’oratore cerca <strong>di</strong> evocare il pericolo della <strong>di</strong>scor<strong>di</strong>a civile. La famosa<br />
secessione della plebe sul Monte Sacro aveva ottenuto come risultato l’istituzione del<br />
tribunato della plebe; ora, insinua l’oratore, proprio i tribuni hanno forse istigato le<br />
donne: la questione in <strong>di</strong>scussione potrebbe essere soltanto un pretesto, per chissà quali<br />
oscuri e minacciosi fini 98 . La tendenziosità insita nei termini usati da Catone per<br />
98 E’ vero, come osservano i commentatori (v. Briscoe, Commentary on Livy books 34-37, Oxford,<br />
1981, p. 47), che non è verosimile che Catone, homo novus e plebeo, ricorra ad un argomento che<br />
presuppone <strong>di</strong>sapprovazione per le lotte con cui la plebe era giunta all’eguaglianza civile e politica<br />
con i patrizi, costringendoli, con secessiones, ad accipere leges. <strong>Livio</strong> avrebbe cioè attribuito al suo<br />
personaggio, facendogli alludere con <strong>di</strong>sapprovazione alle “se<strong>di</strong>zioni tribunizie” e alle secessiones,
Letteratura latina B a.a. 2008-2009 mod. 2. Appunti delle lezioni 80<br />
descrivere il comportamento delle donne verrà denunciata, con garbata ironia, dal<br />
tribuno Valerio 99: “ha definito coetus 100 e se<strong>di</strong>tio, e talvolta secessio delle donne il fatto<br />
che le matrone vi <strong>ab</strong>biano chiesto <strong>di</strong> <strong>ab</strong>rogare una legge, promulgata contro <strong>di</strong> loro in<br />
tempi duri, durante la guerra, ora che siamo in tempo <strong>di</strong> pace, e lo stato è prospero e<br />
fiorente. Queste e altre sono parole altisonanti, quelle che si ricercano, lo so bene, per<br />
esagerare l’importanza della questione: e che Catone sia un oratore non solo potente ma<br />
talvolta anche violento, benché per indole sia mite, lo sappiamo tutti” (34,5,5-6).<br />
Passando a descrivere la reazione <strong>di</strong> uno dei consoli, Catone stesso, allo<br />
sconveniente tumulto <strong>di</strong> donne, l’oratore <strong>di</strong>chiara <strong>di</strong> aver provato vergogna:<br />
prob<strong>ab</strong>ilmente prima <strong>di</strong> tutto come supremo magistrato, che si sente in certo modo<br />
respons<strong>ab</strong>ile <strong>di</strong> quella deplorevole situazione, e poi forse anche come vir, uomo e marito,<br />
rappresentante dell’intera categoria maschile. Il <strong>di</strong>scorsetto, che avrebbe voluto rivolgere<br />
alle donne, viene ora impiegato come un nuovo e più aspro rimprovero ai viri, dopo quello<br />
dell’esor<strong>di</strong>o 101 . Le parole sono deliberatamente offensive. La domanda (retorica) an<br />
blan<strong>di</strong>ores...estis? trasforma una riven<strong>di</strong>cazione collettiva in nulla più che un capriccio,<br />
per sod<strong>di</strong>sfare il quale le donne possono solo ricorrere alle blan<strong>di</strong>tiae, lecite però<br />
unicamente nell’intimità della propria casa, con il proprio marito, non in pubblico e con i<br />
mariti altrui: un comportamento che trasforma le rispett<strong>ab</strong>ili matrone in cortigiane.<br />
Anche questa parziale concessione viene però spazzata via, con il quamquam correttivo:<br />
le donne per bene non devono occuparsi <strong>di</strong> politica.<br />
Il solenne richiamo ai maiores, contrapposti a nos che apre il periodo seguente<br />
(§11), illustra quali siano i fines entro i quali le matrone devono restare, o meglio esser<br />
prontamente fatte rientrare. Il riferimento è confuso e impreciso. L’oratore sovrappone<br />
due <strong>di</strong>versi tipi <strong>di</strong> controllo, quello del tutor e quello dei parenti, come se le donne fossero<br />
contemporaneamente sottoposte ad entrambi. Invece le donne <strong>di</strong> con<strong>di</strong>zione libera, sia<br />
all’epoca cui Catone si riferisce sia all’epoca stessa <strong>di</strong> Catone, erano soggette, come i figli<br />
maschi, alla potestas del pater familias; quando si sposavano, entravano a far parte della<br />
famiglia del marito, cadendo sotto la potestas del pater familias <strong>di</strong> quella (non<br />
necessariamente il marito). Solo quando non era sotto la potestas <strong>di</strong> nessuno la donna<br />
veniva giuri<strong>di</strong>camente sottoposta, per tutta la vita, ad un tutor, del cui consenso aveva<br />
un argomento del tutto inadatto al Catone reale. Si può osservare invece che non è affatto<br />
inverosimile che l’oratore, per ottenere lo scopo che si prefigge e trarre dalla sua parte anche la<br />
componente più conservatrice del pubblico, faccia ricorso ad argomenti in contrasto con le sue<br />
personali convinzioni.<br />
99 Come anche la scarsa pertinenza <strong>di</strong> tutta la parte del <strong>di</strong>scorso <strong>di</strong> Catone non de<strong>di</strong>cata alla<br />
confutazione della proposta: plura verba – osserva Valerio – in castigan<strong>di</strong>s matronis quam in<br />
rogatione nostra <strong>di</strong>ssuadenda consumpsit (34,5,3), “ha speso più parole a biasimare le matrone<br />
che a combattere la nostra proposta”.<br />
100 Il termine compare in 2,3, alla fine dell’esor<strong>di</strong>o, non ancora in riferimento <strong>di</strong>retto alle donne.<br />
101 Anche la contrapposizione singulae / universae rinvia a quella con cui si apre il <strong>di</strong>scorso.
Letteratura latina B a.a. 2008-2009 mod. 2. Appunti delle lezioni 81<br />
bisogno per tutti gli atti più importanti 102, soprattutto quelli riguardanti il patrimonio<br />
(ven<strong>di</strong>te, acquisti, donazioni, ere<strong>di</strong>tà). Inoltre, la potestas era esercitata sulla donna dal<br />
padre o dal marito (se questi era il pater familias), non mai però – per quanto sappiamo –<br />
dai fratelli. Elencando tutti insieme i <strong>di</strong>versi tipi <strong>di</strong> controllo esercitati dai maiores sulle<br />
donne, e aggiungendone uno inesistente, Catone crea l’impressione che vi fosse una<br />
quantità più grande del vero <strong>di</strong> ostacoli e cautele saggiamente frapposti dagli antichi alle<br />
iniziative delle donne: ciò conferisce risalto alla scandalosa situazione attuale, in cui esse<br />
invece pretendono <strong>di</strong> partecipare a contiones e comitia 103, e gli uomini glielo concedono.<br />
Catone parla come se si fosse deciso non solo <strong>di</strong> ammettere le donne alla contio, ma<br />
anche <strong>di</strong> farle partecipare al voto. Ciò è ovviamente paradossale, in armonia con il tono<br />
generale <strong>di</strong> questa sezione del <strong>di</strong>scorso. Con suadent e censent <strong>di</strong> proposito l’oratore<br />
ricorre a verbi tecnici del linguaggio politico: suadeo (e <strong>di</strong>ssuadeo) in<strong>di</strong>cano l’intervento<br />
pubblico in appoggio a (o contro) una proposta; censeo, seguito dalla perifrastica passiva,<br />
costituisce la formula ufficiale con cui si esprime il proprio parere sulla proposta104, o, in<br />
senato, il proprio voto. Dopo aver detto che si permette alle donne <strong>di</strong> capessere rem<br />
publicam, Catone le descrive come intente ad esercitare i loro nuovi <strong>di</strong>ritti: con suadent le<br />
donne salgono sulla tribuna a parlare davanti alla contio, con censent sono forse<br />
ammesse ad<strong>di</strong>rittura in senato. La descrizione è ovviamente derisoria, e il bersaglio sono<br />
ancora una volta i viri, cui l’oratore rivolge un altro rimprovero, questa volta <strong>di</strong>rettamente<br />
(2,13-3,2), rudemente esortandoli a riprendere, finché sono in tempo, il controllo <strong>di</strong> esseri<br />
irrazionali e ribelli105, che, una volta strappata questa sola concessione, arriveranno a<br />
dominare gli uomini106. L’insistenza, davvero eccessiva, sul pericolo rappresentato dalle<br />
donne mira a far passare in secondo piano la questione specifica in <strong>di</strong>scussione, come se<br />
essa fosse secondaria rispetto alla necessità <strong>di</strong> recuperare prima che sia troppo tar<strong>di</strong> il<br />
102<br />
Tutti naturalmente <strong>di</strong> carattere privato; l’espressione nullam ne privatam quidem rem, cui si<br />
contrappone rem publicam capessere in riferimento alla situazione attuale, amplifica<br />
retoricamente il rigore del controllo esercitato dagli antichi sulle donne, in quanto i soli atti che<br />
esse potevano compiere erano appunto <strong>di</strong> carattere privato. E’ noto che le donne erano<br />
completamente escluse da qualsiasi partecipazione ufficiale alla vita pubblica.<br />
103<br />
La contio è l’assemblea ufficiale del popolo o dell’esercito, convocata per essere informata <strong>di</strong><br />
qualcosa; il comitium è la parte del foro riservata alle adunanze ufficiali, e anche l’adunanza stessa,<br />
investita <strong>di</strong> competenze elettorali, legislative e giu<strong>di</strong>ziarie, convocata da un magistrato in carica e<br />
sud<strong>di</strong>visa per tribù, curie o centurie, a seconda <strong>di</strong> ciò su cui si deve votare. Quella davanti alla<br />
quale Catone tiene il suo <strong>di</strong>scorso è una contio; la votazione che seguirà il giorno successivo<br />
(cf.34,8,1) vedrà il popolo sud<strong>di</strong>viso per tribù, sarà cioè una riunione dei comitia tributa.<br />
104<br />
Si veda la conclusione del <strong>di</strong>scorso: ego nullo modo <strong>ab</strong>rogandam legem Oppiam censeo, 34,4,21.<br />
105<br />
Il quadro delle donne offerto in questa sezione è fatto in termini generali, non riguarda quelle<br />
che si sono radunate nelle vie, ma la natura femminile in quanto tale. I due sostantivi natura e<br />
animal (“essere vivente”, non si tratta <strong>di</strong> un insulto) sono equivalenti; gli aggettivi che li<br />
qualificano contrappongono invece il dominio esercitato su se stessi (impotens, che può però<br />
significare anche “prepotente”), <strong>di</strong> cui le donne sono incapaci, a quello imposto da altri (indomitus),<br />
cui le donne tendono a ribellarsi.<br />
106<br />
Si noti la correctio in omnium rerum libertatem, immo licentiam, giacché il termine libertas ha<br />
una connotazione generalmente positiva.
Letteratura latina B a.a. 2008-2009 mod. 2. Appunti delle lezioni 82<br />
predominio maschile. In realtà Catone non <strong>di</strong>spone <strong>di</strong> argomenti veramente persuasivi<br />
contro la proposta <strong>di</strong> <strong>ab</strong>rogazione.<br />
Tractatio 2. La legge è utile allo stato (3,3-5). La sezione, assai più breve,<br />
de<strong>di</strong>cata alla lex Oppia si apre con la figura retorica dell’occupatio: la frase at<br />
hercule...deprecantur espone il punto <strong>di</strong> vista dei sostenitori dell’<strong>ab</strong>rogazione e dei <strong>di</strong>ritti<br />
delle donne, contrapponendo iniuria a ius. La risposta dell’oratore è sostenuta e solenne.<br />
Notiamo l’anafora <strong>di</strong> quam, la ripetizione <strong>di</strong> legem, e soprattutto il nesso asindetico<br />
accepistis iussistis, che richiama la formula con cui il magistrato che presiedeva<br />
l’assemblea invitava il popolo a votare: velitis iubeatis –sc. rogo - , cui seguiva il testo<br />
della proposta oggetto della votazione 107. Il passaggio dalla singola legge, che il popolo ha<br />
votato e che non deve essere cancellata, alle considerazioni <strong>di</strong> carattere generale avviene<br />
per mezzo <strong>di</strong> una massima: nulla lex satis commoda omnibus est (§5). Lo stile dell’oratore<br />
prosegue enfatico e solenne; si noti l’interrogatio retorica quid attinebit...?, l’allitterazione<br />
in destruet ac demolietur, che, insieme al significato dei verbi, che evocano scene <strong>di</strong><br />
<strong>di</strong>struzione e rovina, concorre a sottolineare l’inau<strong>di</strong>ta gravità del principio che, a <strong>di</strong>re<br />
dell’oratore, si rischierebbe <strong>di</strong> introdurre, minando la saldezza dell’intera legislazione. Il<br />
tribuno Valerio (34,6,4 ss.) confuta questo argomento tracciando una <strong>di</strong>stinzione fra le<br />
leges che non in tempus aliquod sed perpetuae utilitatis causa in aeternum latae sunt e<br />
quelle che, richieste da circostanze particolari, si possono definire mortales, e possono e<br />
107 V. Gellio, 5,19,9. La formula in questo caso sottopone all’approvazione del popolo il passaggio<br />
<strong>di</strong> una persona dalla propria ad un’altra familia, con l’adozione detta adrogatio (quella, appunto,<br />
che avviene per populi rogationem): Eius rogationis verba haec sunt: 'Velitis iubeatis, uti L. Valerius<br />
L. Titio tam iure legeque filius siet [=sit], quam si ex eo patre matreque familias eius natus esset,<br />
utique ei vitae necisque in eum potestas siet, uti patri endo [=in] filio est. Haec ita, uti <strong>di</strong>xi, ita vos,<br />
Quirites, rogo.', “Le parole <strong>di</strong> questa consultazione sono le seguenti: ‘Se vogliate e or<strong>di</strong>niate che<br />
Lucio Valerio <strong>di</strong>venti figlio <strong>di</strong> Lucio Tizio per <strong>di</strong>ritto e secondo la legge, come se fosse nato da quel<br />
padre e dalla moglie <strong>di</strong> lui, e che egli (sc. Lucio Tizio) <strong>ab</strong>bia su <strong>di</strong> lui <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> vita e <strong>di</strong> morte, come<br />
lo ha un padre sul proprio figlio. Questo, Quiriti, così come ho detto, chiedo a voi’ ”. Identica è la<br />
formula ricordata da <strong>Livio</strong> per la rogatio relativa all’inchiesta sulla pecunia regis Antiochi, in 38,54,<br />
3-4: Fuit autem rogatio talis: 'Velitis iubeatis, Quirites, quae pecunia capta <strong>ab</strong>lata coacta <strong>ab</strong> rege<br />
Antiocho est quique sub imperio eius fuerunt, quod eius in publicum relatum non est, uti de ea re Ser.<br />
Sulpicius praetor urbanus ad senatum referat, quem eam rem velit senatus quaerere de iis, qui<br />
praetores nunc sunt.' , “La consultazione fu <strong>di</strong> questo tenore: ‘Se vogliate e or<strong>di</strong>niate, Quiriti, che<br />
del denaro preso, sottratto, ricavato dal re Antioco e da quanti erano sotto il suo dominio, per<br />
quella parte <strong>di</strong> esso che non è stata versata all’erario, il pretore urbano Servio Sulpicio riferisca al<br />
senato, perché il senato decida a quale dei pretori in carica assegnare l’inchiesta’ ”. La formula<br />
velitis iubeatis si conserva anche nella interrogativa <strong>di</strong>retta, v. <strong>Livio</strong> 22,10,2 (dopo la sconfitta del<br />
Trasimeno): Rogatus in haec verba populus: ‘Velitis iubeatisne haec sic fieri? Si res publica populi<br />
Romani Quiritium ad quinquennium proximum [...] salva servata erit ...’, “Il popolo fu consultato<br />
con queste parole: ‘Volete e or<strong>di</strong>nate che si faccia così? Se lo stato del popolo romano dei Quiriti<br />
per i prossimi cinque anni [...] si manterrà sano e salvo...’ ”. Si tratta della promessa in voto <strong>di</strong> un<br />
ver sacrum, cioè del sacrificio delle primizie <strong>di</strong> tutte le greggi: la formulazione del voto è molto<br />
lunga, per questo prob<strong>ab</strong>ilmente viene sintatticamente svincolata dalla <strong>di</strong>pendenza da velitis<br />
iubeatis.
Letteratura latina B a.a. 2008-2009 mod. 2. Appunti delle lezioni 83<br />
debbono essere <strong>ab</strong>rogate, quando non sussistono più i motivi contingenti che le hanno<br />
causate; la lex Oppia, sostiene persuasivamente, fa parte <strong>di</strong> questa seconda categoria <strong>di</strong><br />
leggi.<br />
Tractatio 3. I motivi delle donne sono cattivi (3,6-9). Con finta<br />
con<strong>di</strong>scendenza, con un atteggiamento ostentatamente aperto e tollerante (volo tamen<br />
au<strong>di</strong>re...), Catone prende ora in considerazione le ragioni <strong>di</strong> quella parte della popolazione<br />
cui la legge reca danno, per <strong>di</strong>mostrare che tali ragioni – che non devono in ogni caso mai<br />
prevalere sull’interesse della maggioranza e dello stato nel suo complesso, come l’oratore<br />
ha appena detto – non sono né valide né serie. Per <strong>di</strong>mostrare quanto scandalosamente<br />
frivoli e biasimevoli siano i motivi che hanno indotto le matrone ad uscire per le strade,<br />
Catone ricorre ad exempla storici. Ricorda, nella forma enfatica della interrogatio retorica,<br />
altre due occasioni, risalenti entrambe alla seconda guerra punica, in cui le donne<br />
avevano <strong>ab</strong>bandonato, come ora, il loro consueto riserbo, per scopi tuttavia ben più seri.<br />
Il primo, narrato da <strong>Livio</strong> in 22, 58-61, riguarda il riscatto dei prigionieri catturati<br />
da Annibale dopo la battaglia <strong>di</strong> Canne. E’ vero che in quella circostanza feminas quoque<br />
metus ac necessitas in foro turbae virorum miscuerat (22,60,1); ma anche la turba virorum,<br />
costituita dai parenti dei prigionieri, non <strong>di</strong>versamente dalle feminae, aveva fatto<br />
pressioni sul senato perché accettasse la proposta <strong>di</strong> Annibale. La decisione presa infine<br />
dal senato, <strong>di</strong> non pagare il riscatto, era stata molto sofferta, e preceduta da una lunga<br />
<strong>di</strong>scussione. La versione che Catone offre <strong>di</strong> quella vicenda contrappone invece le donne<br />
a tutti gli altri, come se esse soltanto avessero avuto a cuore il riscatto dei loro congiunti.<br />
Con negastis poi egli si rivolge a tutto il popolo presente, con una duplice alterazione dei<br />
fatti: non solo molti, come si è detto, avevano appoggiato e con<strong>di</strong>viso le preghiere delle<br />
donne, ma la decisione era stata presa dal solo senato, non era stata sottoposta al voto<br />
popolare.<br />
Il secondo episo<strong>di</strong>o, che non necessita <strong>di</strong> essere alterato agli scopi dell’oratore,<br />
corrisponde nella sostanza al racconto che <strong>Livio</strong> ne fa in prima persona108: nel 204, per<br />
propiziare la vittoria, in ossequio ad una in<strong>di</strong>cazione tratta dai Libri Sibillini e confermata<br />
e precisata dal responso dell’oracolo <strong>di</strong> Delfi, il simulacro della Magna Mater Cìbele era<br />
stato solennemente trasportato, per concessione del re Attalo <strong>di</strong> Pergamo, a Roma da<br />
Pessinunte in Frigia, dove sorgeva un importante tempio della dea ed era conservata la<br />
pietra sacra che la rappresentava. Il compito <strong>di</strong> accogliere degnamente e custo<strong>di</strong>re la dea<br />
108 In 29,10,4-11,8 e 14, 5-14
Letteratura latina B a.a. 2008-2009 mod. 2. Appunti delle lezioni 84<br />
in forma <strong>di</strong> pietra era stato assegnato, secondo la prescrizione dell’oracolo 109, a Scipione,<br />
accompagnato da tutte le matrone fin sul lido <strong>di</strong> Ostia. Il breve riferimento che Catone fa<br />
alla vicenda è limitato alla partecipazione delle matrone, ma è corretto.<br />
Nel <strong>di</strong>scorso attribuito al tribuno Valerio <strong>Livio</strong> inserisce un numero maggiore <strong>di</strong><br />
exempla <strong>di</strong> questo tipo. Che cosa c’è <strong>di</strong> inconsueto, argomenta persuasivamente il<br />
tribuno, se le donne si sono mostrate in pubblico, per una questione che <strong>di</strong>rettamente le<br />
riguarda? Lo hanno fatto spesso in passato, e sempre nell’interesse dello stato (34,5,7); il<br />
tribuno passa quin<strong>di</strong> in rassegne altre occasioni in cui le matrone in publico<br />
apparuerunt 110 . Fingendo <strong>di</strong> ricavare gli esempi proprio dalle Origines <strong>di</strong> Catone 111 ,<br />
Valerio ne trae una conclusione opposta: “Ciò che nessuno si è scandalizzato le donne<br />
facessero a vantaggio <strong>di</strong> tutti, ora ci scandalizziamo lo facciano per una cosa che le<br />
riguarda? [...] I padroni ascoltano le preghiere dei loro servi, e noi ci in<strong>di</strong>gniamo che<br />
donne rispett<strong>ab</strong>ili ci rivolgano una richiesta?” (34,5,12-13)<br />
Catone invece, ovviamente, sfrutta ai propri fini il contrasto fra l’importanza delle<br />
occasioni che ha ricordato e i motivi biasimevoli che ora animano la rivolta delle donne112, mettendo in bocca a loro stesse una <strong>di</strong>chiarazione sfacciata e arrogante. Esse sono<br />
rappresentate come intente a celebrare il trionfo sulla legge <strong>ab</strong>rogata: quella carrozza il<br />
cui uso la legge aveva loro vietato equivale al carro del generale vittorioso; l’oro e la<br />
porpora sono i medesimi che adornano il mantello del generale che celebra il trionfo. La<br />
coppia “oro e porpora” compare due volte nei frammenti <strong>di</strong> Catone113, e ben tre114 nel<br />
<strong>di</strong>scorso el<strong>ab</strong>orato da <strong>Livio</strong> per il suo personaggio: è prob<strong>ab</strong>ile che lo storico tragga il<br />
nesso dalle opere <strong>di</strong> Catone, e lo impieghi per echeggiare il suo stile, il suo modo <strong>di</strong><br />
tuonare contro il lusso. Le rovinose conseguenze dell’<strong>ab</strong>rogazione della legge, fatte<br />
esprimere dalle donne stesse (ne ullus modus sumptibus, ne luxuriae sit, § 9), offrono il<br />
109<br />
Naturalmente l’oracolo, secondo le sue consuetu<strong>di</strong>ni, non aveva in<strong>di</strong>cato Scipione per nome, ma<br />
aveva prescritto che a prendersi cura della dea fosse il vir optimus <strong>di</strong> cui Roma <strong>di</strong>sponeva; e i<br />
senatori Publium Scipionem [...] iu<strong>di</strong>caverunt in tota civitate virum bonorum optimum esse, 39,14,8.<br />
110<br />
In 34,5,8-10 sono ricordati, oltre al secondo degli exempla <strong>di</strong> Catone, questi episo<strong>di</strong>: l’intervento<br />
durante il proelium fra Romani e S<strong>ab</strong>ini, intercursu matronarum [...] sedatum (in questo caso in<br />
verità le donne erano s<strong>ab</strong>ine e non romane); quello per <strong>di</strong>stogliere Coriolano dal proposito <strong>di</strong><br />
marciare contro Roma alla testa dei Volsci; l’offerta dell’oro allo stato per riscattare la città<br />
conquistata dai Galli (evidentemente anche Valerio sapeva che il riscatto era stato pagato); l’aiuto<br />
offerto durante la seconda punica all’erario esausto dalle vedove che offrirono il loro denaro.<br />
111<br />
Tuas adversus te Origines revolvam, <strong>di</strong>chiara Valerio (34,5,7). L’espe<strong>di</strong>ente è felice e molto<br />
efficace, ma cronologicamente errato: nell’anno del suo consolato Catone non aveva ancora<br />
composto, e forse neppure progettato, la sua opera storica, cui si de<strong>di</strong>cò nella vecchiaia, come si<br />
apprende da Cornelio Nepote (Senex historias scribere instituit, Cato, 3,3): dunque dopo il 174,<br />
poiché gli antichi facevano generalmente iniziare la senectus a 60 anni.<br />
112<br />
Contrasto sottolineato dall’impiego dal medesimo tipo <strong>di</strong> proposizione: ut [...] fulgamus e ut [..]<br />
vectemur , come sopra ut captivi...re<strong>di</strong>mantur.<br />
113<br />
Origines, fr. 113 Peter: mulieres opertae auro purpuraque; orat.rel fr. 172 Sblendorio Cugusi (=<br />
224 Malcovati): fures privatorum furtorum in nervo atque in compe<strong>di</strong>bus aetatem agunt, fures<br />
publici in auro atque in purpura.<br />
114<br />
34,3,9; 4,10 e 14.
Letteratura latina B a.a. 2008-2009 mod. 2. Appunti delle lezioni 85<br />
passaggio al punto successivo, in cui il <strong>di</strong>scorso si allontana alquanto dal tema specifico,<br />
per trattare, in una sorta <strong>di</strong> <strong>di</strong>gressione, della generale corruzione dei mores, provocata e<br />
favorita dall’accresciuto benessere materiale, uno dei temi cari al Catone reale.<br />
Tractatio 4. Digressione (4,1-11) <strong>Livio</strong> attribuisce al suo personaggio un<br />
richiamo, molto verosimile, alle molte occasioni in cui già i Romani avevano avuto<br />
occasione <strong>di</strong> u<strong>di</strong>re <strong>di</strong>scorsi <strong>di</strong> Catone in deplorazione <strong>di</strong> avaritia e luxus, capaci <strong>di</strong><br />
mandare in rovina omnia magna imperia (un’altra massima sentenziosa), e introdotti in<br />
Roma dalle inlecebrae e dalle gazae <strong>di</strong> Grecia e d’Asia. In realtà, nel momento in cui<br />
Catone parla, l’Asia non era respons<strong>ab</strong>ile <strong>di</strong> nessuno dei mali lamentati dall’oratore:<br />
nessun esercito romano aveva ancora messo le mani sui tesori orientali, giacché la prima<br />
spe<strong>di</strong>zione in Asia, quella contro Antioco, avvenne soltanto cinque anni più tar<strong>di</strong>. <strong>Livio</strong><br />
non si cura tanto dell’esattezza cronologica, quanto piuttosto <strong>di</strong> assegnare al suo<br />
personaggio un argomento topico ben appropriato a questo contesto. L’Asia era da<br />
sempre considerata – già dai Greci – il luogo della vita molle e <strong>di</strong>ssoluta, corrotta e<br />
corruttrice; e un luogo comune della storiografia romana consisteva nell’in<strong>di</strong>care il<br />
momento preciso in cui la corruzione era entrata in Roma, minando con l’avaritia e la<br />
luxuria 115 la compatta saldezza dei mores antiqui. La data varia sensibilmente da un<br />
autore all’altro116, ma è significativo che un ruolo importante nel processo <strong>di</strong> corruzione<br />
sia sempre attribuito all’Asia, che fa conoscere ai rozzi e virtuosi Romani un sistema <strong>di</strong><br />
vita più piacevole, rendendoli sensibili e soggetti al fascino pericoloso delle raffinatezze,<br />
degli oggetti preziosi, delle opere d’arte. Quest’ultimo tema (le opere d’arte) viene svolto<br />
da Catone in riferimento ad un’epoca più antica, quella della conquista <strong>di</strong> Siracusa nel<br />
212, quando Marcello fece portare a Roma da quella città molte statue <strong>di</strong> dèi, togliendole<br />
sacrilegamente dai loro templi. La vendetta degli dèi ostili consisterebbe, secondo<br />
l’oratore, nell’aver ispirato ai Romani <strong>di</strong>sprezzo per le antiche immagini in terracotta (o in<br />
115 Si veda, per l’accostamento dei due concetti, l’analoga formulazione <strong>di</strong> Sallustio, Cat. 5,8:<br />
pessuma ac <strong>di</strong>vorsa inter se mala, luxuria atque avaritia; anche <strong>Livio</strong>, in praef. 12 menziona questi<br />
due vizi, ma per rilevare quanto a lungo Roma ne fu immune.<br />
116 Una parte della tra<strong>di</strong>zione annalistica, e <strong>Livio</strong> stesso (39,6,7) in<strong>di</strong>cano il ritorno dell’esercito<br />
romano dalla spe<strong>di</strong>zione vittoriosa contro Antioco III <strong>di</strong> Siria come la causa dell’aumento della<br />
luxuria. Sallustio (Cat. 10,1-6) in<strong>di</strong>vidua il punto <strong>di</strong> partenza del processo <strong>di</strong> corruzione nella<br />
<strong>di</strong>struzione <strong>di</strong> Cartagine, nel 146, e il punto d’arrivo nel ritorno dall’Asia dell’esercito <strong>di</strong> Silla,<br />
nell’88, dopo la vittoria su Mitridate (Cat. 11,5-6). Così Sallustio descrive la perniciosa influenza<br />
esercitata dai luoghi sui soldati, già guastati dall’allentamento della <strong>di</strong>sciplina permesso da Silla<br />
per legare a sè l’esercito: “I luoghi attraenti e ricchi <strong>di</strong> allettamenti facilmente avevano<br />
nell’inattività reso fiacchi gli animi fieri dei soldati: qui per la prima volta l’esercito romano si<br />
avvezzò alla compagnia <strong>di</strong> concubine e alle gozzoviglie, imparò ad ammirare statue, quadri, vasi<br />
cesellati, e a farne razzìa in luoghi privati e pubblici, e a spogliare i santuari, e a contaminare ogni<br />
cosa, sacra e profana”.
Letteratura latina B a.a. 2008-2009 mod. 2. Appunti delle lezioni 86<br />
legno) delle <strong>di</strong>vinità, primo segno <strong>di</strong> ce<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> fronte alla luxuria, che porterà con sé<br />
anche l’ammirazione per gli ornamenta <strong>di</strong> Corinto e <strong>di</strong> Atene 117.<br />
Ad un’epoca ancora più antica (280) riporta la menzione <strong>di</strong> Pirro: dopo la battaglia<br />
<strong>di</strong> Eraclea egli tentò <strong>di</strong> intavolare con il senato trattative <strong>di</strong> pace; i doni offerti erano un<br />
tentativo <strong>di</strong> far pressione perché il senato accogliesse la proposta <strong>di</strong> pace, e furono<br />
effettivamente offerti anche alle donne, come riferiscono altre fonti 118 , e tutti<br />
in<strong>di</strong>stintamente, uomini e donne, li rifiutarono. Catone ovviamente ha interesse a<br />
prendere in considerazione solo il rifiuto delle donne <strong>di</strong> allora, per contrapporlo più<br />
avanti (4,11) all’opposto comportamento attuale (solo immaginato). Il confronto, molto<br />
tendenzioso, è posto a conclusione <strong>di</strong> una analisi delle ragioni della incorruttibilità delle<br />
donne romane <strong>di</strong> un tempo, corredata da un paragone <strong>di</strong> tono sentenzioso (sicut ante<br />
morbos...§ 8) e da due nuovi exempla storici, che tendono a presentare tutte le<br />
<strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> legge (dunque anche la lex Oppia) come introdotte per frenare pericolose e<br />
già <strong>di</strong>laganti deviazioni dal retto comportamento119. Tractatio 5 Conseguenze dell’<strong>ab</strong>rogazione della legge (4,12-18). Dopo la<br />
parentesi costituita dalla deplorazione moralistica della corruzione dei costumi, Catone<br />
torna a considerare la situazione presente, per mostrare quanto siano meschini i motivi<br />
veri e taciuti della richiesta delle donne. Per la prima volta l’oratore non le considera più<br />
tutte insieme, come ostinatamente concor<strong>di</strong> nella biasimevole richiesta, ma da questo<br />
punto in avanti le sud<strong>di</strong>vide in due gruppi: le povere (invi<strong>di</strong>ose e sciocche) e le ricche<br />
(superbe). Alla dubbia consolazione che può offrire alle povere (la legge vi vieta <strong>di</strong> avere<br />
ciò che non potreste comunque avere, e dunque non avete motivo <strong>di</strong> protestare), Catone<br />
premette un severo richiamo ai valori positivi della parsimonia e della paupertas120, <strong>di</strong> cui<br />
nessuno deve provar vergogna. Ben comprensibile è invece la protesta delle ricche, che<br />
vorrebbero finalmente tornare a <strong>di</strong>stinguersi dalle povere; Catone fa esprimere questa<br />
117<br />
Non ancora conquistate nel 195, ma conosciute dai Romani durante la seconda guerra<br />
macedonica.<br />
118<br />
Plutarco, Pirro, 18,4; Valerio Massimo 4,3,14.<br />
119<br />
Entrambe le leggi menzionate venivano spesso aggirate. La lex Licinia (una delle leggi Licinie-<br />
Sestie del 367) fissava un limite all’estensione degli appezzamenti <strong>di</strong> ager publicus che ogni privato<br />
poteva occupare; la cifra <strong>di</strong> 500 iugeri è però da riferire certamente ad un’epoca successiva,<br />
poiché nel 367 Roma non <strong>di</strong>sponeva ancora <strong>di</strong> terra conquistata <strong>di</strong> estensione compatibile con tale<br />
cifra. La lex Cincia, proposta da Marco Cincio Alimento, tribuno della plebe, e approvata nel 205,<br />
vietava agli avvocati <strong>di</strong> percepire compensi per <strong>di</strong>fendere un imputato in un processo o assistere<br />
un cliente in una causa civile, e forse anche semplicemente per dare consigli legali: sembra poco<br />
verosimile infatti che i plebei dovessero ricorrere così spesso alle prestazioni <strong>di</strong> un avvocato in<br />
tribunale da <strong>di</strong>ventare “tributari fissi” del senato. Erano naturalmente solo i senatori, oratori ed<br />
esperti <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto, a poter offrire queste prestazioni. La lex Cincia fu <strong>ab</strong>rogata solo nel 47 d.C.,<br />
dall’imperatore Clau<strong>di</strong>o (Tacito, ann.11,5-7).<br />
120<br />
Il termine in<strong>di</strong>che la modestia <strong>di</strong> mezzi, non la povertà, l’in<strong>di</strong>genza (egestas).
Letteratura latina B a.a. 2008-2009 mod. 2. Appunti delle lezioni 87<br />
meschina e malevola motivazione <strong>di</strong>rettamente da una rappresentante della categoria,<br />
con un altro breve brano in <strong>di</strong>scorso <strong>di</strong>retto.<br />
Avviandosi a concludere il suo <strong>di</strong>scorso, l’oratore torna a rivolgersi ai viri che si<br />
apprestano ad andare a votare, con l’appellativo ufficiale <strong>di</strong> Quirites, e prospetta loro le<br />
conseguenze rovinose che l’<strong>ab</strong>rogazione della legge produrrebbe: liti domestiche e la<br />
rovina economica. Ritorna in questa sezione finale l’espressione ambigua alieni viri<br />
(“uomini estranei” e “mariti altrui”) già usata in 2,9, che implicitamente equiparava le<br />
matrone scese in piazza a cortigiane: essa funge da rinvio al tema della prima parte del<br />
<strong>di</strong>scorso, il biasimo per i viri che non impe<strong>di</strong>scono alle loro donne <strong>di</strong> tenere un<br />
comportamento tanto sconveniente. Ma il tema principale della sezione finale è un altro,<br />
e l’oratore si impegna a <strong>di</strong>mostrare che, una volta cancellata la legge, sia cedere ai<br />
capricci delle donne sia non cedere sarà egualmente rovinoso. Molto efficace è, alla fine<br />
del § 4,18, il passaggio ai verbi al singolare (es; facies), come se l’oratore volesse rivolgersi<br />
personalmente a ciascuno degli ascoltatori.<br />
Conclusio (4,19-21). Un breve riepilogo degli argomenti principali e la mozione<br />
degli affetti dovevano, secondo le norme dei retori, concludere il <strong>di</strong>scorso. La piana<br />
asserzione che l’<strong>ab</strong>rogazione della legge non riporterà la situazione nelle con<strong>di</strong>zioni<br />
precedenti (che vale come succinto riepilogo dei temi svolti, soprattutto nell’ampia<br />
<strong>di</strong>gressione sulla corruzione dei mores) è rafforzata da due massime <strong>di</strong> tono sentenzioso,<br />
ben adatte a caratterizzare l’oratore. La mozione degli affetti è affidata invece alla<br />
personificazione della luxuria, che si scatenerà come una bestia feroce non appena sarà<br />
liberata dai vincula della legge.<br />
La formulazione ufficiale della proposta dell’oratore, e il convenzionale, solenne<br />
richiamo agli dèi chiudono il <strong>di</strong>scorso.
Letteratura latina B a.a. 2008-2009 mod. 2. Appunti delle lezioni 88<br />
Bibl. consultata<br />
R.M. OGILVIE, A Commentary on Livy. Books I-V, Oxford, 1965<br />
S.P. OAKLEY, A Commentary on Livy. Books I-X: vol I, Oxford, 1997 (VI); vol. II 1998 (VII-<br />
VIII); vol. III 2005 (IX).<br />
J. BRISCOE, A Commentary on Livy, Oxford, 1973 (XXXI-XXXIII); 1981 (XXXIV-XXXVII);<br />
2008 (XXXVIII-XL)<br />
M. MAZZA, Storia e ideologia in <strong>Livio</strong>, Catania, 1966<br />
M.A.S. ROBBINS, Heroes and Man in Livy 1-10, Ann Arbor (Michigan), 1968<br />
P.G. WALSH, Livy. His Historical Aims and Methods, Cambridge, 1970<br />
G. CIPRIANI, L’epifania <strong>di</strong> Annibale, Adriatica ed., 1984<br />
J. FRIES, Der Zweikampf. Historische und literarische Aspekte seiner Darstellung bei T.<br />
Livius, Hain, 1985<br />
T.J. MOORE, Artistry and Ideology: Livy’s Voc<strong>ab</strong>ulary of Virtue, Frankfurt am Main, 1989<br />
D.S. LEVENE, Religion in Livy, Leiden, 1993<br />
R. CHEVALLIER et R. POIGNAULT (a cura <strong>di</strong>), Presence de Tite-Live. Hommage au<br />
Professeur P. Jal, Tours, 1994.<br />
G.B. MILES, Livy. Reconstructing Early Rome, Ithaca and London, 1995<br />
G.FORSYTHE, Livy and Early Rome, Stuttgart, 1999
Letteratura latina B a.a. 2008-2009 mod. 2. Appunti delle lezioni 89<br />
INDICE<br />
NOTIZIE SULL’AUTORE. ATTIVITÀ LETTERARIA p. 2<br />
Data <strong>di</strong> nascita p. 2<br />
Morte p. 3<br />
Opere filosofiche p. 3<br />
Opinioni sullo stile p. 3<br />
Rapporti con Augusto p. 5<br />
Con<strong>di</strong>zione sociale ed educazione p. 6<br />
Patavinitas p. 6<br />
Composizione dell’opera storica p. 6<br />
Libri conservati e periǒchae p. 7<br />
GLI AB URBE CONDITA LIBRI p. 9<br />
<strong>Tito</strong>lo p. 9<br />
Fonti documentarie p. 9<br />
Fonti letterarie e metodo del loro impiego p. 12<br />
CARATTERI IDEOLOGICI DELLA STORIA DI LIVIO p. 14<br />
Religione: pietas e fides p. 14<br />
Politica interna p. 19<br />
Politica estera e guerra p. 23<br />
Vita privata p. 27<br />
LA PREFAZIONE p. 29<br />
§§ 1-2 p. 30<br />
§ 3 p. 31<br />
§ 4 p. 32<br />
§ 5 p. 32<br />
§ 6 p. 34<br />
§§ 7-9 p. 35<br />
§ 10 p. 38<br />
§§ 11-12 p. 38<br />
§ 13 p. 41<br />
IL PRIMO LIBRO. STORIA DELLA MONARCHIA p. 42<br />
IL REGNO DI ROMOLO p. 42<br />
Il sinecismo s<strong>ab</strong>ino. Prima fase: il ratto (1,9) p. 44<br />
Seconda fase. Il tempio <strong>di</strong> Giove Feretrio. (1,10-11,4) p. 45<br />
Terza fase. La guerra contro i S<strong>ab</strong>ini (1, 11,5-13) p. 47<br />
MARCO FURIO CAMILLO p. 53<br />
Asse<strong>di</strong>o e resa <strong>di</strong> Faleri (5,26,9-27) p. 54<br />
Camillo e i Galli (5,47-49) p. 56<br />
NOVA AC NIMIS CALLIDA SAPIENTIA (42,47) p. 58<br />
DUELLI p. 61<br />
Il duello <strong>di</strong> <strong>Tito</strong> Manlio Torquato contro un Gallo (7,9-11,1) p. 62<br />
Cenni ad altri duelli p. 65
Letteratura latina B a.a. 2008-2009 mod. 2. Appunti delle lezioni 90<br />
L’ INIZIO DELLA TERZA DECADE p. 68<br />
Prefazione. Il giuramento <strong>di</strong> Annibale (21,1) p. 69<br />
Ritratto <strong>di</strong> Annibale (21,4) p. 72<br />
DISCORSO DI CATONE CONTRO L’ABROGAZIONE DELLA LEX OPPIA (34,2-4) p. 76<br />
Esor<strong>di</strong>o (2,1-3) p. 78<br />
Tractatio 1 La consternatio muliebris (2,4-3,2) p. 79<br />
Tractatio 2. La legge è utile allo stato (3,3-5) p. 82<br />
Tractatio 3. I motivi delle donne sono cattivi (3,6-9) p. 83<br />
Tractatio 4. Digressione (4,1-11) p. 85<br />
Tractatio 5 Conseguenze dell’<strong>ab</strong>rogazione della legge (4,12-18) p. 86<br />
Conclusio (4,19-21) p. 87<br />
Bibliografia consultata p. 88