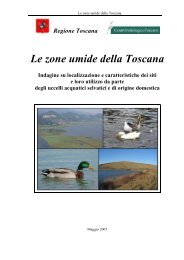Scarica il pdf - CentrOrnitologicoToscano
Scarica il pdf - CentrOrnitologicoToscano
Scarica il pdf - CentrOrnitologicoToscano
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
36 Gli aironi coloniali in Toscana. Andamento, distribuzione e conservazione Le specie 37<br />
Tutela<br />
Per <strong>il</strong> continente europeo esistono valutazioni ripetute della consistenza<br />
dell’Airone rosso che permettono di seguirne l’andamento<br />
nel tempo: la popolazione nidificante era stata stimata in 49.000-<br />
100.000 coppie all’inizio degli anni ’90 ed era ritenuta in decremento<br />
generalizzato e dunque con uno stato di conservazione sfavorevole:<br />
era pertanto classificata come SPEC3 - Vulnerab<strong>il</strong>e (Tucker e<br />
Heath, 1994). Tale stima della consistenza era confermata pochi<br />
anni dopo, quando la popolazione europea era valutata in 49.000-<br />
105.000 coppie (Kushlan e Hafner, 2000). Successivamente, valutazioni<br />
forse più accurate relativamente alla Russia, hanno portato ad<br />
una profonda revisione di tali stime: la popolazione europea è stata<br />
valutata in 29.000-42.000 coppie, confermandone la classificazione<br />
come SPEC3-in (probab<strong>il</strong>e) declino (BirdLife International 2004).<br />
L’andamento della specie nel periodo esaminato è però alquanto<br />
differente all’interno del continente: dopo una prima fase di declino<br />
generalizzato tra <strong>il</strong> 1970 ed <strong>il</strong> 1990, l’Airone rosso ha conosciuto un<br />
recupero nell’Europa mediterranea e centrale mentre in quella orientale<br />
continuerebbe a diminuire. In particolare ciò avverrebbe proprio<br />
a carico della popolazione russa che rappresenta circa un terzo di<br />
quella dell’intero continente.<br />
La popolazione italiana rappresenta <strong>il</strong> 4-7% di quella europea (BirdLife<br />
International, 2004). I risultati dei censimenti nazionali riportano<br />
900 coppie nel 1981 (Fasola et al., 1981), oltre 1.000 nel 1986 e<br />
2.268 nel 2002 (Fasola et al., 2007), per circa <strong>il</strong> 70% concentrate<br />
nelle regioni nord-orientali (Em<strong>il</strong>ia-Romagna centro-orientale, Veneto<br />
e, in misura minore, Friuli-Venezia-Giulia). Per gli anni successivi al<br />
2002 non si hanno informazioni circa l’andamento della specie in<br />
tutto <strong>il</strong> paese: nell’Italia nord-occidentale essa è ulteriormente aumentata<br />
fino a circa 600 coppie (Fasola et al., 2010 e 2011); in<br />
Veneto <strong>il</strong> censimento eseguito nel 2009 ha registrato un calo di circa<br />
<strong>il</strong> 50% rispetto al 2002 (336-384 coppie contro 667) (Scarton et al.,<br />
2010); nel Lazio, dove la nidificazione avveniva in modo dubitativo in<br />
un singolo sito, si è consolidata intorno alle 10 coppie in quattro siti<br />
(Angelici et al., 2009).<br />
Nella lista rossa italiana lo stato di conservazione dell’Airone rosso<br />
è stato classificato di minima preoccupazione (LC; Peronace et al.,<br />
in stampa).<br />
L’andamento positivo registrato in Toscana nel corso degli ultimi<br />
trent’anni risulta quindi sim<strong>il</strong>e a quello osservato in Italia o almeno<br />
nella maggior parte del paese, anche se l’incremento osservato fino<br />
ai primi anni 2000 risulta più marcato a livello regionale.<br />
La popolazione toscana di Airone rosso rappresentava nel 1981<br />
circa <strong>il</strong> 4% di quella nazionale, mentre nel 2002 circa l’8%. Inoltre<br />
essa costituisce praticamente la totalità della popolazione dell’Italia<br />
peninsulare. La popolazione toscana è considerata vulnerab<strong>il</strong>e (Chiti-<br />
Batelli e Puglisi, 2008).<br />
L’Airone rosso è:<br />
- inserito nell’allegato I della Direttiva Uccelli (2009/147/CE);<br />
- inserito nell’allegato II della Convenzione di Berna;<br />
- inserito nell’allegato II della Convenzione di Bonn;<br />
- inserita tra le specie di interesse regionale ai sensi della LRT<br />
56/2000 e successive modifiche;<br />
- specie protetta ai sensi della LN 157/92.<br />
Airone bianco maggiore (Foto R.<br />
Romanelli)<br />
Airone bianco maggiore Casmerodius albus<br />
Specie politipica, la sua distribuzione include Nord e Sud-America,<br />
Europa, Asia ed Africa; Ardea modesta, talvolt a sottospecie<br />
dell’Airone bianco maggiore, è presente in Australia ed Asia sudorientale<br />
(Kushlan e Hancock, 2005).<br />
La sottospecie nominale è presente dall’Europa occidentale fino alla<br />
Cina settentrionale, in una fascia latitudinale che in Europa occidentale<br />
va dalle coste settentrionali del Mediterraneo all’Olanda mentre,<br />
verso est, scende attraverso la penisola balcanica fino all’Iran<br />
e a nord non supera l’isoterma di 20°C in luglio (Hagemeijer e Blair,<br />
1997; Kushlan e Hancock, 2005). All’interno del suo areale europeo,<br />
ha una distribuzione tutt’altro che uniforme, in parte frutto di una<br />
recente espansione verso ovest e che ha nell’Ungheria, Moldavia,<br />
Ucraina e Russia <strong>il</strong> nucleo di diffusione più continua; nel corso degli<br />
anni ’70 la sua presenza invernale è divenuta crescente nell’Europa<br />
occidentale ed è stata la premessa per l’insediamento di alcune piccole<br />
colonie, in particolare nei primi anni ’90, in paesi dove prima<br />
non nidificava, quali Olanda, Lettonia, Francia ed Italia (Hagemeijer<br />
e Blair, 1997; Kushlan e Hafner, 2000). La popolazione europea è<br />
concentrata in Russia (BirdLife International, 2004).<br />
Le popolazioni europee di Airone bianco maggiore sono migratrici<br />
parziali e dispersive; la migrazione autunnale sembra spesso indotta<br />
dalla formazione del ghiaccio e le aree di svernamento sono localizzate<br />
nell’Europa occidentale, nel bacino del Mediterraneo, ma è<br />
riportato anche un singolo dato di ricattura nell’Africa sub-sahariana<br />
di un individuo russo (Voisin, 1991; Kushlan e Hafner, 2000).<br />
In Toscana era una specie rara fino ai primi anni ’80, svernante regolare<br />
e migratrice; a partire dai primi anni ’90 si sono verificati casi di<br />
estivazione (Tellini Florenzano et al., 1997), cui ha fatto seguito nel<br />
2003 la prima nidificazione a Fucecchio (Bartolini, 2004). Attualmente<br />
quindi la specie è presente tutto l’anno, con massimi in periodo