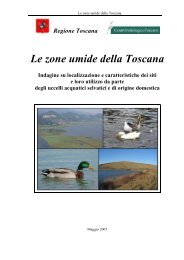Scarica il pdf - CentrOrnitologicoToscano
Scarica il pdf - CentrOrnitologicoToscano
Scarica il pdf - CentrOrnitologicoToscano
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
72 Gli aironi coloniali in Toscana. Andamento, distribuzione e conservazione Le specie 73<br />
Svernamento<br />
Lo svernamento della specie in Toscana è diffic<strong>il</strong>mente r<strong>il</strong>evab<strong>il</strong>e a<br />
causa delle abitudini strettamente notturne nel periodo invernale. I<br />
primi dati risalgono al dicembre 1990 per <strong>il</strong> Lago di Massaciuccoli,<br />
ma dal 1992 è stata rinvenuta con regolarità (Fig. 42) lungo <strong>il</strong> corso<br />
dell’Arno in provincia di Firenze e Pisa, ed in maniera più occasionale<br />
nel Valdarno superiore, in Valdichiana e lungo <strong>il</strong> basso corso<br />
dell’Ombrone: non in tutte le località, però, la presenza della specie<br />
è stata r<strong>il</strong>evata in anni recenti (Fig. 43). Le difficoltà di individuazione<br />
e censimento di questi piccoli gruppi non permettono di definire con<br />
precisione l’andamento della specie in periodo invernale (Arcamone<br />
et al., 2007); è tuttavia probab<strong>il</strong>e che questo sia positivo, certamente<br />
i conteggi fino a circa 60 individui compiuti negli ultimi anni devono<br />
essere considerati valutazioni per difetto.<br />
Figura 42 – Numero di individui di Nitticora censiti in Toscana nel mese di gennaio nel periodo 1991-2010 e numero<br />
di zone IWC occupate.<br />
Figura 43 – Presenza invernale della Nitticora. A sinistra: numero medio di individui censiti nel mese di gennaio degli<br />
anni 2006-10 nelle zone umide individuate per <strong>il</strong> progetto IWC; a destra, numero di individui conteggiati presso i dormitori<br />
nel 2009 (due dormitori ut<strong>il</strong>izzati ma non censiti nel 2009 sono indicati da un rombo entro un cerchio bianco).<br />
I simboli sono proporzionali al numero di individui e sono riferiti alla medesima scala.<br />
Stato di conservazione<br />
La consistenza della Nitticora si è fortemente ridotta nel corso del<br />
XIX secolo a causa della persecuzione diretta e della distruzione<br />
dell’habitat; dopo la seconda guerra mondiale la specie ha fatto registrare<br />
un andamento positivo, in alcuni casi originato dall’insediamento<br />
artificiale di colonie, e fac<strong>il</strong>itato, in alcuni paesi come l’Italia,<br />
dall’espansione della coltivazione del riso (Kushlan e Hafner, 2000).<br />
La popolazione mondiale di Nitticora è considerata avere uno stato di<br />
conservazione di minima preoccupazione (least concern; IUCN, 2008).<br />
Le stime ripetute della consistenza della popolazione continentale<br />
e le valutazioni sul suo andamento permettono di seguire l’evolversi<br />
dello stato di conservazione della specie in Europa. All’inizio<br />
degli anni ’90 la consistenza della Nitticora era stimata in 51.000-<br />
71.000 coppie, in moderato declino complessivo, seppure questo<br />
andamento era dovuto alla somma di tendenza nazionali diverse<br />
all’interno del continente; pertanto la specie era classificata come<br />
SPEC3 – in declino (Tucker e Heath, 1994). Tale valutazione era sostanzialmente<br />
confermata dopo pochi anni, quando la popolazione<br />
europea fu stimata in 50.000-75.000 coppie (Kushlan e Hafner,<br />
2000). Nel 2000 tale stima fu rivista in 63.000-87.000 coppie,<br />
con un trend generale stab<strong>il</strong>e, determinato da un suo decremento<br />
in alcuni paesi secondari per la specie e dal fatto che in altri in cui<br />
la Nitticora si concentra, fosse stab<strong>il</strong>e o fluttuante; <strong>il</strong> suo stato fu<br />
definito, sulla base di un moderato declino avventuo nel passato,<br />
SPEC3 – indebolito (BirdLife International, 2004). Le differenze riscontrate<br />
nelle tre valutazioni successive sono da ricondursi principalmente<br />
ad una miglior conoscenza dell’andamento delle diverse<br />
popolazioni, in particolare di quelle più numerose, piuttosto che a<br />
effettive variazioni numeriche.<br />
La popolazione italiana è particolarmente numerosa e nel 2000<br />
era pari a circa <strong>il</strong> 14-22% di quella continentale (BirdLife International,<br />
2004). La sua consistenza era stata valutata in circa 17.000<br />
coppie nel 1981 (Fasola et al., 1981), di poco inferiore (16.650)<br />
nel 1986 e di meno di 14.000 nel 2002 (Fasola et al., 2007). La<br />
distribuzione della specie è fortemente eterogenea: nell’Italia nordoccidentale,<br />
nell’area delle coltivazione intensiva del riso che si<br />
estende tra Piemonte e Lombardia, nel 2002 ha nidificato <strong>il</strong> 75%<br />
circa delle Nitticore italiane, mentre le regioni meridionali ed insulari<br />
ospitavano nel 2002 complessivamente circa l’1% della popolazione<br />
nazionale.<br />
Confrontando i risultati del censimento del 1981 con quello del<br />
2002, si osserva che l’andamento delle specie però è risultato<br />
divergere tra i vari settori del paese: nell’Italia nord-occidentale è<br />
diminuita, passando da 15.340 coppie in 40 garzaie a 9.940 in 55;<br />
nell’Italia nord-occidentale è aumentata in Em<strong>il</strong>ia Romagna e diminuita<br />
in Veneto e Friuli Venezia Giulia, con una riduzione complessiva<br />
da 2.850 a 2.147 coppie; nell’Italia centrale, dove la specie è<br />
fortemente concentrata in Toscana, si è insediata nel corso degli<br />
anni ’80 e nel 2002 vi erano oltre 1.200 coppie.