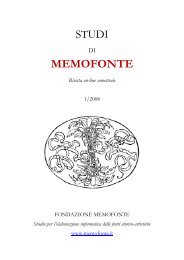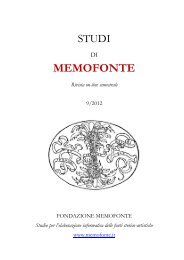storia pittorica della italia dell'abate luigi lanzi antiquario della r ...
storia pittorica della italia dell'abate luigi lanzi antiquario della r ...
storia pittorica della italia dell'abate luigi lanzi antiquario della r ...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
qualche dotto di quella età, ed eseguite da incerta mano. Di certo vi ha sol lo stile giottesco, che a<br />
me pare avere assai rapidamente occupato il Padovano, il Veronese, il Bergamasco e gran parte<br />
<strong>della</strong> terraferma.<br />
Oltre questa maniera, che può in qualche modo chiamarsi estera, altre se ne veggono e in Venezia, e<br />
nelle città soggette, che più veramente direi nazionali; così son lontane dallo stile di Giotto e de'<br />
suoi seguaci detti poc'anzi. Spesso ho dubitato che a questa qualunque originalità contribuissero i<br />
miniatori, che, in niuna età mancati in Italia, erano moltiplicati in [8] quel secolo e crescevano col<br />
loro ingegno, ritraendo le cose dal naturale, non da alcuno esemplare <strong>italia</strong>no o greco. Né poco si<br />
erano essi avanzati in ogni parte del dipingere quando Giotto venne in quei paesi. Nella gran<br />
raccolta di manoscritti che ha formata in Venezia il sig. abate Canonici, vidi un Evangeliario<br />
acquistato in Udine, con miniature di assai buon gusto pel secolo XIII in cui furon fatte; e di simili<br />
monumenti non son punto scarse le biblioteche dello stato. Sospetto dunque che molti di quei pittori<br />
novelli o perché educati dai miniatori, o perché dalla vicinità delle arti invitati alla loro imitazione,<br />
gli emulassero nel disegno, nel compartimento de' colori, nelle composizioni. Così rendesi buona<br />
ragione perché anche veduto Giotto non tutti fossero giotteschi, e nondimeno dipingessero<br />
lodevolmente.<br />
Tale è quel Maestro Paolo che lo Zanetti trovò ricordato in una pergamena del 1346. È il primo de'<br />
nazionali di cui esista opera non equivoca col nome del suo autore; vedendosi nel gran tempio di<br />
San Marco una tavola, o, come dicesi, un'ancona a più spartimenti con la immagine del Redentor<br />
morto e con vari Apostoli e storie del Santo Evangelista, sotto la quale trovasi scritto: Magister<br />
Paulus cum Jacobo et Johanne filiis fecit hoc opus. Similmente quel Lorenzo pittore, di cui loda lo<br />
Zanetti una tavola in Sant'Antonio di Castello con suo nome e con data del 1358 pagatagli trecento<br />
ducati d'oro, non posso dubitare che non sia veneto, da che si legge in un quadro <strong>della</strong> nobil casa<br />
Ercolani in Bologna: manu Laurentii de Venetiis. 1368. A tutti gl'indizi è quel frescante che [9]<br />
nella chiesa di Mezzaratta fuor di Bologna figurò Daniele nel lago de' leoni e vi soscrisse:<br />
Laorentius P., opera niente giottesca condotta circa il 1370. Veneto senza dubbio è Niccolò<br />
Semitecolo, che in una Pietà con alcune storie di S. Sebastiano, che si conserva nella libreria<br />
capitolare di Padova, si soscrive: Nicoleto Semitecolo da Veniexia impense 1367. L'opera è un bel<br />
monumento di questa scuola: il nudo vi è assai ben dipinto, le proporzioni delle figure sono svelte,<br />
sebbene talora oltre il dovere; e, ciò che fa al proposito di questo luogo, niuna somiglianza vi<br />
traspare collo stile di Giotto, a cui resta indietro nel disegno, ma sta a lato nel colorito. Né tacerò in<br />
questo proposito che il Baldinucci stesso rispettò la veneta libertà e la indipendenza di questa scuola<br />
dalla fiorentina, non avendo inserito alcun veneto nel suo albero di Cimabue. Che nazi confessa<br />
nella vita di un Antonio Fiorentino scolare di Angiol Gaddi, ch’egli dimosrò in Venezia, e ne trasse<br />
il cognome di Antonio Veneziano; ma che ne partì per maneggi de' professori nazionali, ch'è quanto<br />
dire di una Scuola anteriore alla sua. E tanto era anteriore che già a quell'ora tutto lo stato e i luoghi<br />
vicini avea pieni e di quadri e di alunni; comeché di pochi si conosca e il nome e la mano. Fra questi<br />
pochi è un Simon da Cusighe terra presso Cadore e Belluno, nella qual città restan memorie di un<br />
Pietro e di altri pittor trecentisti, e qualche immagine molto ragionevole con la epigrafe Simon<br />
pinxit. Vi son pure Pecino e Pietro de Nova, che in Santa Maria Maggiore di Bergamo operarono<br />
dal 1363 per non pochi anni e molto lodevol[10]mente; ma essi, quasi al par de' padovani già<br />
rammentati, molto si avvicinano al far di Giotto, e poterono da Milano avere attinto quel gusto 3 .<br />
Il valore <strong>della</strong> pittura veneziana maggiormente si scuopre nel secolo quintodecimo, secolo che a<br />
grado a grado venne preparando la strada alla gran maniera de' Giorgioni e de' Tiziani. In Murano,<br />
una delle isole, cominciò il nuovo stile; in Venezia si perfezionò. Un antichissimo artefice, che si<br />
soscrive Quiricius de Muriano, conobbi nello studio del sig. Sasso. La sua pittura è un Nostro<br />
Signore sedente, a' cui piedi sta una divota velata; ma non vi è nota di tempo. D'incerta epoca<br />
3 Prima di questi era in Bergamo scuola di pittura; in prova di che il conte Tassi adduce una pergamena del 1296 col<br />
nome di un maestro Guglielmo pittore. Non si sa in qual gusto egli dipingesse. Uno de' suoi successori, che in Santa<br />
Maria Maggiore dipinse l'Albero di San Bonaventura copioso di sacre immagini, è pittor più rozzo, ma più originale che<br />
i due fratelli de Nova. È ignoto il suo nome, e solo vi appose l'anno 1347.