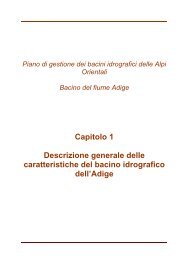Capitolo 1 Descrizione generale delle caratteristiche ... - Alpi Orientali
Capitolo 1 Descrizione generale delle caratteristiche ... - Alpi Orientali
Capitolo 1 Descrizione generale delle caratteristiche ... - Alpi Orientali
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Piano di gestione dei bacini idrografici <strong>delle</strong> <strong>Alpi</strong> <strong>Orientali</strong><br />
L’alimentazione dell’acquifero indifferenziato è assicurata principalmente dalle dispersioni<br />
d’alveo che si verificano a Nord, secondariamente dalle precipitazioni dirette, dall’irrigazione,<br />
dal ruscellamento di versante e dalle dispersioni dei corsi d'acqua minori afferenti alla valle<br />
principale. Nella falda freatica esiste un ricambio continuo d’acqua con oscillazioni annuali<br />
medie di circa 10 metri. Il Torrente Chiampo ed il Torrente Agno-Guà, nel tratto settentrionale,<br />
disperdono all’incirca 60 l/sec. per km, con valori massimi di 100 l/sec. per km. Il deflusso idrico<br />
sotterraneo <strong>generale</strong> scende verso valle con direzione media NW-SE, anche se verso Est e<br />
Sud le isofreatiche assumono un andamento E-W, con direzione della falda<br />
approssimativamente N-S, questo in quanto i bacini idrogeologici dell’Agno-Guà e del Chiampo<br />
tendono ad “anastomizzarsi”.<br />
In questo bacino, analogamente alla porzione orientale del Bacino Idrogeologico “Alta Pianura<br />
Veronese”, l’emergenza <strong>delle</strong> superficie freatica nel passaggio tra alta e media pianura è<br />
talmente frammentaria, che nell’area non sono presenti fontanili di particolare interesse.<br />
Media e Bassa Pianura<br />
Come già accennato nell’introduzione, l’impostazione del modello concettuale ha consentito di<br />
individuare, con buona approssimazione, dei bacini idrogeologici di alta pianura, ma non ha<br />
ancora permesso una suddivisione specifica per quanto riguarda la media e bassa pianura. Le<br />
informazioni in possesso permettono solamente di individuare il limite superiore <strong>delle</strong> risorgive<br />
come delimitazione tra alta e media pianura, ed il limite tra depositi ghiaiosi e depositi sabbiosi,<br />
come passaggio tra la media e la bassa pianura. La suddivisione in bacini idrogeologici di<br />
dettaglio sarà impostata in seguito, prendendo in considerazione la geomorfologia e le<br />
<strong>caratteristiche</strong> <strong>delle</strong> alluvioni.<br />
Media Pianura Veneta (MPV)<br />
E’ situata a valle della fascia di alta pianura, a partire dal limite superiore della fascia <strong>delle</strong><br />
risorgive e possiede una larghezza variabile dai 5 (limite regionale occidentale) ai 15 km (limite<br />
regionale orientale). Il limite superiore <strong>delle</strong> risorgive corrisponde all’intersezione della superficie<br />
freatica con quella topografica, e quindi non può rappresentare una delimitazione fissa, in<br />
quanto le condizioni idrogeologiche e meteoclimatiche possono influenzare l’emergenza della<br />
falda freatica proveniente dall’alta pianura; classico esempio è rappresentato dalla scomparsa<br />
di numerose “polle di risorgiva” in vaste porzioni della pianura veneta. Il limite inferiore invece,<br />
può essere considerato con buona approssimazione una demarcazione netta, in quanto<br />
identificato dal passaggio tra acquiferi a componente prevalentemente ghiaiosa ed acquiferi a<br />
componente prevalentemente sabbiosa.<br />
Bacino del fiume Adige<br />
<strong>Descrizione</strong> <strong>generale</strong> <strong>delle</strong> <strong>caratteristiche</strong> del bacino idrografico dell’Adige<br />
79