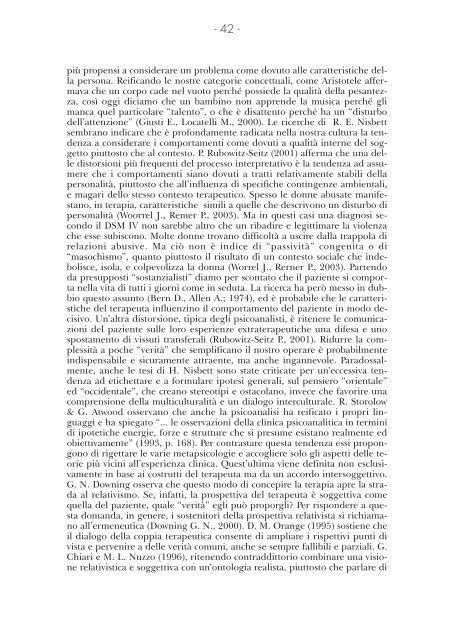psicodermatologia - Rivista Nuove Prospettive in Psicologia
psicodermatologia - Rivista Nuove Prospettive in Psicologia
psicodermatologia - Rivista Nuove Prospettive in Psicologia
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
- 42 -<br />
più propensi a considerare un problema come dovuto alle caratteristiche della<br />
persona. Reificando le nostre categorie concettuali, come Aristotele affermava<br />
che un corpo cade nel vuoto perché possiede la qualità della pesantezza,<br />
così oggi diciamo che un bamb<strong>in</strong>o non apprende la musica perché gli<br />
manca quel particolare “talento”, o che è disattento perché ha un “disturbo<br />
dell’attenzione” (Giusti E., Locatelli M., 2000). Le ricerche di R. E. Nisbett<br />
sembrano <strong>in</strong>dicare che è profondamente radicata nella nostra cultura la tendenza<br />
a considerare i comportamenti come dovuti a qualità <strong>in</strong>terne del soggetto<br />
piuttosto che al contesto. P. Rubowitz-Seitz (2001) afferma che una delle<br />
distorsioni più frequenti del processo <strong>in</strong>terpretativo è la tendenza ad assumere<br />
che i comportamenti siano dovuti a tratti relativamente stabili della<br />
personalità, piuttosto che all’<strong>in</strong>fluenza di specifiche cont<strong>in</strong>genze ambientali,<br />
e magari dello stesso contesto terapeutico. Spesso le donne abusate manifestano,<br />
<strong>in</strong> terapia, caratteristiche simili a quelle che descrivono un disturbo di<br />
personalità (Woorrel J., Remer P., 2003). Ma <strong>in</strong> questi casi una diagnosi secondo<br />
il DSM IV non sarebbe altro che un ribadire e legittimare la violenza<br />
che esse subiscono. Molte donne trovano difficoltà a uscire dalla trappola di<br />
relazioni abusive. Ma ciò non è <strong>in</strong>dice di “passività” congenita o di<br />
“masochismo”, quanto piuttosto il risultato di un contesto sociale che <strong>in</strong>debolisce,<br />
isola, e colpevolizza la donna (Worrel J., Rerner P., 2003). Partendo<br />
da presupposti “sostanzialisti” diamo per scontato che il paziente si comporta<br />
nella vita di tutti i giorni come <strong>in</strong> seduta. La ricerca ha però messo <strong>in</strong> dubbio<br />
questo assunto (Bern D., Allen A.; 1974), ed è probabile che le caratteristiche<br />
del terapeuta <strong>in</strong>fluenz<strong>in</strong>o il comportamento del paziente <strong>in</strong> modo decisivo.<br />
Un’altra distorsione, tipica degli psicoanalisti, è ritenere le comunicazioni<br />
del paziente sulle loro esperienze extraterapeutiche una difesa e uno<br />
spostamento di vissuti transferali (Rubowitz-Seitz P., 2001). Ridurre la complessità<br />
a poche “verità” che semplificano il nostro operare è probabilmente<br />
<strong>in</strong>dispensabile e sicuramente attraente, ma anche <strong>in</strong>gannevole. Paradossalmente,<br />
anche le tesi di H. Nisbett sono state criticate per un’eccessiva tendenza<br />
ad etichettare e a formulare ipotesi generali, sul pensiero “orientale”<br />
ed “occidentale”, che creano stereotipi e ostacolano, <strong>in</strong>vece che favorire una<br />
comprensione della multiculturalità e un dialogo <strong>in</strong>terculturale. R. Storolow<br />
& G. Atwood osservano che anche la psicoanalisi ha reificato i propri l<strong>in</strong>guaggi<br />
e ha spiegato “... le osservazioni della cl<strong>in</strong>ica psicoanalitica <strong>in</strong> term<strong>in</strong>i<br />
di ipotetiche energie, forze e strutture che si presume esistano realmente ed<br />
obiettivamente” (1993, p. 168). Per contrastare questa tendenza essi propongono<br />
di rigettare le varie metapsicologie e accogliere solo gli aspetti delle teorie<br />
più vic<strong>in</strong>i all’esperienza cl<strong>in</strong>ica. Quest’ultima viene def<strong>in</strong>ita non esclusivamente<br />
<strong>in</strong> base ai costrutti del terapeuta ma da un accordo <strong>in</strong>tersoggettivo.<br />
G. N. Down<strong>in</strong>g osserva che questo modo di concepire la terapia apre la strada<br />
al relativismo. Se, <strong>in</strong>fatti, la prospettiva del terapeuta è soggettiva come<br />
quella del paziente, quale “verità” egli può proporgli? Per rispondere a questa<br />
domanda, <strong>in</strong> genere, i sostenitori della prospettiva relativista si richiamano<br />
all’ermeneutica (Down<strong>in</strong>g G. N., 2000). D. M. Orange (1995) sostiene che<br />
il dialogo della coppia terapeutica consente di ampliare i rispettivi punti di<br />
vista e pervenire a delle verità comuni, anche se sempre fallibili e parziali. G.<br />
Chiari e M. L. Nuzzo (1996), ritenendo contraddittorio comb<strong>in</strong>are una visione<br />
relativistica e soggettiva con un’ontologia realista, piuttosto che parlare di