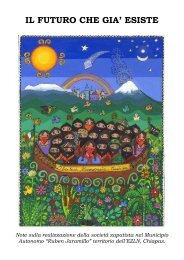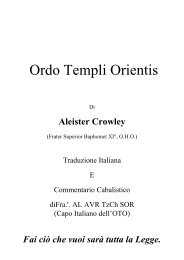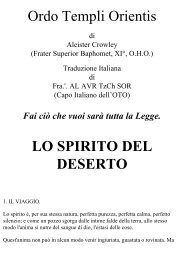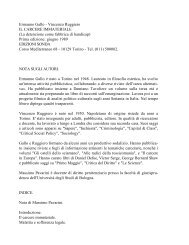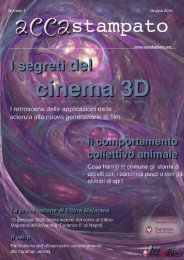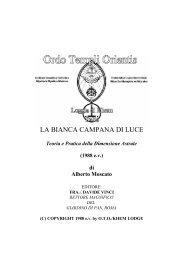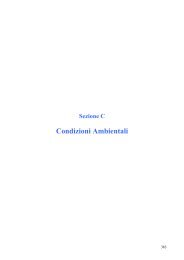Jean Améry. INTELLETTUALE A AUSCHWITZ. Bollati Boringhieri ...
Jean Améry. INTELLETTUALE A AUSCHWITZ. Bollati Boringhieri ...
Jean Améry. INTELLETTUALE A AUSCHWITZ. Bollati Boringhieri ...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
cosa mi riferisco. L'uomo dello spirito, e in particolare l'intellettuale di cultura tedesca, ha in<br />
sé una concezione estetica della morte che ha origini remote e i cui impulsi più recenti risalgono<br />
al romanticismo tedesco. Possiamo caratterizzarla approssimativamente citando Novalis,<br />
Schopenhauer, Wagner, Thomas Mann. Ad Auschwitz non vi era spazio per la morte nella sua forma<br />
letteraria, filosofica, musicale. Nessun ponte conduceva dalla morte ad Auschwitz alla "Morte a<br />
Venezia". Risultava insopportabile ogni reminiscenza poetica della morte, che si trattasse della<br />
«Cara sorella Morte» di Hesse o di Rilke che cantava: «O Signore, dài a ognuno la sua morte.»<br />
All'intellettuale la concezione estetica della morte si palesò come espressione di una "vita"<br />
estetizzante: dove questa era ormai pressoché dimenticata, anche quella risultava un'elegante<br />
futilità. Nel campo, alla morte non s'accompagnava la musica del Tristano, ma solo le urla delle<br />
S.S. e dei Kapo. Poiché la morte di un essere umano a livello sociale era un avvenimento che dalla<br />
cosiddetta sezione politica del Lager veniva registrato semplicemente con la formula "Abgang durch<br />
Tod" [letteralmente: abbandono (del campo) causa decesso], anche a livello individuale essa finì<br />
per perdere tanto del suo valore specifico che la sua veste estetica, per colui che l'attendeva<br />
divenne in un certo senso una provocazione impudente e, nei confronti dei compagni, sconveniente.<br />
Una volta crollata la concezione estetica della morte, il prigioniero intellettuale si trovava<br />
disarmato al suo cospetto Se cercava di stabilire comunque un rapporto spirituale e metafisico con<br />
la morte, tornava a scontrarsi con la realtà del Lager che impediva ogni tentativo in questa<br />
direzione. Cosa avveniva concretamente? Per dirla nel modo più conciso e banale: al pari del suo<br />
compagno non spirituale, anche il prigioniero intellettuale si occupava non della morte, ma del<br />
"morire"; il problema nel suo complesso veniva così ridotto a una serie di considerazioni concrete.<br />
Nel Lager si narrava ad esempio di una S.S. che aveva sbudellato un detenuto riempiendogli poi la<br />
pancia di sabbia. E' evidente che di fronte a simili possibilità non ci si occupava quasi più del<br />
"se" o del fatto "che" si dovesse morire, ma solo del "come" sarebbe avvenuto. Si discuteva di<br />
quanto tempo impiegasse il gas a fare il suo effetto. Si speculava sulla dolorosità della morte<br />
provocata da iniezioni di acido fenico. Era preferibile un colpo sul cranio o la lenta morte per<br />
sfinimento in infermeria? E' significativo dell'atteggiamento dei prigionieri nei confronti della<br />
morte che solo pochi abbiano deciso di «correre verso il filo», ossia di suicidarsi toccando il<br />
filo spinato attraversato dall'alta tensione. Il filo era in fondo una soluzione buona e abbastanza<br />
sicura, sebbene vi fosse la possibilità di essere scorti anzitempo, e di finire quindi nel bunker,<br />
il che significava morire con maggiori difficoltà e sofferenze. Il morire era onnipresente, la<br />
morte si sottraeva.<br />
E' vero che l'angoscia della morte è ovunque sostanzialmente angoscia di morire, e anche per il<br />
campo vale ciò che una volta disse Franz Borkenau, e cioè che l'angoscia della morte è il timore di<br />
soffocare. Tuttavia quando si è liberi è possibile pensare alla morte senza per forza pensare al<br />
morire, senza essere angosciati dal morire. In una condizione di libertà la morte a livello<br />
spirituale può, almeno in linea di principio, essere sganciata dal morire: in senso sociale,<br />
proiettando su di essa considerazioni sulla famiglia che rimane, sul lavoro che si lascia, e in<br />
senso filosofico attraverso lo sforzo di avvertire nell'esistere un alito del Nulla. Superfluo<br />
aggiungere che un simile tentativo non porta ad alcun risultato, che la contraddizione della morte<br />
è irrisolvibile. In ogni caso però l'anelito trova in sé stesso la propria dignità: nei confronti<br />
della morte l'uomo libero può assumere una determinata posizione spirituale perché per lui la morte<br />
non si risolve totalmente nell'affanno del morire. L'uomo libero può avventurarsi sino al confine<br />
dell'immaginabile perché in lui esiste un sia pure limitatissimo spazio sgombro da angoscia. Per il<br />
prigioniero invece la morte non possedeva alcun aculeo: un aculeo che facesse male, che lo<br />
spingesse a riflettere. Forse così si spiega perché il prigioniero del campo - e la considerazione<br />
vale per tutti, intellettuali e non - abbia conosciuto sì la straziante paura di fronte a<br />
determinati modi di morire, ma non la vera e propria angoscia della morte. Se mi è consentito<br />
parlare della mia esperienza personale, vorrei assicurare che non ho mai pensato di essere<br />
particolarmente coraggioso e che probabilmente non lo sono. Ciò nonostante, quando un giorno, dopo<br />
alcuni mesi di campo di punizione, fui prelevato dalla cella e la S.S. mi assicurò gentilmente che<br />
sarei stato fucilato, accettai la comunicazione con assoluta imperturbabilità. «Hai paura, eh?»<br />
aggiunse quel tale che aveva solo voluto divertirsi un po'. «Sì», risposi io, ma più per<br />
compiacerlo e per non provocare, deludendo le sue aspettative, una reazione brutale. No, non<br />
avevamo paura della morte. Ricordo con chiarezza come i compagni nelle cui baracche erano previste<br />
le selezioni per le camere a gas, non parlassero di queste, bensì, con tutti i segni del timore e<br />
della speranza, della consistenza della zuppa che doveva essere distribuita. La realtà del Lager<br />
trionfava facilmente sulla morte e sull'insieme delle cosiddette questioni ultime. Anche qui lo<br />
spirito s'imbatteva nei limiti che gli erano posti.<br />
Tutti i problemi che per convenzione linguistica definiamo «metafisici», divenivano inconsistenti.<br />
Anche in questo caso però, non era l'abulia a rendere impossibile la riflessione, bensì, al<br />
contrario, la crudele perspicacia di un intelletto affilato e temprato dalla realtà del Lager. Si<br />
aggiunga che venivano a mancare le energie emozionali grazie alle quali si sarebbe magari potuto<br />
dare contenuto, e quindi rendere sensati a livello soggettivo e psicologico, vaghi concetti<br />
filosofici. Di tanto in tanto qualcuno si ricordava magari di quel tristo mago del paese degli<br />
alemanni, il quale aveva detto che agli umani l'Ente apparirebbe solo attraverso la luce