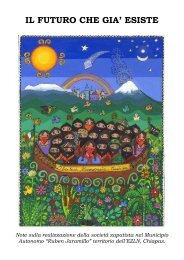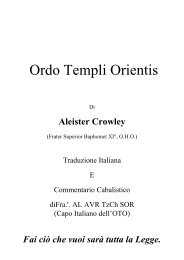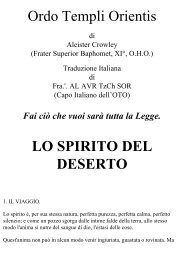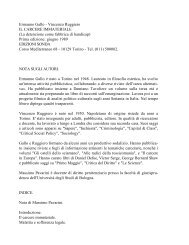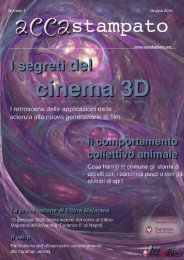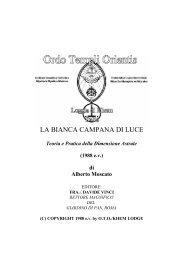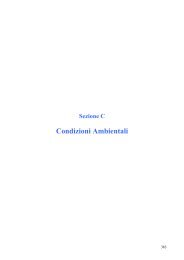Jean Améry. INTELLETTUALE A AUSCHWITZ. Bollati Boringhieri ...
Jean Améry. INTELLETTUALE A AUSCHWITZ. Bollati Boringhieri ...
Jean Améry. INTELLETTUALE A AUSCHWITZ. Bollati Boringhieri ...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
quindi di vivere. La Germania intera, ma cosa dico, il mondo intero, diede il suo consenso<br />
all'impresa, sebbene qua e là affiorasse qualche superficiale rincrescimento.<br />
E' necessario ricordarlo: quando nel secondo dopoguerra una marea di profughi proveniente dai<br />
diversi paesi a governo comunista si riversò in occidente, gli stati di quello che viene definito<br />
il mondo libero, rivaleggiarono nella loro disponibilità ad accoglierli e soccorrerli, sebbene solo<br />
una sparuta minoranza fra loro nei rispettivi paesi d'origine dovesse davvero temere per la propria<br />
vita. Noi invece, anche quando ogni persona ragionevole avrebbe dovuto rendersi conto cosa ci<br />
attendesse nel Reich, non ci voleva nessuno. Fu quindi una conseguenza necessaria che gli ebrei,<br />
autentici o meno, al sicuro nell'illusione di Dio e di una prospettiva nazionale o invece<br />
assimilati, non trovassero in sé le energie per opporsi quando il nemico li marchiò con l'immagine<br />
dello "Stürmer" streicheriano. Questa debolezza non aveva, beninteso, molto in comune con il<br />
classico odio per sé stessi degli ebrei, tipico di un ebraismo che negli anni precedenti l'avvento<br />
del nazismo era disposto all'assimilazione e anzi fortemente la reclamava. Gli ebrei che odiavano<br />
sé stessi ritenevano di non poter realizzare la loro speranza di essere tedeschi, e perciò si<br />
disprezzavano. Non avevano voluto farsi carico della loro esistenza di non tedeschi, ma nessuno li<br />
aveva costretti a negarsi in quanto ebrei. Quando invece tra il 1933 e il 1945 proprio le teste più<br />
attente e oneste fra gli ebrei, autentici o meno, momentaneamente capitolarono di fronte a<br />
Streicher, si trattò di un'abdicazione diversa, non più di ordine morale ma social-filosofica. Il<br />
mondo, si saranno forse detti, ci considera in un certo modo, pigri, brutti, inutili, malvagi; che<br />
senso ha, di fronte a un tale accordo universale, contraddire ancora e ribadire che non lo "siamo"?<br />
L'arrendersi degli ebrei all'immagine che lo "Stürmer" dava di loro, altro non era che<br />
l'accettazione di una realtà sociale: appellarsi in questa situazione a una diversa valutazione di<br />
sé, doveva in certi momenti apparire come una pretesa ridicola o folle.<br />
Bisogna tuttavia esserci stati per poter dire la propria. Se penso alla realtà sociale del muro di<br />
rifiuto che ovunque si ergeva innanzi a noi, mi viene in mente la mia permanenza ad Auschwitz-<br />
Monowitz. Nel campo stesso, ma anche fra i cosiddetti operai liberi, sul lavoro esisteva, imposta a<br />
tutti dai nazisti, una rigida gerarchia etnica. Un "Reichsdeutscher" [tedesco del Reich] valeva di<br />
più di un "Volksdeutscher" [tedesco etnico]. Un belga fiammingo era superiore a un belga vallone.<br />
Un ucraino proveniente dal "Generalgouvernement" [governatorato generale] era messo meglio del suo<br />
compatriota polacco. L'operaio dell'Europa orientale godeva di minor credito di quello italiano.<br />
Più in basso di tutti, sui gradini inferiori della scala si trovavano i prigionieri dei Lager, fra<br />
i quali gli ebrei a loro volta erano al livello più basso. Anche il più depravato criminale non<br />
ebreo era collocato ben sopra di noi. I polacchi, che si trattasse di autentici combattenti per la<br />
libertà, finiti nel campo dopo l'infelice insurrezione di Varsavia, o di piccoli borsaioli, ci<br />
odiavano unanimemente. Lo stesso dicasi dei semianalfabeti operai bielorussi. O dei francesi.<br />
Ricordo ancora la discussione fra un operaio libero francese e un ebreo francese, prigioniero del<br />
campo. «Je suis Français», disse il prigioniero. «Français, toi? Mais, tu es juif, mon ami»,<br />
ribatté realisticamente e senza rancore il suo connazionale che aveva, in una mescolanza di paura e<br />
indifferenza, appresa la lezione dei signori dell'Europa. Ripeto: il mondo era d'accordo con il<br />
posto assegnatoci dai tedeschi, il piccolo mondo del campo e quello grande fuori, che solo in rari<br />
ed eroici casi individuali protestava, quando a Vienna, a Berlino, ad Amsterdam, a Parigi o a<br />
Bruxelles nottetempo venivano a prelevarci nelle nostre case.<br />
Al processo di privazione della dignità messo in atto nei confronti degli ebrei, che ebbe inizio<br />
con le leggi di Norimberga e condusse direttamente a Treblinka, corrispose da parte nostra, da<br />
parte mia, un simmetrico processo di riconquista della dignità. Un processo che ancora non si è<br />
concluso. Queste mie riflessioni siano testimonianza dello sforzo da me compiuto nel tentativo di<br />
comprenderne le varie fasi e del provvisorio risultato cui sono pervenuto; al lettore rivolgo la<br />
preghiera di volermi accompagnare per un tratto. E' un percorso breve ma difficile, ricco di<br />
ostacoli e insidie. Perché, in fin dei conti, cosa significa la dignità che mi fu negata per la<br />
prima volta nel 1935, di cui fui ufficialmente privato sino al 1945, che forse ancora oggi non mi<br />
si vuole riconoscere e che per questo motivo devo essere io a conquistare? Che cos'è in ultima<br />
analisi la dignità?<br />
Possiamo azzardare una definizione ribaltando l'identificazione tra privazione della dignità e<br />
minaccia di morte proposta più sopra. Se era corretto il ragionamento per cui la privazione della<br />
dignità altro non sarebbe che una potenziale privazione della vita, allora la dignità dovrebbe<br />
essere il diritto alla vita. Se era inoltre corretto quanto ho asserito, e cioè che la concessione<br />
e la privazione della dignità sono atti di consenso sociale, sentenze quindi, contro le quali non è<br />
possibile fare appello alla «coscienza di sé», tanto che sarebbe insensato, nei confronti di una<br />
comunità sociale che ci priva della dignità, argomentare che invece noi senza alcun dubbio ci<br />
«sentiamo» degni: se tutto ciò era esatto ogni sforzo per riconquistare la dignità sarebbe stato, e<br />
tuttora sarebbe, privo di valore. Essere privati della dignità, e cioè vivere sotto minaccia di<br />
morte, sarebbe un destino ineluttabile. Fortunatamente le cose non stanno esattamente nei termini<br />
in cui li vuole questa logica. E' certamente vero: la dignità, che si tratti della dignità di un<br />
incarico pubblico, o della dignità professionale o più genericamente della dignità del cittadino,<br />
può essere concessa solo dalla società e la rivendicazione avanzata esclusivamente nella sfera<br />
interiore individuale («Io sono un essere umano e in quanto tale ho la mia dignità, per quanto