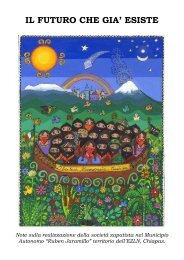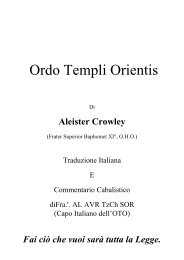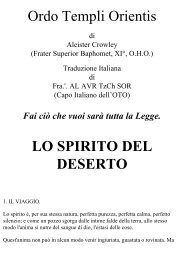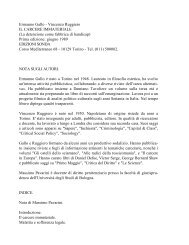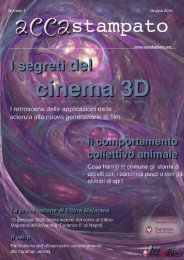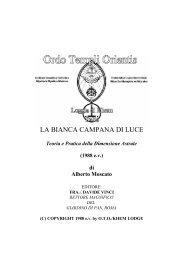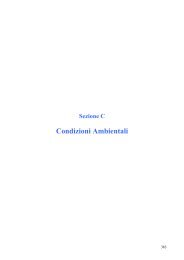Jean Améry. INTELLETTUALE A AUSCHWITZ. Bollati Boringhieri ...
Jean Améry. INTELLETTUALE A AUSCHWITZ. Bollati Boringhieri ...
Jean Améry. INTELLETTUALE A AUSCHWITZ. Bollati Boringhieri ...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
fra Bruxelles e Anversa. La fortezza risale alla prima guerra mondiale e non so quale sia stato<br />
allora il suo destino. Nella seconda guerra, durante i diciotto brevi giorni di resistenza<br />
dell'esercito belga del maggio 1940, Breendonk fu l'ultimo quartier generale di re Leopoldo. In<br />
seguito, durante l'occupazione tedesca, divenne una sorta di piccolo campo di concentramento, un<br />
"Auffanglager" [campo di raccolta] come si diceva nel gergo del Terzo Reich. Oggi è Museo nazionale<br />
belga.<br />
Il forte Breendonk a prima vista appare molto vecchio, con una lunga storia alle spalle. A vederlo<br />
così, sotto il cielo eternamente gravido di pioggia delle Fiandre, con i suoi tetti a cupola<br />
ricoperti di erba e i muri grigio-neri, sembra una melanconica incisione della guerra francoprussiana<br />
del 1870-71: si pensa a Gravelotte e Sedan e da un momento all'altro dalle basse,<br />
imponenti porte ci si aspetta di veder uscire, il képi in mano, l'ormai sconfitto imperatore<br />
Napoleone Terzo. Bisogna avvicinarsi perché alla vaga immagine dei tempi passati se ne sovrapponga<br />
un'altra, a noi più consueta: lungo il fossato che circonda la fortezza si innalzano torrette di<br />
guardia, tutto è circondato da reticolato di filo spinato. All'incisione del 1870 si sovrappongono<br />
bruscamente le raccapriccianti fotografie di quello che David Rousset ha definito l'"univers<br />
concentrationnaire". I responsabili del Museo nazionale hanno lasciato tutto com'era negli anni<br />
1940-44. Annunci ingialliti: «Wer weitergeht wird erschossen» [Oltre questo limite si spara a<br />
vista]. Non sarebbe stato necessario erigere davanti alla fortezza quel patetico monumento alla<br />
resistenza - un uomo costretto in ginocchio che tuttavia caparbiamente solleva una testa dai tratti<br />
curiosamente slavi - non sarebbe stato necessario questo monumento per spiegare al visitatore<br />
"dove" si trovi e cosa gli venga richiamato alla memoria.<br />
Si entra attraverso il portone principale e si raggiunge presto un locale che allora<br />
misteriosamente si chiamava "Geschäftszimmer" [stanza degli affari, ufficio]. Alla parete una foto<br />
di Heinrich Himmler, sul lungo tavolo, a mo' di tovaglia, una bandiera con la svastica, qualche<br />
sedia disadorna. "Geschäftszimmer". Ciascuno seguiva i propri affari, il loro era l'omicidio. Poi i<br />
corridoi simili a umide cantine, debolmente illuminati con le stesse lampadine dalla luce fioca e<br />
rossastra che già allora pendevano dai soffitti. Celle chiuse da spesse porte in legno. Bisogna<br />
passare numerosi pesanti cancelli prima di giungere in un ambiente con soffitto a volta privo di<br />
finestre, in cui sono sparsi diversi insoliti attrezzi in ferro. Da qui le urla non potevano<br />
giungere all'esterno. Accadde in questo locale: qui subii la tortura.<br />
Parlando di tortura bisogna stare attenti a non esagerare. Ciò che io subii in quell'indicibile<br />
stanza di Breendonk non fu certamente la forma peggiore di tortura. Non mi furono infilati aghi<br />
roventi sotto le unghie, né spente sigarette sulla nuda pelle. Subii solo ciò che in seguito dovrò<br />
narrare; fu una tortura relativamente benigna, e sul mio corpo non sono rimaste cicatrici evidenti.<br />
E tuttavia, ventidue anni dopo quell'avvenimento, sulla scorta di un'esperienza che non giunse ai<br />
limiti estremi, oso affermare che la tortura è l'esperienza più atroce che un essere umano possa<br />
conservare in sé.<br />
Molti esseri umani, tuttavia, conservano in sé un'esperienza simile, e l'atrocità da me subita non<br />
rivendica alcuna esclusività. Nella maggior parte dei paesi occidentali la tortura in quanto<br />
istituzione e metodo è stata abolita alla fine del diciottesimo secolo. Ciò nonostante oggi, due<br />
secoli più tardi, uomini e donne possono ancora affermare di essere stati torturati e nessuno sa<br />
dire quanti siano. Redigendo questo mio contributo mi è capitato fra le mani un giornale con alcune<br />
fotografie che ritraggono esponenti dell'esercito sudvietnamita mentre torturano alcuni ribelli<br />
vietcong loro prigionieri. Lo scrittore inglese Graham Green ha scritto a questo proposito una<br />
lettera al «Daily Telegraph» di Londra in cui si afferma quanto segue:<br />
"La novità delle fotografie pubblicate dalla stampa inglese e americana è che esse vennero<br />
evidentemente fatte con l'accordo degli aguzzini e pubblicate senza commento. Quasi si trattasse<br />
delle tavole di un testo di zoologia sulla vita degli insetti! Significa che le autorità americane<br />
considerano la tortura una forma legale di interrogatorio di prigionieri politici? Queste foto<br />
sono, se si vuole, un segno di onestà, poiché dimostrano che le autorità non chiudono gli occhi.<br />
Solo mi chiedo se a una tale forma di inconsapevole franchezza alla fine non sia da preferire<br />
l'ipocrisia del passato..."<br />
Chiunque di noi si porrà l'interrogativo di Graham Green. Ammettere la tortura, accettare il<br />
rischio - ma è ancora tale? - che si corre nel presentare all'opinione pubblica simili foto, è<br />
possibile solo presupponendo che non si debba più temere una rivolta delle coscienze. Vien da<br />
pensare che queste coscienze si siano abituate alla prassi della tortura. Del resto in questi<br />
decenni la tortura non è stata impiegata solo nel Vietnam. Sarei curioso di sapere cosa accade<br />
nelle prigioni sudafricane, angolane, congolesi. E so, e anche il lettore probabilmente sa, cosa<br />
avvenne nelle galere dell'Algeria francese negli anni che vanno dal 1956 al 1963. Esiste<br />
sull'argomento un libro terribilmente preciso e sobrio, "La question" di Henri Alleg, un'opera la<br />
cui diffusione fu vietata, il resoconto di un testimone che ha di persona visto e vissuto, e che<br />
con semplicità e modestia ha messo a verbale l'orrore. Intorno al 1960 vennero pubblicati anche<br />
numerosi altri libri e pamphlet sul medesimo argomento: il dotto trattato criminologico del famoso<br />
avvocato Alec Mellor, la protesta del giornalista Pierre-Henri Simon, lo studio di ordine morale di