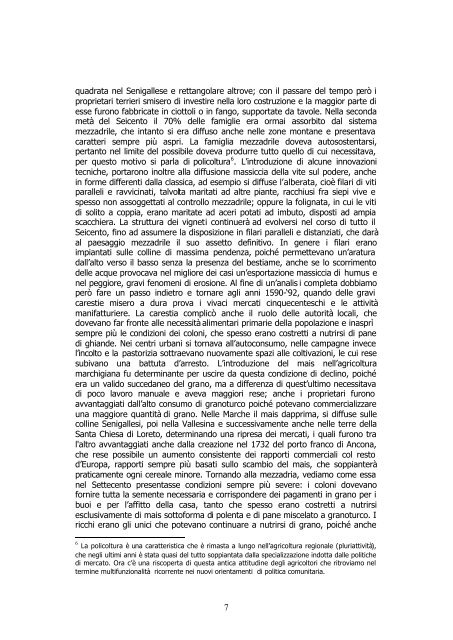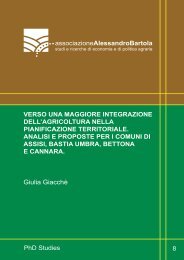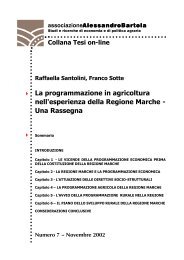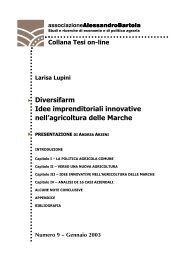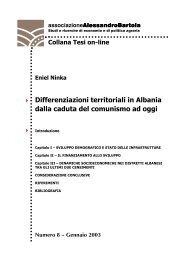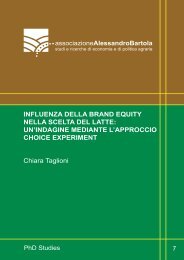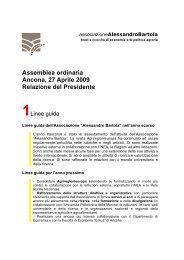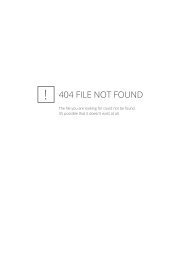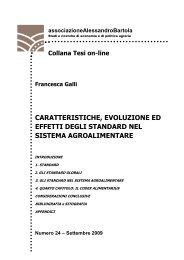Le esternalità dell'agricoltura. Una analisi degli effetti ambientali ...
Le esternalità dell'agricoltura. Una analisi degli effetti ambientali ...
Le esternalità dell'agricoltura. Una analisi degli effetti ambientali ...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
quadrata nel Senigallese e rettangolare altrove; con il passare del tempo però i<br />
proprietari terrieri smisero di investire nella loro costruzione e la maggior parte di<br />
esse furono fabbricate in ciottoli o in fango, supportate da tavole. Nella seconda<br />
metà del Seicento il 70% delle famiglie era ormai assorbito dal sistema<br />
mezzadrile, che intanto si era diffuso anche nelle zone montane e presentava<br />
caratteri sempre più aspri. La famiglia mezzadrile doveva autosostentarsi,<br />
pertanto nel limite del possibile doveva produrre tutto quello di cui necessitava,<br />
per questo motivo si parla di policoltura 6 . L’introduzione di alcune innovazioni<br />
tecniche, portarono inoltre alla diffusione massiccia della vite sul podere, anche<br />
in forme differenti dalla classica, ad esempio si diffuse l’alberata, cioè filari di viti<br />
paralleli e ravvicinati, talvolta maritati ad altre piante, racchiusi fra siepi vive e<br />
spesso non assoggettati al controllo mezzadrile; oppure la folignata, in cui le viti<br />
di solito a coppia, erano maritate ad aceri potati ad imbuto, disposti ad ampia<br />
scacchiera. La struttura dei vigneti continuerà ad evolversi nel corso di tutto il<br />
Seicento, fino ad assumere la disposizione in filari paralleli e distanziati, che darà<br />
al paesaggio mezzadrile il suo assetto definitivo. In genere i filari erano<br />
impiantati sulle colline di massima pendenza, poiché permettevano un’aratura<br />
dall’alto verso il basso senza la presenza del bestiame, anche se lo scorrimento<br />
delle acque provocava nel migliore dei casi un’esportazione massiccia di humus e<br />
nel peggiore, gravi fenomeni di erosione. Al fine di un’analis i completa dobbiamo<br />
però fare un passo indietro e tornare agli anni 1590-‘92, quando delle gravi<br />
carestie misero a dura prova i vivaci mercati cinquecenteschi e le attività<br />
manifatturiere. La carestia complicò anche il ruolo delle autorità locali, che<br />
dovevano far fronte alle necessità alimentari primarie della popolazione e inasprì<br />
sempre più le condizioni dei coloni, che spesso erano costretti a nutrirsi di pane<br />
di ghiande. Nei centri urbani si tornava all’autoconsumo, nelle campagne invece<br />
l’incolto e la pastorizia sottraevano nuovamente spazi alle coltivazioni, le cui rese<br />
subivano una battuta d’arresto. L’introduzione del mais nell’agricoltura<br />
marchigiana fu determinante per uscire da questa condizione di declino, poiché<br />
era un valido succedaneo del grano, ma a differenza di quest’ultimo necessitava<br />
di poco lavoro manuale e aveva maggiori rese; anche i proprietari furono<br />
avvantaggiati dall’alto consumo di granoturco poiché potevano commercializzare<br />
una maggiore quantità di grano. Nelle Marche il mais dapprima, si diffuse sulle<br />
colline Senigallesi, poi nella Vallesina e successivamente anche nelle terre della<br />
Santa Chiesa di Loreto, determinando una ripresa dei mercati, i quali furono tra<br />
l'altro avvantaggiati anche dalla creazione nel 1732 del porto franco di Ancona,<br />
che rese possibile un aumento consistente dei rapporti commerciali col resto<br />
d’Europa, rapporti sempre più basati sullo scambio del mais, che soppianterà<br />
praticamente ogni cereale minore. Tornando alla mezzadria, vediamo come essa<br />
nel Settecento presentasse condizioni sempre più severe: i coloni dovevano<br />
fornire tutta la semente necessaria e corrispondere dei pagamenti in grano per i<br />
buoi e per l’affitto della casa, tanto che spesso erano costretti a nutrirsi<br />
esclusivamente di mais sottoforma di polenta e di pane miscelato a granoturco. I<br />
ricchi erano gli unici che potevano continuare a nutrirsi di grano, poiché anche<br />
6 La policoltura è una caratteristica che è rimasta a lungo nell’agricoltura regionale (pluriattività),<br />
che negli ultimi anni è stata quasi del tutto soppiantata dalla specializzazione indotta dalle politiche<br />
di mercato. Ora c’è una riscoperta di questa antica attitudine <strong>degli</strong> agricoltori che ritroviamo nel<br />
termine multifunzionalità ricorrente nei nuovi orientamenti di politica comunitaria.<br />
7