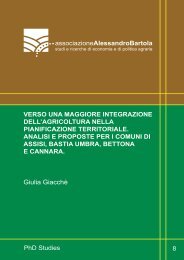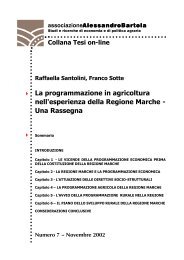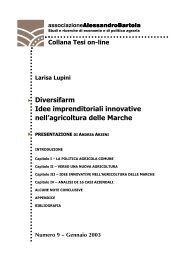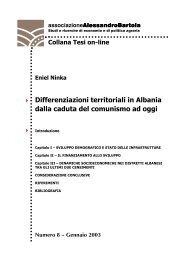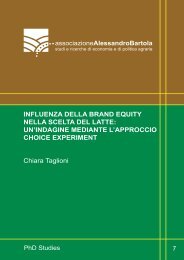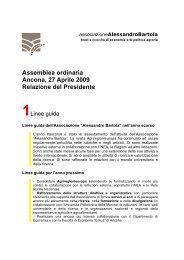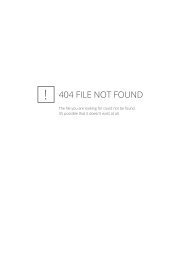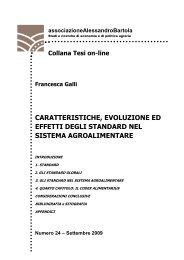Le esternalità dell'agricoltura. Una analisi degli effetti ambientali ...
Le esternalità dell'agricoltura. Una analisi degli effetti ambientali ...
Le esternalità dell'agricoltura. Una analisi degli effetti ambientali ...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
CAPITOLO 1<br />
L’EVOLUZIONE DEL PAESAGGIO AGRARIO NELLE MARCHE<br />
Il paesaggio naturale smette d’essere tale nel momento in cui l’uomo inizia ad<br />
interagire con esso; sono, infatti, i modi di organizzazione delle società e le<br />
culture dominanti a determinare le forme del paesaggio, il quale non è altro che<br />
la risultante di tanti segni indelebili, che nel tempo si sono stratificati l’uno<br />
sull’altro: i geografi francesi parlano a riguardo di geografia umana. L’impronta<br />
dell’uomo è rilevata in primis dalla sistematica sostituzione delle specie animali e<br />
vegetali originarie con altre di maggiore utilità per la collettività, l’esempio più<br />
ricorrente è quello dei boschi con le colture cerealicole. Gli antesignani del<br />
processo di trasformazione, infatti, furono proprio i pastori che bruciavano vaste<br />
estensioni di bosco per creare i pascoli per le loro greggi e si spostavano<br />
attraverso dei selciati naturali (tratturi), che sarebbero diventati nelle epoche<br />
successive strade. Lo stesso paesaggio marchigiano, se non fosse intervenuto<br />
l’uomo, sarebbe tuttora un’unica foresta, dal litorale fino ai monti Sibillini, mentre<br />
oggi mostra molteplici varietà di coltivazioni. Ma quali sono state quindi le<br />
influenze che hanno determinato il paesaggio agrario contemporaneo? La storia<br />
del nostro territorio ha delle radici molto antiche, infatti, ci sono reperti che<br />
attestano la presenza di villaggi e capanne nel Fabrianese già nel paleolitico. <strong>Le</strong><br />
prime zone rurali risalgono invece al V sec. a.C., all’indomani dell’insediamento<br />
<strong>degli</strong> Etruschi, i quali erano conoscitori dell’aratro e abili agricoltori e<br />
sperimentavano diverse colture promiscue fra cui la piantata, ovvero la vite<br />
maritata al pioppo o all’acero. Si trattava ancora di piccole isole agricole e<br />
pastorali che spuntavano di tanto in tanto fra le foreste e i boschi, lasciati<br />
incontaminati dalle altre popolazioni insediate nelle valli del Misa e dell’Esino.<br />
L’arrivo del popolo romano nel III sec. a.C. significò invece una drastica riduzione<br />
delle zone collinari e montane lasciate ai pascoli pubblici e alle selve, e una<br />
contemporanea espansione della pianura prosciugata, che era ridistribuita fra<br />
vinti e vincitori secondo la lex flaminia 1 : il paesaggio agrario assumeva quindi<br />
quell’aspetto di tante maglie rettangolari che si è conservato fino ai nostri giorni.<br />
All’epoca le trasformazioni avvenivano in tempi molto lunghi, infatti, solamente<br />
nel III sec. d.C. si ebbero altri cambiamenti rilevanti, in particolare nel Piceno,<br />
dove accanto ai poderi coltivati dai coloni nascevano le villae 2 , nelle quali si<br />
ricorreva ad una forza lavoro composta esclusivamente da schiavi e da coloni<br />
soggetti a corvées 3 . Questa nuova struttura del lavoro agricolo, insieme alle<br />
scorrerie dei Visigoti, causarono un forte declino economico e demografico,<br />
determinando di conseguenza il rimboschimento delle pianure, il riformarsi di<br />
paludi e quindi la diffusione della malaria. Nello stesso tempo le città romane<br />
cambiavano veste, cingendosi di mura e prendendo le distanze da quelle<br />
1 “<strong>Le</strong>x de agro Piceno et Gallico viritim dividendo” voluta da C. Flaminio nel 232 a.C., che sanciva la<br />
distribuzione delle terre fra vincitori e vinti all’indomani della battaglia di Sentino.<br />
2 Termine franco che indica la corte, cioè una sorta di azienda agricola divisa in due parti; una<br />
parte veniva fatta coltivare ai servi dal proprietario per il suo fabbisogno; l’altra parte divisa in<br />
poderi era affittata a famiglie di contadini liberi in cambio di prestazioni in denaro o in natura.<br />
3 <strong>Le</strong>tteralmente richiesta od opera. Prestazione di lavoro a tempo e gratuita che i servi della gleba<br />
erano obbligati a compiere nelle proprietà fondiarie del signore accanto ai servi.<br />
3