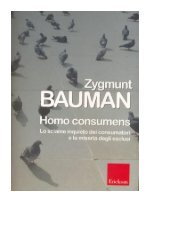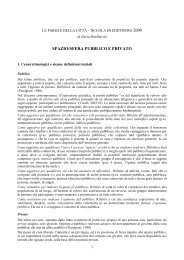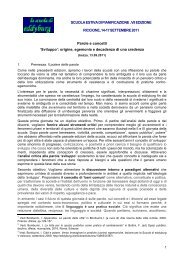La citt nel XX secolo: il successo infelice - Eddyburg
La citt nel XX secolo: il successo infelice - Eddyburg
La citt nel XX secolo: il successo infelice - Eddyburg
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
dell’immagine della <strong>citt</strong>à come foresta impenetrab<strong>il</strong>e evidenzia la negazione di questa fac<strong>il</strong>ità di<br />
lettura; forse rivela più un disagio interpretativo delle discipline che si occupano della <strong>citt</strong>à che una<br />
oscurità oggettiva. Ma le immagini, le rappresentazioni sociali, specie quando sono veicolate da<br />
canali forti, diventano più reali di ogni realtà materiale.<br />
Ogni crisi - usiamo questo termine <strong>nel</strong> significato corrente - ha <strong>il</strong> suo tempo e a esso appartiene:<br />
la Roma metropolitana della decadenza imperiale, la Parigi secentesca delle tante “corti dei<br />
miracoli”, la Londra fumosa e crudele di Dickens sono realtà diverse, accomunate dallo sguardo<br />
retrospettivo o dalla capacità universalistica dell’invenzione letteraria. In realtà, ci si presentano<br />
con indicatori oggettivi diversi. Se c’è una costante <strong>nel</strong>le crisi sociali è, semmai, quella determinata<br />
dal venir meno della corrispondenza tra forme fisiche e comportamenti delle istituzioni da una parte<br />
e bisogni, aspettative, comportamenti dei gruppi sociali dall’altra: quando le prime non riescono più<br />
a contenere, indirizzare, dare forma coerente alle trasformazioni reali, e gli altri, cioè i gruppi sociali,<br />
percepiscono confusamente <strong>il</strong> mutamento, ma non sono rassicurati dalla presenza di fattori<br />
automatici o intenzionali di riadattamento e di riequ<strong>il</strong>ibrio, accade che questi ultimi siano costretti<br />
ad assumersi soggettivamente <strong>il</strong> carico delle tensioni trasformative, elaborandolo in termini di<br />
disagio, rischio, allarme sociale.<br />
<strong>La</strong> crisi della metropoli contemporanea è sostenuta - <strong>nel</strong> senso di una più enfatizzata elaborazione<br />
- da due soggetti nuovi, l’urbanistica e i mass media, che trasformano, non intenzionalmente, i<br />
problemi urbani in gravi patologie. Cercherò di dimostrare che questo non è affatto un paradosso,<br />
come invece potrebbe sembrare.<br />
L’urbanistica è un potente elaboratore di analisi e di terapie che nasce dalla crisi urbana e di<br />
questa ha bisogno per crescere e affermarsi come potere tecnico, per alimentare le proprie<br />
contraddizioni e offrirle ora all’una ora all’altra manifestazione della coscienza inquieta del vivere<br />
urbano. L’urbanistica moderna nasce un po’ farmaco dulcamariano, un po’ tecnica di rigore<br />
sperimentale, un po’ proclama utopico, un po’, addirittura, scientia scientiarum di fronte ai mali<br />
di una <strong>citt</strong>à vista sempre, almeno dall’Ottocento a oggi, come “malata” (v. Choay, 1980); non per<br />
nulla <strong>il</strong> suo linguaggio usa spesso delle metafore (sventramento, demolizione, risanamento, ecc.).<br />
L’urbanistica come sapere e saper fare autonomi rivendica la sua tecnicità politicamente<br />
neutra, ma ha sempre portato <strong>nel</strong> suo seno le due anime contrapposte del pensiero utopico urbano:<br />
progressisti contro culturalisti, razionalismo e industrialismo contro comunitarismo e naturalismo.<br />
E, malgrado la sua dichiarata oggettività, non può non indurre <strong>nel</strong>le “proiezioni architettoniche<br />
o spaziali, un certo numero di pratiche e di mutamenti sociali” (v. Roncayolo, 1988, p. 112).<br />
<strong>La</strong> progettazione urbanistica finisce col “muovere società”, proponendo con modalità<br />
sostanzialmente autoritarie modelli che implicano nuovi st<strong>il</strong>i di vita o che finiscono anche<br />
indirettamente per determinarli. D’altra parte l’invenzione urbana può trasformarsi in formula e<br />
questa può essere riprodotta - in un delirio tecnocratico - in contesti temporali e spaziali diversi,<br />
senza curarsi della presenza o meno di altri interventi che pur appartengono alla coerenza del<br />
piano: la V<strong>il</strong>le radieuse si trasforma <strong>nel</strong> Corviale di Roma o <strong>nel</strong>le sette Vele di Napoli o <strong>nel</strong>lo Zen<br />
di Palermo; non ci si può aspettare che la new town, anche quando sia realizzata con la giusta<br />
dotazione di servizi e di verde, crei necessariamente la comunità.<br />
<strong>La</strong> crescita dell’urbanistica ha provocato la sua separazione dall’architettura: “Questa<br />
(recente) separazione nasconde altre fratture e altre lacerazioni profonde. L’urbanistica si è<br />
allontanata dal suolo, dalla <strong>citt</strong>à fisica, dalla sua carica simbolica, dalle pratiche sociali, dalle<br />
comunità, dalle loro aspirazioni, dalla loro domanda d’identità e di futuro” (v. Pavia, 1996, p. 7).<br />
Viene a mancare così la capacità di rispondere alla domanda di qualità simbolica e di rappresentazione<br />
espressa dalla comunità: la grande opera architettonica, come si è ricordato in<br />
precedenza, si delocalizza; non è inscrivib<strong>il</strong>e, quindi, all’interno di una possib<strong>il</strong>ità di lettura<br />
comune della <strong>citt</strong>à. Una <strong>citt</strong>à che non si può leggere, che non offre alla maggior parte possib<strong>il</strong>e dei<br />
suoi <strong>citt</strong>adini e dei suoi visitatori codici, anche diversi, di rappresentazione e di appropriazioneappartenenza,<br />
è una <strong>citt</strong>à che genera alienazione, che evidenzia i suoi costi ma scolora i suoi benefici,<br />
che, in altre parole, trasmette immagini di crisi.