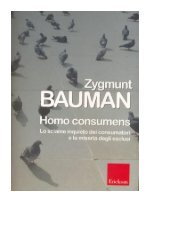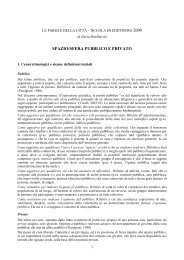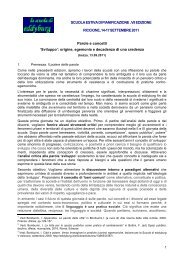La citt nel XX secolo: il successo infelice - Eddyburg
La citt nel XX secolo: il successo infelice - Eddyburg
La citt nel XX secolo: il successo infelice - Eddyburg
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
governo Thatcher abolirà <strong>nel</strong> 1985 le forme di governo metropolitano che pure avevano assicurato<br />
all’esperienza inglese di pianificazione su scala metropolitana-regionale una funzione p<strong>il</strong>ota.<br />
Un secondo fattore di crisi matura negli stessi ambienti tecnici e scientifici, con la constatazione<br />
che la complessità e l’elevato dinamismo della società postindustriale “avevano raggiunto ormai<br />
livelli tali da frustrare ogni velleità di controllo e regolazione centralizzati, ogni possib<strong>il</strong>ità di<br />
previsione e pianificazione razionale e comprensiva” (v. Strassoldo, 1998, p. 50).<br />
Infine, peserà sull’urbanistica razionalista <strong>il</strong> generalizzato clima di sfiducia sulla razionalità<br />
scientifica che comincia a permeare <strong>il</strong> mondo occidentale, principalmente con la crisi dei regimi<br />
socialisti e con l’esplosione della questione ambientale.<br />
Alla fine del <strong>XX</strong> <strong>secolo</strong> si afferma così un nuovo movimento di idee, ma anche di realizzazioni<br />
concrete, destinato a mutare ancora una volta realtà e immagine della <strong>citt</strong>à, un movimento che si<br />
definisce, con una semplificazione semantica, “postmoderno”. Esso non nasce però come pura<br />
negazione del moderno, poiché è stato preceduto e preparato dalle culture metropolitane degli ultimi<br />
vent’anni: nei significanti elettronici del cinema, della televisione, dei video, dei megaconcerti; <strong>nel</strong>la<br />
moda e negli st<strong>il</strong>i giovan<strong>il</strong>i, in tutti quei suoni e immagini che ogni giorno vengono missati in quella<br />
sorta di schermo gigante che la <strong>citt</strong>à è ormai diventata.<br />
Stiamo vivendo un cambiamento radicale: “Il principio del piacere sta prendendo <strong>il</strong> posto di<br />
quello dell’ut<strong>il</strong>ità che aveva segnato l’esperienza urbana per almeno centocinquanta anni [...]<br />
colpendo al cuore i principi fondamentalmente ascetici e puritani del CIAM e del razionalismo”<br />
(v. Amendola, 1998, p. 42); a condizione, però, di sottolineare che <strong>nel</strong> postmoderno <strong>il</strong> “piacere”<br />
finisce con <strong>il</strong> produrre nuova “ut<strong>il</strong>ità” e, conseguentemente, nuova competizione e nuovi conflitti.<br />
È proprio <strong>nel</strong>l’ambito dell’architettura che <strong>il</strong> concetto di postmoderno ha fatto le sue prime prove,<br />
diffondendosi poi in altri universi del sapere e del fare. Nella <strong>citt</strong>à postmoderna l’architetturachiave<br />
non è più quella tradizionale delle grandi istituzioni civ<strong>il</strong>i e religiose, dei grandi santuari del<br />
commercio e della finanza (le banche, la borsa, ecc.): estese attrezzature espositive e museali, centri<br />
direzionali, aerostazioni, centri commerciali, stadi sportivi, macrostrutture alberghiere, <strong>citt</strong>à della<br />
scienza risaltano per dimensioni, originalità e qualità formali, per soluzioni tecnologiche<br />
innovative, imponendosi come le cattedrali di una nuova religione, quella del marketing urbano. “I<br />
luoghi più caratteristici dell’architettura e urbanistica postmoderna possono essere raggruppati in<br />
tre grandi categorie. <strong>La</strong> prima comprende le nuove <strong>citt</strong>à del tempo libero e del divertimento; la<br />
seconda le cattedrali del consumo materiale e culturale, la terza i vecchi centri storici rinnovati”<br />
(v. Strassoldo, 1998, p. 59). A volte l’architettura si misura con una distribuzione specialistica dei<br />
luoghi rispetto alle tre categorie-funzioni; più spesso deve rispondere alle esigenze di<br />
concentrazione <strong>nel</strong>lo stesso luogo di più funzioni (rafforzando la capacità competitiva della <strong>citt</strong>à),<br />
magari attraverso simulazioni della funzione assente o riconversione accelerata e fantasiosa di<br />
preesistenze fisiche ed economiche verso le nuove funzioni.<br />
L’architettura postmoderna esprime la volontà di usare le tradizioni e gli st<strong>il</strong>i del passato, ma,<br />
con un grande eclettismo st<strong>il</strong>istico, riscopre <strong>il</strong> valore dell’ornamento e ricorre ai colori anche più<br />
inusuali, ostenta la propria frag<strong>il</strong>ità e precarietà, cerca di coinvolgere l’intero apparato sensoriale<br />
degli abitanti e dei visitatori facendone degli “spettatori”.<br />
Sotto l’espressione di <strong>citt</strong>à postmoderna sembra intessersi un patchwork di sensazioni, di<br />
immagini, di punte tecnologiche, di nuovi prodotti e di nuovi consumi urbani che affascina, ma<br />
<strong>nel</strong>lo stesso tempo si rivela tanto sfuggente quanto privo di qualsiasi logica organizzativa.<br />
Ma forse è proprio questo <strong>il</strong> “possib<strong>il</strong>e” della <strong>citt</strong>à contemporanea, una possib<strong>il</strong>ità di destino<br />
metropolitano che ci offre l’ipotesi di un’ulteriore trasformazione dell’urbano.<br />
1c. Tra <strong>citt</strong>à e urbano: è già metropoli.<br />
Partiamo dall’etimo di metropoli, <strong>citt</strong>à-madre, dal quale si potrebbero ricavare, seguendo le<br />
suggestioni di una improbab<strong>il</strong>e “sociologia della maternità”, le sue vocazioni contraddittorie.<br />
Insieme captativa e oblativa, la metropoli attira e cattura risorse demografiche, economiche,