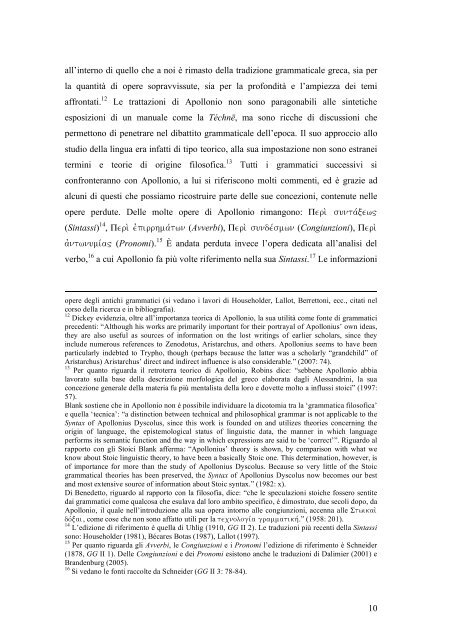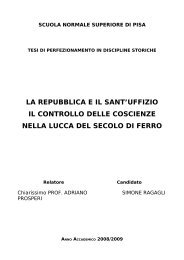TESI Sara Eco Conti - Scuola Normale Superiore
TESI Sara Eco Conti - Scuola Normale Superiore
TESI Sara Eco Conti - Scuola Normale Superiore
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
all’interno di quello che a noi è rimasto della tradizione grammaticale greca, sia per<br />
la quantità di opere sopravvissute, sia per la profondità e l’ampiezza dei temi<br />
affrontati. 12 Le trattazioni di Apollonio non sono paragonabili alle sintetiche<br />
esposizioni di un manuale come la Téchnē, ma sono ricche di discussioni che<br />
permettono di penetrare nel dibattito grammaticale dell’epoca. Il suo approccio allo<br />
studio della lingua era infatti di tipo teorico, alla sua impostazione non sono estranei<br />
termini e teorie di origine filosofica. 13 Tutti i grammatici successivi si<br />
confronteranno con Apollonio, a lui si riferiscono molti commenti, ed è grazie ad<br />
alcuni di questi che possiamo ricostruire parte delle sue concezioni, contenute nelle<br />
opere perdute. Delle molte opere di Apollonio rimangono: Peri; suntavxew~<br />
(Sintassi) 14 , Peri; ejpirrhmavtwn (Avverbi), Peri; sundevsmwn (Congiunzioni), Peri;<br />
ajntwnumiva~ (Pronomi). 15 È andata perduta invece l’opera dedicata all’analisi del<br />
verbo, 16 a cui Apollonio fa più volte riferimento nella sua Sintassi. 17 Le informazioni<br />
opere degli antichi grammatici (si vedano i lavori di Householder, Lallot, Berrettoni, ecc., citati nel<br />
corso della ricerca e in bibliografia).<br />
12 Dickey evidenzia, oltre all’importanza teorica di Apollonio, la sua utilità come fonte di grammatici<br />
precedenti: “Although his works are primarily important for their portrayal of Apollonius’ own ideas,<br />
they are also useful as sources of information on the lost writings of earlier scholars, since they<br />
include numerous references to Zenodotus, Aristarchus, and others. Apollonius seems to have been<br />
particularly indebted to Trypho, though (perhaps because the latter was a scholarly “grandchild” of<br />
Aristarchus) Aristarchus’ direct and indirect influence is also considerable.” (2007: 74).<br />
13 Per quanto riguarda il retroterra teorico di Apollonio, Robins dice: “sebbene Apollonio abbia<br />
lavorato sulla base della descrizione morfologica del greco elaborata dagli Alessandrini, la sua<br />
concezione generale della materia fu più mentalista della loro e dovette molto a influssi stoici” (1997:<br />
57).<br />
Blank sostiene che in Apollonio non è possibile individuare la dicotomia tra la ‘grammatica filosofica’<br />
e quella ‘tecnica’: “a distinction between technical and philosophical grammar is not applicable to the<br />
Syntax of Apollonius Dyscolus, since this work is founded on and utilizes theories concerning the<br />
origin of language, the epistemological status of linguistic data, the manner in which language<br />
performs its semantic function and the way in which expressions are said to be ‘correct’”. Riguardo al<br />
rapporto con gli Stoici Blank afferma: “Apollonius’ theory is shown, by comparison with what we<br />
know about Stoic linguistic theory, to have been a basically Stoic one. This determination, however, is<br />
of importance for more than the study of Apollonius Dyscolus. Because so very little of the Stoic<br />
grammatical theories has been preserved, the Syntax of Apollonius Dyscolus now becomes our best<br />
and most extensive source of information about Stoic syntax.” (1982: x).<br />
Di Benedetto, riguardo al rapporto con la filosofia, dice: “che le speculazioni stoiche fossero sentite<br />
dai grammatici come qualcosa che esulava dal loro ambito specifico, è dimostrato, due secoli dopo, da<br />
Apollonio, il quale nell’introduzione alla sua opera intorno alle congiunzioni, accenna alle Stwikai;<br />
dovxai, come cose che non sono affatto utili per la tecnologiva grammatikhv.” (1958: 201).<br />
14 L’edizione di riferimento è quella di Uhlig (1910, GG II 2). Le traduzioni più recenti della Sintassi<br />
sono: Householder (1981), Bécares Botas (1987), Lallot (1997).<br />
15 Per quanto riguarda gli Avverbi, le Congiunzioni e i Pronomi l’edizione di riferimento è Schneider<br />
(1878, GG II 1). Delle Congiunzioni e dei Pronomi esistono anche le traduzioni di Dalimier (2001) e<br />
Brandenburg (2005).<br />
16 Si vedano le fonti raccolte da Schneider (GG II 3: 78-84).<br />
10